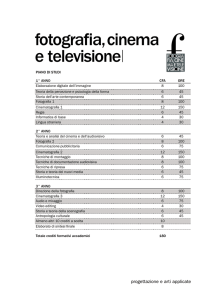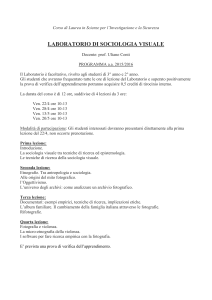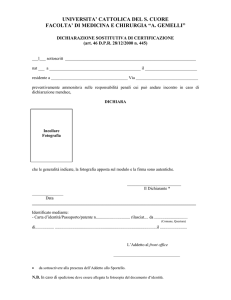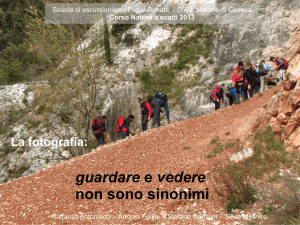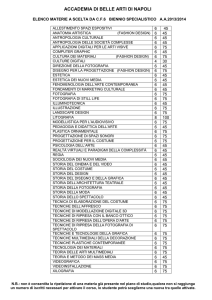Etnofotografia
La Sociologia Visuale è un approccio (in via di definizione), prevalentemente qualitativo,
che si sviluppa negli anni ’70, a partire dalle riflessioni di Becker (e, in Italia, di Ferrarotti).
La sociologia visuale non considera le immagini nel ruolo marginale e aggiuntivo di
documenti o illustrazioni, ma come fonte di dati rilevanti, come strumento, come parte
integrante del processo di ricerca, cogliendo la specificità ed il valore ermeneutico del dato
iconico (Henny, 1986). Quindi possiamo considerare la Sociologia visuale come la
registrazione, l’analisi e la comunicazione della vita sociale attraverso le rappresentazioni
grafiche, le fotografie e i video. I sociologi visuali sono interessati alla funzione delle
immagini nella società e ad usare i mezzi audiovisivi come strumenti di ricerca.
La ricerca dell’autorevolezza della sociologia visuale è un costante work in progress, in cui
molti studiosi continuano a proporre riflessioni da oltre 20 anni.
In particolare si discute sui criteri di scientificità della ricerca per immagini, attraverso i
concetti di validità e attendibilità. Per validità si intende il principio di corrispondenza fra
immagini e concetto; per attendibilità si intende la credibilità tecnica.
Nello specifico, il concetto di validità viene associato a quello di misurazione. Ammassari,
però, propone una definizione di validità che si discosta da quelle tradizionali, secondo la
quale “per validità degli strumenti di rilevazione si intende la loro capacità ad accertare
proprio e non altro il referente empirico del concetto cui si intende riferire”. Questa
definizione tiene conto di un concetto di misurazione che non fa riferimento alla sola
dimensione numerica del dato, ma ad un ampio processo di classificazione e
categorizzazione. Inoltre viene sottolineata l’importanza della “validità interna”, cioè il
grado con cui un indicatore corrisponde ad una definizione. Questi chiarimenti sono
fondamentali nel caso dei dati visivi, i quali di per sé non misurano in termini numerici, ma
riproducono una realtà significativa nell’ambito di un progetto di ricerca, sulla quale
possono poi essere condotte ulteriori elaborazioni quantitative o valutative.
Bisogna distinguere tra validità delle tecniche e validità dei dati visivi:
Per verificare la v. delle tecniche visive dobbiamo chiederci se esse siano adeguate a
rappresentare/riprodurre gli indicatori visivi. Si tratta, quindi, di verificare se i codici
comunicativi e di trasmissione( inquadratura, illuminazione, montaggio, ecc; )
consentono di restituire gli aspetti della realtà sociale rilevanti ai fini della ricerca;
La validità dei dati visivi (cioè i prodotti che si ottengono mediante le tecniche
fotografiche, cinematografiche ed videoelettroniche) consiste nella capacità
referenziale di contenere tutti gli aspetti di un dato fenomeno o evento, rilevanti per la
ricerca. Questa v. è detta “di contenuto” e fa riferimento al grado di iconicità
dell’immagine, cioè alla capacità di un’immagine di riprodurre la realtà.
L’attendibilità, invece, consiste nella capacità di fornire risultati uguali quando si procede a
misurazioni diverse di uno stesso fenomeno. Essa riposa su dispositivi meccanici ed
elettronici, nonché su fenomeni fisici, chimici ed ottici. Ma investe anche le strategie e le
procedure di ricerca che utilizzano dati visuali. Wagner propone una serie di metodi per
garantire il più possibile l’attendibilità delle procedure di ricerca visiva. Egli distingue tra i
metodi di produzione delle immagini e i metodi di lettura delle immagini. Nel primo caso si
può aumentare l’affidabilità delle immagini effettuando una precisa registrazione delle
modalità di ripresa e affiancando alle fonti visive dati statistici, materiali documentari
scritti e orali, interviste, ecc. Nel secondo caso bisogna procedere ad un’analisi del
contenuto delle immagini utilizzando le più nuove metodologie di tipo qualitativo e
quantitativo, e comunque tenendo conto della specificità dei documenti visivi analizzati.
I lavori di sociologia visuale, però, non sempre rispettano tali criteri di scientificità,
soprattutto perché vi è una duplice definizione di sociologia visuale.
La definizione forte non considera la s. v. una disciplina ma un metodo, una modo di fare
ricerca che offre informazioni e dati di carattere visivo, utili nel contesto dell’indagine. La
definizione debole, però, considera la s. v. come un complesso di studi che riguardano la
comunicazione visiva in genere e che, quindi, non enfatizza il carattere scientifico della
disciplina, ma la propone come fattore di cambiamento culturale e sociale, trascurando la
vocazione scientifica a favore di una libertà espressiva o di una prassi sociale che
appartengono al mondo dell’arte, del giornalismo o della militanza politica, e che quindi
non necessitano di quella garanzia di intersoggettività che contraddistingue la conoscenza
scientifica.
Un’altra problematica affrontata dalla s. v. è legata all’oggettività delle immagini. Essendo
considerate riproduzioni fedeli del mondo le immagini, nella seconda meta del XIX secolo,
entrarono di diritto in tutti i campi dell’informazione e della scienza. Tuttavia questo modo
di pensare venne messo in discussione a partire dal secolo successivo. Si riteneva, infatti,
che il fotografo fosse un osservatore acuto, ma imparziale. Quando, però, ci si rese conto
che nessuno fotografa nello stesso modo una stessa cosa, l’ipotesi che le macchine
fornissero un’immagine impersonale e oggettiva dovette cedere al fatto che le fotografie
non attestano soltanto ciò che c’è, ma ciò che un individuo ci vede, che non sono soltanto un
documento, ma una valutazione del mondo.
Si comincia quindi a concepire la fotografia come un atto selettivo (e quindi soggettivo), che
comunque mantiene un rapporto indicale (Eco, 1973) con la realtà.
L’immagine fotografica è oggi riconosciuta come il frutto della relazione tra la realtà e
l’interpretazione di quella realtà da parte del soggetto che fotografa. Queste riflessioni
influenzano il rapporto tra la fotografia e le scienze sociali, nelle quali l’interferenza del
ricercatore è una variabile da tenere sotto controllo, perché l’oggetto di studio è la realtà
umana, che è di per sé complessa, problematica e potenzialmente influenzabile, e con la
quale il ricercatore stabilisce un rapporto di interazione. Per superare la contrapposizione
soggettivo/oggettivo bisognerebbe saper cogliere la polisemicità e l’impatto emotivo delle
immagini come un plus per la ricerca. Questa prospettiva, anche se viene tenuta in disparte
da alcuni studiosi, ha delle fondamenta teoriche ben salde. Basti pensare ai primi scritti di
Becker, secondo il quale «ogni fotografia contiene un fattore estetico e creativo che, lungi
dal danneggiarne o limitarne l’uso nella ricerca sociologica, garantisce la peculiarità
d’analisi della sociologia visuale».
Per poter “leggere” un’immagine e farne uso nella ricerca sociologica, è necessario
soffermarsi sul problema dei codici visivi.
Un codice è costituito da un repertorio di segni e dalle loro regole di combinazione, che
consente di interpretare un messaggio in base ai significati convenzionali assegnati a
ciascun segno e a specifiche combinazioni di segni. I codici visivi hanno una particolarità: i
segni, detti icone, hanno sia lo scopo di comunicare dei significati, sia quello di selezionare,
isolare e riprodurre degli spezzoni di realtà.
La funzione comunicativa dei codici visivi può essere denotativa, cioè dal carattere
descrittivo referenziale, o connotativa, cioè può assumere significati complessi.
Possiamo distinguere 4 codici di particolare interesse per il sociologo visuale:
1. Codici di trasmissione – sono legati ad una serie di potenzialità tecnologiche che
consentono certi tipi di registrazione e di riproduzione della realtà. Hanno un basso
grado di ambiguità e seguono regolo abbastanza standardizzate. Hanno una
funzione denotativa, perché forniscono gli elementi costitutivi dell’immagine a
prescindere dal significato che a essa si vuole attribuire.
2. Codici iconici – permettono di riconoscere genere e specie dei singoli soggetti
rappresentati nelle immagini.
3. Codici iconografici – fanno riferimento alla combinazione dei singoli oggetti in scena,
in un complesso di elementi o in una successione di immagini. Dato che tali codici
sono largamente diffusi e universalmente condivisi, possiamo considerare la loro
funzione prevalentemente denotativa, perché essi assegnano significati
standardizzati alla realtà e facilitano la funzione descrittivo-informativa della
comunicazione visiva.
4. Codici socioculturali – attengono all’uso che viene fatto delle immagini. Essi sono
innumerevoli: fotografia artistica, fotogiornalismo, propaganda, scienze naturali e
scienze sociali. Tali codici sono prevalentemente di tipo connotativo, perché
caricano di ulteriori significati la significazione elaborata dai codici iconici e
iconografici. Ad esempio, la fotografia artistica tende ad alterare la realtà e i
significati comunemente veicolati dalla realtà rappresentata, inducendo allusioni e
associazioni di idee. Poiché il processo di connotazione tende a creare significati
decodificabili solo entro una particolare subcultura, si può dire che generalmente i
codici socioculturali presentano un alto grado di ambiguità.
La tipologia di immagine che più di altre è stata presa in considerazione negli studi di
sociologia visuale è l’immagine fotografica. È possibile delineare il percorso evolutivo della
fotografia sociale.
Inizialmente prevale una fotografia di “commiserazione”, in cui il fotografo si cala nella
realtà dell’emarginazione e della miseria, con l’intento di portare il mondo a conoscenza di
una realtà altrimenti ignota e bisognosa d’aiuto. Sono gli anni in cui emergono gravi
problemi sociali innescati dallo sviluppo industriale, quali sovrappopolazione, migrazione,
condizioni di vita pessime a causa delle insopportabili condizioni igieniche e dell’assenza
dei servizi essenziali nei villaggi di baracche affollati dai lavoratori delle fabbriche. In
questo scenario la fotografia svolse un ruolo importantissimo, grazie anche allo sviluppo
tecnologico raggiunto in quel campo. Infatti grazie alla commercializzazione di lastre
fotografiche più sensibili e del magnesio come fonte di illuminazione i fotografi furono in
grado di riprendere le piaghe sociali in tutta la loro drammatica evidenza. Ne sono un
esempio le fotografie di John Thomson, Eugène Atget e Heinrich Zille.
Un taglio sociologico analogo rivestono le foto del conte Giuseppe Primoli, autore di
numerose fotografie che ritraggono la Roma umbertina in diversi aspetti, e le fotografie dei
fratelli Alinari, che si dedicarono al mondo del lavoro, alla vita dei campi e al folclore
italiano. Di particolare interesse sono le fotografie realizzate in occasione dell’Inchiesta
sulle condizioni dei contadini meridionali, sotto la responsabilità di Coletti, che auspicava
all’utilizzo della fotografia come strumento di ricognizione visiva del fenomeno esaminato.
Verso la fine del XIX secolo e i primi del XX si afferma una fotografia “filantropica”, in cui il
fotografo si fa operatore sociale, interviene nella realtà con il proposito di denunciare le
contraddizioni del progresso industriale, per spingere l’opinione pubblica e le istituzioni ad
intervenire a favore delle classi sociali più sofferenti. Rappresentanti della fotografia
filantropica sono Jacob Riis e Lewis W. Hine.
Riis è danese e sbarca negli USA dove inizia a lavorare come giornalista. Nel 1890
pubblica un libretto dal titolo “Come vive l’altra metà” in cui illustrazioni, incisioni e
disegni ricavati da fotografie si affiancano alla descrizione degli slums di New York. Nel
1892 collabora ad un’indagine sociale sulla vita quotidiana nella metropoli americana,
provvista di numerose illustrazioni fornite dallo stesso Riis, che rivela al pubblico le
contraddizioni dello sviluppo. Riis fu il primo in America a manifestare un esplicito
intento di ricerca e documentazione e gode oggi di grande considerazione. I suoi lavori
furono riscoperti nel 1947 e nel 1948 fu proclamato “padre della fotografia sociale
americana”.
Hine era laureato in sociologia. Rivolse il suo interesse al mondo del lavoro industriale,
dedicandosi in particolare alle immagini del lavoro minorile. Nel suo lavoro però non
sembra aver messo a frutto i suoi studi sociologici. Infatti il suo intento non era quello
di ottenere dati sistemici secondo un progetto definito, ma le sue foto hanno soprattutto
un una presa sociale e uno scopo di denuncia.
All’inizio del XX secolo, quindi, Sociologia e fotografia sembravano destinate a percorrere
un lungo e fruttuoso cammino insieme. Entrambe volevano esplorare la società, e per un
breve periodo lo fecero insieme: l’American Journal of Sociology, tra il 1896 e il 1916,
pubblicò 31 articoli corredati di fotografie, in cui i temi erano ancora quelli della povertà e
dell’immigrazione e le fotografie avevano il compito di documentare i miglioramenti
avvenuti in seguito all’intervento delle istituzioni di assistenza sociale. I contributi più
interessanti sono quelli di Charles Bushnell, il quale utilizza le illustrazioni fotografiche
come fonte originale di informazione accanto al testo scritto. I lavori di Bushnell
riguardano 3 temi: l’ambiente di lavoro, la vita quotidiana dei lavoratori al di fuori della
fabbrica e la documentazione di alcuni provvedimenti disposti dalle aziende per migliorare
il tenore di vita dei lavoratori. Sul Journal apparvero anche vari contributi fotografici,
raccolti sotto la serie Chicago housing problems, che documentavano la vita nelle
baraccopoli di periferia della città americana. Dopo il 1915 le fotografie sparirono
rapidamente dal Journal poiché il direttore del giornale Albion Small privilegiò articoli e
ricerche quantitative, accusando la fotografia di essere un mero strumento descrittivo,
superfluo e fuorviante, perché incontrollabile sul piano scientifico e scarsamente
utilizzabile a livello quantitativo.
Non potendo soddisfare il sapere scientifico la fotografia si rifugia nel giornalismo
d’inchiesta per soddisfare la curiosità dell’opinione pubblica, dando vita al fotogiornalismo.
Il fotogiornalismo si impone, quindi, come fonte primaria di informazione e di diffusione
delle informazioni. Il primo giornale illustrato apparve già nel 1885 ma è solo a partire
dagli anni ’20 che il fotogiornalismo assume un ruolo fondamentale nel campo
dell’informazione, grazie anche allo sviluppo tecnologico. Vengono infatti commercializzati
apparecchi più maneggevoli che permettono al giornalista di essere presente ovunque,
inoltre le nuove emulsioni fotosensibili consentono ingrandimenti sempre maggiori e
quindi una migliore qualità della fotografia. Il fotogiornalismo si impone soprattutto in
Germania. I personaggi di maggior spicco sono Eric Solomon e Hans Bauman (detto Felix
Man).
La produzione di Solomon riguarda ambienti in cui non solo era difficile fotografare ma
talvolta era vietato dalla legge. E proprio perché riuscivano a dare un’immagine di ambienti
inaccessibili le sue foto erano molto apprezzate sia dai giornali che dal pubblico.
Bauman si occupa della vita quotidiana di Monaco e Berlino e una delle sue caratteristiche
di maggior rilievo sta nella predilezione della sequenza di immagini, che consente di dare
una descrizione complessa e articolata di un evento. Il fotogiornalismo tedesco costituì
l’ispirazione per altre iniziative simili in Europa (in Francia la rivista “Vu” e in Italia “Il
Tempo”) e soprattutto negli Stati Uniti dove nel 1936 nasce la rivista “Life” che raccolse
subito un grande successo di pubblico. E sono proprio gli Stati Uniti a dare il maggior
impulso al fotogiornalismo, mentre la fotografia sociale europea è rappresentata da un
esiguo numero di personaggi, tra cui vanno ricordati August Sander e Henry Lartigue.
Sander lavorò ad un vero e proprio “catalogo” (Il volto del nostro tempo) della popolazione
tedesca. Le sue foto sono delle classificazioni di tutti i ceti, le classi, i mestieri o i tipi del
popolo tedesco. Il suo intento sembra quello di collegare tra loro una posa, uno status, un
modo di vestire per proporre generalizzazioni. In realtà non vi è alcun ulteriore strumento
interpretativo per individuare caratteri comuni in grado di dare fondamento euristico ad
una classificazione.
Lartigue raccolse migliaia di fotografie di ogni genere mosso solo dalla curiosità. È per
questo il rappresentate della “fotografia dozzinale”, cioè quel modo di fare fotografia senza
un disegno preciso, che tuttavia fornisce una preziosa documentazione ad ampio raggio
della vita e della società del tempo.
La fase successiva è quella della fotografia di “solidarietà”, che realizza il progressivo
passaggio ad una più profonda immedesimazione del fotografo nelle vicende e nei problemi
di cui dà testimonianza. Rappresentanti di questa fotografia sono i fotografia impegnati
nella Farm Security Administration (FSA) che dal 1935 si occupò degli effetti della crisi
agricola. Nella produzione della FSA si verificò un incontro di varie tendenze ideologiche e
di stile. In particolare si trovarono di fronte i “pittorialisti”, per i quali la foto d’arte doveva
contenere prevalenti contenuti lirici, e gli esponenti “naturalistici” o della “straigth
photography”, ispirata dal poeta Whitman, per i quali il bello può ritrovarsi in qualsiasi
immagine, soprattutto in quelle che ritraggono l’uomo e la sua attività quotidiana, il suo
mondo, i suoi oggetti. A favorire la diffusione della “straight photography” fu Alfred
Stieglitz, fondatore della rivista fotografica “Camera Work”. Egli infatti nella sua rivista
ospitò numerosi fotografi che si ispiravano a Whitman e che con le loro fotografie
avviarono quel processo di saldatura tra fotografia estetica e fotografia sociale.
Il personaggio che meglio riassume questo incontro tra estetica fotografica e sensibilità
sociale è Dorothea Lange. In particolare, nella collaborazione con la FSA, rivela una
evidente inclinazione per l’analisi sociale. Questa sensibilità deriva dalla conoscenza dei
lavori di Riis e Hine e dalla collaborazione con le indagini del marito, sociologo ed
economista, Paul Taylor. In più occasioni la Lange sottolinea la funzione documentaria
della fotografia, il ruolo di tecnica d’indagine del sociale che poteva e doveva avere. Per la
Lange, la fotografia poteva costituire uno strumento,un mezzo di ricerca sociale, come i
grafici, le statistiche, i questionari.
Tuttavia la Lange era soprattutto una fotografa. Di conseguenza, mentre manca una reale
sistematicità d’indagine e un reale progetto documentario alla base del suo lavoro,la Lange
si preoccupò sempre di scattare foto che si inserissero coerentemente nel suo stile, nella
sua estetica fotografica.
Un altro noto personaggio della FSA è Walker Evans. Tuttavia egli diverrà noto al pubblico
solo nel 1938, con una raccolta di foto, “American Photographs” , che ambiva a farsi ritratto
dell’America.
Alla fine degli anni ’40 e l’inizio dei ’50 si afferma la cosiddetta fotografia “concerned”,
impegnata nel sociale. Essa si afferma alla fine del secondo conflitto mondiale con la nascita
a Parigi dell’Agenzia Magnum, creata da alcuni fotografi e fotogiornalisti. L’agenzia aveva
un duplice intento: da un lato tutelare la figura del fotografo per ottenere gli stessi diritti
degli altri giornalisti; dall’altro, descrivere attraverso la foto la storia del mondo,
producendo immagini vere, che senza celare nulla della realtà di vita, esprimessero anche
un’interpretazione. Così alla fine degli anni ’50 negli Stati Uniti emerge una nuova tendenza
legata al filone della fotografia “concerned” e che trova i suoi fondamenti nel
fotogiornalismo più spregiudicato, che registra la realtà in tutti i suoi aspetti, anche quelli
più sgradevoli. Ne danno testimonianza le foto di Arthur Felling (detto Weegee), che
pubblicò una raccolta di foto sulla vita notturna di New York, e quelle di Robert Frank, che
pubblicò una collezione di ritratti, “The Americans”, che descriveva i luoghi e i volti
dell’America, senza alcuna preoccupazione per le inquadrature, la nitidezza delle immagini,
la significatività espressiva delle persone o delle immagini.
Negli anni ’60, sulla stessa linea, si afferma il lavoro di Diane Arbus, che portò alle estreme
conseguenze l’approccio di Weegee e Frank, analizzando il sociale nei suoi aspetti più
degradati e insoliti. La Arbus prediligeva quei personaggi che vivono in condizioni di
estrema degradazione fisica e morale, quali nani, prostitute, travestiti, barboni, o anche una
persona qualunque sorpresa però in un’espressione strana, una posa sconveniente o
imbarazzante.
Non le interessavano coloro che soffrivano la miseria e l’emarginazione. Difficile dire se le
esperienze della Arbus dipendessero da una visione disturbata della realtà e del ruolo del
fotografo, o facessero progetto realmente consapevole.
Negli anni ’60 si verifica anche la crisi dei rotocalchi illustrati, a causa della televisione che
rende meno attraenti le immagini fotografiche.
Tuttavia proprio in questi anni si delinea una nuova fase evolutiva della fotografia, definita
“d’intervento”. Sono gli anni della recessione economica, della crisi energetica, delle rivolte
studentesche, della guerra del Vietnam e della crisi in Medio Oriente e nell’America Latina.
Si mettono così in evidenza i fotografi di guerra che documentano la disperazione, la
sofferenza, la morte, e quelli che cercano di diffondere temi rivoluzionari e di tipo marxista.
In particolare, in Italia si afferma una generazione di fotografi(Patellani, Jodel, Giacomelli,
Bellini, Secchiaroli, ecc;) che producono reportages di denuncia, restituiscono la realtà del
Sud, le tragedie delle inondazioni e dei terremoti, il dramma della lotta operaia e la
partecipazione intensa del Sessantotto studentesco. C’è, quindi, una profonda presa di
coscienza di natura politica tra i fotografi italiani, che nel 1969 organizzano il Primo
Incontro Nazionale di Fotografia, in cui viene espressa la volontà di manifestare un
maggiore impegno nella realtà sociale e politica. Due anni dopo, nel’Incontro di Sorrento
del 1971, si delineò il programma dei fotografi “rivoluzionari”, che si concentrò sulla
funzione politica di alcuni gruppi fotografici che in realtà celava un’aggregazione politica
militante. Queste iniziative, anche se discutibili, ebbero il merito di porre la fotografia in
primo piano e di contrastare l’influenza dei media elettronici.
I cambiamenti avvenuti negli anni ’60 portarono fotografi e sociologi a condividere le
stesse suggestioni e a promuovere e divulgare le stesse forme di denuncia sociale e politica.
Ad essi si aggiungevano gli antropologi, sempre più interessati agli aspetti della cultura
urbana e metropolitana. E proprio a partire da questa complessa rete di scambi, ricerche
interdisciplinari, esperienze militanti e questa mobilitazione delle coscienze e della cultura
che viene a delinearsi la Sociologia Visuale.
Fra il 1975 e il 1978 nascono le prime riviste specializzate di s. v., ch costituirono il
trampolino di lancio per molti esponenti della disciplina.
Nel 1983 viene fondata l’International Association of Visual Sociology. Essa consente di
riunire e coordinare le esperienze di sociologi di continenti diversi. I lavori costitutivi
dell’Associazione si svolgono in occasione del primo Convegno Internazionale di Sociologia
Visuale, che si tiene a Windsor, nel quale si tengono numerose relazioni che si avvalgono di
filmati, proiezioni di diapositive, videoregistrazioni, con lo scopo di dimostrare l’esistenza e
la plausibilità di una sociologia visuale. Nei primi anni l’Associazione aveva avuto un
carattere di internazionalità fittizio, poiché membri,organizzatori e relatori erano tutti
nordamericani. Un’eccezione era costituita da Leonard Henny, direttore dell’International
Journal of Visual Sociology, edita in Europa. Nel 1986 il Convegno si svolge in Germania,
consentendo un confronto più dinamico tra ricercatori americani ed europei, e offrendo un
ricco volume di relazioni, molte delle quali tornano ad approfondire aspetti teorici,
metodologici e semiologici, che in precedenza erano stati “sacrificati” in favore della ricerca
applicata. Successivamente il congresso annuale tornò per 2 anni negli Stati Uniti,
determinando una nuova americanizzazione dei partecipanti. Nel 1989 il congresso torna
in Europa, questa volta in Olanda. In questa occasione la prevalenza dei temi antropologici
appare ancora più evidente, constatando che in Europa i sociologi visuali sono ancora una
minoranza, con idee ancora poco chiare circa la propria identità e gli itinerari della loro
ricerca. Anche per questo motivo l’Associazione resta un’iniziativa prevalentemente
americana.
I lavori di maggior rilievo della s. v. sono quelli di:
Douglas Harper – conduce la sua ricerca tra i barboni di Boston nel 1977; inizia il suo
lavoro con lo scopo di scattare “belle foto”, cioè di raccogliere una collezione di volti e
immagini di ispirazione arbusiana, con la qual illustrare la vita “deviante” di questi
personaggi. Tuttavia la sua sensibilità sociologica prende il sopravvento e si risveglia in
lui la tradizione della sociologi partecipante. Harper, così, condivide con i barboni
un’esperienza di 2 settimane, in cui raccoglie moltissime informazioni, apprende regole
di comportamento e di linguaggio. Dopo l’esperienza tra i barboni, vi torna per fare
fotografie, sapendo già dove, quando e come fotografare, seguendo un itinerario di
ricerca rigorosamente sociologico. La sua indagine si estende ai vagabondi che
attraversano l’America cui carri merci della ferrovia. Harper vi ritrova le consuetudini,
la spontanea solidarietà, l’isolamento libertario, il moralismo religioso, violenza, spirito
d’iniziativa, capacità di adattamento. Nell’indagine la fotografia assume un ruolo
primario, poiché non si limita ad illustrare, ma costituisce il dato, rappresenta il
fenomeno, lo caratterizza e fornisce lo spunto per un’ulteriore occasione di discussione.
Bruce Jackson – realizza un reportage sulla vita di un penitenziario statunitense,
intitolato Killing time:life in the Arcansas penitentiary, edito nel 1977 e considerato un
classico di s.v. Jackson utilizza la fotografia, ma anche l’intervista, la life-story, gli articoli
dei giornali, i documenti ufficiali del penitenziario, i fascicoli dei tribunali per
ricostruire gli episodi e i problemi della condizione carceraria. Vi è, quindi,
l’integrazione di tecniche d’indagine qualitative diverse che hanno lo scopo, non solo di
descrivere, ma anche di denunciare e rappresentare situazioni e problemi della società.
Jackson non era un sociologo professionista, ma mostrò una notevole acutezza nel
processo di documentazione. Il suo lavoro rappresenta il primo caso in cui la fotografia
viene adottata come uno dei vari mezzi di ricerca qualitativa.
Helen Stummer – l’oggetto d’indagine è un ghetto di Newark abitato prevalentemente
da neri e ispano-americani. L’intento è quello di incoraggiare la conoscenza di sé e la
percezione dei propri modi di vita negli abitanti del ghetto, di strappare certi luoghi
comuni sulle abitudini di quella gente. La Stummer mostrava le foto agli intervistati e
iniziava un lungo colloquio a partire da certi stimoli, da certe osservazioni, da certi
commenti espressi dai soggetti.
Bill Aron – è un fotografo professionista che vuole dare un quadro dell’ambiente urbano
e della vita del quartiere ebraico di New York., una zona che appare segnata da un
declino inarrestabile. Egli afferma di voler usare la macchina fotografica come un
questionario o un’intervista, con cui dar conto delle condizioni sociali del quartiere,
della sua evoluzione, ma anche dei rapporti sociali, delle caratteristiche, degli standard
di vita dei suoi abitanti, con particolare riferimento agli esponenti della comunità
ebraica residente. Le fotografie di Aron documentano il decadimento delle sinagoghe
chiuse, l’invecchiamento della popolazione, le tradizioni ebraiche più radicate, che
resistono in alcuni nuclei familiari più ortodossi. Il lavoro di Aron costituisce un buon
esempio di come sia possibile utilizzare l immagini a vari livelli di indagine: come prima
documentazione di sfondo, come raccolta e descrizione di dati, come strumento di
verifica nel processo di ricerca.
Oltre alla descrizione e alla denuncia dei problemi dell’emarginazione anche il tema della
famiglia ha ricevuto particolare attenzione dalla sociologia visuale. Tra le ricerche che
hanno trattato i problemi della famiglia vanno ricordati quelli di:
Sandra Titus – (1976) studia le foto di famiglia che vengono scattate in occasione di
cerimonie, festeggiamenti, gite o viaggi, e che vengono a costituire il patrimonio visivo
delle memorie della famiglia. Tali foto costituiscono un documento rivelatore
dell’evoluzione dei rapporti all’interno del nucleo familiare; in particolare diventa
interessante notare il riorientamento della famiglia quando vengono a farvi parte nuovi
membri. Il metodo adottato dalla Titus è prevalentemente qualitativo e la ricerca
risente ancora della mancanza di una più corposa riflessione metodologica sull’uso
delle immagini fotografiche nella ricerca sociale. Tuttavia dimostra l’utilità di studiare
le dinamiche familiari anche attraverso la produzione iconografica.
Christopher Musello – (1978) considera le foto di famiglia come espressioni delle
esperienze, delle relazioni, dei valori, delle credenze e delle abitudini dei membri, e si
chiede in che modo vengano a costituire uno strumento di comunicazione e di
continuità e quali principi ne guidino la produzione. Musello utilizza un modello che
dovrebbe consentire di comparare le foto prodotte da gruppi sociali diversi per
struttura, per cultura e per mezzi tecnici disponibili, denominato “sociovidistic frame
work”. Grazie a tale schema, Musello trova particolari uniformità in determinate
categorie di foto: quelle che riprendono episodi di vita quotidiana, quelle che celebrano
feste e ricorrenze, quelle che compaiono come memorie di viaggio. Per ciascuno di
questi raggruppamenti si possono evidenziare diverse modalità determinate dalle
caratteristiche sia del fotografo, sia dei soggetti rappresentati.
Joan Boerdam e W. M. Oosterbaan – (1980) si concentrano sulle motivazioni e sulle
scelte dei fotografi dilettanti alle prese con scene di famiglia. La prevalenza di certe
pose, di certe situazioni e la scelta di certe inquadrature, testimoniano la tendenza delle
foto di famiglia a registrare i “momenti felici” e ad enfatizzarne gli aspetti al di là delle
stessa realtà quotidiana.
Un’altra direzione di ricerca di notevole interesse è la sociologia visuale del territorio. I
lavori intrapresi finora sembrano orientarsi verso una recensione delle forme di intervento
dell’uomo sul territorio, adottando la tecnica del before/after. In questa prospettiva vanno
considerati anche gli studi di sociologia urbana che registrano lo sviluppo urbanistico, le
forme di abusivismo, il processo di assorbimento dei borghi periferici da parte della
metropoli, ecc. In genere, questi studi utilizzano materiale visivo a scopo illustrativo e
spesso senza una precisa consapevolezza di metodo. Fra le eccezioni ricordiamo gli studi
di:
Lello Mazzacane – si tratta di una complessa ricerca condotta in Basilicata, che aveva lo
scopo di ricostruire attraverso le immagini, una sorta di identità socio-antropologica
della regione. Le fasi della ricerca comprendevano la raccolta di foto di famiglia, di
documenti fotografici della vita quotidiana, dei luoghi di aggregazione urbana e rurale,
del lavoro artigiano, delle feste, ma anche un’approfondita analisi delle abitazioni, in
particolare di quelle di campagna. Mazzacane adotta in questo caso una griglia che
consente la registrazione e poi la comparazione di immagini relative agli spazi, che
consente di ricostruire il senso e la funzione delle strutture abitative nella storia e nella
cultura lucana.
Ervin Zube – non è un sociologo, ma in un lavoro del 1976 che voleva analizzare la
formazione e gli effetti di forti correnti d’aria in alcuni spazi urbani, venne studiato il
comportamento dei passanti e i loro rapporti con le strutture ambientali. Le
apparecchiature utilizzate erano sia la macchina fotografica che la cinepresa. Veniva
scelto un luogo pubblico e ad intervalli regolari una cinepresa riprendeva per un certo
periodo di tempo il movimento dei passanti. Tutto il materiale cinematografico veniva
poi ritradotto in grafici che evidenziavano sia gli addensamenti dei passanti in alcuni
spazi specifici, sia i punti di incrocio, sia le corsie preferenziali nell’attraversamento
della zona, sia i punti di incrocio, sia le zone in cui le correnti d’aria interferivano più
decisamente con i comportamenti delle persone. Inoltre contribuiva a fissare le
strategie individuali di ciascuno per proteggersi dal vento. Questo lavoro dimostra
chiaramente la possibilità di elaborare in termini quantitativi una serie di immagini
cinematografiche.
Il terreno su cui le tecniche di indagine audiovisiva si sono misurate con notevole utilità è
quello di “etologia umana”, che si riferisce ai comportamenti collettivi e alle dinamiche di
gruppo. A questo proposito va ricordata l’interaction process analysis di
Robert Bales – studiava l’interazione nei gruppi di laboratorio affidandosi ad una
registrazione manuale degli atti comunicativi interindividuali entro una tipologia molto
articolata che consentiva di individuare il soggetto emittente, il soggetto destinatario, il
tipo di interazione, la frequenza degli atti interattivi, ecc.
Si trattava di una mole di lavoro molto pesante, che richiedeva una grande esperienza
da parte dei rilevatori. Inizialmente Bales non riteneva utile l’uso delle cineprese poiché
una caratteristica della rilevazione era quella di fondarsi sull’immediatezza. Ma
l’adozione delle videocamere di uscire dal laboratorio e misurarsi con gruppi e forme di
interazione “reali”, calati in determinati contesti socio-ambientali.
Un altro ambito di ricerca e di impegno della s. v. è rappresentato dagli archivi iconografici.
Si tratta di preservare e rendere fruibile una massa di informazioni visive che rappresenta
un patrimonio incalcolabile per la civiltà moderna. Tale esigenza spinse antropologi e
mecenati a progettare e realizzare ricchissimi archivi cine-fotografici in grado di
raccogliere testimonianze di culture in via di estinzione o di usi e costumi disseminati in
ogni angolo della terra. Con il tempo, gruppi, organizzazioni, associazioni, partiti,
movimenti comunità, hanno scoperto l’utilità e l’importanza sociale e culturale di creare
una memoria storica visiva. In Italia alcune istituzioni si mossero in questa direzione:
Fototeca Nazionale – nasce come archivio fotografico già nel 1892 e ha un ricco
patrimonio di fotografie raccolte per scopi istituzionali;
Istituto Luce – risale al 1924-25 e, oltre a possedere fotografie e filmati di grande
importanza storica, ospita un laboratorio di restauro. Non si limita alla funzione di
raccolta e catalogazione d’archivio, ma cura la produzione e la distribuzione di
documentari. È dotato di oltre 3 milioni do fotografie dell’epoca fascista e di 12 milioni
di metri di pellicola, tra cui vanno ricordati circa 7500 giornali prodotti tra il 1928 e il
1973;
Archivio Fotografico Toscano – è un istituto a carattere regionale e si propone di
sviluppare un’attività all’avanguardia, curando la raccolta, la catalogazione e il restauro
di grandi fondi fotografici provenienti in genere da collezioni private toscane;
Archivi privati – vanno ricordati l’Archivio Storico Audiovisivo del Movimento Operaio
del 1979, la Publifoto del 1927 e la Fondazione Primoli del 1928.
La Sociologia visuale, oltre che all’immagine fotografica, si è rivolta anche all’ immagine
cinematografica.
La nascita del cinema si deve ai fratelli Lumière. Esso fece la sua comparsa in un periodo di
grande vitalità politica ed economica, di progressi scientifici e tecnici di ogni genere e in un
mondo che stava riducendo le distanze grazie allo sviluppo di mezzi di trasmissione e di
comunicazione. È anche un periodo di trasformazione per la filosofia e le scienze sociali che
mostrano un rinnovato interesse per l’uomo. In particolare, è l’inizio della grande stagione
della sociologia, che si afferma nel tentativo di interpretare i grandi problemi di una società
in rapida trasformazione. Era, quindi, un clima di grande entusiasmo e grandi prospettive
per il futuro. E proprio per questo il cinema destò subito una grande curiosità e costituì un
ulteriore segno del progresso umano.
Inizialmente il cinema sembrava dover restare confinato ai livelli di sperimentazione,
poiché appariva come un mero perfezionamento della fotografia, adatto a riprendere il
movimento. Ma la prima proiezione a pagamento dei fratelli Lumière, il 28 Dicembre 1895,
sancì la svolta che avrebbe fatto del cinema lo “spettacolo di massa” per eccellenza, e diede
vita all’industria cinematografica. I primi filmati dei Lumière si potevano considerare dei
reportages di vita quotidiana, senza alcun tentativo di sceneggiatura. Ma grazie a George
Mélies, che introdusse la messinscena e il trucco cinematografico, il cinema divenne
spettacolo di massa. In un certo senso, il cinema perfezionava il romanzo letterario,
producendo immagini e sequenze narrative reali, consentiva una fruizione di massa e
offriva una ricchezza di scenari, grazie alla ricostruzione di ambienti e al montaggio.
Lo sviluppo del cinema commerciale non impedì comunque quello del film scientifico, che
fu soprattutto film etnografico.
Il precursore del film di ricerca sociale è Félix Louis Régnault , un fisiologo con l’intento di
condurre uno studio comparato delle attività motorie di varie popolazioni. Per questo nel
1896 riprese alcuni movimenti presso i Wolof, i Fulan e i Diola e nel 1912 propose la
creazioni di archivi cinematografici per lo studio comparato dei movimenti e della cultura
dei popoli primitivi in estinzione.
Il primo vero lavoro cinematografico sul campo è, però, quello di Alfred Cort Haddon, girato
nel 1898 nello stretto di Torres, in Sud America. Haddon registra anche i suoni su cilindri di
cera, che però non erano sincronizzati con le riprese. Haddon è considerato il fondatore
dell’antropologia visuale e dell’urgent anthropology.
Tuttavia, già alla vigilia del primo conflitto mondiale il film etnografico conosce un periodo
di crisi, dovuta ad un cambiamento degli orientamenti teorici e di ricerca. Infatti, dalla
cultura materiale e dai comportamenti, l’attenzione si sposta verso lo “spirito” dei popoli,
ossia verso forme sociali immateriali che fossero rappresentative dei tratti psicologici delle
varie culture. Un freno arrivava inoltre dagli ambienti dell’etnologia e dell’antropologia
ufficiale, preoccupate di veder contaminati i propri studi da un mezzo che stava
riscuotendo successo nel campo artistico e commerciale.
A partire dal 1912 compaiono i primi filmati coloniali, predisposti dai governi delle nazioni
imperialiste per istruire le popolazioni dei paesi dominanti. Questi film paragonavano la
vita quotidiana delle popolazioni soggiogate, di cui si sottolineava la precarietà e
l’arretratezza, con la vita agiata e moderna del cittadino bianco. Lo scopo era quello di far
accettare l’occidentalizzazione e quindi la distruzione delle culture locali. Ovviamente,
questi filmati fornivano un quadro negativo delle culture, alterato e condizionato dai
pregiudizi e dagli stereotipi dei bianchi.
In questi anni emerge anche il genere del documentario, che però non garantiva
l’attendibilità del messaggio proposto perché legato alla “sincerità” degli autori, e con molte
concessioni cinematografiche, che tuttavia erano tollerate nella convinzione che
l’interpretazione di una cultura esiga anche uno sforzo di immedesimazione e trascrizione
simbolica del reale.
In questa situazione emerge la figura di Robert Flaherty, un cineoperatore con una certa
esperienza e una buona sensibilità etnoantropologica. Il suo lavoro più noto è Nanook of the
Noth, in cui descrive la vita di una famiglia di eschimesi. Questo lavoro ebbe un notevole
successo sia presso il pubblico che tra gli antropologi, ma non fu esente da critiche. Molti,
infatti, rimproverano a Flaherty di aver “ricostruito” alcune scene; altri, invece, pur
riconoscendogli un valore educativo, una carica drammatica e un’ispirazione notevole, lo
considerano dubitabile sul piano scientifico. Tutto ciò dipende dal fatto che Flaherty era
soprattutto un bravo filmaker e non un antropologo. Così anche gli altri suoi lavori
presentano problemi simili: Moana, del 1926, ambientato nei Mari del Sud, rappresenta
un’interessante fonte documentaria, ma si arricchisce di vari motivi romanzeschi; The man
of the Aran, del 1934, descrive gli abitanti dell’isola di Aran, in un ambiente selvaggio e di
grande bellezza, ma si sofferma più sulla descrizione dell’isola che su certi aspetti e
problemi dei suoi abitanti; The Land, del 1939, descrive il processo di desertificazione
causato dalla siccità nel Midwest americano, ma non risulta incisivo e analitico rispetto ai
problemi umani scatenati dalla crisi agricola americana.
Si era delineata, quindi, anche grazie ai lavori di Flaherty, la tendenza ad accostare
documentario e fiction, ricerca antropologica e narrazione. Ma in opposizione a tale
tendenza che legittimava la ricostruzione del reale per fini di ricerca si delinea la proposta
di registrare la realtà così come si presenta. Questo principio venne elaborato da Dziga
Vertov. Egli afferma che la cinepresa deve operare come un occhio in grado di registrare
tutto ciò che lo circonda, ogni evento, introducendosi ovunque, senza il bisogno della
messinscena, di teatri di posa e nemmeno di attori. Per questo egli è considerato il
fondatore del “cinema verità”. Alcuni però lo considerano il fondatore del “cinema
militante”, poiché mentre in alcuni film come Cine occhio: la vita colta alla sprovvista e
L’uomo con la macchina da presa sono una dimostrazione delle sue teorie, altri film come
Avanti Soviet o Tre canti su Lenin sono delle esaltazioni del leninismo. In effetti, il vero
documentario a sfondo sociale nasce in Russia negli anni ’20.
Negli anni che separarono i due conflitti mondiali il cinema di fiction trasse raramente
ispirazione dai problemi sociali, poiché si era indirizzato verso film di forte carica emotiva
e passionale, ai drammi storici o a storie comiche o d’avventura. L’immagine
cinematografica del sociale, quindi, si fonda ancora sul film etnografico e sulla scuola
documentaristica russa. Proprio a partire dall’esperienza di quest’ultima in Europa e negli
Stati Uniti si diffonde un documentario sociale “governativo”.
In Italia, ad esempio, il regime fascista indirizzò la produzione verso obiettivi
propagandistici, esaltando provvedimenti e riforme avviate dallo stato fascista.
In Gran Bretagna invece si afferma una scuola documentaristica molto solida, in cui, però,
prevale una sorta di intento riformistico, migliorativo, che cerca di evidenziare più le vie
del consenso che non quelle del conflitto sociale. È a partire dal 1936, con i lavori di Paul
Rotha, che vengono realizzati documentari più impegnati sul piano sociale, e che
descrivono la vita dei minatori, degli impiegati e dei vari problemi del Paese.
Negli USA il documentario sociale si deve alla “Scuola di New York”, che propone una sorta
di cinema-verità, che tende ad enfatizzare i fatti, ad affrontarli con spirito pratico e
costruttivo. I vari documentari trattarono i problemi dell’emarginazione,
dell’urbanizzazione, del razzismo e della crisi agricola.
Alla fine del secondo conflitto mondiale tutte le nazione erano impegnate in una
ricostruzione fisica e morale che portava ad impegnarsi nella risoluzione di problemi
sociali. Così anche il cinema di fiction da vita ad una produzione più realista e impegnata
nel sociale, che vede l’Italia in una posizione di guida. Il neorealismo italiano rappresenta
infatti una pagina di grande importanza per la storia del cinema, perché non solo interpreta
il disagio sociale dell’immediato dopoguerra, ma inaugura uno stretto rapporto tra cinema
e società. Si tratta di un cinema realista, popolare e nazionale, che si avvicina ai problemi
della gente e si ambienta nei luoghi in cui essa effettivamente vive ed opera. I classici del
neorealismo italiano sono Roma città aperta, di Rossellini, e Ladri di biciclette di De Sica.
Negli anni ’70 si delinea una produzione di impegno sociale più agguerrita sul piano
politico. L’intento dei registi è quello di svelare gli amari risvolti di un progresso economico
ambiguo, che sembrava realizzarsi a spese degli ideali dello stato democratico e
repubblicano. I film denuncia o di impegno sociale, come Le mani sulla città, Sovversivi, La
classe operaia va in paradiso, sono, quindi, il prodotto di un vasto movimento di idee e
interpretazioni delle aspirazioni delle classi lavoratrici.
Allo stesso tempo entra in crisi il documentario a sfondo sociale. In effetti, gli anni ’70
sanciscono definitivamente la crisi irreversibile del documentario cinematografico, sia
perché gli veniva preferita la fiction, in cui la creatività dell’autore poteva esprimersi senza
rinunciare all’impegno sociale, sia perché il mercato tendeva ormai a rifiutare una
produzione fondata esclusivamente sul rigore analitico e descrittivo di un fenomeno o di un
problema sociale. Al tracollo del documentario contribuì anche il progresso tecnologico,
che permise di immettere sul mercato cineprese 16 mm molto maneggevoli, le quali
permisero una rapida diffusione del cinema dilettantistico, e soprattutto l’avvento della
televisione.
Fino alla fine degli anni ’60 la televisione è stato quasi esclusivamente un mezzo di
diffusione delle immagini cinematografiche del sociale. Infatti, documentari, inchieste
filmate e film con risvolti sociali venivano girati su pellicola cinematografica e poi trasmessi
sui teleschermi. Inoltre gran parte del personale tecnico e creativo proveniva dal cinema.
La televisione si prestava, quindi, a veicolare ad un vasto pubblico casalingo la produzione
cinematografica. Tuttavia per molto tempo i film furono banditi dalla televisione, mentre
trovarono ampio spazio i documentari. Il documentario girato per la televisione assume più
i tratti dell’inchiesta, alternando alle immagini le interviste, alla descrizione dei fatti la loro
interpretazione, orientandosi verso gli aspetti più drammatici e più attuali delle
problematiche sociali. Ben presto però si verifica un declino del documentario d’ispirazione
cinematografica, a favore di servizi –inchiesta più concisi, più legati alla cronaca e
all’attualità e più articolati nel formato, dando spazio a programmi come TV7, Cronache
italiane, Settimanale giovani. Con il tempo si delinea sempre più la tendenza a concepire e
produrre programmi che, accanto all’analisi di tematiche politiche, sociali e di costume,
presentino elementi di richiamo e di spettacolo, con l’intento di catturare l’attenzione dei
telespettatori. Ciò ha portato ad arricchire il contenuto delle inchieste televisive e a
provocarne una rivoluzione con l’introduzione della diretta.
La diretta vera e propria, che si realizza nel mentre si verifica l’evento e consente allo
spettatore di vivere l’evolversi del fatto, non riguarda l’inchiesta televisiva. Quest’ultima,
infatti, necessita di un diverso tipo di diretta, che si realizza attraverso i lunghi piani
sequenza non montati girati sul posto, con telecamere portatili.
L’inchiesta televisiva proposta dalle grandi emittenti diventa un prodotto di consumo
veloce, perde il carattere di documento, raramente smuove le coscienze e più spesso
suscita curiosità.
In Italia la nascita della s. v. si fa risalire alla pubblicazione nel 1974 del volume “Dal
documento alla testimonianza. La fotografia nelle scienze sociali”, di Franco Ferrarotti.
Ferrarotti era il caposcuola della cosiddetta Sociologia Partecipante che si stava orientando
verso l’emarginazione sociale e il degrado urbano. Per Ferrarotti la fotografia assume un
ruolo di documentazione, denuncia e di stimolo nell’indagine sociologica, ma era anche uno
strumento per conferire dignità e rilevanza storica alle condizioni delle classi subalterne.
Inoltre Ferrarotti avvertiva la necessità di dare alla fotografia una definizione sistematica
nelle scienze sociali e un impiego non occasionale nella ricerca.
Occorre menzionare anche il contributo di Lello Mazzacane, fotografo e antropologo.
Mazzacane dedica vari articoli al tentativo di identificare più precisi percorsi metodologici
per la fotografia sociologica e alcune interessanti esemplificazioni di ricerca. Egli propone
una sorta di griglia molto articolata per la classificazione delle fotografie, che permette una
loro lettura secondo diversi livelli di astrazione e di complessità, consentendo di passare
dalla descrizione alla comparazione e di qui all’interpretazione del dato socioantropologico. Questa tecnica è stata adottata per uno studio delle feste e, con alcune
modifiche, per un’analisi del paesaggio rurale.