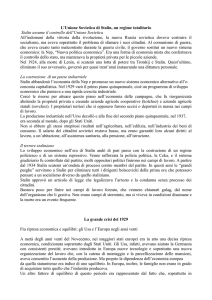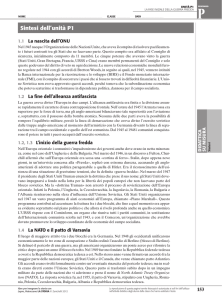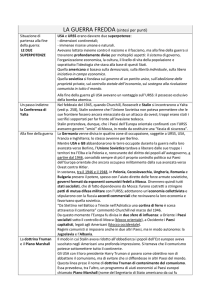La “Guerra fredda” e la politica
internazionale (1945-1991)1
di Ennio Savi*
Le conferenze interalleate
Il 2009 è stato un anno ricco di
anniversari. Uno di questi è stato
il 70° dallo scoppio della seconda
guerra mondiale, certamente il più
importante di tutti: quella guerra
infatti è stata l’evento culminante
del XX secolo. In sette interminabili
anni tra il 1939 e il 1945, il mondo
cambiò radicalmente (2).
Alla fine del 1941, con l’entrata
in guerra degli Stati Uniti in seguito
dell’attacco giapponese a Pearl Harbor, il problema per gli Alleati non fu
più se avessero vinto la guerra contro
le potenze dell’Asse, ma quando e
a che costo. Allo scopo di organizzare lo sforzo bellico e la strategia
generale della guerra, gli Alleati organizzarono, tra il 1941 e il 1945, una
lunga serie di grandi conferenze a
livello diplomatico e militare. Dopo
le grandi battaglie di contenimento
e le prime grandi controffensive del
1942-1943, a partire dalla conferenza
di Teheran le discussioni tra gli Alleati si spostarono progressivamente
sempre di più dalla condotta delle
operazioni belliche alla definizione
dell’ordine politico internazionale
dopo la vittoria che si stava profilando sempre più vicina.
Ancora a guerra in corso però
emerse chiaro il contrasto di vedute
e di interessi tra le due principali
potenze vincitrici, e cioè gli Stati
Uniti e l’Unione Sovietica.
Il presidente americano Franklin
*Ennio Savi, laureato in Storia
contemporanea all’Università Ca’
Foscari di Venezia.
D. Roosevelt, partendo dall’inter­
nazionalismo del suo predecessore
Woodrow Wilson nel primo dopoguerra (libertà dei mercati e sicurezza collettiva, ma nell’ottica, nuova, di
una politica di contenimento degli
attori che rimangono fuori da questo
ordine), aveva elaborato un ambizioso piano che avrebbe dovuto rivoluzionare totalmente i rapporti tra le
nazioni. Esso era basato su tre punti:
1) un’organizzazione mondiale delle
Nazioni Unite che sostituisse la vecchia Società delle Nazioni; 2) un’organizzazione economico-monetaria
mondiale sotto la guida degli Stati
Uniti; 3) un mondo smilitarizzato
dove l’ordine internazionale fosse
garantito dall’alleanza di quattro
potenze militari: USA, URSS, Gran
Bretagna e Cina («the four policemen», «i quattro poliziotti»). Quella
di Roosevelt era una visione che,
al di là degli idealismi, rispondeva
perfettamente agli interessi di una
potenza in enorme crescita che aveva bisogno di espandere la propria
economia all’estero cercando nuovi
mercati.
Gli Stati Uniti erano infatti emersi
dalla guerra, al contrario di tutti gli
altri paesi, enormemente rafforzati.
Non avevano problemi di ricostruzione, dato che furono l’unico
grande paese belligerante a non
avere sul proprio territorio le rovine
della guerra. Grazie alle forniture
belliche, la loro economia era in
straordinaria espansione e le loro
risorse industriali e tecnologiche non
avevano paragone con nessun altro
paese. Con la massiccia immigrazione di scienziati di origine ebraica
dall’Europa a seguito delle leggi razziali naziste e fasciste, le università
e i laboratori americani si trovarono
in pochissimo tempo all’avanguardia
nella ricerca scientifica. E la supremazia tecnologica degli Stati Uniti
era diventata supremazia militare
grazie al monopolio della bomba
atomica. Non è esagerato dire che sia
stata quella americana l’unica vera
«superpotenza» emersa dalla guerra.
Ma la dirigenza statunitense,
ricordando ancora la drammatica
esperienza della «grande depressione», aveva un grande timore: che la
nuova forza del paese fosse messa
in ginocchio da una devastante crisi
di sovrapproduzione. Non bastava
riconvertire l’industria alla produzione di pace: occorreva anche
aprire ad essa nuovi mercati. Per
ottenere questo bisognava superare
in modo radicale il protezionismo
degli anni ‘30, il quale, creando nei
vari paesi delle economie chiuse in
competizione tra loro (basti pensare
alla famosa «autarchia» fascista),
aveva contribuito non poco allo
scoppio della guerra, e sostituirgli
un sistema liberista, con le barriere
doganali ridotte al minimo e la libera
circolazione dei capitali privati. Era
ancora vivo in tutti il ricordo del caos
monetario del periodo tra le due
guerre e della grande depressione,
durante la quale i controlli sul tasso
di cambio e le barriere commerciali avevano minato il sistema di
pagamenti internazionali su cui era
basato il commercio mondiale. I governi infatti avevano usato politiche
di svalutazione per far crescere le
esportazioni giocando sulla compe7
titività del cambio, con lo scopo di
ridurre il deficit della bilancia dei
pagamenti, causando però come effetti colla­terali la caduta a picco delle
entrate nazionali, la riduzione della
domanda, un aumento esponenziale
della disoccupazione e un’ondata di
protezionismo durante la quale gli
scambi si ridussero a ristretti gruppi
di nazioni che si riferivano alla stessa
valuta, ad esempio il blocco della
sterlina inglese del Commonwealth).
Questa strategia, tesa ad aumentare
i redditi dei singoli paesi nel breve
periodo, aveva provocato disastri nel
medio e lungo periodo.
A tale scopo occorreva creare
nuove strutture internazionali, sotto
la guida degli Stati Uniti, che potessero regolare un regime globale
di libero scambio. Queste strutture
furono create con la conferenza di
Bretton Woods del luglio 1944 (3).
Questa conferenza monetaria
e finanziaria delle Nazioni Unite
aveva come scopo la ricostruzione
del sistema monetario e finanziario
dopo la guerra e riunì delegati di
44 nazioni alleate a Bretton Woods
(New Hampshire). Dopo un acceso
dibattito, durato tre settimane, i delegati firmarono una serie di accordi
tesi principalmente a due obiettivi: il
primo era l’obbligo per ogni paese di
adottare una politica monetaria tesa
a stabilizzare il tasso di cambio ad un
valore fisso rispetto al dollaro, che
veniva così eletto a valuta principale,
consentendo solo delle lievi oscillazioni delle altre valute; il secondo la
costituzione di un Fondo Monetario
Internazionale allo scopo di riequilibrare le dispartià causate dai pagamenti internazionali e di una Banca
internazionale per la ricostruzione
e lo sviluppo (detta anche «Banca
mondiale»). Le istituzioni divennero
operative nel 1946. L’anno dopo fu
firmato il GATT (General Agreement
on Tariffs and Trade, Accordo Generale sulle Tariffe ed il Commercio),
lo strumento principale per gestire
il libero scambio internazionale ed
evitare le guerre doganali.
In pratica il sistema progettato
a Bretton Woods era un «gold ex­
change standard», basato su rapporti
di cambio fissi tra le valute, tutte
8
agganciate al dollaro, il quale a sua
volta era agganciato all’oro. Gli interessi degli Stati Uniti diventavano
così gli interessi di tutto l’occidente
capitalista. Il sistema di Bretton
Woods però non prevedeva un controllo internazionale sulla quantità
di dollari emessi, permettendo così
agli USA l’emissione incontrollata
di moneta, fatto contestato più volte
da Francia e Germania in quanto
gli USA in questo modo potevano
esportare la loro inflazione.
La conferenza di Dumbarton
Oaks, un ciclo di colloqui informali
fra Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina
e Unione Sovietica, si apr il 21 agosto
1944 e si chiuse il 7 ottobre dello
stesso anno, pose le basi del progetto
per l’Organizzazione delle Nazioni
Unite, che sarebbe stata istituita
con la conferenza di San Francisco
dell’aprile 1945. La proposta iniziale,
elaborata dal Dipartimento di Stato
americano, suscit comunque gi in
questa sede sostanziali divergenze
proprio nelle questioni pi importanti, come la composizione del
Consiglio di Sicurezza, il diritto di
veto e le forze armate da mettere
a disposizione del Consiglio. Non
si trov altra soluzione che quella di
rimandare la discussione ad ulteriori
colloqui. L’Urss in particolare manifestava grandi perplessit sull’idea di
un Consiglio di Sicurezza che potesse far rispettare le proprie decisioni
con la forza.
L’istituzione ufficiale dell’ONU
si ebbe con la conferenza di San
Francisco dell’aprile-giugno 1945; la
firma della Carta delle Nazioni Unite
data invece 24 ottobre 1945.
L’Unione Sovietica aveva invece
prospettive meno mondiali e meno
nobili, ma per quanto la riguardava
molto più concrete.
Subito dopo la guerra, la principale preoccupazione di Stalin e del
partito comunista sovietico non poteva che essere la ricostruzione. Le
distruzioni della guerra erano state
enormi, sia dal punto di vista demo­
grafico (l’URSS soffrì qualcosa come
20 milioni di morti, la percentuale di
gran lunga maggiore fra tutti i paesi
belligeranti), che dal punto di vista
economico. L’economia delle regioni
occidentali dell’Unione Sovietica,
quelle più ricche e produttive, era
stata sconvolta: l’agricoltura, specie
in Ucraina, era in un incredibile
stato di devastazione, e l’industria
era stata spostata in Siberia e totalmente convertita allo sforzo bellico.
I sovietici, inoltre, diffidavano della
superiore potenza americana e
ritenevano necessario sviluppare
un sistema socialista chiuso e il piu
possibile autosufficiente, in netto
contrasto col mondo di mercati
aperti, interconnessi e organizzati
attorno al dollaro propugnato dal
governo statunitense.
La strategia di Stalin per il dopoguerra era dunque sintetizzabile in
alcuni - pochi ma ben chiari - punti:
1) riportare l’Unione Sovietica entro
i confini della Russia zarista; 2) assicurare all’etnia russa la supremazia
all’interno dell’Unione Sovietica
rispetto alle altre nazionalità (anche
con metodi brutali, come le depor­
tazioni di massa); 3) creare attorno
all’Unione Sovietica un anello di
stati subordinati che ne agevolasse la
difesa contro un eventuale nuovo aggressore (era la cosiddetta «dottrina
dell’accerchiamento capitalistico»).
L’enfatizzazione d’altra parte di una
presunta minaccia esterna permetteva a Stalin di giustificare di fronte
al popolo russo e ai comunisti esteri
la continuazione della repressione
del tenore di vita e della libertà individuale tipiche della sua gestione
del potere.
Il governo britannico di Winston
Churchill si trovò spiazzato dal grande progetto rooseveltiano, al quale
aderì più per costrizione che per convinzione. Anzi, le idee di Roosevelt
andavano direttamente contro gli
interessi nazionali inglesi: la loro realizzazione avrebbe infatti sostituito
il dollaro alla sterlina come moneta
di riferimento dei mercati finanziari,
ed avrebbe aperto alla concorrenza
americana tutti i mercati tradizionali
per le merci inglesi, come i paesi del
Commonwealth o il Sud­america. Ma
la Gran Bretagna, unico paese ad
aver combattuto senza interruzione
per tutta la durata della guerra, in
Europa, in Africa e nel Pacifico, era
nel 1945 finanzia­riamente dissan-
guata, e perciò del tutto dipendente
dagli aiuti americani. Andare contro
la politica americana, rischiando
ritorsioni finanziarie, era una cosa
che la Gran Breta­gna non poteva
permettersi.
Ma in particolare, Churchill era
preoccupatissimo di quella che per
lui era una pericolosa tendenza
da parte di Roosevelt a venire incontro alle richieste di Stalin pur
di averne l’appoggio per la sua
riorganiz­z azione postbellica del
mondo. In più il primo ministro
inglese era spaventato dall’avanzata
dell’Armata Rossa nei Balcani, alla
quale rispose dapprima cercando
di convincere il grande alleato d’oltreoceano a cacciare i tedeschi dai
Balcani creando così nella regione
una presenza anglo-americana, e in
seguito, di fronte al rifiuto americano
di distogliere lo sforzo bellico dalla
sua direttrice principale (cioè quella
che prevedeva di sbarcare in Francia
per combattere poi i tedeschi sul
Reno), cercando un accordo direttamente con Stalin. Ne venne fuori
il patto Churchill-Stalin di Mosca
dell’ottobre 1944, o «accordo delle
percentuali»: grosso modo, Romania
e Bulgaria sarebbero andate alla
Russia; la Grecia agli occidentali;
Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia
e Jugoslavia invece avrebbero visto
una compartecipazione “fifty-fifty”.
Questo accordo, fatto senza tener
in alcun conto l’autodeterminazione
dei popoli interessati, ebbe in seguito
grande importanza perché contribuì
a creare, quando sorsero regimi
comunisti in tutti i territori occupati
dall’Armata Rossa, la convinzione
da parte degli occidentali che Stalin
non fosse stato ai patti.
La prima grande conferenza interalleata che influenzò con le sue
decisioni l’assetto internazionale
del dopoguerra fu quella di Teheran
(28 novembre - 1 dicembre 1943). In
genere viene considerata di seconda
importanza rispetto a quelle successive di Jalta e di Potsdam, ma in
effetti la sua importanza fu cruciale.
A Teheran infatti furono prese tutte
le decisioni fondamentali sul nuovo
assetto territoriale dell’Europa: il
nuovo confine polacco sulla linea
I tre protagonisti della Conferenza di Yalta. Da sinistra: Winston Churchill,
Franklin Delano Roosevelt e Josif Stalin.
Oder-Neisse; l’annessione all’URSS
dei paesi baltici; la conferma del confine russo-polacco così come definito
dal patto nazi-sovietico del 1939; il
riconoscimento dell’influenza sovietica nei Balcani; la divisione della
Germania in zone di occupazione.
La conferenza di Jalta (4 - 11 febbraio 1945) fu in pratica un vertice
tra Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill e Stalin. Non venne
invitato il leader francese Charles de
Gaulle, che per il resto della sua vita
ricordò sempre con rancore quello
che considerava un affronto alla sua
persona e all’onore della Francia.
Roosevelt riuscì a far progredire
il suo grande progetto di organizzazione mondiale: nell’aprile 1945
si sarebbe tenuta a San Francisco
la conferenza che avrebbe visto la
nascita dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite. A Jalta fu anche raggiunto un primo accordo di massima
sulla composizione del Consiglio di
Sicurezza dell’ONU. Stalin espresse
la sua richiesta di avere «paesi amici»
alle frontiere dell’URSS. L’ambiguo
significato del termine «paesi amici»
fu ciò che conteneva in nuce la situazione venutasi a creare negli anni
immediatamente seguenti (4). Per
Stalin infatti questo significava paesi
comunisti, politicamente, economicamente e militar­mente soggetti a
Mosca (anche se si guardò bene dal
dirlo); per gli occidentali invece il
termine non significava necessariamente la rinuncia per questi paesi
al pluralismo politico e all’economia
di mercato, ma in sostanza solo la
smilitarizzazione dei loro confini con
l’URSS. I timori occidentali sulla
sorte degli stati occupati dall’Armata Rossa furono sopiti da Stalin
con una vaga promessa di elezioni
democratiche, e con l’insediamento
di governi di coalizione in Polonia
e in Jugoslavia. Chur­chill denunciò
l’instaurazione di regimi comunisti
in Romania e Bulgaria; Stalin negò,
e lo statista inglese non poté fare
altro che prendere atto del fatto
compiuto. L’appello all’au­to­de­ter­­
mina­zione dei popoli liberati dal
nazismo per Stalin era solo pura
propaganda, un contentino per
placare la coscienza dei due alleati
occidentali. Questi invece ritenevano
di aver vincolato Stalin a rispettare
l’autodeter­minazione politica dei
popoli dell’Est europeo.
Per quanto riguardava la Germania e l’Austria, fu confermata la de9
cisione di azzerarle completamente
come entità statuali e di smembrarle
in quattro zone di occupazione,
ognuna gestita dalle quattro potenze
vincitrici (USA, URSS, Regno Unito e Francia).
Al di là del suo progetto di ordine
mondiale, Roosevelt aveva comunque un motivo ben concreto per
essere accomodante con Stalin. Nel
febbraio 1945 il Giappone non aveva
ancora alcuna intenzione di deporre
le armi. Gli americani sarebbero
stati impegnati nei mesi seguenti
nelle due cruente battaglie di Iwo
Jima ed Okinawa, dove avrebbero
sperimentato direttamente il fanatismo giapponese nel difendere il
patrio suolo. La guerra nel Pacifico
sembrava ancora lontana dal concludersi. Gli angloamericani sarebbero
sbarcati direttamente in Giappone,
ma avevano bisogno che i sovietici,
che fino allora erano rimasti neutrali,
entrassero in guerra. Pur di assicurarsi che i russi avrebbero attaccato
i giapponesi in Manciuria, gli angloamericani concessero loro i territori
perduti dallo zar nella guerra del
1905 (5).
Alcuni storici parlano di un «mito
di Jalta», sostenendo che il ruolo
della conferenza nella spartizione
dell’Europa in sfere d’influenza non
fu così decisivo come si è sempre
creduto (6). In effetti questo è vero:
prima di tutto, Jalta da sola non
spiega molto se non viene inserita
nel contesto delle conferenze interal­
leate di guerra, almeno a partire da
Teheran in poi; inoltre, Germania
a parte, non vi fu alcuna esplicita
«spartizione» dell’Europa: la sovie­
tizzazione dell’Europa orientale fu la
conseguenza naturale di una serie di
fattori scaturiti dall’andamento della
guerra, primo tra tutti l’avanzata
dell’Armata Rossa.
L’idea della «spartizione» ebbe
due origini principali: il generale De
Gaulle e, negli USA, il partito repubblicano. De Gaulle, che sentì il suo
mancato invito a Jalta, in qualità di
rappresentante della Francia grande
potenza vincitrice, come un affronto
personale, utilizzò Jalta come la
prova che i tre grandi avevano agito
alle spalle dei popoli europei, quello
10
francese - naturalmente - in primis.
Altrettanto fecero i repubblicani
statunitensi contro i seguaci di Roosevelt: pur essendo ormai vicino
alla fine, il presidente avrebbe voluto affrontare la prova di un quarto
mandato, col risultato di presenziare
al vertice senza la forza di opporsi
a Stalin. Sul «tradimento di Jalta»
i repubblicani basarono gran parte
della loro polemica contro il partito
democratico negli anni Cinquanta.
Comunque non si sbaglia poi di molto, facendo le debite precisa­zioni,
dicendo che fu nelle ultime due
conferenze interalleate di Jalta e di
Potsdam che iniziarono a delinearsi i
conflitti tra occidentali e sovietici che
portarono negli anni successivi alla
vera spartizione dell’Europa.
L’ultimo dei vertici interalleati fu
la conferenza di Potsdam, tenutasi
dal 17 luglio al 2 agosto 1945 (7). Vi
fu un significativo rima­neg­giamento
dei rappresentanti di Stati Uniti e
Gran Bretagna: morto Roosevelt il
12 aprile, il presidente americano era
adesso Harry S. Truman, coadiuvato
dal segretario di Stato James F. Byrnes; in quanto alla Gran Bretagna,
dopo la sconfitta elettorale di Churchill che portò alle sue dimissioni
il 26 giugno, era rappresentata dal
primo ministro Cle­ment Attlee e dal
ministro degli esteri Ernest Bevin.
Unico elemento di continuità con
Jalta la granitica presenza di Stalin e
del suo ministro degli esteri Molotov.
L’ordine del giorno della conferenza
comprendeva la ridiscussione delle
frontiere europee, l’ammontare delle riparazioni per i danni di guerra,
la gestione e il governo del territorio
tedesco e la conduzione della guerra
nel Pacifico, dove i giapponesi non
avevano ancora alcuna intenzione di
deporre le armi. A Potsdam furono
definite le zone di occupazione della
Germania, e fu deciso di dividere in
zone anche la città di Berlino.
Le decisioni prese nel corso della
conferenza di Potsdam dettero luogo
alla «Dichiarazione di Potsdam».
Furono stabiliti i confini tra Polonia e
Germania sulla linea Oder-Neisse e
fu deciso che tutta la popolazione tedesca presente nel territorio divenuto polacco, cecoslovacco e ungherese
doveva essere espulsa e assorbita in
Germania. La Germania fu suddivisa
in quattro zone di occupazione amministrate dalle potenze vincitrici.
Non vi fu accordo sull’ammontare
dei risarcimenti, mentre le potenze
occidentali perseguivano una linea
più morbida Stalin insistette per dei
risarcimenti molto elevati. Per questo motivo fu deciso che all’interno
della propria zona di occupazione
ogni potenza avrebbe gestito entità
e tipologia di risarcimento in modo
autonomo. Harry S. Truman, forte
del successo del primo esperimento
atomico ad Alamo­gordo, lanciò un
ultimatum al Giappone che se non si
fosse arreso non avrebbe evitato una
«immediata e completa distruzione».
La bomba atomica
L’idea che una reazione a catena
nucleare si potesse produrre artificialmente fu sviluppata nella seconda metà degli anni trenta in seguito
alle scoperte di Lise Meitner e di
Otto Hahn. Un gruppo di scienziati
europei rifugiatisi negli Stati Uniti
a seguito delle persecuzioni razziali
(Enrico Fermi, Leo Szilard, Edward
Teller ed Eugene Wigner) si preoccuparono del possibile utilizzo militare
della scoperta fatta dai due scienziati
tedeschi. Nell’ottobre 1939 Fermi e
Szilard convinsero Albert Einstein
a scrivere una lettera al presidente
Roosevelt per fargli presente il
pericolo che i tedeschi potessero
costruire una «bomba all’uranio».
Roosevelt ne fu colpito e nacque
così il «Progetto Manhattan» (8).
Nel dicembre 1942 a Chicago Enrico
Fermi e collaboratori riuscirono ad
assemblare la prima «pila atomica»,
ossia il primo reattore nucleare a
fissione. A quel punto era stata provata la fattibilità di un’arma atomica,
e il «Progetto Manhattan» entrò
nella fase di industrializzazione, che
richiese enormi risorse finanziarie.
Nato come semplice programma di
ricerca, il progetto Manhattan mutò
nel 1942 i suoi obiettivi e crebbe fino
a occupare più di 130.000 persone e
costando alla fine oltre 2 miliardi di
dollari dell’epoca (corrispondenti a
28 miliardi di dollari del 2008). Ad
Hanford (stato di Washington), Oak
Ridge (Tennessee) e Los Alamos
(New Mexico) furono costruiti giganteschi impianti per la produzione
dei materiali fissili necessari, e sotto
la direzione scientifica di Robert Oppenheimer dopo tre anni di intenso
e segretissimo lavoro la bomba vide
la luce.
Il 16 luglio 1945, durante il cosiddetto «Trinity test», ad Alamogordo
(New Mexico) esplose la prima bomba atomica. L’annuncio della riuscita
dell’esperimento Trinity fu dato al
presidente Truman mentre questi
era impegnato nella conferenza di
Potsdam. Truman cercò di sfruttare
politicamente la cosa, accennando a
Stalin della bomba per intimorirlo;
ma questi non fece una piega. Infatti era già al corrente dell’ordigno
americano, e i fisici sovietici erano
già da qualche tempo al lavoro per
produrre una loro arma nucleare.
Gli americani erano invece convinti
che sarebbero passati parecchi anni
prima che i russi potessero avere «la
bomba».
Il 26 luglio 1945 la Dichiarazione
di Potsdama aveva stabilito i termini
per la resa giapponese. Il giorno
seguente, i giornali giapponesi riportarono la dichiarazione, il cui testo
venne diffuso anche radiofonica­
mente in tutto il Giappone, ma il
governo militare la respinse. Il segreto della bomba atomica era ancora
custodito, e la sua esistenza non
venne minimamente accennata nella
dichiarazione. Truman affermò che
se i giapponesi non si arrendevano,
sarebbero stati totalmente distrutti, ma si guardò bene dal rendere
pubblica l’esistenza della bomba
atomica. Il governo giapponese non
prese nemmeno in considerazione
l’avvertimento (9).
I fatti che seguirono sono tristemente noti: la mattina del 6 agosto
1945, una bomba atomica fu sganciata su Hiroshima (10); il 9 agosto,
un’altra bomba fu sganciata su Nagasaki. Il giorno prima l’8 agosto, i
sovietici attaccarono i giapponesi in
Manciuria, per evitare che lo sgancio
delle atomiche li privasse dei vantaggi loro promessi a Potsdam in cambio
dell’intervento.
Un gesto così distruttivo, così
Nagasaki, 9 agosto 1945. Il caratteristico “fungo” originato nell’atmosfera dallo
scoppio della bomba atomica.
gravido di implicazioni militari,
politiche e morali, non poteva non
essere oggetto al tempo di feroci polemiche, e in seguito di interminabili
dibattiti fra gli storici.
La tesi “ufficiale” statunitense
è che i bombardamenti atomici
abbiano costretto i giapponesi ad
arrendersi, risparmiando così la vita
a milioni di persone, sia americani
che giapponesi. Le forze armate
USA avevano preparato per l’invasione del Giappone l’«operazione
Down­f all», divisa in due grandi
sbarchi, «Olympic» e «Coronet»,
che avrebbero dovuto svolgersi rispettivamente nel novembre 1945
sull’isola di Kyushu e nella primavera
1946 sull’isola di Honshu, mentre
l’esercito sovietico avrebbe invaso
l’isola settentrionale di Hokkaido.
La guerra si sarebbe certamente prolungata almeno fino alla fine del 1946
(11) e gli strateghi americani prevedevano perdite computabili a circa
un milione di militari alleati e a una
cifra almeno dieci volte superiore tra
militari e civili giapponesi. Questa
ipotesi non era poi così peregrina,
dato che si venne a sapere poi che le
autorità militari nipponiche stavano
effettivamente preparando un piano
di resistenza all’invasore che avrebbe
mobilitato l’intera popolazione, e
prevedevano di utilizzare nella resistenza enormi masse di kamikaze.
Nonostante le due bombe atomiche
e l’attacco sovietico, ci volle tutta
l’autorità dell’imperatore Hiro Hito
per far accettare ai militari nazionalisti la resa, e vi fu da parte di questi
ultimi perfino un tentativo di colpo
11
di stato per impedire la richiesta di
armistizio. Esistono d’altra parte
inchieste e documenti che farebbero
supporre l’esatto contrario, cioè che
sarebbero bastati ancora pochi mesi
di bombardamenti convenzionali
e di blocco navale per far cadere il
Giappone (12). In ogni caso, non
si può certo tornare indietro per
vedere come sarebbe andata a finire
senza Hiro­shima e Nagasaki, per
cui tutto rimane, e rimarrà sempre,
nell’ambito delle pure speculazioni.
L’America era rimasta sgomenta
dalle perdite dei marines avvenute durante gli sbarchi a Iwo Jima
e Okinawa. Una carneficina per
ridurre alla ragione un nemico già
virtualmente sconfitto, che continuava a combattere solo per fanatismo,
era qualcosa che nessun americano
voleva, la guerra era stata già abbastanza lunga, tragica e costosa: se i
giapponesi volevano farsi ammazzare tutti, padronissimi di farlo, ma
non una goccia di sangue americano
in più doveva essere versata. Questo
in quei giorni era il clima psicologico
nel governo di Truman e nell’opinione pubblica americana.
Ciò non toglie che il bombardamento atomico del Giappone
rispondeva anche ad altre logiche,
che riguardavano non la guerra che
stava per concludersi, ma ciò che
sarebbe successo dopo. Una prima
preoccupazione era quella di dimostrare al mondo intero il potere
distruttivo del nuovo ordigno, allora
di esclusiva proprietà degli Stati
Uniti, che avrebbero mostrato così
il loro nuovo status di “superpotenza”, e nessuno avrebbe più potuto
contestare la leadership globale americana: ogni riferimento all’Unione
Sovietica è qui tutto fuorché casuale.
Per questo fu deciso a tavolino di non
utilizzare la bomba su un obiettivo
esclusivamente militare, e meno
che meno su un’area deserta a solo
scopo dimostrativo, come proposto
da alcuni scienziati: essa doveva
essere utilizzata contro una zona
urbana, e a tale scopo Hiroshima
fu deliberatamente risparmiata dai
bombardamenti convenzionali che
devastavano le altre città giapponesi.
È difficile non considerare i bom12
bardamenti terroristici delle città
tedesche e giapponesi come «crimini
contro l’umanità», soprattutto se si
pensa che non avevano alcuna giustificazione di carattere militare (13).
Un’altra preoccupazione, per
quanto aberrante possa sembrare,
era di carattere più “tecnico”: i
militari americani volevano studiare
gli effetti della bomba per capirne le
modalità d’uso. A questo scopo per
esempio erano aggregati all’aereo
con la bomba altri due apparecchi,
uno per ricognizione meteorologica
e un altro letteralmente stipato di
macchine fotografiche e di strumenti
scientifici.
In questo senso, Hiroshima può
essere considerata senza dubbio sia
come l’ultimo atto della seconda
guerra mondiale, sia come il prologo
della guerra fredda.
Nel secondo dopoguerra l’arma
atomica entrò nell’arsenale tutte le
principali potenze mondiali. L’Unione Sovietica recuperò abbastanza
rapidamente il ritardo e sperimentò la prima bomba a fissione il 29
settembre 1949, ponendo così fine
al monopolio degli Stati Uniti. Il
Regno Unito vi arrivò nel nel 1952,
dopo che gli Stati Uniti, nonostante
la partecipazione britannica al «progetto Manhattan», si rifiutarono di
condividere con i “cugini” i segreti
della bomba; la Francia nel 1960; la
Cina nel 1964.
Dalla “guerra calda” alla “guerra
fredda”: 1945-1949
Il destino finale della Germania
dette luogo a varie discussioni tra
gli alleati. A guerra non ancora conclusa era stato preso seriamente in
considerazione il «piano di pastora­
lizzazione» di Henry Morgenthau,
Jr., segretario del Ministero del
Tesoro degli Stati Uniti. La Germania doveva essere divisa in due stati
indipendenti, uno per la Germania
settentrionale e uno per la Baviera
e land limitrofi; i principali centri
industriali ed estrattivi tedeschi,
cioè le zone della Saar, della Ruhr e
della Slesia dovevano essere interna­
zionalizzati o annessi dalle nazioni
vicine; tutta l’industria pesante
doveva essere smantellata. Al se-
condo Convegno del Quebec, il 16
settembre 1944, il presidente statunitense Roosevelt e Morgenthau stesso
persuasero il Primo Ministro britannico Winston Churchill, inizialmente
molto riluttante, ad acconsentire al
programma. Il piano era talmente
punitivo che Goebbels poté usare
il programma per sostenere la resistenza tedesca sul fronte occidentale
(14). Il dibattito sul destino della
Germania dopo la cessazione delle
ostilità dipendeva in larga parte dalle
interpretazioni sulle conseguenze
del trattato di Versailles che aveva
concluso la prima guerra mondiale. L’interpretazione d’ispirazione
keynesia­na (The economic consequences of the peace), faceva notare
come le pesanti riparazioni di guerra
avesser impedito la ripresa economica tedesca e costituito dunque uno
degli elementi basilari del revanscismo tedesco. Altre interpretazioni,
come quella di Morgenthau, erano
incentrate sulla natura “bellicosa”
dello stato prussiano. Il Piano Mor­
genthau, condiviso da Roose­velt,
venne accantonato da Truman. Dopo
la resa incondizionata del Terzo
Reich l’8 maggio 1945 e l’arresto
dei leader del governo Dönitz e von
Krosigk avvenuto il 23 maggio da
parte dell’esercito inglese, le potenze
alleate azzerarono lo stato tedesco
prendendo a carico direttamente
l’amministrazione del paese, così
come deciso nell’accordo inter­
alleato firmato a Berlino il 5 Giugno
1945, detto Dichiarazione Comune
riguardo alla Sconfitta della Germania (o «Dichiarazione del 1945»). La
Germania fu divisa in quattro zone
di occupazione, così come era stato
deciso a Jalta. La linea Oder-Neisse
diventava il nuovo confine con la
Polonia. Germania e Austria non
esistevano più come entità statali
indipendenti (15). Per la Germania
il 1945 fu l’«anno zero».
In origine, la Francia, anche se
facente parte delle potenze alleate, non doveva avere una zona di
occupazione, a causa sia della sua
storica ostilità con la Germania,
sia del ruolo minimo giocato dalla
Francia durante la guerra. A Jalta
però sia gli inglesi che gli americani
si accordarono per concedere una
parte delle loro porzioni ai francesi.
La città di Berlino fu occupata da
tutte e quattro potenze alleate e fu
suddivisa pertanto in quattro settori.
Ogni potenza possedeva l’autorità di
governo della propria zona, ma per
coordinare le attività delle quattro
potenze occupanti fu istituito un
«Consiglio di Controllo».
Nel giro di due anni furono liquidati gli ultimi strascichi del conflitto
appena concluso. Nel 1946 fu celebrato il processo di Norimberga ai
criminali nazisti. Nello stesso anno
si aprì a Parigi la «Conferenza dei
Ventuno» che si concluse l’anno
dopo con la firma dei trattati di pace
riguardanti gli alleati della Germania, tra cui l’Italia. La visione roose­
veltiana non vi ebbe alcuna parte: il
risultato della pace fu una riedizione
della politica delle annessioni che
aveva caratterizzato trent’anni prima
il trattato di Versailles che chiuse la
prima guerra mondiale. La parte
del leone, nelle annessioni, la ebbe
ovviamente l’Unione Sovietica, che,
Polonia e Finlandia a parte, tornò
grosso modo ai confini dell’impero
zarista. Il drastico spostamento
dei confini ad occidente di Unione
Sovietica e Polonia portarono a un
grande e doloroso esodo verso ovest
di tedeschi e polacchi.
Il rapidissimo deterioramento
dei rapporti tra alleati occidentali
ed Unione Sovietica impedì che al
trattato di Parigi seguissero regolari
trattati di pace con le due grandi
potenze sconfitte, la Germania e il
Giappone. Già a partire dal 1946
infatti iniziarono le prime crisi
legate alla formazione delle sfere
d’influenza occidentale e sovietica.
Cercando di capitalizzare al massimo
la presenza dell’Armata Rossa nei
vari territori occupati, Stalin cercò
di prolungare l’occupazione dell’Iran
settentrionale. Fin dal 1942 gli alleati
avevano messo piede militarmente in
questo stato mediorientale a causa
della sua importanza strategica, non
solo per il petrolio, ma soprattutto
perché garantiva una sicura via di
comunicazione tra le colonie inglesi
e l’URSS. La zona sovietica dell’Iran
fu isolata dal resto del paese, la
Il tracciato della “Cortina di ferro” che divideva i paesi della Nato da quelli
del Patto di Varsavia.
popolazione curda fu istigata alla
rivolta, e fu instaurato un governo
comunista della minoranza azera.
Nel gennaio 1946 Teheran chiese un
intervento del Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite, ma l’URSS pose
il veto, anzi spostò i propri soldati
fino alle porte della capitale. A quel
punto gli Stati Uniti iniziarono a
fornire all’Iran aiuti economici e
militari. Ai sovietici non rimase altro
che ritirarsi protestando.
Inoltre, Stalin iniziò a pretendere
dalla Turchia non solo una presenza
nel Bosforo e nei Dardanelli, ma
anche la restituzione della regione
di Kars, conquistata dagli ottomani
nel 1917 e rimasta alla Turchia dopo
la rivoluzione d’ottobre. Il dittatore
sovietico ordinò l’ammassamento di
truppe alla frontiera turca. Gli Stati
Uniti allora, con la scusa di riportare
in patria la salma dell’ambasciatore
turco, morto a Washington, inviarono nel Mar Nero una corazzata. Il
messaggio fu recepito, e Kars rimase
in territorio turco.
Le mire sovietiche verso la Turchia e l’Iran erano totalmente ingiu­
stificate da un punto di vista diplomatico, perché la Turchia era rimasta
neutrale per tutta la guerra, e l’Iran
non aveva mai parteggiato per l’As-
se, come invece aveva fatto l’Irak nel
1941. Queste rivendicazioni rispondevano invece non solo al disegno
staliniano di ritorno alle frontiere
dell’impero zarista, oltretutto forse
con un tratto di rivincita personale
vista l’origine georgiana di Stalin, ma
erano la prosecuzione tale e quale
delle vecchie direttrici dell’espansionismo russo nell’Ottocento. Così
come in Iran, i sovietici tentarono di
fare in Manciuria, da loro occupata
nei pochi giorni di guerra contro
il Giappone. Anche la Manciuria
era una vecchia gloria della politica
estera degli zar.
Winston Churchill, in un discorso
all’università di Fulton (Missouri,
USA), il 5 marzo 1946, commentò il
deterioramento dei rapporti tra gli
ex-alleati con la sua famosa affermazione: «Da Stettino nel Baltico a
Trieste nell’Adriatico una cortina di
ferro è scesa attraverso il continente» (16).
Il nuovo presidente americano,
Truman, non aveva la passione di
Roosevelt per la politica estera, ed
odiava i bizantinismi diplomatici.
Anticomunista fino al midollo osseo,
si convinse fin da subito che occorreva adottare con i sovietici la «linea
dura»: famosa la sua frase «la forza
13
è l’unica cosa che i russi capiscono
[…]. I russi si stavano preparando a
conquistare il mondo» (17). La prima
parte della frase è sacrosanta: l’unica
cosa che Stalin considerasse, nella
sua assoluta mancanza di scrupoli,
erano i rapporti di forza (famosa la
sua battutaccia su Pio XII: «Il papa!
Quante divisioni ha?»). Non aveva
invece alcun senso la seconda: al
di là delle teorie propagandistiche
dell’ideologia marxista-lenini­s ta,
l’Unione Sovietica non aveva alcuna
intenzione di conquistare il mondo, soprattutto alla fine degli anni
Quaranta; le occorreranno ancora
almeno dieci anni prima di proporsi
in modo credibile come potenza
globale. La paura del comunismo
era piuttosto un argomento della
polemica politica dei repubblicani
americani ad esclusivo uso interno.
Truman invece, nel suo rozzo ma sicuro istinto politico, aveva compreso
benissimo la natura della politica
estera sovietica quando disse: «non
ci sarà nessuno scontro tra noi e loro,
ma i sovietici sono duri negoziatori
e sono capaci di chiedere il mondo
intero per accontentarsi poi di un
acro di terra» (18).
Nel 1947 così il presidente americano, ormai convinto della disonestà
dei sovietici e perciò dell’impossibilità di risolvere gli attriti con loro
tramite trattative diplomatiche,
enunciò quella che sarebbe diventata la «Dottrina Truman»: gli
Stati Uniti avrebbero appoggiato
qualsiasi popolo «minacciato» dalla
sovversione interna o dalle ingerenze di potenze straniere. Tradotto in
termini concreti, significava che gli
USA si sarebbero opposti a qualsiasi tentativo da parte dell’URSS
di estendere il proprio dominio su
altri stati, oppure da parte dei partiti
comunisti di prendere il potere con
le armi. In quegli anni la situazione
era particolarmente grave in Grecia,
dove infuriava la guerra civile tra
l’esercito regolare monarchico e i
partigiani comunisti, che già durante
la guerra erano stati combattuti dai
soldati inglesi. Stalin però non fece
nulla per loro: la Grecia apparteneva
alla sfera d’influenza occidentale, e il
dittatore sovietico, pur arrogandosi
14
il diritto di avere le mani libere in
Europa orientale, non aveva alcuna
intenzione di rischiare una nuova
guerra con azzardate politiche
espansionistiche. Chi appoggiava
attivamente i comunisti greci, nel
quadro di un suo piano per fare della
Jugoslavia la potenza egemone nei
Balcani, era il maresciallo Tito.
Ma allora, perché l’Occidente
percepiva l’URSS come una potenza
aggressiva che aveva intenzione di
assoggettare a sé l’intera Europa?
Stalin in soldoni faceva questo
discorso: io non andrò oltre la cortina di ferro, ma tutto ciò che faccio
dietro la cortina di ferro sono solo
affari miei. Il fatto era che quell’invisibile ma ben concreto confine
non era riconosciuto dalle potenze
occidentali; era invece un dato di
fatto, originato dal limite dell’avanzata sovietica durante la guerra e
dalla spartizione della Germania
fatta a Jalta. Gli occidentali basavano invece le proprie rivendicazioni
sostanzialmente sull’«accordo delle
percentuali» tra Churchill e Stalin.
Al di là delle dichiarazioni di principio, nessuno ad occidente obiettava
sull’influenza sovietica in Polonia,
Romania e Bulgaria; ma non era
affatto scontato per gli occidentali
che in Cecoslovacchia, in Jugoslavia
e in Germania orientale dovessero
sorgere dei regimi comunisti. La
repentina sovietizzazione dell’Europa orientale fu dunque percepita
all’ovest come la prova di un disegno
espansionistico globale che avrebbe
portato il comunismo in tutto il
continente.
A sostegno di questa tesi arrivò
la costituzione, nell’ottobre 1947,
del «Cominform», l’organizzazione
internazionale dei partiti comunisti
europei, di stretta ortodossia stali­
niana e in effetti docili strumenti
degli interessi di Mosca (19). Una simile organizzazione non poteva non
apparire come una specie di «quinta
colonna» sovversiva all’interno delle
democrazie occidentali, soprattutto
in Italia e in Francia, dato che PCI e
PCF erano gli unici appartenenti al
«Cominform» che non provenissero
da paesi già nell’orbita sovietica (20).
In verità, Stalin nei partiti comunisti
occidentali appoggiò l’ala moderata favorevole all’inserimento nei
sistemi democratico-parlamentari,
piuttosto che gli estremisti che volevano trasformare, senza soluzione di
continuità, l’esperienza resistenziale
della guerra in rivoluzione proletaria. Per Stalin, i comunisti occidentali
dovevano rafforzare la loro presenza
nelle istituzioni parlamentari e nella
società civile, in attesa che l’inevitabile crisi dei regimi capitalisti
aprisse la strada alla «dittatura del
proletariato».
Il collegamento sempre più stretto tra diffusione del comunismo e
tendenze egemoniche della Russia
spiega da un lato l’intreccio di motivi
ideologici e di politica di potenza
nella strategia sovietica, e, dall’altro
lato, il progressivo manifestarsi negli
stessi partiti comunisti di tendenze
autonomistiche non disposte ad
accettare supinamente qualsiasi
direttiva di Stalin. Fu questo il caso
soprattutto della Jugoslavia di Tito.
Il progressivo aggravarsi delle
tensioni con l’occidente portò ad
una nuova mobilitazione militare.
L’Armata Rossa, che era passata
nell’immediato dopoguerra da 11 a
meno di 3 milioni di uomini, risalì
a più di 5 milioni. Al monopolio
atomico americano i russi risposero
quindi con la superiorità nelle armi
convenzionali. Questo riarmo fece
continuare quello che era il maggior
squilibrio dell’economia sovietica,
ossia la sproporzione tra l’industria
pesante e l’industria leggera.
Nella prima metà del 1947, mentre i sovietici paventavano il rischio
di un accerchiamento ostile, gli americani erigevano a pericolo centrale
del dopoguerra quello di un’espansione dell’influenza sovietica, e si
risolvevano a contrastarla con una
ferma strategia di «containment»,
di «contenimento». Fu proprio il
1947 l’anno in cui il termine «guerra
fredda» fu introdotto dal consigliere
presidenziale Bernard Baruch e dal
giornalista Walter Lippmann, per
richiamare l’attenzione sui rischi
della nuova dottrina statunitense del
«containment»: uno stato di tensione
permanente tra Usa e Urss basato
sul rifiuto di riconoscere la legitti-
mita dell’avversario e negoziare le
divergenze di interessi per via diplomatica. Risulta oggi poco credibile
l’idea che i sovietici, intransigenti ma
anche assai cauti, perseguissero un
deliberato progetto di espansione.
Ma i dirigenti americani contemplavano preoccupati l’accavallarsi di
numerosi punti di crisi e instabilità,
che essi temevano offrissero grandi
opportunita potenziali per la diplomazia sovietica.
Dopo il 1945 l’URSS decisse, per
dare il via alla ricostruzione, fare
affidamento solo alle proprie limitate risorse interne. Anche se questa
decisione portava alla rinuncia agli
aiuti occidentali, che avrebbero indubbiamente accelerato i tempi e le
dimensioni della ripresa economica,
d’altra parte garantiva a Stalin la
completa libertà di perseguire i propri obiettivi di politica internazionale, senza temere eventuali ritorsioni
commerciali. Stalin, la cui condotta
fu sempre assolutamente priva di
scrupoli, per reperire risorse ricorse
in modo vessatorio alle riparazioni
per danni di guerra imposte agli stati
sconfitti, soprattutto ai danni della
Germania Est, che fu spogliata di
quasi tutto il proprio apparato industriale. Inutile dire che gli investimenti necessari furono trovati anche
mantenendo la popolazione ad uno
stato di mera sussistenza ed utilizzando - così come avevano fatto i nazisti
- la manodopera gratuita fornita dai
prigionieri di guerra e dai detenuti
politici. Nel 1949 i legami economici
tra l’URSS e le nuove «democrazie
popolari» furono for­ma­lizzati con
la creazione del «Co­mecon», una
specie di mercato comune per mezzo
del quale l’Unione Sovietica mirava
a organizzare lo spazio economico
e geografico che la circondava in
relazione ai propri interessi.
In occidente invece il problema
della ricostruzione fu affrontato in
modo ben più costruttivo, anche se
sempre in subordine agli interessi
economici e commerciali statunitensi. Il generale George Marshall, ex
capo di stato maggiore dell’esercito
americano durante la guerra, ed ora
segretario di stato di Truman (21),
in un discorso fatto il 5 giugno 1947
Aiuti dell’UNRRA per l’Italia.
all’Università di Harvard annunciò
l’avvio dell’«European Recovery
Program» (ERP), noto a tutti da
allora come «Piano Marshall». Mar­
shall affermò che l’Europa avrebbe
avuto bisogno di ingenti aiuti da parte statunitense per la ricostruzione
e che, senza di essi, gran parte del
continente sarebbe stato esposto al
pericolo di un grave deterioramento
delle condizioni politiche, economiche e sociali. Gli Stati Uniti si
trovavano perciò davanti ad un’altra
grande missione: sostenere, favorendo la ripresa economica postbellica,
l’economia di mercato in Europa.
I primi aiuti all’Europa sconvolta
dalla guerra furono gestiti dalla
«United Nations Relief and Reha­
bilitation Administration» (UNR­
RA), costituita a Washington il 9
novembre 1943. Si trattava di una
organizzazione umanitaria internazionale, fondata con l’accordo di
quarantaquattro paesi allo scopo di
fornire aiuto e assistenza immediati
ai paesi più colpiti dal conflitto.
L’UNRRA cominciò a operare in
Europa già nel 1944, al seguito
dell’avanzata alleata nel Mediterraneo. L’azione dell’UNRRA si concentrò soprattutto nei Paesi europei
(Polonia, Grecia, Albania e Italia)
e in Cina.
Il periodo più intenso dell’attività
UNRRA fu dal 1944 al 1946, quando vennero spesi quattro miliardi e
mezzo di dollari in aiuti, forniti per
lo più dagli Stati Uniti d’America.
Gli aiuti comprendevano soprattutto
generi di prima necessità quali viveri,
medicinali, vaccini e forniture mediche, la distribuzione di vestiario e
l’assegnazione di sementi, concimi e
macchinari per permettere la ripresa
della produzione agricola, nonché
di materie prime e beni strumentali
per aiutare le industrie locali a riorganizzare la loro attività. Lo sforzo
profuso dall’UNRRA fu comunque
orientato, in generale, verso le fasce
di cittadini più indigenti e verso i
bambini. L’UNRRA cessò di esistere
nel 1947; i progetti rimasti in sospeso
vennero ereditati dall’Organizzazione internazionale per i rifugiati,
dall’Organizzazione mondiale per
la sanità e dal Fondo internazionale
d’emergenza delle Nazioni Unite per
l’infanzia (che diventerà in seguito
il Fondo delle Nazioni unite per
l’Infanzia – UNICEF).
Nei tre paesi occupati - Germania,
Austria e Giappone – furono invece
attivi gli aiuti del programma GARIOA («Government Aid and Relief
in Occupied Areas», ossia Aiuti e
Soccorsi Governativi nelle Aree
15
Occupate) dal 1946 a circa il 1950.
Gli aiuti consistevano soprattutto
in viveri per fronteggiare la grave
situazione alimentare venutasi a
creare nei paesi sconfitti.
Passate le prime emergenze, i pianificatori del Dipartimento di Stato
americano, fra tutti William Clayton
e George F. Kennan (l’ideatore
della teoria del «containment» nei
confronti dei comunisti), si resero
conto che l’Europa necessitava,
per rimanere aperta alle istanze
commerciali americane, di un programma di sostegno economico
che non fosse affatto contingente
e disorganico come quelli attuati
fino allora: il nuovo piano Marshall,
per Clayton e Kennan, doveva assumere un carattere il più omogeneo
possibile, in modo da perseguire
quattro grandi obiettivi: 1) fornire
i capitali e le materie prime necessarie ad alimentare la ripresa delle
economie europee; 2) accrescere di
conseguenza i livelli di produttività,
di reddito e di occupazione; 3) integrare l’economia tedesca in un’area
di scambi europea; 4) determinare
una duratura interdipendenza dei
mercati mondiali, in primo luogo di
quelli euro-americani. Questi obiettivi non erano altro che l’altra faccia
della strategia del «containment»: il
consolidamento di una robusta crescita economica avrebbe stabilizzato
le nazioni europee, rafforzando il
consenso sociale e marginalizzando
le opposizioni comuniste, cosi da
contrapporre all’Urss la solidità di
un’Europa prospera e fiduciosa della
leadership statunitense.
L’idea di Marshall, che era stata
comunque già sostanzialmente
comunicata agli inglesi, venne positivamente accolta dalla Francia che
però chiese di estendere gli incontri
preparatori anche all’Unione Sovietica. Così, dopo un primo incontro
tra il ministro degli Esteri britannico
Ernest Bevin e quello francese Georges Bidault, alla metà di giugno,
su iniziativa di quest’ultimo si decise
di convocare una conferenza a tre a
Parigi (che si svolse tra il 27 giugno
e il 2 luglio 1947), invitando il commissario agli Esteri sovietico Molo­
tov. Questi, dopo giorni cui alternò
16
collaborazione e ostilità, abbandonò
i lavori accusando gli anglo-francesi
divoler avallare un piano statunitense per dividere l’Europa in due,
non avendo essi accettato la sua
idea di presentare piani particolareggiati per ciascun Paese anziché
un programma unico. L’URSS di
conseguenza, dopo un’iniziale manifestazione di interesse, si rifiutò di
partecipare al negoziato, obbligando
anche tutti i Paesi della sua zona
d’influenza a fare altrettanto.
Il 12 luglio 1947 si aprì a Parigi
una conferenza di tutti i paesi europei (eccetto Spagna e URSS),
indetta da Francia e Gran Bretagna
con l’assenso degli Stati Uniti, per
predisporre un piano complessivo
di aiuti da presentare a Washington.
Nessun paese dell’Europa orientale
partecipò alla conferenza, dopo che
al Governo cecoslovacco - che in un
primo momento aveva accettato di
presenziare - fu imposto senza mezzi
termini da Stalin di ritirarsi. Anche
Polonia e Jugoslavia, che avevano
espresso una certa disponibilità in
merito, vennero meno. La Finlandia,
pur in assenza di una chiara richiesta
sovietica, decise di non partecipare
non volendo indispettire Mosca.
Nella Conferenza, che proseguì
fino a settembre, emersero posizioni
molto distanti dato che, paradossalmente proprio come aveva chiesto
Molotov, ogni Paese chiese per sé
dei piani particolareggiati, in virtù
delle esigenze nazionali. Inoltre,
emersero forti divergenze anche tra
i paesi occidentali: la Francia chiese
esplicitamente che la Germania
venisse esclusa dagli aiuti, mentre
i paesi del Benelux si espressero in
modo diametralmente opposto; la
Gran Bretagna cercò di far valere
il suo “statuto speciale” di alleato
privilegiato degli USA; i paesi scandinavi chiesero che fosse garantita
la loro neutralità. Il rappresentante
degli Stati Uniti, Clayton, insistette
invece sulla presentazione di un piano complessivo, dove fosse promossa
l’integrazione economica e commerciale europea. Alla fine venne
raggiunto un accordo, per il quale,
pur tenendo presenti le esigenze
nazionali, si decise di presentare
al Governo statunitense un unico
programma di richieste. Truman
firmò il 3 aprile 1948 il decreto che
istituiva ufficialmente l’Economic
Cooperation Administration, incaricata di gestire la predisposizione
degli aiuti negli Stati Uniti, e l’Euro­
pean Recovery Program, organismo
atto ad applicare concretamente in
Europa gli stanziamenti previsti in
base alle richieste dei singoli Paesi.
A questo traguardo si giunse dopo
un serrato e complesso dibattito in
seno al Congresso, dove la fazione
isolazionista dei Repubblicani si
oppose al Programma.
I paesi che usufruirono del piano
Marshall in Europa furono: Austria, Belgio, Danimarca, Francia,
Germania Federale (ammessa dopo
la sua costituzione nel settembre
1949), Grecia, Islanda, Irlanda,
Italia (compresa la «zona libera» di
Trieste), Lussemburgo, Paesi Bassi,
Norvegia, Portogallo, Regno Unito,
Svizzera, Svezia, Turchia (22). Alcuni
di questi paesi non avevano partecipato alla seconda guerra mondiale
e perciò non avevano problemi di
“ricostruzione”, ma era opportuno
che rientrassero nella nuova sfera
economica dell’Europa occidentale. Con l’obiettivo di favorire una
prima integrazione economica nel
Continente, nacque contestualmente
all’ERP anche la OEEC - Organisation for European Economic
Cooperation (in italiano OECE),
organismo sostanzialmente tecnico
in cui i programmatori inviati da
Washington cercarono di spingere
gli europei ad utilizzare gli aiuti non
per fronteggiare le contingenze del
momento quanto piuttosto per avviare un processo di trasformazione
strutturale dell’economia dei loro
Paesi. L’O­EEC, nata per coordinare
gli aiuti del piano Marshall segnò
l’inizio dell’integrazione europea.
Ma, contrariamente a quanto
auspicato, pur non opponendosi alla
stabilizzazione delle loro valute e
all’ordine del commercio internazionale voluto dagli Stati Uniti, la quasi
totalità dei Paesi beneficiari chiese
alla Economic Cooperation Ad­mi­
nistration (ECA), l’ufficio preposto
alla collazione degli aiuti, di poter
utilizzare i finanziamenti forniti
dall’ERP per l’acquisto di generi di
prima necessità, prodotti industriali,
combustibile e, solo in minima parte,
macchinari e mezzi di produzione.
Nello stesso tempo diverse centinaia
di consiglieri economici statunitensi
furono inviati in Europa, mentre fu
consentito a studiosi ed esperti europei di visitare impianti industriali
e di frequentare corsi d’istruzione
negli Stati Uniti.
Il piano Marshall poneva grossi
problemi di politica internazionale,
tra cui il principale era lo status
politico della Germania, alla quale
gli aiuti del piano Marshall arrivavano solo nella parte occidentale.
Il progetto originario degli Alleati
per governare la Germania come
singola unità attraverso il Consiglio
di Controllo ben presto si era rivelato inattuabile: la distanza tra le
posizioni degli alleati occidentali da
una parte e dei sovietici dall’altra
aumentava ogni giorno di più. A
quel punto gli Stati Uniti, nel 1947,
decisero di cambiare politica: non
più una lenta e incerta trattativa
con i sovietici per mantenere unito il
paese, ma invece una rapida rinascita
economica e politica della Germania sotto il controllo degli alleati
occidentali, sacrificando la zona di
occupazione sovietica, che d’altra
parte era sotto il diretto - e ormai
permanente - controllo di Mosca.
Meglio insomma una Germania
Ovest economicamente forte e parte
stabile del blocco occidentale, che
una Germania sì unita, ma debole
e politicamente incerta. Alternativa
quest’ultima che invece piaceva a
Stalin, che avrebbe sempre potuto
tentare di mettere le mani su una
Germania neutrale e smilitarizzata
attraverso l’azione politica di un
partito comunista a lui fedele. Stalin
inoltre non aveva alcun interesse ad
una rinascita economica della Germania: l’unica sua preoccupazione
era quella di poter sfruttare fino
all’osso il suo diritto alle riparazioni
di guerra, in modo da poter scaricare
sull’ex-nemico parte dei costi della
ricostruzione postbellica dell’URSS.
Il Piano terminò nel 1951, come
originariamente previsto, nonostan-
AIUTI DEL PIANO MARSHALL AI PAESI EUROPEI
(in milioni di dollari distribuiti per anni)
Austria
Belgio e Lussemburgo
Danimarca
Francia
Germania Ovest
Grecia
Islanda
Irlanda
Italia e Trieste
Paesi Bassi
Norvegia
Portogallo
Regno Unito
Svizzera
Svezia Turchia 1948/49 1949/50 1950/51 Totale
232 166 120 488
195 222 360 777
103 87 195 385
1,085 691 520 2,296
510 438 500 1,448
175 1
56 45 366
6
22 15 43
88 45 —
133
594 405
205 1,204
471 302 355 1,128
82 90 200 372
—
—
70 70
1,316 921 1,060 3,297
—
—
250 250
39 48 260 347
28 59 50 137
te i molti pareri contrari. I tentativi
di prolungarlo per qualche tempo
non ebbero effetto, non solo a causa
degli ottimi risultati conseguiti, che
fecero ritenere agli Stati Uniti di aver
raggiunto i propri scopi, ma anche
per lo scoppio della guerra di Corea
e la vittoria dei repubblicani nelle
elezioni per il Congresso dell’anno
precedente.
È scontato dire che la storiografia
d’impronta marxista, tutta incentrata
sulla categoria di “imperialismo”
attribuita esclusivamente agli Stati
Uniti, ha sempre visto nel Piano
Marshall nient’altro che uno strumento per perpetuare il dominio statunitense sull’Europa e per rendere
le economie del Continente funzio­
nali alle esigenze del sistema produttivo americano. Questa storiografia,
troppo spesso manichea, non ha mai
considerato il fatto che, anche nel
più gretto egoismo degli intenti, gli
interessi nazionali non sono sempre
in conflitto, ma in determinate circostanze possono anche convergere.
Il piano infatti consentì da una parte
agli Stati Uniti di evitare la tanto
paventata crisi di sovrapproduzione,
e dall’altro all’economia europea di
accelerare la ripresa produttiva nel
dopoguerra tanto da superare, alla
fine del Piano Marshall, l’indice di
produzione prebellico. Inoltre, cosa
da non sottovalutare, insinuò negli
europei l’idea che l’interdipendenza
poteva costituire una soluzione ai
conflitti che da sempre avevano caratterizzato la loro storia. Sul piano
interno l’aiuto statunitense consentì
alle fragili democrazie occidentali
di rilassare le politiche di austerità
e di migliorare le condizioni di vita
della popolazione, cosa di cui benefi­
cianoro i partiti politici allora al governo. E siccome l’unica alternativa a
questi era una sinistra ege­moniz­zata
da partiti comunisti fanaticamente
legati all’ortodossia stalinia­na, col
senno di poi si può ben dire, citando
Leibniz, che il Piano Mar­shall assicurò all’occidente europeo il migliore
dei mondi possibili.
Già 17 marzo 1948 Benelux, Francia e Regno Unito firmarono il Trattato di Bruxelles che creò l’Unione
dell’Europa Occidentale (UEO), ma
17
si trattava ancora di un’alleanza che
non aveva ben chiaro se il “nemico”
sarebbe stata l’Unione Sovietica o
una Germania risorta pronta per il
“terzo round”.
La tensione tra est e ovest si aggravò ulteriormente con il «blocco
di Berlino», che ebbe luogo dal 24
giugno 1948 all’11 maggio 1949, e
fu non solo la crisi più grave tra i
due ex-alleati prima della guerra
di Corea, ma anche la crisi che indusse definitivamente gli Stati Uniti
a creare un sistema di alleanze in
Europa. Per eliminare la presenza
occidentale nell’enclave di Berlino
Ovest, Stalin ordinò di bloccarne
tutti gli accessi stradali e ferroviari.
Il casus belli dell’iniziativa sovietica fu l’introduzione, il 18 giugno
1948, nei tre settori occidentali, del
marco tedesco al posto della valuta
di occupazione. Era un passo obbligato del progetto americano per la
rinascita economica della Germania
occidentale. I sovietici protestarono
e rinnovarono la loro pretesa di ottenere pagamenti dei danni di guerra
anche dai settori occidentali. Truman
rifiutò e Stalin rispose dando vita
ad un governo comunista tedesco
a Pankow, un sobborgo di Berlino,
primo atto della futura Repubblica
Democratica Tedesca.
Il 24 giugno 1948 l’URSS bloccò
gli accessi ai tre settori di Berlino
ovest, tagliando tutti i collegamenti
stradali e ferroviari che inevitabilmente attraversavano la parte di
Germania sotto controllo sovietico.
Le parti occidentali della città furono anche scollegate dalla rete elettrica, che era alimentata dal territorio
orientale. I sovietici avevano messo
Berlino ovest sotto assedio.
Gli occidentali, segnatamente
Stati Uniti e Gran Bretagna, risposero organizzando un grande “ponte
aereo”, come già avevano fatto in
diverse occasioni durante la seconda
guerra mondiale (23). Un blocco è
già di per sé un atto ostile, che in genere prelude ad uno stato di conflitto
aperto: quando iniziò il ponte aereo,
i sovietici non interferirono in alcun
modo con i voli, che si svolgevano
all’interno di corridoi aerei internazionali (24), ben sapendo che ciò
18
avrebbe significato la guerra.
Il blocco di Berlino fu un disastro
politico per Stalin e per la dirigenza
del PCUS. L’Unione Sovietica si
trovò a recitare la parte del paese
aggressore che, dopo aver scatenato
la crisi, era stato sconfitto dall’enorme potere aereo degli Stati Uniti,
che si presentavano ora al mondo
come una vera superpotenza globale, in grado di intervenire in modo
massiccio ovunque ve ne fosse stato
bisogno.
Ma il danno non fu solo di immagine. Il timore, nei governi e nell’opinione pubblica occidentale, che il
regime comunista sovietico potesse
non accontentarsi della spartizione
dell’Europa generata dalle conferenze di guerra alleate, e potesse progettare così un’espansione globale del
marxismo-leninismo attraverso una
nuova vittoriosa guerra. Maturò così
l’idea di un’alleanza internazionale
dei paesi occidentali per difendersi
contro l’aggressività sovietica.
Il trattato istitutivo della nuova alleanza occidentale (il famoso «patto
atlantico») fu firmato a Wa­shington
il 4 aprile 1949 ed entrò in vigore il
nell’agosto dello stesso anno: era
nata la «North Atlantic Treaty Organization», universalmente conosciuta col suo acronimo NATO (25).
I dodici stati membri fondatori
furono Belgio, Canada, Danimarca,
Francia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo,
Regno Unito e Stati Uniti. Il concetto alla base dell’alleanza era
quello della «difesa collettiva», che
considerava un attacco ad uno dei
fir­matari come un attacco a tutti i
paesi dell’alleanza (26).
Si ripro­poneva così, dopo pochi
anni, lo stesso contrasto geopolitico
tra una potenza continentale e una
potenza marittima: non più Germania e Gran Bretagna, ma Unione
Sovietica e Stati Uniti. La scala era
però molto più grande: non più continentale, ma mondiale.
Dopo la vicenda del blocco di
Berlino, gli alleati occidentali si
sentirono liberi da ogni remora
per quanto riguardava la divisione
della Germania. Il ,,, maggio 1949
le tre zone occidentali, già unificate
nella “Trizona”, si trasformarono
nella Repubblica Federale Tedesca.
La contromossa dei sovietici fu
l’inevitabile creazione, nell’ottobre
dello stesso anno, della Repubblica Democratica Tedesca. Ad ovest
l’occupazione continuò ufficialmente
fino al 1955, ma dopo la creazione
della repubblica federale i governatori militari furono sostituiti da
“alti commissari” civili, con funzioni
ibride tra quelle di governatore e di
ambasciatore.
Nel 1955 la repubblica federale
fu riconosciuta stato sovrano, entrò
nella NATO e partecipò assieme agli
altri paesi dell’alleanza al riarmo
finanziato dagli Stati Uniti con la
formula del «conto MAP», con la
quale in pratica gli USA affidavano
materiale bellico in comodato d’uso
ai paesi alleati. Si trattava di una
versione aggiornata della vecchia
legge «Affitti e prestiti» che aveva
permesso alla Gran Bretagna di
resistere durante i primi, critici anni
della seconda guerra mondiale.
Berlino ovest però non entrò a
far parte della Germania Federale:
rimase ufficialmente, fino al 1990,
sotto l’occupazione degli alleati
occidentali, anche se di fatto, per
scopi amministrativi, i tre settori
della città di loro pertinenza furono
riuniti in una strana entità chiamata
semplicemente «Berlino Ovest».
La sovietizzazione dell’Europa
orientale, perseguita con coerenza e
determinazione da Stalin fin dagli ultimi mesi di guerra, si compì nell’arco di circa un triennio. In tutti i paesi
interessati, i governi di coalizione
furono sostituiti appena possibile
da governi comunisti, adottando la
cosiddetta «tattica del salame»: fetta
dopo fetta, il potere veniva sempre
più concentrato nelle mani dei
partiti comunisti. La prima fase era
quella dell’assorbimento dei partiti
socialdemocratici e radicali. La seconda era l’instaurazione di governi
formalmente di coalizione, ma dove
le redini del potere, attraverso le
nomine nei ministeri chiave (interni,
giustizia, difesa), erano saldamente
in mano comunista. La terza ed
ultima fase era l’eliminazione degli
esponenti politici non comunisti,
mediante la tecnica squisitamente
staliniana del fabbricare ad arte
presunti complotti che finivano con
processi-farsa dove era già scontata
la condanna degli imputati. Il caso
che destò più scalpore nei paesi
occidentali fu il cosiddetto «colpo
di Praga» del maggio 1948, che costò
la vita al ministro degli esteri Jan
Masaryk.
Non tutto andò dritto però nei
progetti di Stalin.
L’unica esperienza comunista
a sottrarsi alla rigida obbedienza
sovietica fu quella della Jugoslavia
guidata da Josip Broz, detto Tito,
non a caso l’unico paese nell’Europa
orientale a essersi liberato dall’occupazione nazista non per l’intervento
dell’Armata rossa ma in forza di una
propria vittoriosa guerra partigiana.
Lo scontro tra Stalin e Tito fu causato non tanto da un anelito di libertà
da parte di quest’ultimo, quanto
piuttosto dal suo estremo nazionalismo. Tito avviò una efficace opera
di mediazione istituzionale tra le
varie nazionalita che componevano
la nuova Federazione jugoslava, e
soprattutto tra le maggiori di esse,
la serba e la croata (in passato divise
da sanguinosi antagonismi, e che non
a caso dopo la sua scomparsa tornarono reciprocamente a scannarsi),
e si mostrò sempre piu sospettoso
nei confronti dell’egemonia sovietica. Dopo il 1945, consolidato il
suo potere, Tito in pratica cercò di
ripetere, su scala regionale, in modo
autonomo da Mosca, la politica di
massi­mizzazione dei dividendi della
vittoria portata avanti, su scala più
vasta, dallo stesso Stalin. Il caso
tristemente più noto dell’aggressivo
attivismo titino fu l’occupazione di
Trieste e della Venezia Giulia, dove
fu effettuata una vera e propria «pulizia etnica» ai danni degli italiani.
Il maresciallo non si limitò però
all’Italia, ma tentò pure di annettersi
l’Austria meridionale ed appoggiò i
comunisti greci nonostante l’esplicita proibizione da parte di Mosca.
Stalin non poteva tollerare, da
parte dei leader comunisti stranieri,
iniziative che fossero indipendenti
dalle sue diret­tive. I rapporti tra lui
e Tito peggiorarono rapidamente, e
Berlino - Scorcio su una parte del famoso “muro” che divideva la città.
quando nel maggio del 1948 a Lubiana il maresciallo dichiarò che la
Jugoslavia non sarebbe mai più stata
dipendente da nessuno, la «scomunica» fu inevitabile: Tito fu accusato
di «revisio­nismo» e la Jugoslavia fu
espulsa dal Cominform.
Tutt’altro che terrorizzato, e forte
del consenso popolare nel suo paese,
Tito denunciò lo sfruttamento operato dall’URSS nei riguardi dei paesi
satelliti, rifiutò la teoria dello «stato
guida» e si rivolse all’Occidente per
ottenere aiuti economici, orientandosi nel con­tempo in politica estera
verso posizioni neu­traliste. Stalin
ovviamente da parte sua non si lasciò
fuggire l’occasione per un’altra bella
«purga» ai danni degli esponenti
comunisti del Co­minform che non
fossero a suo avviso abbastanza su-
pini ai suoi voleri.
Una vittima illustre di questa nuova fase dello stalinismo nell’Europa
orientale fu il polacco Wla­dislaw
Go­mulka, che dopo essere stato per
anni in carcere, sarà “risuscitato” da
Chrusèëv e diventerà poi la guida incontrastata della Polonia comunista
negli anni Sessanta e Settanta.
E.S.
(continua)
Note
(1) Questo articolo è il risultato
della collazione degli appunti raccolti
dall’autore per una sua conferenza
tenuta a San Gregorio nelle Alpi nel
novembre 2009, voluta dall’assessore
al turismo del Comune di San Gregorio, Marco Crepaz, al quale vanno
i ringraziamenti dell’autore per l’autorizzazione alla pubblicazione.
19
(2) La bibliografia sulla seconda
guerra mondiale - a prova della
sua fondamentale importanza
storica - è a dir poco sterminata.
Chi desiderasse un’introduzione
generale può rivolgersi, tra le opere
di più facile reperimento, a basil
liddel hart, Storia militare della
Seconda guerra mondiale, Milano,
Mondadori 1970, e a cartier r., La
seconda guerra mondiale, Milano,
Mondadori 1968.
(3) http://it.wikipedia.org/wiki/
Con­ferenza_di_Bretton_Woods.
(4) Vedi mammarella g.,
Da Yalta alla perestrojka, RomaBari, Laterza 1990, pp. 5-6.
(5) A Jalta fu anche deciso che
i prigionieri russi liberati dagli
occidentali sarebbero stati tutti
consegnati alle autorità sovietiche,
indipendentemente dalla loro volontà. Fu un vero crimine contro
l’umanità: centinaia di migliaia di
persone passarono direttamente
dai lager tedeschi ai gulag russi.
­ arella
(6) Vedi per esempio mamm
g., Da Yalta alla peres­trojka, RomaBari, Laterza 1990, pp. 3-14.
(7) http://it.wikipedia.org/wiki/
Con­ferenza_di_Potsdam.
(8) l «progetto Manhattan» era
ritenuto fondamentale per vincere
la guerra contro il Terzo Reich, che
erroneamente si supponeva stesse
continuando a portare avanti un
programma militare analogo sotto
la guida di Kurt Diebner. Ma nel
1944, a guerra ancora in corso, gli
alleati scoprirono che per fortuna
i tedeschi, dopo due anni di lavoro
dal 1939 al 1941 per cercare di produrre una bomba atomica, si erano
poi fermati ritenendo il progetto
irrealizzabile e ripiegando sulla costruzione di un semplice reattore.
http://it.wikipedia.org/wiki/
Bom­b a­_ atomica;http://it.wiki­
pedia.org/wiki/ Arma_nucleare;
http://it.wiki­pedia.org/wiki/Progetto_Manhattan; http://it.wikipedia.
org/wiki/Bom­b ar­d a­m ento_­a to­
mico_­di_­Hiro­shi­ma_­e_Nagasaki.
(9) L’etica guerriera giapponese, come è noto, era debitrice del
bushido, ossia dell’antico codice
d’onore dei samurai. Per il bushido, in guerra le alternative erano
20
la vittoria o la morte, tertium non
datur. Questo, assieme all’esasperato nazionalismo, diede origine
alla infame condotta di guerra
dei giapponesi nei confronti dei
civili e dei prigionieri. Vi furono
diversi casi in cui i naufraghi delle
navi giapponesi preferirono farsi
divorare dagli squali piuttosto che
essere salvati dagli americani. La
differenza tra l’etica militare europea e quella orientale è nettissima.
Mentre per gli europei - nonostante
purtroppo le innumerevoli eccezioni - il «nemico» mantiene la sua
connotazione umana e personale,
per cui quando non è più in grado
di nuocere è immorale ucciderlo,
in genere nelle culture asiatiche
esso non è considerato un essere
umano, e perciò è lecito - anzi
doveroso - ucciderlo anche se si
arrende o è disarmato. In Vietnam
per esempio i regolari nordvietnamiti e i guerriglieri vietcong, dopo
uno scontro, ammazzavano tutti
i feriti nemici che trovavano sul
terreno.
(10) Testimone oculare del
bombardamento di Hiroshima fu
il padre gesuita e futuro generale
dei gesuiti Pedro Arrupe, che allora
si trovava in missione in Giappone
presso la comunità cattolica della
città e che si prodigò nel soccorso
ai sopravvissuti.
(11) Gli strateghi americani
pianificavano di ottenere la vittoria
sul Giappone circa 18 mesi dopo
la fine della guerra in Germania,
cioè intorno alla fine del 1946, ma
i pessimisti arrivavano a parlare
della primavera 1947.
(12) Http://it.wikipedia.org/wiki/
Bom­b ar­d amen­t o_ato­m i­c o_­d i_Hi­
roshi­ma_e­_Na­ga­saki. Secondo questa fonte, l’indagine degli Stati Uniti
sul Bombardamento Strategico,
dopo aver intervistato centinaia
di civili e militari giapponesi dopo
la resa del Giappone, riportò: «
Basata su investigazioni dettagliate
di tutti i fatti, e supportata dalla
testimonianza dei leader giapponesi
sopravvissuti coinvolti, è opinione
dell’Indagine che certamente prima
del 31 dicembre 1945, e con tutta probabilità prima del 1° novembre 1945,
il Giappone si sarebbe arreso anche
se le bombe atomiche non fossero
state sganciate, anche se la Russia
non fosse entrata in guerra, e anche
se nessuna invasione fosse stata pianificata o contemplata». I sostenitori
della tesi opposta fanno notare che
i bombardamenti convenzionali su
Tokyo del marzo 1945 fecero più
vittime della bomba di Hiro­shima, e
che per costringere i giapponesi alla
resa i bombardamenti aerei in ogni
caso sarebbero continuati provocando ancora più perdite.
(13) L’articolo 25 della Convenzione dell’Aja del 1907 recita: «È
vietato di attaccare o di bombardare, con qualsiasi mezzo, città,
villaggi, abitazioni o edifizi che
non siano difesi». Leo Szilard, uno
dei fisici che, dopo aver avuto un
ruolo fondamentale nel «progetto
Manhattan», di fronte all’inaspettata potenza del nuovo ordigno
furono presi da tardivi scrupoli di
coscienza, fece negli anni successivi
questo eloquente commento: «Se
i tedeschi avessero gettato bombe
atomiche sulle città al posto nostro,
avremmo definito lo sgancio di
bombe atomiche sulle città come
un crimine di guerra, e avremmo
condannato a morte i tedeschi
colpevoli di questo crimine a Norimberga e li avremmo impiccati».
(14) http://it.wikipedia.org/wiki/
Pia­no_Morgenthau.
(15) http://it.wikipedia.org/wiki/
Zone_­di_occupa­zio­ne_del­la_Ger­
mania; http://it.wi­ki­pe­dia­.org­/wiki/
Consi­glio_di­_con­trol­lo_alleato.
Il testo della «dichiarazione
del 1945» si può trovare in http://
cro­n ologia.leonardo.it/ugopersi/
se­conda_gm/dichia­ra­zio­ne­_do­po­
re­sa.htm.
(16) http://it.wikipedia.org/wiki/
Cor­tina_­di_ferro. Curiosamente,
il primo ad utilizzare l’espressione
«cortina di ferro» fu Joseph Goeb­
bels, che nelle ultime settimane
di guerra in Europa scrisse: «Se
il popolo tedesco deporrà le sue
armi, i Sovietici, in base agli accordi
presi tra Roosevelt, Churchill e
Stalin, occuperanno tutta l’Europa
Orientale e Sudorientale assieme a
gran parte del Reich. Una cortina
di ferro cadrà sopra questo enorme
territorio controllato dall’Unione
Sovietica, dietro il quale le nazioni verranno massacrate». Al di
là dell’ipocrisia di Goebbels, che
taceva il massacro delle nazioni
perpetrato dai tedeschi, è significativo il fatto che già alla fine della
seconda guerra mondiale era ben
chiaro quale sarebbe stato il futuro
dell’Europa dopo la vittoria alleata. È risaputo che lo stesso Adolf
Hitler nei suoi ultimi giorni di vita
ripose le sue ultime nevrotiche speranze su una possibile rottura degli
alleati occidentali con l’Unione
Sovietica. Speranze illu­sorie, perché prima di combattersi tra loro
gli ex-alleati avrebbero comunque
prima chiuso i conti con la Germania nazista. http://www.cal­vin.edu/
aca­demic/cas/gpa/go­e­b 49. htm.
(17) Citato da mammarella g.,
Da Yalta alla perestrojka, cit., p. 18.
(18) Ibid. , p. 37.
(19) I documenti scoperti da
Leonid Gibianskii negli archivi
di Tito a Belgrado suggeriscono
che l’idea del Cominform fosse
già stata discussa durante i colloqui fra Stalin e Tito a Mosca nel
maggio-giugno 1946. Békés, con
documenti provenienti dagli archivi ungheresi, sostiene che non
soltanto un programma sovietico
per ristabilire un’organizzazione
comunista internazionale era già in
discussione fin dal marzo del 1946,
ma che l’esecuzione del programma sia stata posposta per evitare
effetti negativi durante le elezioni
in Francia e Cecoslovacchia. Infatti, nel discorso pronunciato dal
segretario generale del partito comunista ungherese alla seduta del
comitato centrale, 17 maggio 1946,
s’informano i membri del partito
delle intenzioni dei sovietici circa la
creazione di una nuova organizzazione comunista mondiale diversa
dalla terza internazionale per come
aveva avuto modo di ascoltare fra il
28 marzo e 2 aprile 1946, durante
una missione segreta a Mosca, in
cui stava provando a realizzare i
termini migliori per l’Ungheria
alla prossima conferenza di pace.
Proprio il 1 aprile 1946, incontrò
Stalin e Molotov ed è probabile,
per Békés, che a quel punto ricevette le informazioni con le quali
si è presentò successivamente al
Comitato del partito comunista
ungherese. L’idea di installazione posteriore del Cominform,
piuttosto che essere una reazione
all’intensificazione degli attriti
fra gli alleati, fu originariamente
parte di uno schema sovietico di
più largo respiro rivolto alla promozione del cambio di gestione
comunista in Europa centrale e
orientale attraverso mezzi pacifici,
e contemporaneamente mirante
alla conservazione di rapporti di
cooperazione pacifica con l’Occidente. Tutto ciò determina una
modificazione generale della rappresentazione storica della guerra
fredda rispetto all’immagine consolidata. Mas­similiano Aloe, Nuovi
orientamenti sulla Guerra Fredda.
Rappresentazioni, percezioni e
distinzioni, in «Storiadelmondo»
n. 38, 16 gennaio 2006, reperibile
al sito http://www.storiadelmondo.
com/38/alo­e.guerrafredda.pdf.
(20) I partiti comunisti che diedero vita a questa specie di Terza
Internazionale in formato ridotto
erano quelli di URSS, Ungheria,
Polonia, Cecoslovacchia, Bulgaria,
Romania, Jugoslavia e, appunto,
Italia e Francia.
(21) Come è noto «segretario di
stato» è il nome dato negli USA al
ministro degli esteri.
(22) Gli aiuti furono estesi poi
anche al Canada. Fece richiesta in
merito anche l’Argentina, ma Wa­
shington rifiutò a motivo dell’abbondante produzione agricola di
quel paese.
(23) Si toccò una punta di circa
1.400 voli al giorno, per complessive
13.000 tonnellate circa di rifornimenti. In totale i voli furono 278.228,
per un totale di 2.326.406 tonnellate
di rifornimenti (soprattutto viveri e
carbone). L’Unione Sovietica tolse il
blocco a mezzanotte del 12 maggio
1949, ma il ponte aereo continuò
fino al 30 settembre in modo da fornire a Berlino scorte sufficienti nel
caso i sovietici bloccassero di nuovo
la città. Vedi Http://it.wikipedia.org/
wiki/Blocco_di_Berlino e Http://
it.wik­ipe­dia.org/wiki/Pon­te_­Ae­reo_­
di_­Ber­lino.
(24) Ufficialmente non era mai
stata intavolata una trattativa per
chiarire lo status internazionale
delle comunicazioni tra la Germania occidentale e Berlino ovest,
dato che l’idea iniziale era quella
di istituire uno stato tedesco unificato, che comprendesse anche la
zona di occupazione sovietica. Si
può constatare come entrambi gli
schieramenti si preoccuparono di
fare in modo che la prova di forza
non degenerasse in guerra aperta.
Il comandante delle truppe di occupazione americane, il generale
Lucius D. Clay, aveva all’inizio
proposto a Truman di inviare una
grossa colonna corazzata attraverso le strade che collegavano la
Germania occidentale a Berlino.
La colonna avrebbe marciato pacificamente per scortare gli aiuti
umanitari ma sarebbe stata pronta
a rispondere al fuoco se bloccata
o attaccata. Una simile proposta
avrebbe fatto quasi sicuramente degenerare la crisi e Tru­man rifiutò,
dando invece ordine all’aviazione
americana (United States Air Force, USAF) di studiare la fattibilità
di un ponte aereo.
(25) http://it.wikipedia.org/wiki/
Nato; http://www.nato.int (sito
ufficiale dell’Alleanza Atlantica).
(26) L’Art. 5 del trattato recita:
«Le parti concordano che un attacco armato contro una o più di esse,
in Europa o in America settentrionale, deve essere considerato
come un attacco contro tutte e di
conseguenza concordano che, se
tale attacco armato avviene, ognuna di esse, in esercizio del diritto
di autodifesa individuale o collettiva, riconosciuto dall’articolo 51
dello Statuto delle Nazioni Unite,
assisterà la parte o le parti attaccate prendendo immediatamente,
individualmente o in concerto con
le altre parti, tutte le azioni che
ritiene necessarie, incluso l’uso
della forza armata, per ripristinare
e mantenere la sicurezza dell’area
Nord Atlantica». Cfr. http://www.
nato.int.
21