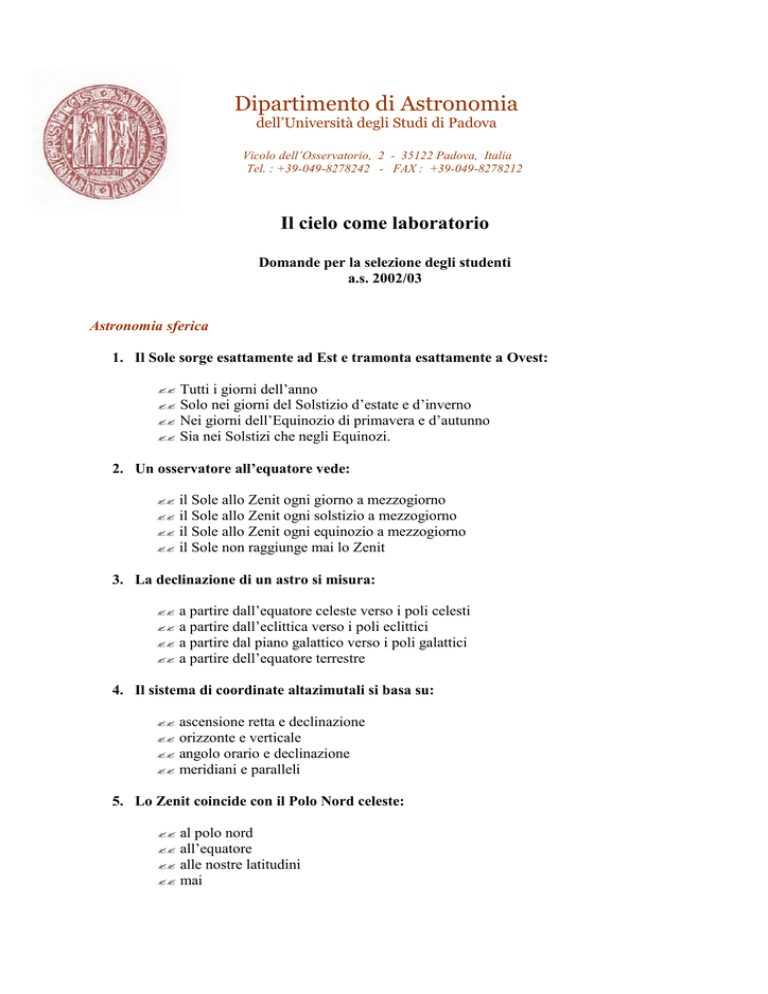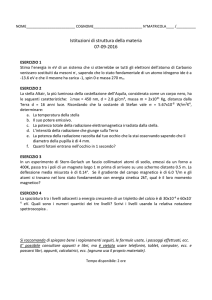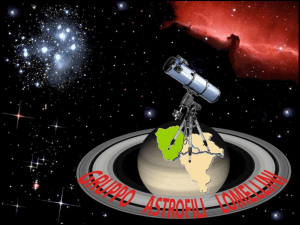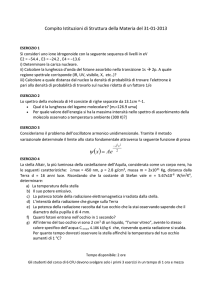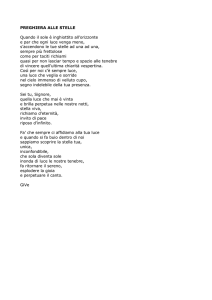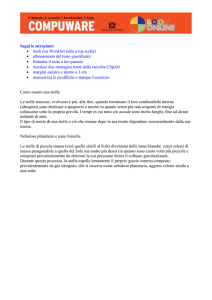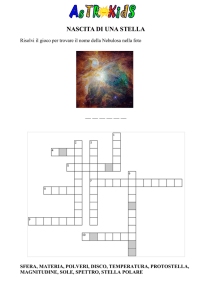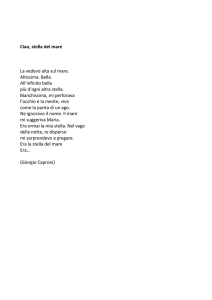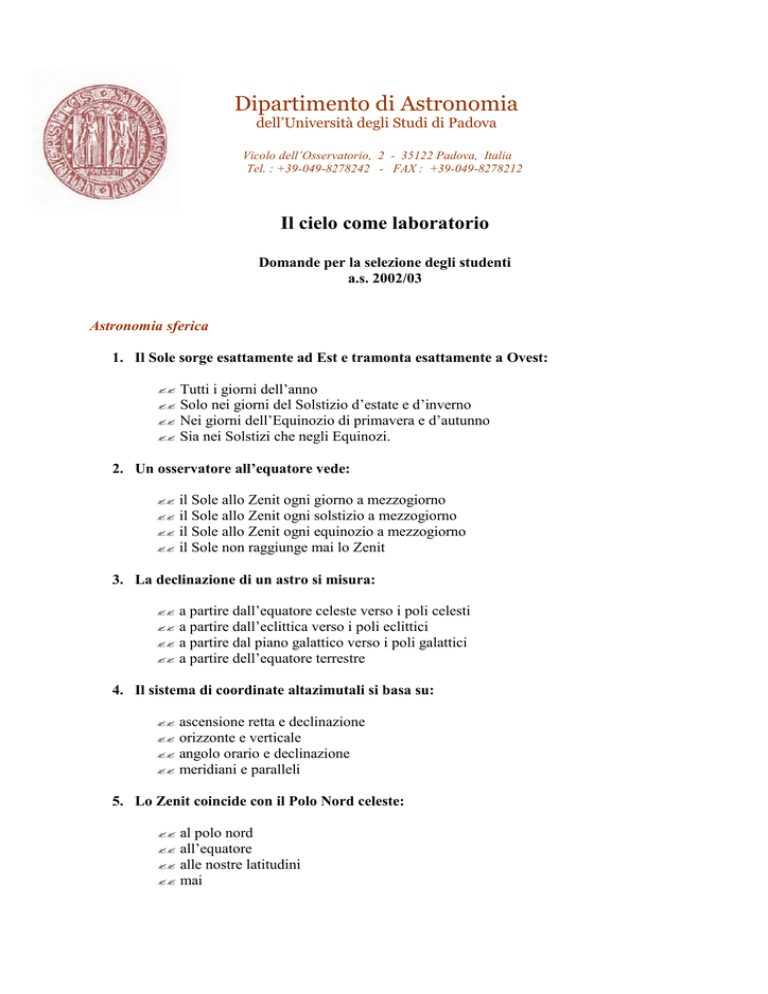
Dipartimento di Astronomia
dell’Università degli Studi di Padova
Vicolo dell’Osservatorio, 2 - 35122 Padova, Italia
Tel. : +39-049-8278242 - FAX : +39-049-8278212
Il cielo come laboratorio
Domande per la selezione degli studenti
a.s. 2002/03
Astronomia sferica
1. Il Sole sorge esattamente ad Est e tramonta esattamente a Ovest:
??
??
??
??
Tutti i giorni dell’anno
Solo nei giorni del Solstizio d’estate e d’inverno
Nei giorni dell’Equinozio di primavera e d’autunno
Sia nei Solstizi che negli Equinozi.
2. Un osservatore all’equatore vede:
??
??
??
??
il Sole allo Zenit ogni giorno a mezzogiorno
il Sole allo Zenit ogni solstizio a mezzogiorno
il Sole allo Zenit ogni equinozio a mezzogiorno
il Sole non raggiunge mai lo Zenit
3. La declinazione di un astro si misura:
??
??
??
??
a partire dall’equatore celeste verso i poli celesti
a partire dall’eclittica verso i poli eclittici
a partire dal piano galattico verso i poli galattici
a partire dell’equatore terrestre
4. Il sistema di coordinate altazimutali si basa su:
??
??
??
??
ascensione retta e declinazione
orizzonte e verticale
angolo orario e declinazione
meridiani e paralleli
5. Lo Zenit coincide con il Polo Nord celeste:
??
??
??
??
al polo nord
all’equatore
alle nostre latitudini
mai
6. Siete in un luogo di osservazione a latitudine 60º Nord. Culminano allo Zenit le stelle
che hanno declinazione:
??
??
??
??
90º
30º
60º
40º
7. Il tempo siderale di una stella in meridiano superiore è:
??
??
??
??
l’ascensione retta della stella
l’ascensione retta del punto ?
l’Azimut della stella
l’angolo orario della stella
8. Una stella che transita in meridiano ha raggiunto:
??
??
??
??
9.
la massima altezza sull’orizzonte
la minima distanza zenitale
entrambe le cose
nessuna delle due
A quale ora di tempo siderale sorge un astro di coordinate equatoriali ? ??
= 6h 15m e
? = 18º 20’, per una latitudine geografica ? = 45º ?
??
??
??
??
13h 32m 24s
18h 45m 29s
22h 57m 36s
01h 19m 05s
Corpo Nero
10. Nel corpo nero:
??
??
??
??
l’energia totale emessa dipende dal tipo di materiale di cui è fatto il corpo nero
non si osserva alcuna radiazione
l’emissione osservata dipende esclusivamente dalla temperatura del corpo
l’emissione osservata è sempre la stessa ad ogni temperatura
11. Una cavità isoterma viene riscaldata fino alla temperatura di 6000 °K; da un foro
praticato in una delle sue pareti fuoriesce un pennello di radiazione. E’vero che:
??
??
??
??
Il massimo dell’intensità della radiazione cade nell’IR.
Il massimo dell’intensità della radiazione non cade entro lo spettro visibile.
Se la temperatura della cavità quadruplicasse il massimo dell’intensità della
radiazione cadrebbe nell’UV.
La distribuzione spettrale della radiazione non dipende dalla temperatura della cavità.
2
12. Come viene interpretato lo spettro di corpo nero
??
??
??
??
Tramite l’emissione e l’assorbimento di energia elettromagnetica, da parte di
particelle cariche oscillanti, in modo discreto
Tramite l’emissione e l’assorbimento di energia elettromagnetica, da parte di
particelle cariche oscillanti, in modo continuo
Con l’emissione discreta ed assorbimento continuo di energia elettromagnetica da
parte di particelle cariche oscillanti.
Con la legge di Wien
13. In che senso possiamo dire che una stella è simile ad un corpo nero?
??
??
??
??
Perché essa non emette alcuna radiazione
Perché l’emissione osservata dipende quasi esclusivamente dalla temperatura
superficiale della stella
Perché essa emette radiazione diversa a seconda del materiale di cui èfatta
Perché l’emissione osservata è sempre costante
14. La lunghezza d’onda corrispondente al massimo di emissione del corpo nero:
??
??
??
??
È costante per ogni temperatura
Aumenta al crescere della temperatura
Diminuisce al crescere della temperatura
Il corpo nero non emette
15. Stiamo osservando una stella che emette un flusso di 4x10-10 J m-2 s-1.
Quali sono i valori (approssimati) della sua temperatura e della lunghezza d’onda
del picco di emissione?
??
??
??
??
15 000 K
23 400 K
29 000 K
35 000 K
8000 Å
3000 Å
1000 Å
500 Å
16. La curva di Planck o planckiana:
??
??
??
??
Potrebbe rappresentare la distribuzione spettrale della radiazione emessa da una
lampada al neon.
Potrebbe rappresentare la distribuzione spettrale di una lampadina a
incandescenza.
Ha il massimo spostato verso le frequenze dello spettro UV.
Per lunghezze d’onda molto grandi tende all’infinito.
3
Spettroscopia, stelle
17. Qual’è la componente essenziale di uno spettrografo?
??
??
??
??
la fenditura
il collimatore
il prisma o il reticolo di diffrazione
la camera
18. In uno spettrografo a prisma:
??
??
??
??
la luce violetta viene deviata piu’della luce rossa
la luce rossa viene deviata piu’di quella violetta
tutta la luce viene deviata allo stesso modo
dipende dalla natura del prisma
19. Confrontando gli spettri di due stelle della stessa classe spettrale si scopre che le
righe hanno diverse larghezze; più sottili per la prima e più allargate per la seconda,
cosa si può dedurre da tale osservazione?
??
??
??
??
Stella nana la prima e gigante la seconda
Stella gigante la prima e nana la seconda
L’allargamento non dipende dalla classe spettrale
L’allargamento dipende dalla temperatura centrale delle stelle
20. Rispetto a una stella di classe spettrale K, una stella O ha:
??
??
??
??
una temperatura inferiore
la stessa temperatura
una temperatura superiore
la stessa temperatura a parità di raggio
21. In una stella di classe A (T circa 10 000 K) le righe della serie di Balmer:
??
??
??
??
sono assenti
raggiungono la massima intensità
sono intense come quelle degli elementi pesanti
sono di intensità uguale in tutte le classi spettrali
22. 2 stelle hanno la stessa temperatura ma raggi diversi. E’vero che:
??
??
??
??
Se il rapporto tra i raggi fosse 10 allora il rapporto tra le rispettive luminosità
sarebbe pari a 100.
Se il rapporto tra i raggi fosse 10 allora il rapporto tra le rispettive luminosità
sarebbe pari a 1000.
Se il rapporto tra i raggi fosse 100 allora il rapporto tra le rispettive luminosità
sarebbe pari a 100000.
La stella più grande è più rossa della più piccola.
4
23. 2 stelle hanno temperature una doppia dell’altra e raggi uguali. E’vero che:
??
??
??
??
La stella più calda è 64 volte più luminosa della stella più fredda.
La stella più fredda è 8 volte meno luminosa della stella più calda.
La stella più calda è 16 volte più luminosa della stella più fredda.
La stella più calda è una stella blu.
24. I fotoni prodotti nelle zone centrali delle stelle:
??
??
??
??
Viaggiando alla velocità della luce arrivano alla superficie in pochi secondi.
Non possono essere assorbiti dalla materia stellare perché hanno energie troppo
elevate.
Arrivano alla superficie in tempi dell’ordine di grandezza della vita umana.
Vengono assorbiti e riemessi, arrivando in superficie in milioni di anni.
25. Secondo la teoria evolutiva una stella come il Sole, una volta terminata la fase di
bruciamento dell'idrogeno:
??
??
??
??
si sposta gradualmente lungo la Sequenza Principale verso la zona di basse
temperature e luminosità
si sposta nel Ramo delle Giganti e lì si spegne
si sposta rapidamente nella regione delle Nane Bianche
finisce la sua vita come una nana bianca passando attraverso la fase di gigante
rossa
26. In uno spettro di galassia molto lontana da noi:
??
??
??
??
le righe di emissione sono spostate verso il blu
le righe di emissione sono sempre nello stesso posto
alcune righe di emissione si spostano verso il rosso, altre verso il blu
le righe di emissione sono tutte spostate verso il rosso
Galassie e cosmologia
27. Da quante stelle sono tipicamente formate le galassie come la Via Lattea?
??
??
??
??
10 mila
10 milioni
più di 10 miliardi
10000 miliardi
28. In che tipo di galassia si trova il sistema solare ?
??
??
??
??
galassia a spirale
galassia ellittica
galassia a spirale barrata
non è stato ancora determinato
5
29. Una galassia con redshift z = 0.001 si allontana da noi alla velocità di circa
??
??
??
??
V=3000 km/s
V=300 km/s
V=90000 km/s
V=900 km/s
30. Cosa significa la legge di Hubble?
??
??
??
??
che le galassie si allontanano da noi in maniera proporzionale alla loro distanza
che piu' le galassie sono lontane, piu' deboli appaiono
che le galassie si allontanano da noi in maniera inversamente proporzionale alla
loro distanza
che piu' le galassie appaiono deboli, piu' si allontanano da noi
31. Quale è (circa) la temperatura di corpo nero della radiazione di fondo cosmico ?
??
??
??
??
0.3 K
3K
30 K
3000 K
Radiazione elettromagnetica
32. La radiazione visibile e la radiazione radio nel vuoto viaggiano alla stessa velocità?
??
??
??
??
no, la radiazione radio è piu’veloce perchè ha una lunghezza d’onda maggiore
si, perchè la velocità della luce è sempre la stessa in ogni mezzo
no, perchè la luce visibile è sempre piu’veloce
si, perchè nel vuoto la luce di qualunque lunghezza d’onda viaggia sempre alla
stessa velocità
33. La luce è composta:
??
??
??
??
da un campo elettrico ed un campo elettrostatico
da un campo elettrico statico ed un campo magnetico statico
da un campo elettrico ed un campo magnetico variabili nel tempo e perpendicolari
tra loro
da un campo elettrico ed un campo magnetico variabili nel tempo e paralleli tra
loro
Atomo di H
34. Se un atomo neutro di Idrogeno viene colpito da un fotone di energia > di 13.6 eV:
??
??
??
??
l’atomo resta neutro
l’atomo si eccita ma immediatamente si diseccita emettendo radiazione
l’atomo si ionizza
l’atomo di Idrogeno si trasforma in un atomo di Elio
6
35. La serie di Balmer è prodotta:
??
??
??
??
dall’atomo di Idrogeno
dall’atomo di Elio
dall’atomo di Idrogeno e dall’atomo di Elio
dall’atomo di Idrogeno ionizzato
Telescopi
36. Un telescopio in montatura equatoriale ha l’asse di rotazione che punta:
??
??
??
??
il Polo Nord celeste
lo Zenit
Il mezzocielo
Il Nadir
37. In un telescopio riflettore newtoniano la configurazione ottica è:
??
??
??
??
lente + lente
specchio parabolico primario + specchio piano secondario
specchio parabolico primario + specchio iperbolico secondario
specchio sferico
38. In un telescopio Cassegrain il fuoco si trova:
??
??
??
??
dietro lo specchio primario
tra lo specchio primario e il secondario
lateralmente allo specchio secondario
dietro lo specchio secondario
39. Il potere risolutivo teorico di un telescopio dipende da:
??
??
??
??
Il diametro dello specchio principale
La lunghezza d’onda incidente
La focale del telescopio
Il diametro dello specchio e la lunghezza d’onda
40. La perdita di qualità delle immagini astronomiche dovuta a turbolenza atmosferica,
detta "seeing", è generalmente valutata:
??
??
??
??
a occhio
misurando i diametri dei dischi stellari
valutando la deviazione di forma delle stelle dalla perfetta circolarità
misurando la distanza angolare fra due stelle qualsiasi
7
41. I moderni e sofisticati sistemi di ottica attiva consentono di compensare i dannosi
effetti sulle immagini astronomiche dovuti a:
??
??
??
??
deformazioni meccaniche dei sistemi ottici
turbolenze atmosferiche
luci diffuse in cielo
presenza di nuvole
42. Le tecniche avanzate di ottica adattiva correggono le immagini deformate da:
??
??
??
??
Variazioni di temperatura
Turbolenze atmosferiche
Deformazione degli specchi
Inquinamento luminoso
43. La bontà di un rivelatore di luce viene indicata dalla sua efficenza quantica (cioe` dal
rapporto tra i fotoni misurati e i fotoni incidenti). L'occhio umano, la lastra
fotografica e il CCD sono rivelatori di luce con diversa efficenza quantica.
Ordinali dal meno al più efficente.
??
??
??
??
CCD, lastra fotografica, occhio
occhio, CCD, lastra fotografica
occhio, lastra fotografica, CCD
lastra fotografica, occhio, CCD
44. L’aberrazione ottica detta “coma” produce immagini allungate che puntano verso:
??
??
??
??
il centro del campo osservato
tutte le direzioni
i bordi del campo osservato
tutte nella stessa direzione
Domanda supplementare. Viene valutata solamente per quanti risultano a pari merito.
Esprimi in un massimo di 5 righe la definizione di Corpo Nero
8