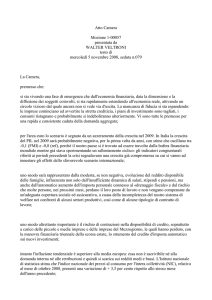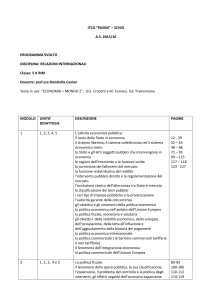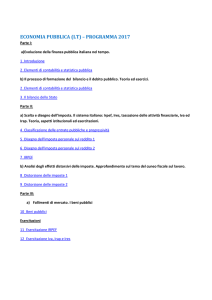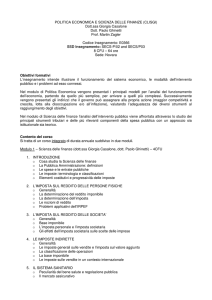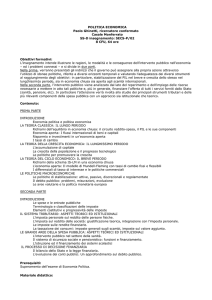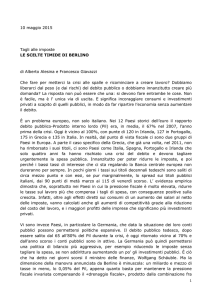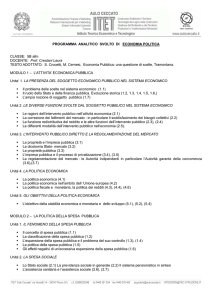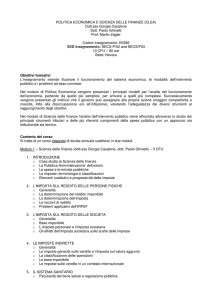Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Facoltà di Economia
Corso di laurea in
Economia europea
Tesi in Scienza delle Finanze
“Le imposte sulle società: effetti distorsivi
nell’ambito del policy making aziendale.”
Il Relatore
Chiar.mo Prof. Stefano Gorini
Il laureando
Lorenzo Colajacomo
Anno accademico 2011/12 2 Indice
INTRODUZIONE
CAPITOLO 1
1.1
Giustificazioni circa l’esistenza delle imposte sulle società.
1.2
Imposta sulle società: cenni storici.
1.2.1 Le principali riforme e i loro effetti a livello internazionale.
1.2.2 Il processo di armonizzazione europeo.
CAPITOLO 2
2.1
La perdita d’efficienza legata alle imposte.
2.1.1 Evidenza empirica.
2.2
La politica d’indebitamento.
2.2.1 La prima proposizione del teorema di Modigliani-Miller.
2.2.2 Il teorema di Modigliani-Miller dopo l’introduzione delle
imposte.
2.2.3 Evidenza empirica.
2.3
La politica dei dividendi.
2.3.1 Il modello di Lintner e l’irrilevanza della politica dei
dividendi.
2.3.2 La politica dei dividendi dopo l’introduzione delle imposte.
2.4
Il trattamento fiscale delle Piccole e Medie Imprese.
3 2.5
Le decisioni sulla forma statuaria.
CAPITOLO 3
3.1 Il fenomeno della globalizzazione e il commercio con
l’estero.
3.1.1 L’impatto delle imposte sulle strategie di espansione
orizzontale e diversificazione geografica.
3.1.2 La concorrenza fiscale: il caso dell’Irlanda.
3.2
Gli investimenti diretti all’estero.
CONCLUSIONI
Ringraziamenti
Riferimenti bibliografici
4 INTRODUZIONE
“Al mondo di sicuro ci sono solo la morte e le tasse.”1 Migliorare la qualità della vita non è più esclusivamente cercare di allungare
quanto più possibile l’età media degli individui, questione che lasciamo alla
scienza medica, ma è anche migliorare sostanzialmente il rapporto tra Stato e
cittadino in quanto a eguaglianza sociale, distribuzione della ricchezza e welfare.
Ed entrano dunque in gioco le imposte, che rappresentano il principale strumento
a disposizione di un governo per trasformare i prelievi effettuati a carico dei
cittadini in beni e servizi da offrire poi agli stessi. Purtroppo l’Italia vanta un triste
primato in quanto a fiscalità: secondo una recente indagine del Centro Studi di
Confcommercio,2 nel Belpaese la pressione fiscale è la più alta al mondo (54,8%),
seguito con più di sei punti percentuali di distacco da Danimarca e Francia. In
pratica, per ogni euro investito, circa cinquantacinque centesimi se ne vanno sotto
forma
di
tasse.
Un
importante
incentivo
all’evasione
fiscale,
secondo
Confcommercio, che nello stesso articolo stima il valore dell’economia sommersa
a 154 miliardi di euro. Al di là dell’evasione totale, ovvero quella per cui non si
paga alcun tipo d’imposta, è interessante vedere come il sistema fiscale sia
capace di generare alcune distorsioni che, talvolta, permettono agli individui di
ridurre il prelievo fiscale compiendo determinate scelte strategiche.
L’obiettivo principale di questo lavoro è di concentrarsi sulle imposte societarie,
individuando la natura di alcune distorsioni che queste generano e gli effetti che
causano, con un’attenzione particolare alle politiche di governo aziendali. Le
società sono governate da individui razionali e, in quanto tali, il loro obiettivo è
massimizzare il profitto e minimizzare, ove possibile, il rischio d’impresa. E’ lecito
dunque pensare che ogni qual volta una società trovi un escamotage, non per
forza illegale, per pagare meno imposte e quindi aumentare il profitto netto,
1 Celebre frase attribuita a B. Franklin. 2 Confcommercio-­‐Imprese per l’Italia (2012), Una nota sulle determinanti dell’economia sommersa. 5 sceglierà quella strada. Ma se è vero che gli individui preposti al governo delle
società sono esseri razionali, è altrettanto vero che questi non sono perfetti e, a
volte, intraprendono scelte che sono controproducenti e che possono arrivare a
mettere a repentaglio la vita stessa dell’impresa, come ad esempio politiche di
eccessivo indebitamento o di non-crescita.
Il lavoro è cosi strutturato: dopo un excursus sulla ragion per cui nelle società
moderne esiste l’imposta sulle società (§1.1), viene presentata una sintesi dei
maggiori cambiamenti fiscali in tema di società che si sono verificati a livello
internazionale nel corso delle ultime decadi (§1.2.1) e che hanno portato a un
dibattito sulla possibilità di armonizzare l’intero sistema fiscale europeo (§1.2.2).
Nel secondo capitolo, dopo una trattazione sulla perdita d’efficienza economica
legata all’introduzione di un’imposta (§2.1), sono illustrate le principali distorsioni
nelle politiche d’indebitamento (§2.2), politiche dei dividendi (§2.3) e trattamento
fiscale delle piccole e medie imprese (§2.4). Infine, con un’ottica internazionale,
viene analizzato l’impatto delle imposte nelle scelte strategiche delle società
multinazionali riguardo politiche d’espansione orizzontale (§3.1.1) e possibilità
d’investimento all’estero (§3.2). Il lavoro termina con delle conclusioni che
nascono da riflessioni personali. Ove possibile, a ogni teoria o a ogni ipotesi
formulata, sono presentati dei dati empirici offerti dalla letteratura internazionale
per valorizzare quanto scritto.
6 CAPITOLO 1
Ancor prima di procedere con l’analisi di come le imposte sulle società giochino un
ruolo cruciale in alcune decisioni di politica aziendale, è utile capire il perché
dell’esistenza di tali imposte, per poi analizzare l’evoluzione dei sistemi tributari
avvenuta nel corso degli anni che ha portato a importanti cambiamenti nel
trattamento fiscale delle società.
1.1
Giustificazioni circa l’esistenza dell’imposta sulle società.
Sono numerose le analisi effettuate dagli economisti per spiegare la tassazione
societaria, ma una prima giustificazione si può trovare nella stessa Costituzione
della Repubblica Italiana, che all’art. 53, comma 1, recita:
“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.” Vi è dunque una prima motivazione fondata sull’uguaglianza nel trattamento
fiscale: come le persone fisiche, anche quelle giuridiche sono generatrici di redditi
e, per questo motivo, devono essere soggette a tassazione; e questo ancor di più
se si pensa che le società siano soggetti economici distinti e indipendenti dai loro
soci.
Altre spiegazioni rilevanti non ci sono date dalla legge o da norme scritte, bensì
dall’intuito e dalla logica. Una considerazione che si potrebbe fare, seppur banale,
è pensare a cosa succederebbe se non esistessero le imposte sulle società: ogni
individuo avrebbe interesse a costituire una società nel caso in cui i costi di
acquisizione della personalità giuridica fossero minori dei vantaggi ottenuti
attraverso il trasferimento del proprio reddito in capo alla società stessa. Questa
situazione è ovviamente paradossale e inaccettabile, poiché costituirebbe un
importante stimolo all’evasione fiscale.
Ma si pensi ad esempio all’uso che le società fanno dei beni pubblici: strade, ponti,
porti, infrastrutture in generale, sicurezza pubblica, istruzione dei dipendenti. Sono
7 questi alcuni dei beni e servizi che lo Stato mette a disposizione della collettività e
per i quali è necessaria una controprestazione fondata sul “principio del beneficio3”
(benefit principle): le imposte sono commisurate ai benefici che gli individui
ricevono dall’utilizzo dei beni e servizi pubblici; o, detto con altre parole, tale
principio afferma che gli individui debbano acquistare i beni pubblici come
qualsiasi altro bene sul mercato e, non esistendo per i primi un vero e proprio
“negozio”, la loro offerta è finanziata attraverso le imposte.
Nicodéme (2008a) individua nell’esistenza delle imposte sulle società anche un
vincolo implicito che i policy makers devono fronteggiare: l’opinione pubblica non
potrebbe mai accettare l’abolizione di tali imposte, poiché considera le grandi
società come soggetti capaci di generare ingenti profitti e possedute da investitori
più che benestanti. Eliminando la tassazione societaria si potrebbero creare dei
disordini sociali, e gli organi politici non possono permettersi che ciò avvenga.
Infine, l’esistenza della tassazione delle società è dovuta al fatto che le imposte
stesse costituiscono un valido strumento di politica economica: attraverso la
tassazione (e quindi anche gli sgravi fiscali), i governi possono ad esempio
regolare monopoli pubblici, favorire lo sviluppo di settori industriali a rischio o
controllare le esternalità del mercato. Si pensi alle politiche degli ultimi anni che
hanno riguardato il settore energetico: molti governi europei hanno concesso e
continuano a concedere numerosi sussidi alle green companies per favorirne lo
sviluppo e incoraggiare la sostenibilità ambientale; sussidi che spesso sono
controbilanciati da una maggiore pressione fiscale o da altri costi per quelle
imprese che, al contrario, sono causa d’inquinamento atmosferico.4
Tuttavia, non tutti gli economisti sono favorevoli all’esistenza delle imposte sulle
società, e alcuni vorrebbero abolirle completamente, come scrive il prof. Scott
Sumner sulle pagine de The Economist:
3Questo
principio è stato oggetto di diverse obiezioni sia per quanto riguarda il problema del free
riding nei confronti dei cd. beni pubblici puri, che per la loro natura non sono soggetti a tale
principio, sia per l’effettiva equità nello scambio tra individuo e Stato. 4 Il sistema di controllo delle emissioni tramite la penalizzazione delle società che compromettono
l’ambiente è regolato a livello europeo dall’Emission Trading System (EU ETS).
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm 8 “Uno dei principi basici in economia è che la tassazione dei capitali è inefficiente. Tasse sugli interessi, dividendi e redditi da capitale rappresentano una sorta di “tassazione doppia” del salario. Per qualche ragione molte persone hanno difficoltà nel comprendere questo concetto, e spesso si vedono addirittura premi Nobel per l’economia parlare di “disuguaglianza sul reddito” utilizzando dati che contengono tanto i salari quanto i redditi da capitale. […] Non dovrebbe esistere l’imposta sulle società, che rappresenta una tripla tassazione del salario. Nella situazione attuale la distribuzione del benessere è assolutamente ingiusta […].”5 Della stessa opinione è Peter Schiff, CEO della Euro Pacific Capital, uno dei
maggiori broker americani, che sulle pagine di Yahoo Finance 6 si domanda:
“Perché tassare le società sui soldi che non vengono spesi per pagare i salari o
per distribuire dividendi?”. Sostenendo che quei “soldi sono quelli che vengono
usati per la crescita e per creare nuove opportunità d’investimento”, e dunque non
è corretto farli rientrare nella base imponibile. La sua proposta è di una flat tax in
stile Hall-Rabushka 7 per “tassare tutto nella stessa maniera e non punire chi
guadagna di più perché lavora duramente”.
Nonostante ciò, non è obiettivo di questo lavoro quello di analizzare la correttezza
o meno dell’esistenza dell’imposta sulle società, bensì quello di presentare i
principali effetti generati da queste imposte in maniera tale da fornire degli spunti
per poi trarre personalmente le dovute conclusioni.
1.2
Imposta sulle società: cenni storici.
1.2.1 Le principali riforme e i loro effetti a livello internazionale.
Degne di nota sono state le diverse riforme fiscali attuate in Inghilterra dalla prima
metà degli anni ’80 che portarono a ingenti tagli dell’aliquota fiscale sui redditi
societari: tra il 1983 e il 2002 l’aliquota per le piccole società fu più che dimezzata,
diminuendo gradualmente dal 40% al 19% (in seguito aumentata al 22% nel 2010),
5 http://www.economist.com/economics/by-­‐invitation/guest-­‐contributions/proper-­‐tax-­‐rate-­‐capital-­‐
income-­‐zero 6 http://finance.yahoo.com/blogs/daily-­‐ticker/peter-­‐schiff-­‐u-­‐abolish-­‐corporate-­‐personal-­‐income-­‐
taxes-­‐20110328-­‐074446-­‐749.html 7 R. E. Hall, A. Rabushka (2007), The Flat Tax, Hoover Institution. 9 mentre l’aliquota per le società con fascia di reddito più alta è passata dal 52% nel
1978 al 28% nel 2009.
Figura 1: Imposta sulle società, aliquota legale, 1979-­‐2005. Fonte: Institute for Fiscal Studies. Elaborazione propria.
Questa diminuzione ha avuto come conseguenza principale una convergenza a
livello internazionale verificatasi all’incirca alla fine degli anni ’80, come mostrato in
figura 1.
Le due maggiori potenze economiche, Stati Uniti e Inghilterra, ridussero l’aliquota
in maniera rilevante già nel 1988 e 1983, rispettivamente, seguite solo dalla
Francia che, nel 1986, optò per una riduzione più graduale. Gli altri paesi,
Germania, Italia e Giappone, si adeguarono a questi cambiamenti solo alla fine
degli anni ’90. Un caso a parte è costituito dalla Spagna, che nel corso degli anni
ha mantenuto l’aliquota stabile intorno al 35%.
La riduzione delle aliquote, poiché accompagnata da un allargamento della base
imponibile, ha fatto si che il gettito totale non variasse significativamente a seguito
delle riforme. Come si può vedere in figura 2, la percentuale del gettito
rappresentato dall’imposta sulle società è rimasta mediamente stabile intorno
10 all’8,9%, in linea con la media dei paesi dell’OECD (8,3%),8 costituendo dunque
una fetta importante degli ingressi pubblici per imposte.
Figura 2: Gettito dell'imposta sulle società come percentuale del gettito totale. Fonte: OECD Statistics. Elaborazione propria.
Un altro cambiamento che ha frenato la diminuzione del gettito in seguito al
rilevante taglio delle aliquote è che l’imposta sui redditi delle società è stata resa
negli anni sempre più progressiva: in questo modo, solo le società con redditi
appartenenti ai primissimi scaglioni sono soggette a un’aliquota bassa, che
aumenta più che proporzionalmente con l’aumentare del reddito. Un caso
esemplare tra tutti sono gli Stati Uniti, dove l’aliquota aumenta in maniera molto
rapida per i redditi compresi tra $0 e $335.000, passando dal 15% al 34%, per poi
appiattirsi gradualmente fino a raggiungere il tetto del 35% per i redditi ben oltre i
diciotto milioni di dollari (figura 3).
8 Fonte: OECD Statistics. 11 Figura 3: Imposta sulle società, aliquota federale negli U.S.A., 2011. Fonte: Internal Revenue Service. Elaborazione propria.
1.2.2 Il processo di armonizzazione europeo.
A livello europeo, la Commissione lavora su un progetto di armonizzazione da
diversi anni: infatti, come vedremo nei capitoli successivi, le società che operano
in più di uno Stato Membro possono incontrare numerose difficoltà dovute
all’esistenza di regimi fiscali nazionali anche molto diversi tra loro. Già nel 1962 il
Rapporto Neumark evidenziò come esistessero delle grandi divergenze tra i
sistemi fiscali, non solo dal lato delle imposte sulle società, ma anche da quello
delle imposte personali, e propose delle soluzioni a questi problemi che però non
furono mai adottate. Dopo una serie di altri rapporti e tentativi di riforma
comunitaria falliti, nel 2011 la Commissione Europea ha presentato un complesso
piano di armonizzazione della base imponibile dell’imposta sulle società (Common
Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB) che, dopo una prima fase di collaudo
su un campione ristretto di società, potrebbe diventare realtà, portando finalmente
a termine un dibattito che dura da più di cinquant’anni. Di seguito è riportata la
dichiarazione d’intenti fatta dalla Commissione nel 2001, anno in cui fu costituito il
gruppo di lavoro che ha elaborato la proposta d’armonizzazione:
12 “Nella convinzione che i regimi fiscali delle imprese in vigore nell'UE non siano più adeguati ai recenti sviluppi determinati dal processo di globalizzazione, dall'integrazione economica del mercato interno e dall'Unione economica e monetaria, la Commissione ritiene necessario un nuovo approccio in materia. […]La Commissione continua a ritenere che le decisioni in materia di aliquote fiscali delle imprese siano di competenza degli Stati membri. […]Al tempo stesso, la Commissione ritiene che, a lungo termine, il regime fiscale delle imprese debba prevedere una base imponibile consolidata per le attività delle imprese aventi dimensioni comunitarie, onde evitare le attuali, costose inefficienze dovute alla compresenza di quindici normative fiscali distinte.”9
9 Commissione Europea (2001), Fiscalità delle imprese: La Commissione propone l’introduzione di un’unica base imponibile consolidata, Europa Press Relases RAPID, IP/01/1468. 13 CAPITOLO 2
2.1
La perdita d’efficienza legata alle imposte.
Una prima causa del fenomeno distorsivo non solo delle imposte sulle società, ma
di tutte le tasse su di un bene, va ricercato nella teoria dell’economia pubblica e
della microeconomia, in particolare nel fenomeno della “perdita secca” di
efficienza economica (deadweight loss o excess burden)10.
La perdita secca che si ha quando s’introduce un’imposta è rappresentata dalla
differenza tra le riduzioni dei surplus del consumatore e del produttore e il gettito
dell’imposta. Immaginiamo ad esempio un mercato perfettamente concorrenziale
in cui sia scambiato un solo bene, come rappresentato in figura 4.
Figura 4: equilibrio competitivo. Elaborazione propria.
10 Più specificamente, il fenomeno della perdita secca di efficienza economica si verifica quando il
prezzo fissato per un bene non corrisponde al prezzo di equilibrio determinato dall’incontro tra
domanda e offerta in un mercato perfettamente concorrenziale. 14 La quantità e il prezzo d’equilibrio, Q* e p* rispettivamente, sono determinati
dall’incontro tra la curva di domanda D e quella d’offerta S. Il surplus del
consumatore (CS) è rappresentato dall’area sottostante la curva di domanda fino
al livello d’equilibrio del prezzo, mentre il surplus del produttore (PS) dall’area
sovrastante la curva d’offerta fino al livello d’equilibrio del prezzo.
Se s’introduce un’imposta fissa, in questo caso direttamente sul produttore, la
curva d’offerta trasla verso nordovest determinando una nuova quantità
d’equilibrio, Qt, e un nuovo prezzo, pt. Il prezzo pagato dal consumatore e quello
ricevuto dal produttore sono distinti tra loro e diversi dal livello d’equilibrio
concorrenziale; la loro differenza rappresenta il gettito per unità di bene scambiato.
Come illustrato in figura 5, non essendo più raggiungibile l’equilibrio di
concorrenza perfetta, il mercato perde efficienza nell’allocazione delle risorse,
perdita che è rappresentata dal triangolo giallo (DwL).
Figura 5: equilibrio dopo l'introduzione di un'imposta. Elaborazione propria.
15 Una caratteristica che è opportuno ricordare è quella della disuguaglianza
dell’incidenza dell’imposta se le curve di domanda e di offerta non sono
perfettamente simmetriche: infatti, anche se l’imposta colpisce direttamente il
consumatore o il produttore (incidenza legale), l’incidenza effettiva è determinata
dall’elasticità delle curve di mercato. Maggiore è l’elasticità della curva d’offerta
rispetto a quella di domanda, maggiore sarà la pressione fiscale sopportata dai
consumatori rispetto ai produttori:
Figura 6: incidenza dell'imposta con curva d'offerta più elastica della curva di domanda. Fonte: http://www.econport.org/econport/request?page=web_experiments_modules_taxes_lecture
Un caso estremo si ha quando la curva d’offerta (di domanda) è perfettamente
elastica (inelastica), per cui l’incidenza dell’imposta ricade esclusivamente sui
consumatori:
Figura 7: incidenza dell'imposta con curva d'offerta perfettamente elastica. Fonte: http://www.econport.org/econport/request?page=web_experiments_modules_taxes_lecture
16 Un contributo importante per osservare la relazione tra gettito e perdita
d’efficienza, e quindi tra beneficio per il governo e “danno di mercato” creato
dall’imposta, è stato dato dall’economista A. Laffer: con il fine di convincere l’allora
candidato a presidente degli Stati Uniti d’America R. Reagan ad alleviare la
pressione fiscale nel paese, Laffer illustrò come esistesse un “tetto” massimo di
prelievo fiscale oltre il quale il gettito del governo diventa addirittura decrescente.
Figura 8: perdita d'efficienza e gettito a confronto. Fonte: N. G. Mankiw (2011), Principles of Economics, 6 ed., South-­‐Western CENGAGE Learning, p. 164.
Man mano che l’imposta aumenta, le dimensioni del mercato diminuiscono
rapidamente e, superato un certo livello, il gettito del governo decresce, lasciando
ampio spazio alla perdita d’efficienza. Il consiglio che Laffer diede a Reagan fu
dunque quello di tagliare le tasse fino a raggiungere quel livello per cui il beneficio
del governo fosse massimo, riuscendo in questa maniera anche a diminuire la
perdita d’efficienza del mercato, rappresentata in quegli anni dal disincentivo a
lavorare a causa dell’elevata pressione fiscale.
17 2.1.1 Evidenza empirica.
E’ interessante quantificare la perdita d’efficienza legata alle imposte sulle società
in Europa. Secondo l’analisi di Huizinga e Laeven (2008), l’elasticità della base
imponibile soggetta a imposta sulle società rispetto al tasso medio d’imposta era,
nell’anno in cui venne scritto l’articolo, pari a 0,45; nello stesso anno, il tasso
medio d’imposta cui erano soggette le società nell’Unione Europea era del 23,6%.
La perdita secca come percentuale del gettito d’imposta, data dalla formula:
𝐷𝑒𝑎𝑑𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝐿𝑜𝑠𝑠 =
𝑡𝜀
2
(1)
dove 𝑡 rappresenta il tasso medio d’imposta ed 𝜀 l’elasticità della base imponibile
rispetto al tasso medio d’imposta, era quindi pari al 5,3% del gettito complessivo.
Senza entrare nel merito della grandezza di tale valore, l’eccessiva inefficienza di
un mercato potrebbe portare un’impresa ad abbandonare il mercato stesso,
generando una perdita di benessere tanto per il produttore, che vedrebbe venir
meno una potenziale fonte di ricchezza, che per i consumatori, i quali soffrirebbero
di una disponibilità inferiore di un bene sul mercato. Ecco perché gli organi di
politica economica dovrebbero tener conto di tale perdita collettiva di benessere a
fronte di una pressione fiscale troppo elevata che, nei casi estremi, potrebbe
condurre a un fallimento settoriale del mercato difficile da risanare. Bisognerebbe
tentare di raggiungere quella situazione d’equilibrio per cui l’incidenza dell’imposta
è bilanciata tra consumatore e produttore al fine di non creare un’eccessiva
disparità di trattamento, cercando allo stesso tempo un livello d’imposta tale da
ridurre al minimo la perdita d’efficienza, riuscendo a massimizzare la
quantità/qualità dei beni e servizi offerti.
18 2.2
La politica d’indebitamento.
2.2.1 La prima proposizione del teorema di Modigliani-Miller.
Il valore di una mela non dipende da come questa sia tagliata. Questa l’intuizione
contenuta nella prima proposizione del teorema di Modigliani-Miller, 11 dove la
mela rappresenta la società e le fette sono le fonti di finanziamento principali:
azioni e debito. In un mondo in cui non esistano tasse, dove i costi di bancarotta
siano pari a zero, il debito assunto sia senza rischio, i costi di transazione e i
conflitti d’agenzia siano inesistenti e vi sia perfetta simmetria informativa, il valore
di
un’impresa
non
dipende
dalla
sua
struttura
di
finanziamento,
ma
esclusivamente dai benefici attesi futuri (E[EBIT])12 capitalizzati per il costo medio
ponderato del capitale (r0):
𝑉=
𝐸[𝐸𝐵𝐼𝑇]
𝑟!
(2)
Quindi il valore di due imprese con uguale quantità di capitale finanziato in
maniera diversa, tramite sole azioni o tramite azioni e debito, deve essere
identico:
𝑉! = 𝑉!
(3)
dove VU è il valore della società finanziata esclusivamente con capitale di rischio e
VL quello della società che ha ricorso anche al debito.
La spiegazione di tale conclusione è semplice: si consideri un individuo indeciso
tra investire nell’impresa U o nell’impresa L. Per lui sarà indifferente comprare
tutte le azioni della società indebitata (L) o comprare quelle della società U e
simultaneamente prendere a prestito una quantità di denaro pari al debito della
11 F. Modigliani, M. Miller (1958), The Cost of Capital, Corporate Finance, and the Theory of Investment, American Economic Review, n. 48, vol. 3, pp. 261-­‐297. 12 EBIT sta per Earnings Beafore Interests and Taxes, o risultato ante interessi e imposte. 19 società L. Siccome i rendimenti dei due investimenti sono identici, il prezzo delle
azioni di L deve essere uguale a quello delle azioni di U meno il denaro preso a
prestito, ossia il debito di L.
La chiave di volta su cui si regge il teorema è che il costo del capitale sia identico
tanto per l’investitore quanto per la società L, e che dunque non esistano
asimmetrie d’informazione.
Ovviamente le ipotesi formulate nel teorema sono inverosimili e nessuna di queste
può verificarsi nella realtà. E tra tutte, quella più importante per la nostra analisi è
senza dubbio l’esistenza delle imposte sulle società e il loro effetto sulle politiche
d’indebitamento. Il punto di partenza è l’esistenza in tutti i sistemi fiscali moderni
della possibilità di dedurre dalla base imponibile la quota d’imposte sugli interessi
relativi ai debiti contratti, e dell’impossibilità di fare questo per i dividendi o per i
ricavi non distribuiti. Ciò, in linea teorica, genera un incentivo per gli amministratori
nello scegliere come fonte di finanziamento l’indebitamento anziché, per esempio,
la ricerca di capitali sui mercati azionari.
2.2.2 Il teorema di Modigliani-Miller dopo l’introduzione delle imposte.
L’intuizione di Modigliani-Miller va quindi rimodellata a seguito dell’introduzione
delle imposte sulle società, poiché la possibilità di dedurre la frazione d’imposte
sugli interessi debitori genera un risparmio fiscale che può essere utilizzato, ad
esempio, come maggior remunerazione per i finanziatori.
Per capire l’effetto di tale risparmio sulla ricchezza di una società, consideriamo il
seguente esempio confrontando un’impresa senza debito (U) e un’altra indebitata
(L) per D=1.000€ all’8%13:
13 Si ipotizza debito perpetuo. 20 Ricavi impresa U
Ricavi impresa L
€1.000
€1.000
0
(€80)
Ricavi al lordo delle imposte
€1.000
€920
Imposte (Tc = 35%)
(€350)
(€322)
€650
€598
€0 + €650 = €650
€80 + €598 = €678
€0
€28
EBIT
Interessi pagati ai bondholders
Ricavi netti agli stockholders
Ricavi totali agli stockholders
e bondholders
Risparmio fiscale
L’impresa indebitata L, attraverso il risparmio fiscale, è in grado di offrire ai propri
finanziatori una remunerazione maggiore di €28 rispetto a quella dell’impresa U.
Per vedere quindi come cambia il valore di un’impresa dopo l’inserimento
dell’imposta, consideriamo il risparmio fiscale espresso in valore attuale, pari a:
𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑋 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖 𝑠𝑢𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑜
=
𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑜
𝑇! (𝑟! 𝐷)
=
= 𝑇! 𝐷
𝑟!
𝑉𝐴 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 =
(4)
Il valore dell’impresa indebitata sarà dunque pari a:
𝑉! =
𝐸 𝐸𝐵𝐼𝑇
1 − 𝑇! + 𝑇! 𝐷 =
𝑟!
(5)
= 𝑉! + 𝑉𝐴(𝑟𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒)
Il vantaggio che questo risparmio fiscale genera è quello di aumentare il valore
dell’impresa e, di conseguenza, di poter offrire una maggiore remunerazione ai
finanziatori.
21 2.2.3 Evidenza empirica
E’ quindi vero che, sul piano teorico, la deducibilità degli interessi rende più
appetibile l’indebitamento rispetto alle altre forme di finanziamento. Ma ciò che è
vero sul piano teorico va poi verificato nella realtà, dove le variabili in gioco sono
molte di più rispetto a quelle formulate nel modello. Già Rajan e Zingales (1995),
analizzando le politiche di finanziamento di diverse società in tutto il mondo,
dimostrano che il livello d’indebitamento è più alto in quei paesi dove la pressione
fiscale sulle società è maggiore. Gordon e Lee (2000) hanno ricercato le loro
conclusioni studiando le serie storiche dell’U.S. Statistics of Income (SOI)
Corporate Income Tax Returns14 stimando che, ad esempio, a seguito del taglio di
dieci punti percentuali dell’aliquota d’imposta sulle società (dal 46% al 36%),
mantenendo le imposte sui redditi personali costanti, la percentuale di capitale
finanziato attraverso l’indebitamento si ridurrebbe del 3,5%.
In conclusione, è opportuno ricordare che politiche di eccessivo indebitamento,
anche se capaci di generare un notevole risparmio fiscale per la deducibilità degli
interessi pagati sul debito, sono causa di altri costi indiretti, talvolta anche più alti:
maggiore è il debito contratto e maggiore sarà il rischio di bancarotta, creando
possibilmente conflitti d’agenzia tra gli shareholders e i bondholders; inoltre, un
alto livello d’indebitamento può essere interpretato dai mercati come sintomo di
problemi finanziari, aumentando ulteriormente i costi di accesso al credito. Anche
per questi motivi, sono diversi i paesi che negli ultimi anni hanno adottato delle
misure fiscali correttive, arrivando a ridurre la proporzione d’interessi deducibili
fino al 50%.
2.3
La politica dei dividendi.
Tra le varie responsabilità in capo ai manager di una società vi è anche quella di
remunerare adeguatamente gli investitori che rendono possibile la realizzazione
dei progetti aziendali. A differenza dei bondholders, che generalmente conoscono
14 La base di dati SOI contiene informazioni sui bilanci di tutte le società, anche le più piccole,
operanti negli Stati Uniti d’America tra il 1954 e il 1995. 22 il rendimento dei titoli di debito acquistati perché questo è dichiarato
esplicitamente al momento della stipulazione del contratto, gli shareholders non
conoscono il rendimento effettivo delle loro azioni perché, al momento
dell’emissione, le società non possono prevedere con esattezza il flusso di
dividendi che pagheranno nel futuro.
2.3.1 Il modello di Lintner e l’irrilevanza della politica dei dividendi.
Nonostante questo, i manager cercheranno di mantenere il più possibile costanti i
profitti dei propri azionisti in maniera tale da non sfiduciarli in caso perdite e da
non esaltarli eccessivamente in caso di elevati profitti che potrebbero non durare a
lungo. Sulla base di questo presupposto, negli anni ’50 il prof. J. Lintner elaborò
una teoria 15 sulla base della quale le società fondano le proprie politiche di
distribuzione dei dividendi, ipotizzando quattro fatti stilizzati frutto di una ricerca
condotta su alcune società: le imprese hanno obiettivi di lungo termine circa il
rapporto di distribuzione degli utili (payout ratio); i manager concentrano la loro
attenzione più sulle variazioni dei dividendi che sui loro livelli assoluti; le variazioni
dei dividendi seguono le variazioni dei profitti di lungo periodo; i manager sono
riluttanti a modificare i dividendi per non rischiare di dover tornare indietro.
Dunque secondo una prima valutazione, una società che fissa il payout ratio a
lungo termine pagherà un dividendo futuro (DIV1) pari a una quota costante del
beneficio per azione (BPA1):
𝐷𝐼𝑉! = 𝑝𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑜𝑏𝑖𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑥 𝐵𝑃𝐴!
(6)
e il cambiamento tra un dividendo e l’altro sarebbe uguale a:
𝐷𝐼𝑉! − 𝐷𝐼𝑉! = (𝑝𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑜𝑏𝑖𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑥 𝐵𝑃𝐴! ) − 𝐷𝐼𝑉!
(7)
In questo modo però, cambiando costantemente gli utili di una società e di
conseguenza i benefici di ciascun’azione, i manager dovrebbero variare di anno in
15 J. Lintner (1956), Distribution of Incomes of Corporations among Dividends, Retained Earnings, and Taxes, American Economic Review n. 46, pp. 97-­‐113. 23 anno i dividendi da distribuire agli azionisti, e dalla sua analisi Lintner osserva che
questi sono abbastanza restii nell’agire in tal modo, poiché rischierebbero di
sfiduciare eccessivamente gli azionisti che invece preferiscono una crescita
costante dei dividendi pagati:
𝐷𝐼𝑉! − 𝐷𝐼𝑉! =
= 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑥 [ 𝑝𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑜𝑏𝑖𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑥 𝐵𝑃𝐴! − 𝐷𝐼𝑉! ]
(8)
In un’ottica di lungo periodo, il dividendo di ciascun anno dipende dagli utili
correnti e dal dividendo dell’anno precedente, che a sua volta dipende dagli utili di
quell’anno e dal dividendo dell’anno anteriore, e così via, venendosi a creare un
percorso temporale stabile.
Figura 9: Politica dei dividendi: il caso Motorola, 1977-­‐1992. Fonte: S. Mayoral Blaya (2012), Gestión Financiera, Trasparencias, Universidad Carlos III de Madrid.
24 Riprendendo le tesi di Modigliani e Miller contenute nel loro articolo del 1961,16 i
due economisti sostengono che in un mercato perfetto dei capitali (senza costi di
transazione e imposte, dove gli investitori sono individui perfettamente razionali) e
date determinate scelte d’investimento prefissate, la politica dei dividendi è
irrilevante e non influenza il prezzo delle azioni, che è determinato come segue:
!
𝑃! =
!!!
𝐷𝐼𝑉!
(1 + 𝑟! )!
(9)
Dove DIVt sono i flussi di cassa distribuiti sotto forma di dividendi e r0 è fattore di
capitalizzazione utilizzato al tempo t=0.
Segue da ciò l’irrilevanza per l’azionista della forma attraverso cui è pagato l’utile,
se con dividendo liquido ovvero con emissione di nuove azioni da assegnare a
titolo gratuito che possono essere successivamente convertite in denaro
vendendole sul mercato.
2.3.2 La politica dei dividendi dopo l’introduzione delle imposte.
Nella realtà tuttavia non si verificano le condizioni per l’esistenza di un mercato dei
capitali perfetto, e gli azionisti potrebbero preferire una politica di retribuzione ad
un’altra a seconda del livello di tassazione.
In linea di principio la teoria è semplice: ogni volta che l’imposta cui sono tassati i
dividendi è maggiore rispetto a quella cui vengono tassati i redditi da capitale, le
società dovrebbero distribuire utili sotto forma di dividendi nella minor quantità
possibile, utilizzando invece tali utili per reinvestirli in altri progetti o per
ricompensare gli azionisti con altre forme di remunerazione, come l’acquisto di
azioni proprie, incrementando così il valore delle azioni in circolazione, o
l’emissione di azioni a titolo gratuito. Dunque, se questo è il caso, gli azionisti
sarebbero disposti a pagare di più per azioni con un basso payout o, detto in altre
16 M. Miller, F. Modigliani (1963), Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction, American Economic Review, n. 53, vol. 3, pp. 433-­‐443. 25 parole, sarebbero disposti a comprare azioni con un basso rendimento prima delle
imposte ma che garantiscano un profitto sotto forma di reddito da capitale anziché
di dividendo.
Consideriamo nel seguente esempio due società che hanno emesso azioni
ordinarie il cui rischio d’investimento è il medesimo:
Società A
Società B
(nessun dividendo)
(alto dividendo)
€112,50
€102,50
€0
€10,00
€112,50
€112,50
Prezzo azione t=0
€100
€97,78
Guadagno capitale
€12,50
€4,72
Prezzo azione t=1
Dividendo
Profitto lordo
Percentuale di
guadagno lorda
Imposta sui dividendi
(40%)
Imposta sui redditi da
capitale (20%)
Profitto netto (dividendi
+ redditi da capitale)
Percentuale di
guadagno netta
100 x (12,5/100) = 12,5%
100 x (14,72/97,78) =
15,05%
€0
0,40 x €10 = €4,00
0,20 x 12,50 = €2,50
0,20 x 4,72 = €0,94
(0 + 12,50) - 2,50 =
(10,00 + 4,72) - (4,00 +
€10,00
0,94) = €9,78
100 x (10/100) = 10%
100 x (9,78/97,78) = 10%
Gli investitori si aspettano che il valore di mercato di un’azione nell’anno venturo
(t=1) sarà per la società A pari a €112,50, mentre per la società B, che pagherà un
dividendo di €10,00, pari a €102,50; in questo modo il profitto lordo è lo stesso e
pari a €112,50. Nonostante questo, e nonostante B offra una percentuale di
guadagno lordo maggiore di A, il prezzo delle sue azioni oggi (t=0) è minore del
prezzo delle azioni di A nello stesso periodo. La ragion per cui accade questo
risiede nel fatto che gli investitori preferiscono le azioni di A rispetto a quelle di B
26 poiché offrono esclusivamente un guadagno capitale soggetto a una tassazione
inferiore rispetto ai dividendi percepiti: ciò permette di realizzare un profitto netto
che è maggiore per chi abbia investito in A (€10,00) rispetto a chi abbia comprato
azioni di B (€9,78). La differenza nei prezzi di mercato permette comunque di
ottenere la stessa percentuale di guadagno netta e quindi di rendere le due
possibilità d’investimento ugualmente attrattive. Ciò che dovrebbero fare i
manager di B è eliminare il dividendo di €10,00 e utilizzare la disponibilità ottenuta
per effettuare operazioni sulle proprie azioni.
Quindi se le imposte sui dividendi percepiti fossero maggiori di quelle sui redditi da
capitale, perché una società dovrebbe continuare a distribuire dividendi ai propri
azionisti? Non sarebbe meglio una politica di zero payout a favore di un continuo
acquisto di azioni proprie o di emissione di azioni a titolo gratuito da assegnare ai
propri azionisti? Ovviamente questo non avviene perché entrano in gioco due
fattori: il primo è quello per il quale la distribuzione di dividendi secondo il modello
di Lintner ha l’effetto di segnalare positivamente la società sui mercati, per cui una
società che distribuisce regolarmente utili sotto forma di dividendi è giudicata
come in buona salute e che gode di una certa solidità economica; il secondo è che
in molti paesi ci sono dei forti limiti legali per quanto riguarda le operazioni sulle
azioni proprie, rendendole difficili o addirittura impossibili.
Inoltre i governi hanno modificato i propri sistemi fiscali proprio per evitare la
differenza nel trattamento dei dividendi e dei redditi da capitale e cercare dunque
di non favorire una modalità o l’altra per la remunerazione degli azionisti.
Nonostante ciò, non serve andare molto lontano negli anni per trovare casi in cui
le imposte creavano effetti distorsivi rilevanti. Nel 2006, ad esempio, in Inghilterra
l’aliquota effettiva sui dividendi era, per le persone fisiche con redditi elevati, del
25%, mentre quella sui redditi da capitale, per gli stessi individui, del 40%. Quindi
la distribuzione di utili attraverso il pagamento di dividendi avrebbe dovuto essere
la scelta da preferire. Ma il sistema fiscale prevedeva per quegli azionisti che
avrebbero tenuto le proprie azioni per un periodo superiore ai dieci anni una
detrazione del 40% dei redditi da capitale; ciò si traduce in un’aliquota effettiva del
24%, minore di quella applicata sui dividendi, rendendo più conveniente una
27 modalità di ripartizione degli utili rispetto all’altra. Quale strategia dovrebbe
scegliere la società? A questa domanda non esiste una risposta standard, poiché
molto dipende dalla composizione dell’azionariato: piccoli investitori che cercano
nei loro investimenti una fonte di reddito costante preferiranno i dividendi in
denaro; grandi azionisti che mirano ad aumentare le loro partecipazioni per
acquisire un maggior controllo della società saranno favorevoli a politiche di zero
payout; investitori professionali il cui obiettivo è accumulare ingenti pacchetti
azionari di elevato valore monetario, da rivendere poi sul mercato quando il prezzo
sia sufficientemente alto, preferiranno operazioni condotte dalla società sulle
proprie azioni; investitori istituzionali potranno avere interessi tanto di controllo
quanto di profitto. Il percorso strategico della società diventa insidioso, e spesso e
volentieri, per riuscire ad andare incontro a una categoria d’investitori, i manager
devono sacrificarne un’altra a causa di una distorsione creata dal sistema fiscale.
2.4
Il trattamento fiscale delle Piccole e Medie Imprese.
Continuando la nostra analisi sugli effetti distorsivi delle imposte sulle società, una
particolare attenzione va rivolta senza dubbio alle Piccole e Medie Imprese (d’ora
in poi PMI) che, nonostante le sofferenze dovute all’ultima crisi economica e
finanziaria, continuano a giocare un ruolo fondamentale nello sviluppo
dell’economia odierna.
Sono molti i paesi che applicano sgravi fiscali o aliquote ridotte per le PMI,
riconoscendo che per questa tipologia d’imprese il ricorso ai grandi mercati dei
capitali è molto difficile, sennonché impossibile, per asimmetrie d’informazione
riguardo alla loro situazione finanziaria, per l’impossibilità di collocare sul mercato
strumenti di raccolta di capitale tanto competitivi quanto quelli usati dalle grandi
multinazionali, per la sfiducia dei risparmiatori dovuta alle piccole dimensioni e
quindi collegata, seppur erroneamente, alla scarsa capacità di generare profitti
remunerativi. Ma ancora, le PMI sono più vulnerabili alle barriere d’ingresso ai
mercati altamente specializzati e non hanno le capacità economiche per costruire
28 valide economie di scala. Quindi l’esistenza di diverse tranche d’imposta, con
aliquote ridotte per le PMI, sembra trovare senso in quanto detto fino ad ora.
Sul piano delle distorsioni, già la presenza di un sistema tributario complesso e
composto di numerosi scaglioni di reddito potrebbe essere capace di generare
problemi di gestione da parte delle PMI, causa anche la loro relativa inesperienza
nell’ottimizzare la gestione fiscale rispetto alle grandi società. E’ molto
interessante il lavoro condotto da Namay II (2011) sui costi di gestione e
adeguamento al sistema tributario per le PMI neozelandesi (si consideri che in
Nuova Zelanda le PMI rappresentano il 97% del business nazionale, e sono
dunque una realtà molto importante per l’economia). L’autore presenza un chiaro
report in cui evidenzia che i costi di gestione e adeguamento al sistema tributario
espressi come percentuale del fatturato sono notevolmente maggiori per le PMI
(13%) che per le grandi società (0,3%).
Figura 10: media dei costi di gestione e adeguamento al sistema fiscale come percentuale del fatturato. Fonte: R. E. C. Namay II (2011), How much does it cost small and medium businesses to comply with New Zeland's tax requirements?, p. 12.
Questo potrebbe senz’altro esse causato anche dall’impossibilita per le PMI di
affidarsi a grandi gruppi di consulenza fiscale, che vantano di grande capacità
29 nell’ottimizzare in maniera efficiente la gestione delle imposte, perché troppo
onerosi rispetto alle dimensioni dei loro affari, dovendo quindi ricorrere o alla forza
lavoro interna o a piccoli studi di consulenza che applicano prezzi lontani da quelli
concorrenziali.
Osserva il problema da un’altra prospettiva Nicodème (2008a), che individua nella
presenza di aliquote ridotte per le PMI rispetto alle grandi imprese un disincentivo
alla crescita, ritenendo che gli aiuti diretti o un miglior funzionamento dei mercati
del credito siano soluzioni ben più efficienti.
2.5
Le decisioni sulla forma statuaria.
Sarebbe dunque lecito considerare che, nel caso in cui la pressione fiscale sulle
società fosse maggiore rispetto a quella sulle persone fisiche, vi sia una
convenienza nel passare da una forma statuaria societaria a una non societaria,
rendendo i profitti generati soggetti a un’aliquota d’imposta più bassa. Gordon,
MacKie-Mason (1994) e MacKie-Mason, Gordon (1997) giungono a risultati
statisticamente significativi ma
il cui ordine di grandezza è molto basso: un
aumento dell’aliquota societaria del 10% porterebbe ad un trasferimento di
ricchezza da un’organizzazione societaria ad una non societaria pari a solo lo
0,5% del capitale totale.
Questo risultato conferma che la forma societaria ha importanti vantaggi che non
rientrano nella sfera della fiscalità (responsabilità limitata dei soci, possibilità di
accesso ai mercati finanziari globali, ecc.).
30 CAPITOLO 3
3.1
Il fenomeno della globalizzazione e il commercio con
l’estero.
Tra i molteplici mutamenti che ha subito l’economia mondiale nell’ultimo secolo, un
posto di prim’ordine ha sicuramente la globalizzazione. Pur essendo un fenomeno
che inizia a svilupparsi permanentemente intorno al 1840, è dopo la Seconda
Guerra Mondiale che la globalizzazione facilita strategie che mirano a
intraprendere scambi con paesi anche molto lontani, soprattutto da parte delle
grandi società multinazionali. Grazie anche ad accordi commerciali come il
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) che ha dato poi vita alla World
Trade Organization (WTO), alla rimozione di numerose barriere commerciali e,
soprattutto, al considerevole crollo dei costi di trasporto dovuto a scoperte e
perfezionamenti nel mondo tecnico-scientifico, nei nostri tempi sono veramente
poche le imprese, non solo di grandi dimensioni, che non abbiano contatti
commerciali con l’estero.
3.1.1 L’impatto delle imposte sulle strategie di espansione orizzontale e
diversificazione geografica.
Già ieri, ma per effetto dell’ultima crisi economica e finanziaria oggi più che mai, le
grandi società multinazionali che hanno scelto strategie di espansione orizzontale
e diversificazione geografica valutano con attenzione dove stabilire i loro
headquarters oltreconfine, e i sistemi fiscali dei paesi stranieri giocano un ruolo
cruciale su questo piano. Ciò non vuol dire che una multinazionale si stabilisca in
un paese solo perché la pressione fiscale è bassa; saranno fatte considerazioni
anche su altri fattori, quali i costi di trasporto, lo sviluppo e la qualità delle
infrastrutture, la stabilità politica ed economica, ecc.; ma ai fini dell’analisi esposta
in queste pagine, ci si limiterà ad analizzare esclusivamente le scelte condizionate
dalle imposte sulle società.
31 Prendiamo ad esempio una grande multinazionale americana come Ford, leader
mondiale nella produzione di automobili, il cui utile netto nel 2011 si aggirava
intorno ai sette miliardi di dollari. Nel caso in cui Ford voglia creare delle strutture
di produzione in Europa da dedicare esclusivamente al mercato comunitario, le
scelte che i suoi manager si troveranno a fare possono essere riassunte in quattro
step. Una prima decisione è innanzitutto se produrre all’estero, e quindi inserirsi
direttamente nel mercato europeo, o se lasciare la produzione negli Stati Uniti ed
esportare successivamente all’estero il prodotto finito. Quest’ultima decisione
comporterà sicuramente degli elevati costi di trasporto da un continente all’altro,
mentre per la prima sarà necessario sostenere dei costi fissi per la costruzione di
nuove fabbriche, acquisto degli impianti ecc. La scelta sarà fatta sulla base dei
profitti al netto delle imposte realizzabili nei due diversi scenari, tenendo conto che
se la produzione dovesse rimanere negli US, le imposte si pagheranno sulla base
del sistema fiscale americano, mentre se la società dovesse optare per
l’espansione in Europa, le imposte si pagheranno secondo le norme vigenti nel
paese ospitante.
Supponendo che Ford abbia deciso di entrare nel mercato europeo, la seconda
scelta da fare è sul paese in concreto che ospiterà le strutture di produzione.
Anche qui il procedimento è simile a quello del primo step: si cercherà di
massimizzare il profitto al netto delle imposte tramite l’analisi del sistema fiscale
del paese obiettivo.
Il terzo step, parallelo al secondo, consiste nella scelta del livello d’investimento
che la multinazionale americana dovrà adottare per massimizzare il proprio
profitto17. Anche qui le imposte giocano un ruolo fondamentale, essendo capaci di
alterare il costo del capitale per due ragioni: la prima deriva direttamente dal costo
di accesso al credito che può essere distinto da paese a paese; la seconda, più
pertinente alla nostra analisi, perché i redditi da capitale sono tassati diversamente
in ogni Stato, tanto a livello societario quanto a livello personale.
17 L’impresa dovrà investire fino al punto in cui il costo del capitale uguaglia il suo prodotto marginale: r=PMK. 32 Infine, l’ultimo step riguarda la decisione su dove destinare i profitti. Avendo
generato un reddito soggetto a imposta, la multinazionale cercherà di collocare
questa ricchezza in un paese, anche diverso da quello di produzione attraverso
società “di comodo”, dove la pressione fiscale sia bassa. Ovviamente ci sono dei
limiti sul trasferimento dei profitti in altri paesi, e se così non fosse potremmo
osservare tutta la ricchezza generata in paradisi fiscali, con gettiti d’imposta
bassissimi in tutto il resto del mondo. Nonostante ciò, l’evidenza empirica dimostra
che il fenomeno del profit shifting esiste ed è rilevante: De Mooij (2005) e Huizinga,
Laeven e Nicodème (2008) stimano che, in Europa, un aumento dell’aliquota
societaria dell’1% porterebbe a un tax flight pari al 17,2% del gettito totale.
Per garantire ai paesi le stesse opportunità di ospitare grandi multinazionali senza
che queste compiano strategie sulla base dei diversi sistemi fiscali che creano
distorsioni e opportunità di maggior profitto, Auerbach, Devereux e Simpson18
sostengono che tale situazione di assenza d’arbitraggio si potrebbe realizzare solo
se l’aliquota marginale (che condiziona la scelta del terzo step) fosse pari a zero, e
se le aliquote media e legale (riferite rispettivamente agli step uno e due, quattro)
fossero uguali in tutti i paesi. Ovviamente ciò richiederebbe un livello di
cooperazione e armonizzazione fiscale che va ben oltre le aspettative attuali e,
seppur i benefici che si otterrebbero sono desiderabili da un punto di vista globale,
nessun paese sarebbe disposto ad accettare questa situazione.
Volendo quantificare l’impatto che le imposte hanno sulle strategie di espansione
internazionale delle società, è di notevole interesse lo studio condotto da Barrios,
Huizinga, Laeven e Nicodème (2008) nel quale sono analizzate le scelte di diversi
gruppi societari europei in materia di espansione geografica, utilizzando come
variabili dipendenti i vari aspetti delle imposte internazionali. Il risultato è che tanto
la tassazione nel paese d’origine quanto quella nel paese di destinazione hanno
un impatto notevole nella strategia di espansione: un incremento di un punto
percentuale dell’aliquota d’imposta per la società (per esempio da un valore medio
18 A. J. Auerbach, M. P. Devereux, H. Simpson (2010), Taxing Corporate Income, in Dimensions of Tax Design, The Mirrlees Review, Oxford University Press. 33 di 35,3% a uno di 36,3%) ridurrebbe la probabilità di espandersi in un determinato
paese del 3,96%, ceteris paribus.
3.1.2 La concorrenza fiscale: il caso dell’ Irlanda.
In particolare, un fenomeno generato dal processo di globalizzazione che può
essere utile per spiegare quanto esposto nel capitolo precedente è la concorrenza
fiscale tra stati, alimentata anche dal fatto che sono sempre di più le multinazionali
che cercano paesi con una bassa pressione fiscale dove stabilirsi. Il caso
esemplare è quello dell’Irlanda, paese piccolo la cui economia si basa
principalmente sui servizi, che rappresentano il 67% del PIL nazionale (mentre
industria e agrucoltura rispettivamente il 31% e il 2%).19
L’imposta sulle società in Irlanda rappresenta circa il 17% del gettito totale
nonostante l’aliquota si sia abbassata notevolmente nel corso degli anni20:
Anno
Aliquota
1999
28%
2000
24%
2001
20%
2002
16%
Dal 2003 ad oggi
12,5%
Questa strategia ha sicuramente come obiettivo quello di rendere il paese più
attraente per le imprese straniere, facendo dell’Irlanda la sede di alcune delle più
grandi multinazionali statunitensi, tra cui Google e Intel per citarne alcune, che
stimolano l’economia celtica offrendo migliaia di posti di lavoro ai cittadini. Le
grandi società d’oltremare hanno scelto l’Irlanda non solo per il trattamento fiscale
19 Fonte: ESRI, The Economic and Social Research Institute. 20 Fonte: Department of Finance, Government of Ireland. 34 e per le aliquote che si situano ben al di sotto della media europea, ma anche per
le semplificazioni amministrative che il governo ha adottato nei confronti delle
imprese straniere.
E la strategia irlandese ha portato i suoi frutti: man mano che l’aliquota fu
abbassata e le società estere attratte, il gettito relativo all’imposta sulle società
aumentava sensibilmente, a dimostrazione che, seppur concorra con altri fattori, la
pressione fiscale è un elemento di notevole importanza nelle decisioni di
espansione geografica delle società multinazionali.
Figura 11: Irlanda. Imposta sulle tocietà, gettito totale (in milioni di Euro). Fonte: OECD Statistics. Elaborazione propria.
3.2 Gli investimenti diretti all’estero.
Per continuare l’analisi rimanendo in un contesto internazionale, è ragionevole
considerare come gli investimenti diretti all’estero (d’ora in poi FDI, Foreign Direct
Investment) siano collegati con la tassazione.
I FDI sono diventati negli anni parte importante dell’economia mondiale,
rappresentando una quota di rilievo dei PIL nazionali. Il grafico in figura 10 mostra
35 l’andamento del flusso di FDI in entrata (quindi investimenti esteri nelle aree
considerate) per l’Unione Europea, i Paesi Membri del G20 e infine il flusso
complessivo del mondo intero. Fermo restando le flessioni verificatesi negli anni
2000 e 2007 per la bolla informatica, prima, e la crisi economico-finanziaria, poi, il
volume d’affari rappresentato dai FDI è cresciuto a dismisura dagli anni ’70 a oggi,
e sembra che il trend attuale sia quello di un repentino aumento.
Figura 12: Flusso d'investimenti diretti all'estero in entrata, 1970-­‐2011. Fonte: UNCTAD STAT. Elaborazione propria.
Due concetti teorici che è opportuno richiamare sono quelli di Capital Export
Neutrality (CEN) e Capital Import Neutrality (CIN). La CEN è verificata quando le
preferenze di un investitore circa la destinazione dell’investimento, nel paese di
residenza o all’estero, non sono influenzate dai sistemi fiscali vigenti. La CIN è
soddisfatta quando un particolare sistema fiscale riserva lo stesso trattamento
tributario a investitori residenti e stranieri, che di conseguenza ottengono lo stesso
rendimento netto. La letteratura considera preferibile la realizzazione della CEN
poiché garantisce una più efficiente allocazione delle risorse.
Tuttavia, la CEN e la CIN non possono realizzarsi contemporaneamente se non
con la piena armonizzazione dei sistemi fiscali di tutti i paesi, ancora lontana dal
36 verificarsi, e da ciò segue che la differenza di trattamento fiscale crea delle
distorsioni a livello internazionale.
Secondo un’ottica di mercato, ogni governo dovrebbe rendere il proprio sistema
fiscale il più attrattivo possibile per gli investimenti esteri, considerati gli
innumerevoli benefici che questi possono portare: creare nuovi posti di lavoro,
migliorare le infrastrutture, introdurre nuove tecnologie, favorire la crescita del
paese e aumentare la sua ricchezza, traducendosi in maggiori entrate per il
governo tramite le imposte. E sempre nella stessa ottica, dovrebbero essere
favoriti anche gli investimenti nazionali all’estero come valido strumento di
accesso ai mercati stranieri.
Resta comunque il fatto che le imposte non sono le uniche variabili che
condizionano le scelte d’investimento. I FDI sono attratti da quei paesi che offrono
un facile accesso ai mercati, stabilità economica e politica, un buon livello di
infrastrutture, un mercato del lavoro sviluppato. Tutti questi fattori contribuiscono
ad aumentare il profitto dell’investimento. Bisogna quindi verificare se il sistema
fiscale giochi un ruolo residuale nelle scelte d’investimento estere o se, al
contrario, sia un fattore rilevante.
Le analisi offerte dalla letteratura presentano tutte dei risultati distinti ma
comunque vicini tra loro. De Mooij ed Ederveen (2003, 2006), dopo aver
considerato molti dei risultati offerti da altri studiosi, calcolano che il valore medio
della semi-elasticità dei FDI rispetto all’aliquota dell’imposta sulle società è pari a
-2,9; ciò si traduce nel fatto che, secondo gli autori, un aumento dell’aliquota
societaria pari all’1% comporterebbe una riduzione dei FDI del 2,9%. Dunque un
incremento ex-ante dell’1% dell’imposta sulle società si traduce, come calcolato
da Nicodème (2008a), in un aumento del gettito di solo lo 0,873% (considerando
esclusivamente la riduzione dei FDI):21 il gioco non vale la candela, poiché per
registrare un aumento residuale del gettito bisognerebbe rinunciare ad una
porzione importante di investimenti esteri che, come detto precedentemente,
costituiscono un importante strumento per lo sviluppo di un paese.
21 La proprietà straniera di capitali europei rappresenta il 21,1% del totale degli attivi (Huizinga e Nicodème, 2006); l’aliquota media utilizzata è del 23,6%. 37 Ciò detto, una riduzione dell’aliquota societaria non sempre è capace di rendere
un paese attrattivo nei confronti degli investimenti esteri. E’ vero che il caso
dell’Irlanda presentato al capitolo 3.1.2 contribuisce a dare un peso notevole al
ruolo della concorrenza fiscale nei flussi di capitali internazionali, ma i paesi che
hanno un gettito d’imposta elevato sono anche quelli che, solitamente, possono
offrire maggiori e migliori infrastrutture, servizi pubblici e tutti quei fattori che nel
complesso rendono più attraente un mercato; questo è anche giustificato da una
logica do ut des secondo cui a maggiori/migliori servizi offerti un paese può
trovarsi legittimamente nella posizione di chiedere di più a chi usufruisce di tali
servizi.
38 CONCLUSIONI
Trarre delle conclusioni sulle molteplici sfumature di un sistema fiscale è un
compito abbastanza arduo, e lo è anche se l’analisi è circoscritta al solo campo
degli effetti distorsivi creati dalle imposte sulle società. L’importanza di tali imposte
è insindacabile: costituiscono una fondamentale fonte di ricchezza per i governi,
che sono così capaci di restituire alla collettività beni e servizi fondamentali per la
crescita dell’economia. Lo sviluppo di un paese si misura anche sulla sua abilità di
essere competitivo sul mercato, ma non attraverso politiche poco corrette come
quelle adottate dall’Irlanda negli ultimi anni, bensì con la capacità di poter offrire
servizi adeguati e sviluppati quali istruzione, sanità, sicurezza, infrastrutture, ecc.,
e l’esistenza delle imposte è conditio sine qua non per l’esistenza di tali servizi.
Certo, non sempre i benefici che si traggono dall’uso della cosa pubblica sono
proporzionali ai contributi versati, ma questo è più che altro dovuto alla
responsabilità (o irresponsabilità) della classe politica.
Dall’analisi fatta in questo lavoro, emerge chiaramente che attuare delle correzioni
del sistema fiscale esclusivamente a livello nazionale non avrebbe molto successo.
Nonostante la convergenza delle aliquote societarie avvenuta tra gli anni ’80 e ’90
abbia permesso di alleggerire la pressione fiscale mantenendo quasi inalterato il
gettito dei governi, è necessario, ora più che mai, un piano d’armonizzazione a
livello europeo per coronare quel progetto di Unione che stiamo faticando a
portare a termine: sono ancora troppe le differenze tra i sistemi fiscali comunitari
che danno luogo a distorsioni e difficoltà per le imprese, con il risultato che le
opportunità di sviluppo dei diversi paesi non sono le stesse. La costruzione di una
base imponibile consolidata permetterebbe, almeno per quelle società che
operano a livello europeo, di veder garantita una maggiore efficienza nella mobilità
dei capitali da un paese all’altro, ripristinando la corretta concorrenza tra gli Stati
Membri che non dovrebbe giocarsi sul ribasso dell’aliquota, ma, come già detto,
sull’effettiva qualità dei servizi offerti.
39 In un periodo di difficoltà economica come quello che attraversiamo, “efficienza” è
la parola d’ordine in molte riforme nazionali. Per un’impresa, efficienza del sistema
fiscale vuol dire anche semplicità e rapidità nella gestione delle imposte; tuttavia,
secondo un recente studio condotto da Confcommercio, 22 le ore spese da
un’impresa per gli adempimenti fiscali sono in media 285h/anno che, per le PMI, si
traducono in costi amministrativi pari al 30,9% del gettito complessivo
(Commissione Europea, 2005). E’ necessario semplificare il sistema fiscale per
alleviare questi costi e favorire la crescita economica e le opportunità di sviluppo
delle imprese, a maggior ragione se a essere colpite sono le PMI, le quali
costituiscono un pilastro fondamentale dell’economia.
Alcune distorsioni sono fisiologiche o comunque difficili da eliminare. La perdita
d’efficienza illustrata al capitolo 2.1 è inesistente solo in alcuni casi; ma trovarne di
tanto particolari, come domanda perfettamente inelastica o offerta perfettamente
elastica, non è facile e, quando si incontrano, spesso la tassazione non
rappresenta una strada percorribile: beni la cui domanda è inelastica sono, ad
esempio, i medicinali cd. salvavita, e tassarli sarebbe molto poco etico per un
governo. Gli sforzi fatti per eliminare quelle distorsioni su politiche aziendali quali
l’indebitamento o la distribuzione dei dividendi sono stati fatti, ma la strada è
ancora lunga: se da un lato è di fondamentale importanza semplificare l’accesso al
mercato del credito in un periodo di recessione, dall’altro è anche profondamente
ingiusto discriminare il ricorso al capitale di rischio perché meno conveniente,
almeno sul piano teorico, dell’indebitamento.
La perfezione di un sistema fiscale, che sia cioè capace di garantire efficienza e
piena equità nella tassazione e nella redistribuzione dei beni e dei servizi, è
probabilmente irraggiungibile, ma avvicinarsi alla quasi-perfezione dev’essere un
obiettivo di prim’ordine.
22 Confcommercio-­‐Imprese per l’Italia (2012), Una nota sulle determinanti dell’economia sommersa. 40 Ringraziamenti
Un primo e speciale ringraziamento va senz’altro al prof. Stefano Gorini, che mi ha
permesso di scegliere e affrontare in questo lavoro un tema che ha suscitato il mio
interesse nel corso degli sudi universitari.
Un altro ringraziamento va ai professori Javier Ruiz-Castillo e Silvia Mayoral Blaya,
docenti rispettivamente di Economia Pubblica e Gestione Finanziaria presso la
Universidad Carlos III de Madrid, perché grazie alla chiarezza delle loro lezioni ho
potuto riproporre in questo lavoro molti dei temi affrontati insieme.
In rappresentanza di tutti gli amici che sono stati al mio fianco durante
l’elaborazione di questo lavoro, ringrazio Ciro, formidabile compagno d’avventure
che, nonostante le difficoltà nel comprendere ed esprimersi in tutto ciò che
riguarda l’economia, ha sempre ascoltato i miei dubbi e le mie incertezze
sull’elaborato.
Infine, un immenso grazie ai miei genitori, Alberto e Donatella, per avermi
permesso di studiare in questi anni difficili, perché la sete di cultura non conosce
crisi.
41 Riferimenti bibliografici
Auerbach A. J. (2001), Taxation and Corporate Financial Policy, NBER Working Papers. A. J. Auerbach, M. P. Devereux, H. Simpson (2010), Taxing Corporate Income, in Dimensions of Tax Design, The Mirrlees Review, Oxford University Press, pp. 837-­‐913. Barrero F. D.; Laborda J. L.; Sauco F. R. (2005), ¿Afectan el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades a la elección de la forma de empresa?, Instituto de Estudios Fiscales, Hacienda Pública Española. Brealey R. A.; Myers S. C. (2003), Principles of Corporate Finance, 7 ed., McGraw-­‐Hill. De Mooij R.; Nicodème G. (2007), Corporate Tax Policy and Incorporation in the EU, European Commission Taxation Papers. Gordon R. H.; Lee Y. (2000), Do taxes affect corporate debt policy? Evidence from U.S. Corporate Tax Return Data, Journal of Public Economics, vol. 82, pp. 195-­‐224. Hines Jr. J. R. (2001), Corporate Taxation, NBER Working Papers. Knoll M. S. (2009), Reconsidering International Tax Neutrality, University of Pennsylvania Law School. MacKie-­‐Mason J. K. (1991), Taxes and the Choice of Organizational Form, NBER Working Papers. Meade J. E. (1978), The Structure and Reform of Direct Taxation, The Institute for Fiscal Studies, pp. 406-­‐428. Nicodème G. (2009), Corporate Income Tax and Economic Distortions, European Commission Taxation Papers. OECD (2008), Tax Effects on Foreign Direct Investment, OECD Policy Brief. Servaes H; Tufano P. (2006), Corporate Dividend Policy. The Theory and Practice of Corporate Dividend and Share Repurchase Policy, Deutsche Bank. Stiglitz J. E. (2000), Economics of the Public Sector, 3 ed., W. W. Norton & Company. 42 NOTE
43 44 45