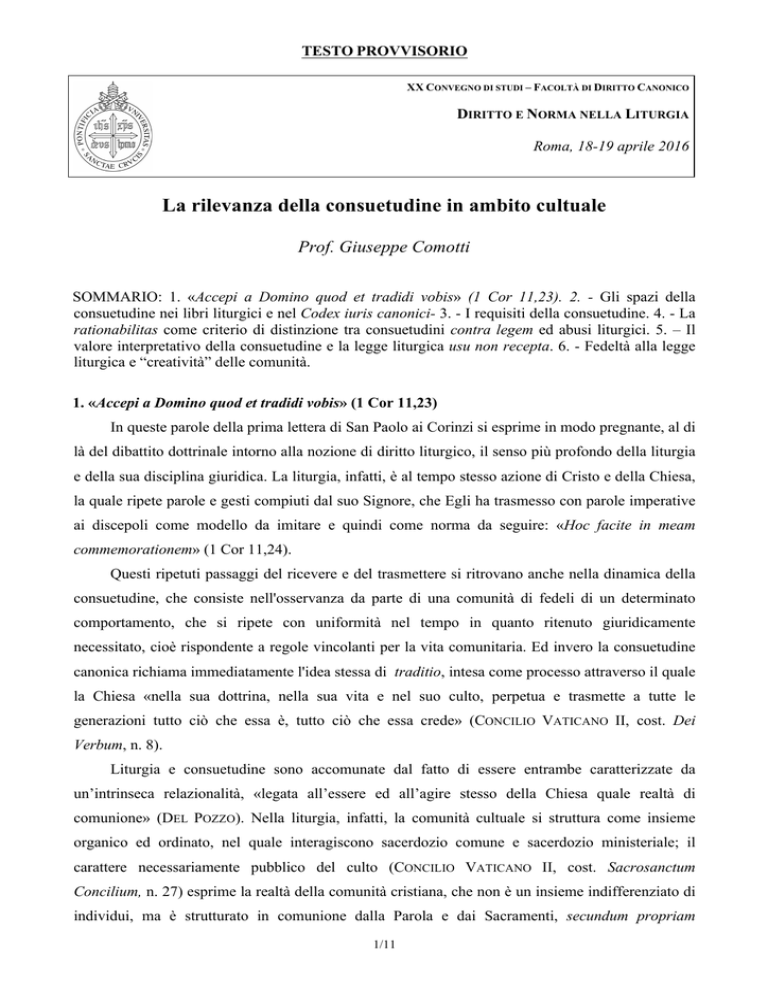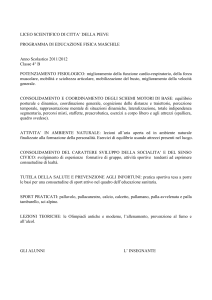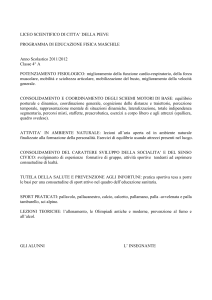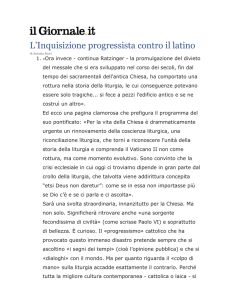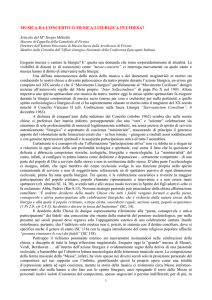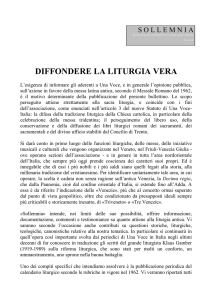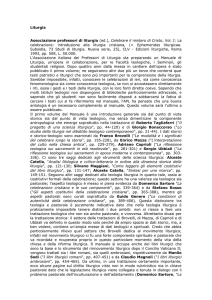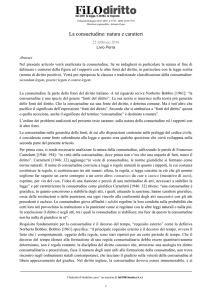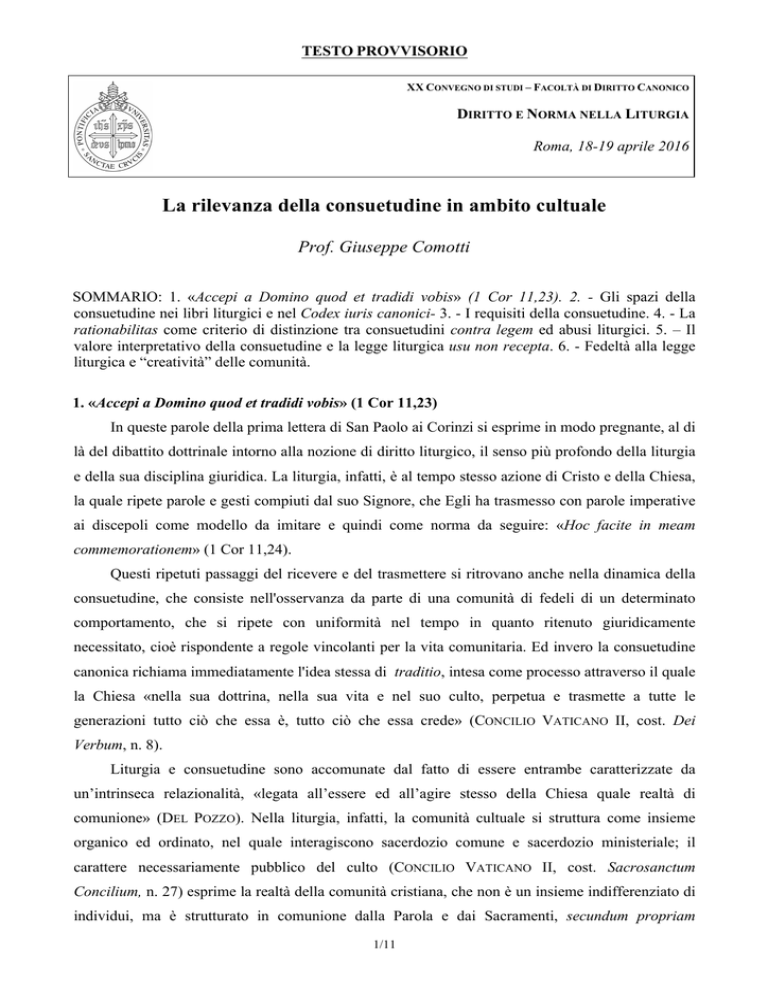
TESTO PROVVISORIO
XX CONVEGNO DI STUDI – FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
DIRITTO E NORMA NELLA LITURGIA
Roma, 18-19 aprile 2016
La rilevanza della consuetudine in ambito cultuale
Prof. Giuseppe Comotti
SOMMARIO: 1. «Accepi a Domino quod et tradidi vobis» (1 Cor 11,23). 2. - Gli spazi della
consuetudine nei libri liturgici e nel Codex iuris canonici- 3. - I requisiti della consuetudine. 4. - La
rationabilitas come criterio di distinzione tra consuetudini contra legem ed abusi liturgici. 5. – Il
valore interpretativo della consuetudine e la legge liturgica usu non recepta. 6. - Fedeltà alla legge
liturgica e “creatività” delle comunità.
1. «Accepi a Domino quod et tradidi vobis» (1 Cor 11,23)
In queste parole della prima lettera di San Paolo ai Corinzi si esprime in modo pregnante, al di
là del dibattito dottrinale intorno alla nozione di diritto liturgico, il senso più profondo della liturgia
e della sua disciplina giuridica. La liturgia, infatti, è al tempo stesso azione di Cristo e della Chiesa,
la quale ripete parole e gesti compiuti dal suo Signore, che Egli ha trasmesso con parole imperative
ai discepoli come modello da imitare e quindi come norma da seguire: «Hoc facite in meam
commemorationem» (1 Cor 11,24).
Questi ripetuti passaggi del ricevere e del trasmettere si ritrovano anche nella dinamica della
consuetudine, che consiste nell'osservanza da parte di una comunità di fedeli di un determinato
comportamento, che si ripete con uniformità nel tempo in quanto ritenuto giuridicamente
necessitato, cioè rispondente a regole vincolanti per la vita comunitaria. Ed invero la consuetudine
canonica richiama immediatamente l'idea stessa di traditio, intesa come processo attraverso il quale
la Chiesa «nella sua dottrina, nella sua vita e nel suo culto, perpetua e trasmette a tutte le
generazioni tutto ciò che essa è, tutto ciò che essa crede» (CONCILIO VATICANO II, cost. Dei
Verbum, n. 8).
Liturgia e consuetudine sono accomunate dal fatto di essere entrambe caratterizzate da
un’intrinseca relazionalità, «legata all’essere ed all’agire stesso della Chiesa quale realtà di
comunione» (DEL POZZO). Nella liturgia, infatti, la comunità cultuale si struttura come insieme
organico ed ordinato, nel quale interagiscono sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale; il
carattere necessariamente pubblico del culto (CONCILIO VATICANO II, cost. Sacrosanctum
Concilium, n. 27) esprime la realtà della comunità cristiana, che non è un insieme indifferenziato di
individui, ma è strutturato in comunione dalla Parola e dai Sacramenti, secundum propriam
1/11
TESTO PROVVISORIO
ciuiusque condicionem et munus.
Analogamente, la realizzazione di una consuetudine richiede il coinvolgimento dell’intera
comunità: è l’agire comunitario, infatti, e non la volontà del singolo («consuetudo a communitate
fidelium introducta»), che acquisisce valore normativo mediante l’approvazione del legislatore (can.
23). Il diritto consuetudinario non è però l’esito di un conflitto tra il potere del legislatore e la
volontà (per qualcuno: potestà) della comunità, la quale rivendichi spazi di libertà nei confronti
della gerarchia, quanto piuttosto l’espressione normativa dell’obbligatorietà della realtà sociale,
frutto del consensus, cioè del “cum-sentire” del legislatore con la comunità medesima.
In questa relazione non mi occupo della rilevanza che hanno avuto la consuetudini, dal punto
di vista storico, nello sviluppo e nella disciplina della liturgia della Chiesa. Basti, a tale riguardo,
citare quanto afferma, con riferimento al Rito romano, l’Ordinamento generale del Messale,
secondo il quale «questo Rito nel corso dei secoli non solo ha conservato gli usi liturgici che hanno
avuto origine nella città di Roma, ma in modo profondo, organico e armonico ha integrato in sé
alcuni altri usi che derivavano dalle consuetudini e dalla cultura dei diversi popoli e delle diverse
Chiese particolari dell’Occidente e dell’Oriente, acquisendo in tal modo un carattere che supera i
limiti di una sola regione» (n. 397).
Intendo piuttosto di considerare quale significato possa assumere, quali spazi possa occupare
oggi nel diritto della Chiesa, ed a quali condizioni, la produzione consuetudinaria di norme nella
disciplina liturgica. Va allora subito rilevato il divario notevole che si può riscontrare tra l’effettiva
incidenza che – storicamente – ha avuto la consuetudine in campo cultuale e lo stretto spazio che,
in linea teorica, è ad essa ora riservato dalla lex orandi: e questo a fronte della forza normativa che
invece il Codice riconosce in qualsiasi ambito dell’ordinamento canonico al diritto consuetudinario,
il quale, alle condizioni previste dal legislatore, può porsi anche contra legem e giungere addirittura
ad abrogare la legge stessa.
2. - Gli spazi della consuetudine nei libri liturgici e nel Codex iuris canonici
Per quanto riguarda i libri liturgici, il riferimento alla consuetudine ricorre in ben pochi casi:
ad esempio, l’Institutio generalis Missalis Romani si limita a rimettere espressamente alla
consuetudine: la scelta di stare in ginocchio dal Sanctus alla conclusione della preghiera eucaristica
e ancora al momento dell’Ecce Agnus Dei (n. 43); l’uso del campanello all’elevazione (n. 150); la
collocazione del tabernacolo nella Chiesa (n. 314); la lampada davanti al SS. Sacramento (n. 316);
l’uso delle vesti liturgiche di colore nero per le messe dei defunti (n. 346). Si osservi poi che, nei
casi considerati, l’Institutio sembra utilizzare il termine consuetudine più nel senso fattuale che
giuridico, cioè con riferimento a semplici usi, anche se non forniti di tutti i requisiti necessari a
configurare una consuetudine giuridica; si tratta comunque – con tutta evidenza - di spazi molto
2/11
TESTO PROVVISORIO
marginali.
Lo stesso può dirsi per i riferimenti alle tradizioni e consuetudini locali che si trovano nei
Praenotanda del Rito del Matrimonio (nn. 17, 20, 29, 39, 42, 43), del Rito della Dedicazione della
chiesa e dell’altare (nn. 31, 41, 42a, ecc.), del Rito del Battesimo dei bambini (n. 24,1), del Rito
delle esequie (nn. 2, 3, 14, 22), del Rituale delle Benedizioni, oppure nei Principi e norme sulla
Liturgia delle ore (nn. 136, 207, 265).
Meno parchi riferimenti si trovano nel Cerimoniale dei Vescovi (che non è propriamente un
libro liturgico), il quale, sebbene sia stato redatto, come recita il proemio, con l’espresso intento di
«opportunamente conservate le consuetudini e le tradizioni locali di cui ciascuna Chiesa particolare
gode come di proprio tesoro, da trasmettere alle future generazioni, rese conformi alla liturgia
rinnovata dal concilio Vaticano II» (n. 2), si limita a rimettere alle consuetudini ben poco (per
esempio, l’incensazione del Capo di Stato presente alla celebrazione e lo scambio con questi
dell’abbraccio di pace da parte del diacono: nn. 97 e 102).
Questa parsimoniosa considerazione delle consuetudini da parte delle fonti liturgiche appare
evidente espressione del processo storico di involuzione del diritto consuetudinario rispetto agli
spazi sempre più ampi conquistati dal diritto legislativo, soprattutto a partire dal Concilio
Tridentino, a seguito del quale non solo sono entrati nei libri liturgici i dispositivi rubricali, ma la
produzione normativa circa la liturgia è stata riservata in via pressoché esclusiva all’autorità
suprema della Chiesa, che solo con il Concilio Vaticano II riprenderà a prevedere specifiche
competenze dei Vescovi e delle Conferenze episcopali, secondo la tripartizione
attualmente
considerata dal can. 838.
Il Codex iuris canonici del 1983, come è noto, pur contenendo disposti volti a regolare la
trama delle relazioni giuridiche che si pongono nell’esercizio del munus sanctificandi e soprattutto
le condizioni di validità degli atti di natura sacramentale, nel can. 2 espressamente esclude la
liturgia dal proprio ambito disciplinare; nel contempo, tuttavia, il Codice ha affermato la propria
preminenza su tutte le leggi liturgiche vigenti al momento della sua entrata in vigore, facendole
salve solo nella misura in cui esse non sono ad esso contrarie. Inoltre, sebbene il diritto liturgico
non sia, per la gran parte, contenuto nel Codice, non vi è dubbio che ad esso si applichino, in
particolare, le norme generali del Libro I, che disciplinano le fonti del diritto e la loro
interpretazione. Conseguentemente, la consuetudine può avere anche nella liturgia valore normativo
pari a quello della legge ecclesiastica, secondo quanto stabiliscono i cann. 23-28,
indipendentemente dagli spazi che le riconoscono le fonti liturgiche scritte. Va anzi precisato che la
regolamentazione della liturgia avviene sia mediante la pubblicazione di libri liturgici, che sono da
osservare obbligatoriamente nelle celebrazioni in forza del can. 846, §1, sia per mezzo di istruzioni
e decreti, che sono però fonti subordinate alla legge e quindi anche alla consuetudine, la quale,
3/11
TESTO PROVVISORIO
avendo vis legis, prevale logicamente su tutti gli atti che tale forza non hanno.
Vale pertanto anche per il diritto liturgico quanto deve dirsi della consuetudine con
riferimento ad ogni altro settore dell’ordinamento della Chiesa: a seconda che il diritto
consuetudinario si ponga in rapporto, rispettivamente, di conformità, di estraneità o di contrarietà a
quello prodotto dalle leggi liturgiche, si dovrà distinguere tra consuetudini secundum legem, praeter
legem, contra legem. In ragione poi dell'ambito di applicazione, si dovranno distinguere
consuetudini universali, riguardanti l'intera Chiesa, e consuetudini particolari, che interessano
comunità più circoscritte.
A quest’ultimo riguardo, ritengo opportuno evidenziare che, in forza dell'approvazione
generale data dal Supremo Legislatore a tutte le consuetudini, tanto universali quanto locali, che
posseggano i requisiti previsti dal Titolo II del Libro I del Codex iuris canonici, al diritto
consuetudinario non è preclusa la produzione normativa in materie riservate al Legislatore
universale, superando così i limiti in cui è invece circoscritta la competenza legislativa in materia
liturgica dei Vescovi diocesani e delle Conferenze episcopali, che in ogni caso, in forza del can.
135, § 2, non possono porre validamente una legge contraria al diritto superiore.
3. - I requisiti della consuetudine
Affinché vi sia produzione normativa mediante la consuetudine, devono realizzarsi le
condizioni o requisiti cui è condizionata l’approbatio legislatoris, che distinguono la consuetudine
propriamente detta o consuetudine giuridica (consuetudo iuris) dal semplice uso (consuetudo facti),
il quale non ha invece valore normativo.
Tra questi requisiti, vi è innanzitutto la riconducibilità del comportamento consuetudinario ad
una comunità di fedeli che sia, come dice il can. 25, capax legis saltem recipiendae. Questo
requisito richiede una peculiare precisazione nella materia che qui ci occupa: se, infatti, «le azioni
liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa» (can. 837, § 1; cfr. cost.
Sacrosanctum Concilium, n. 26; ), nel loro svolgimento chi presiede svolge un ruolo attivo più
evidente rispetto al resto dell’assemblea, la quale a propria volta quasi mai è composta da tutti i
membri della comunità cristiana e molto spesso neppure dalla maggioranza degli stessi.
Affinché si possa parlare di comportamento riferibile alla comunità nel suo complesso,
ritengo non sia necessario che tutti i membri della comunità pongano in essere l’azione materiale in
cui si sostanzia la consuetudine: se così fosse, infatti, non sarebbe mai realizzabile una consuetudine
riguardante gesti o comportamenti che solo chi presiede la liturgia oppure i ministri sacri sono in
grado di compiere (si pensi, ad esempio, all’uso delle vesti liturgiche); analogamente, se così fosse
inteso tale requisito, non potrebbe mai realizzare una consuetudine in ambito liturgico quella
comunità la cui maggioranza dei membri non partecipi abitualmente alle celebrazioni.
4/11
TESTO PROVVISORIO
In realtà, ciò che rende riferibile alla comunità l’azione materiale è la conspiratio, il
consensus di quei fedeli che partecipano abitualmente alla vita liturgica della comunità cristiana e
che perciò sono in grado di individuare determinati comportamenti come vincolanti per la coesione
comunitaria in ambito cultuale: per usare espressioni della tradizione canonica, si può dire che la
consuetudine viene realizzata non tanto dalla maior pars, ma della sanior pars della comunità,
quella cioè animata da una reale volontà d’azione cristiana ed effettivamente impegnata
nell’edificazione della Chiesa.
Tali considerazioni sono necessariamente collegate ad un altro requisito: la configurazione di
una consuetudine giuridica, infatti, che l’elemento materiale sia posto in essere cum animo iuris
inducendi, cioè con la volontà di realizzare l’azione materiale in quanto avvertita come conforme o
necessaria al bene comune, percependola come «testimonianza di fede indispensabile alla coesione
comunitaria» (BONNET).
Anche qui si potrebbe osservare che il requisito dell’animus iuris
inducendi sembra richiedere alla comunità una partecipazione al processo di produzione normativa
tecnicamente ancor più qualificata rispetto all’animus se obligandi previsto dal Codice del 1917,
che comporterebbe nei fedeli preparazione e conoscenze giuridiche difficilmente rinvenibili o ben
poco diffuse, per cui la formazione di consuetudini potrebbe aversi assai di rado.
Le singole volontà individuali, di per se stesse, non si pongono come norma per la collettività
e sono, in genere, rivolte al compimento del singolo atto; l’animus communitatis richiesto dal
Codice non va dunque attribuito ai singoli individui che agiscono, ma alla comunità
complessivamente intesa. Esso perciò non può essere fatto coincidere con la somma dei fattori
psicologici individuali che sorreggono il comportamento consuetudinario nella sua formazione, ma
è il frutto dell’apprezzamento ex post di tale comportamento in termini di rispondenza al bene della
comunità stessa, così come si richiede nel fine che deve proporsi il legislatore nel promulgare la
legge.
4. - La rationabilitas come criterio di distinzione tra consuetudini contra legem ed abusi
liturgici
Tale collegamento tra osservanza consuetudinaria di una regola di condotta e bene comune
viene espresso anche dal requisito della rationabilitas che l'uso comunitario deve possedere per
poter acquisire forza normativa, secondo quanto prevede il can. 24, § 2.
Non diversamente dalla legge canonica stessa e, più in generale, da ogni attività pubblica
nella Chiesa, neppure per la consuetudine può ritenersi sufficiente quella che i canonisti chiamano
rationabilitas negativa, cioè la mera non-contrarietà al diritto divino del comportamento normato,
ma deve esigersi una rationabilitas positiva, cioè il concorso di tutte le condizioni necessarie ad
legem iustam (SUAREZ, De legibus, VII, VI, 14-16), che possono compendiarsi nell’ordinatio ad
5/11
TESTO PROVVISORIO
bonum commune di ogni atto che pretenda essere normativo nella Chiesa. La produzione normativa
implica infatti sempre un giudizio prudenziale, che pone in correlazione il bene comune con la
realtà ecclesiale che si pretende di normare: tale giudizio, che nella produzione della legge è
riservato al soggetto che la promulga, nella consuetudine viene espresso rebus ipsis et factis dalla
comunità stessa, la quale è destinataria della norma che materialmente produce.
Il riferimento alla rationabilitas così intesa diventa oltremodo necessario quando si ragioni
intorno alle consuetudini contrarie alla legge. Esse, infatti, secondo la previsione codicistica, hanno
una forza normativa che prevale sugli stessi disposti legislativi, purché, oltre agli altri requisiti,
siano appunto – come le consuetudini praeter legem - rationabiles, esprimano cioè una ratio
correlata al bene comune.
È questa ragionevolezza che consente, più di ogni altro requisito, di distinguere l'uso con forza
normativa, cioè la consuetudine giuridica, dalla consuetudine di fatto, cioè dal semplice uso, il
quale, realizzandosi in opposizione alla legge, deve qualificarsi come illegittimo, cioè come abuso.
Mentre la consuetudine può produrre diritto anche contra legem, proprio perché è rationabilis e
perciò non è contra ius, l'abuso, non avendo una propria ragionevolezza che vinca quella della
legge, si pone al tempo stesso contra legem e contra ius.
Queste precisazioni assumono un rilevo peculiare in ambito liturgico, dove la pratica diffusa
di comportamenti posti in violazione delle norme ha caratterizzato il periodo postconciliare, con la
pretesa di rivendicare maggiori spazi ora all'inculturazione, ora alla creatività delle comunità.
Anche il Magistero recente ha ripetutamente preso atto della situazione e in molti casi ha
richiamato alla stretta osservanza delle norme e delle rubriche. Nonostante le leggi liturgiche
stabilite per la forma ordinaria del Rito romano prevedano molte eccezioni e varietà legittime di
applicazioni e di formulari (una pluriformità che aumenta nel passaggio dalla editio typica latina
alle versioni nazionali), un gran numero di sacerdoti si arroga il diritto di ulteriormente ampliare,
con fervida fantasia o con discutibili improvvisazioni, lo spazio lasciato alla "creatività", attuando
l’arbitrario cambiamento di parole o di intere frasi rispetto a quelle fissate nei libri liturgici: un
abuso che l'istr. Redemptionis Sacramentum definisce «riprovevole», in quanto rende instabile la
celebrazione della sacra Liturgia e non di rado ne altera il senso autentico (n. 59); oppure capita che
vi sia l'inserimento di "riti" nuovi, del tutto estranei alla tradizione della Chiesa, o ancora l'uso di
paramenti, vasi e suppellettili sacre che poco di sacro hanno, spesso rasentando e talora superando
il ridicolo.
Quando l'azione di pochi, se non addirittura unicamente di chi presiede l'azione liturgica,
suscita nei fedeli sconcerto, disapprovazione, scandalo, essa non è certo suscettibile di diventare
consuetudine normativa, in quanto non vi è il consenso della comunità, ma resta un uso illegittimo,
cioè un abuso: un fenomeno da reprimere, in primo luogo, a tutela del diritto dei fedeli stessi ad
6/11
TESTO PROVVISORIO
un'azione liturgica che sia genuina espressione della vita della Chiesa secondo la sua tradizione e la
sua disciplina (cfr. istr. Redemptionis Sacramentum, n. 11); tutti i fedeli, infatti, «godono del diritto
di avere una liturgia vera e in particolar modo una celebrazione della Santa Messa che sia così come
la Chiesa ha voluto e stabilito, come prescritto nei libri liturgici e dalle altre leggi e norme» (ivi, n.
12). I vescovi diocesani, che sono «moderatori, promotori e custodi di tutta la vita liturgica della
Chiesa loro affidata» (can. 835 § 1), hanno il dovere di «vigilare perché le norme stabilite dalla
legittima autorità siano attentamente osservate e in particolare ciascuno, tanto i ministri come i
fedeli, svolga l’incarico che gli spetta e non altro, senza mai introdurre cambiamenti nei riti
sacramentali o nelle celebrazioni liturgiche secondo preferenze o sensibilità personali» (Direttorio
per il ministero pastorale dei vescovi, n. 145; v. anche n. 150 e can. 392, §2).
Gli usi contrari alla legge, in quei casi in cui essi sono espressamente riprovati, sono affetti da
un'invincibile irrationabilitas, come statuisce il can. 24, §2, per cui essi non potranno, neppure con
il decorso del tempo, acquisire forza normativa. Nell'istr. Redemptionis Sacramentum, ad esempio,
vengono riprovati: l'uso di spezzare l'ostia al momento della consacrazione (n. 55); l'uso che
l'omelia nella celebrazione eucaristica venga tenuta da fedeli non ordinati (n. 65); la sospensione
arbitraria della celebrazione della santa Messa per il popolo, contro le norme del Messale e la sana
tradizione del Rito Romano, con il pretesto di promuovere «il digiuno eucaristico» (n. 115); l'uso di
vasi comuni o di qualità scadente per accogliere il Corpo ed il Sangue del Signore (n. 117); la
celebrazione della Messa senza vesti liturgiche o con la sola stola (n. 126); la distribuzione della
comunione da parte dei ministri straordinari quando vi siano ministri ordinati in grado di farlo (n.
157).
D'altro canto, la mancanza di reazioni da parte della comunità di fronte alla violazione della
legge liturgica non è per sé sola sufficiente a far ritenere che vi sia il consensus necessario alla
formazione di una consuetudine contra legem. Questa infatti, sebbene non richieda la volontà della
comunità di derogare alla legge liturgica violata (che verosimilmente non è neppure conosciuta
dalla gran parte dei fedeli), deve avere i caratteri della ragionevolezza che, come già si diceva, non
dipende solo dalla necessaria conformità al diritto divino dell'uso comunitario, ma anche dall’essere
tale comportamento ritenuto indispensabile per il proprio bene dalla comunità che lo osserva nel
tempo. La legge liturgica potrà perciò venire derogata e, con il decorso del tempo addirittura
abrogata, da una consuetudine contraria solo allorquando il comportamento comunitario esprima
rebus ispis et factis la consapevolezza che viene in tale modo favorito efficacemente l’inveramento
della Parola hic et nunc, cioè nelle circostanze di tempo e di luogo in cui la comunità vive e pratica
il culto. In altri termini, se la consuetudine si realizza necessariamente – come la liturgia - mediante
atti esteriori, questi «devono essere illuminati dalla fede e dalla carità che ci uniscono a Cristo e gli
uni agli altri», in modo che anche le consuetudini liturgiche – non diversamente dalle parole o i riti
7/11
TESTO PROVVISORIO
disciplinati dalla lex orandi - siano «espressione fedele dei sentimenti di Cristo e ci insegnino a
sentire come Lui» (istr. Redemptionis Sacramentum, proemio).
5. – Il valore interpretativo della consuetudine e la legge liturgica usu non recepta
Finché non sarà decorso il periodo di 30 anni, attualmente previsto dal codice affinché la
consuetudine acquisti forza di legge (can. 26), non si produrranno gli effetti abrogativi di una legge
contraddetta da usi contrari; questi tuttavia, non saranno irrilevanti in ordine alla valutazione di
ragionevolezza del disposto legislativo non attuato.
Infatti, anche con riferimento al diritto liturgico, vale la regola ermeneutica enunciata dal can.
27, secondo il quale «Consuetudo est otima legum interpres». Si tratta di una massima breve e
difficile, dovendosi registrare diversità di posizioni in dottrina già sulla sua estensibilità alla
semplice consuetudo facti, cioè all'uso della comunità che non abbia tutti i requisiti propri della
consuetudo iuris e, per la quale, in particolare, non sia trascorso ancora il periodo della legitima
praescriptio.
In ogni caso, l'asserzione del can. 27 «non può essere intesa in relazione con il testo della legge
(altri sarebbero in grado di capire meglio della comunità le formulazioni legali), ma in riferimento
all'applicazione della legge alla realtà da essa regolata» (BAURA). In questo senso, nell'observantia
legis da parte della comunità, è sempre ravvisabile un effetto "confermativo" della razionalità della
legge, espresso da Graziano nel famoso dictum post D. 4, c. 3: «leges firmantur cum morbus
utentium approbantur».
Nella prospettiva di una disciplina ecclesiale che non venga concepita come il frutto della
contrapposizione tra autorità e comunità, la tradizionale tripartizione del diritto consuetudinario
secundum legem, praeter legem e contra legem deve allora essere valorizzata, pure in ambito
liturgico, in senso biunivoco, vale a dire anche nei confronti della legge rispetto alla consuetudine.
Se l’acceptatio legis non è certo necessaria per l’acquisto di forza vincolante del comando del
legislatore, essa ne condiziona indirettamente la conservazione di forza obbligatoria, venendo a
costituire un indispensabile parametro di valutazione della razionalità della legge stessa. Dovendosi
ritenere che il legislatore non intenda mai obbligare ad destruendum, bensì ad aedificandum, il
mancato recepimento della legge, che non sia riprovato, né sia contrario al diritto divino e non sia
riconducibile a ragioni futili, oppure al dispregio o alla ribellione nei confronti del legislatore,
potrebbe essere indice emblematico del carattere non realistico della legge medesima e della sua
inadeguata visione della realtà che pretende di disciplinare. In questi termini, però, verrebbe meno
la rationabilitas della legge e si avrebbe pertanto anche la sua cessazione ab intrinseco: infatti le
leggi - comprese quelle liturgiche - che non siano realistiche, risultano in pratica inutili o
impossibili da compiere e talora potrebbero essere addirittura nocive, perché introducenti uno
8/11
TESTO PROVVISORIO
squilibrio nella vita della comunità, dalla quale si esige un comportamento che essa non è in grado
di osservare.
Per analoghe ragioni, va attentamente valutata la rationabilitas delle leggi che si
contrappongano o pretendano di abrogare consuetudini consolidate, come talora è improvvidamente
avvenuto nel contesto della riforma liturgica postconciliare. Sant’Agostino esprime una valutazione
negativa circa qualsiasi intervento autoritativo avverso agli usi della comunità cristiana, che non
trovi ragione nella necessità di reprimere quelli contrari alla fede o alla morale ed esorta a grande
prudenza, invitando a considerare, in particolare, se i vantaggi apportati con il cambiamento non
siano inferiori al danno che esso potrebbe arrecare: infatti, «mutatio consuetudinis, etiam quae
adiuvat utilitate, novitate perturbat» (Epistola LIV, 5, 6).
Il diritto prodotto o manifestato per via consuetudinaria ha invece il pregio, per la propria
natura, di essere immune da crisi di rigetto conosciute dalla norma legislativa, perché la norma
consuetudinaria è solo se viene osservata, e quindi non si può distinguere il momento della
previsione astratta rispetto a quello attuativo, a differenza di quanto accade con la legge, la cui
mancata attuazione potrebbe ricondursi all'«estraniamento culturale» della previsione normativa
(BONNET) rispetto alla realtà effettiva delle comunità cristiane per le quali essa è stata formulata.
Un esempio concreto può farsi con riferimento alle rubriche liturgiche, il cui linguaggio è a
volte meramente «descrittivo», cioè volto ad illustrare in modo indicativo le modalità di
compimento di una determinata azione; altre volte le rubriche sono invece «prescrittive o
dispositive», nel senso che obbligano a tenere un determinato compimento, oppure lo vietano; in
altri casi ancora le rubriche sono «esortative», quando cioè non richiedono in modo vincolante una
pratica, ma la consigliano o raccomandano vivamente (expedit, laudabiliter, valde commendatur:
cfr. Institutio generalis Missalis Romani, nn. 65-66, 73, 80, 83, 84-88, 281-287), oppure la lasciano
alla discrezionalità valutativa di chi presiede, tenendo conto delle circostanze (ad libitum, pro
opportunitate, si casus fert). Ebbene, l’uso della comunità – a maggior ragione se possiede i
requisiti della consuetudine giuridica - è uno strumento di notevole rilevanza nell’applicazione delle
previsioni rubricali, la cui obbligatorietà o meno potrà configurarsi nella realtà in modo diverso da
quello che è il loro tenore letterale, evitando così «eccessive rigidità o pretese assolutizzazioni
attuative» (MONTAN), magari rimesse all’arbitrio di pochi.
Le consuetudini particolari, in questo senso, non solo costituiscono uno strumento privilegiato
di salvaguardia delle diversità culturali radicate nella differenziazione delle genti che formano la
Chiesa ed al tempo stesso peculiarmente coerente alla struttura della Comunione ecclesiale, ma
possono anche fornire quella «risposta creativa, sempre inedita» che le Chiese locali devono dare
all’incontro del Vangelo con le diverse culture (CATTANEO).
9/11
TESTO PROVVISORIO
6. - Fedeltà alla legge liturgica e “creatività” delle comunità
L'interpretazione delle norme liturgiche attuata nella prassi ha un ulteriore compito di
adeguazione e di adattamento, tanto più necessari quanto più la formula astratta si allontana - nel
tempo e nello spazio - dall'ambito concreto di applicazione. La comunità che si adegua al disposto
legislativo non si arresta certo alla rievocazione del senso originario dello stesso, come se si
trattasse di un elemento storico avente un senso concluso di per sé, ma ne dimostra la praticabilità e
quindi il vigore attuale, coniugando la volontà del legislatore con la realtà cultuale, che ha costituito
l'oggetto della previsione legislativa.
È chiaro che non sarebbe ammissibile che la consuetudine, restando interpretativa, potesse
pervenire a risultati estranei o contrari alla voluntas legislatoris; anche nel diritto canonico, tuttavia,
tale volontà non può correttamente intendersi in senso strettamente psicologico, ma normativo:
nulla perciò impedisce di concepire la legge liturgica come una legislazione "aperta", soggetta ad
un'interpretazione consuetudinaria che, lungi dal potersi definire praeter o addirittura contra legem,
ha l’effetto di tradurre in pratica una normazione già contenuta in nuce nel dettato legislativo. Dal
momento, infatti, che la legge è diretta ad una universalità di casi più varia e complessa di quella
che può storicamente indurre il legislatore all'emanazione della legge, essa non può non prevedere
che le condizioni determinanti la rationabilitas dei propri disposti possano mutare a seconda dei
tempi e dei luoghi di applicazione: tanto più quanto si consideri la complessa realtà dell'orbs totus,
che è l'ambito territoriale di applicazione delle leggi canoniche liturgiche, in considerazione della
quale divengono imprescindibili le esigenze di adattamento ed armonizzazione con la variegata
realtà delle Chiese locali.
Indubbiamente la «fedeltà» agli aspetti normativi e disciplinari delle fonti liturgiche sulla
quale insistono il Codice e ripetutamente i Romani Pontefici, «ha consentito di assicurare lungo i
secoli l’ortodossia delle formule di preghiera e l’unità ecclesiale intorno all’unità liturgica»
(MONTAN), che tuttavia non significa uniformità. Lo stesso Concilio Vaticano II ha ribadito che,
anche nella liturgia, «la Chiesa non desidera imporre una rigida uniformità nelle cose che non
riguardano la fede o il bene di tutta la comunità» (cost. Sacrosanctum Concilium, n.37; cfr. nn. 21 e
23).
Se la liturgia deve essere liturgia della Chiesa, non del singolo celebrante o di un gruppo
particolare - ed è questo il senso più profondo dell'esistenza di norme liturgiche vincolanti per tutti
coloro che si muovono nello spazio della liturgia - ciò non implica che non possano esservi una
comprensione ed un’attuazione diversificate nello spazio e nel tempo delle azioni liturgiche. In
questo senso, la «fedeltà» alle norme non lascia certo spazio ad arbitrî personali, ma, al tempo
stesso, non determina una sorta di immobilismo. Non solo chi presiede l’assemblea liturgica, ma
l’assemblea stessa nel suo complesso può, specialmente attraverso la consuetudine, esprimere
10/11
TESTO PROVVISORIO
quella piena, cosciente e attiva partecipazione, che è richiesta dalla natura stessa della liturgia ed
alla quale i fedeli hanno diritto.
Sotto tale aspetto, sarebbe perciò riduttivo e fuorviante considerare con atteggiamento di
sufficienza o, all'opposto, di diffidenza la consuetudine nella liturgia, alla stregua di similari
fenomeni sociologici, che, rispondendo a precise leggi di psicologia sociale, è dato di rinvenire in
molti ordinamenti giuridici.
Nella Chiesa l'efficacia normativa del comportamento comunitario, in ultima istanza, deve
piuttosto venire sempre ricondotta, secondo l'incisiva espressione del Codex canonum Ecclesiarum
orientalium, alla rispondenza dell'azione della comunità all'«actuositas Spiritus Sancti in corpore
ecclesiali» (can. 1506, §1): una rispondenza all’azione dello Spirito che si esprime non nell'illusoria
libertà di fare tutto ciò che si vuole, ma nella libertà di fare ciò che è degno e giusto.
11/11