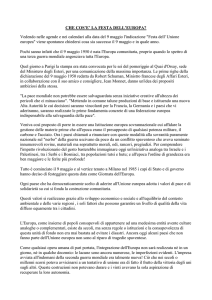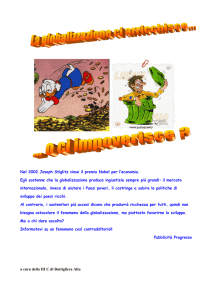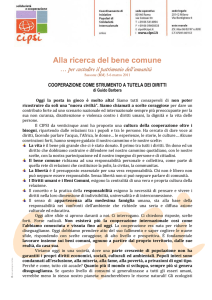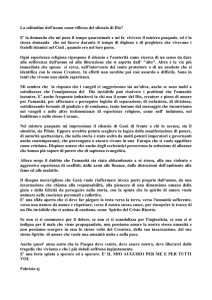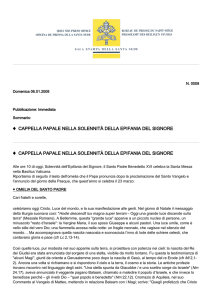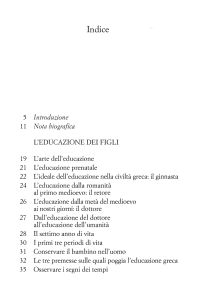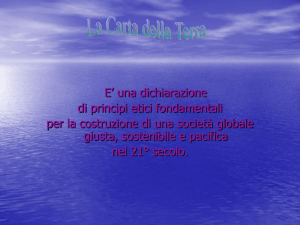Chiesa di San Martino in Greco, 11 marzo 2016
Abramo padre di una moltitudine di nazioni
(Gn17, 5c)
di Bruno Segre
Il patriarca Abramo (Abraham in ebraico) è capostipite di nazioni e popoli che in lui sono benedetti.
Nella prospettiva biblica, le benedizioni che Dio rivolge a Israele non escludono le altre nazioni.
Ishma’el (Ismaele), il primogenito di Abramo, nella tradizione ebraica è il capostipite dei “popoli
arabi e islamici”. ’Esau (Esaù), primogenito di Itzhaq (Isacco), il secondo dei patriarchi, è il
capostipite dei “popoli cristiani”. Nella ghematria, cioè nella numerologia cabbalistica, la
consonante ebraica yud corrisponde al numero dieci. La consonante he corrisponde al numero
cinque. La consonante he di Abraham è il segno di una presenza divina che avvolge il mondo
intero. Trasferitasi dalla moglie Sarai (che perde la yud diventando Sarah) al marito (che da Abràm
diventa Abraham), la duplice he di Abraham e di Sarah è il segno di una benedizione, di un
rinnovamento che appartiene al mondo intero. Nell’ebraismo biblico l’umanità è rappresentata
come una grande famiglia simbolicamente formata da settanta popoli: settanta, come il numero di
coloro che con Giacobbe scesero in Egitto.
L’idea che esista un dio particolare per ogni nazione è indice di tribalismo. Il monoteismo biblico
insegna per la prima volta all’essere umano a uscire fuori e al di là della sua polis, del suo Stato,
della sua nazione o tribù per rivolgersi all’umanità intera. Dio, creatore dell’universo, fa la sua
alleanza con l’intera umanità (l’Arca di Noè). Il che peraltro non si traduce nella proposta di una
fede unica, di un solo credo, di una sola strada. Dio infatti, facendo spazio alle differenze, volge poi
la sua attenzione a un popolo particolare. E dando corpo alla sua alleanza con il popolo ebraico,
ammette la possibilità che gli altri popoli, le altre culture possano avere proprie relazioni con
l’unico Dio nel contesto delle leggi di Noè. In sostanza, l’unità di Dio si riflette nell’infinita
ricchezza e diversità della sua creazione. La dignità umana è radicata nel fatto che ognuno di noi è
unico e irripetibile. Nella prospettiva dell’etica biblica, l’essenza del mondo sta nella sua illimitata
intima diversità: biologica, personale, culturale, religiosa.
Abraham è un ebreo (’ivrì) perché è altrove, non nel senso fisico e materiale del termine, ma con la
mente e con lo spirito. Il suo orizzonte mentale è una giustizia rivolta a tutta l’umanità e che si
estende anche al mondo animale e vegetale. La vita degli ebrei nella diaspora non è stata solo una
valle di lacrime. Diaspora ed esilio non sono sinonimi. L’immagine della Sukkah, cioè della
capanna in cui dimorarono gli ebrei nel deserto, non è un’immagine di perdita, ma di una presenza
di vita che nessuna realtà statale potrebbe mai surrogare. Il rapporto che l’ebraismo intrattiene con
la Terra non è di appropriazione, né di saccheggio, né di dominio. La memoria della condizione
straniera in terra d’Egitto è un appello rivolto al futuro, che assume il sentimento di estraneità come
valore costitutivo dell’essere umano contro la tentazione regressiva dell’idolatria nazionalistica e
statalistica. La condizione straniera, come ripete con insistenza il Deuteronomio, è una condizione
ontologica che prescinde dalla condizione materiale e dalla sovranità. La libertà non si misura sul
potere che si ha sugli altri. Quella è la libertà del Faraone, che conduce il mondo alla catastrofe. La
condizione straniera è intrascendibile, non è una questione di territorio o di provenienza.
Oggi la globalizzazione ha trasformato il nostro mondo in un piccolo paese in cui tutti sono
stranieri. È doveroso domandarci, allora, se siamo capaci di riconoscere l’immagine di Dio in colui
che non sembra fatto a nostra immagine, in uno straniero. È essenziale che per noi le differenze
cessino di essere una minaccia di conflitto per trasformarsi in un invito a sentirci arricchiti dalle
specifiche diversità degli altri. Occorre impedire che le nostre distinte identità creino un’artificiosa
tensione tra un “noi” e un “loro”.
Tutte e tre le grandi religioni del ceppo di Abramo ‒ ebraismo, cristianesimo e islam ‒ hanno
sviluppato al proprio interno, nel corso dei secoli, vocazioni all’inclusione e all’apertura accanto a
pericolosissime forme di esclusione e di chiusura: con significativi riflessi anche circa il modo
d’affrontare il grande, centrale tema del rapporto con l’altro, con il diverso da sé, con lo straniero.
Ciascuna di queste grandi religioni fa riferimento a un deposito di sapere teologico elaborato in
tempi più o meno remoti. E sulla base di tale sapere, attorno alla parola di Dio e alla divina
rivelazione, ciascuna fa circolare un suo specifico discorso con proiezioni importanti nei campi
dell’etica, dei rapporti e dei costumi sociali, della vita politica, dell’organizzazione economica,
degli orientamenti che si presume debbano guidare la storia della stessa umanità. Ma prima ancora
di interrogarci su che tipo di contributo queste tre vetuste e autorevoli correnti di cultura religiosa
siano in grado di dare per restituirci uno spazio di civile convivenza, non è forse vero che esse si
trovano oggi di fronte al compito gravoso e urgente di rapportarsi in termini positivi, ciascuna al
proprio interno e secondo modalità sue proprie, con la contemporaneità?
Provo a spiegarmi, e per farlo mi limiterò qui a menzionare un paio di temi che, quando non
vengano elusi, si collegano a ben vedere anch’essi a quella dimensione di apertura che è implicita
in un rapporto costruttivo con l’altro, con il diverso da sé, con lo straniero. Il primo tema ha a che
fare con le sempre più pressanti e diffuse rivendicazioni espresse, nei confronti di strutture clericali
tradizionalmente maschiliste, da parte dell’universo femminile, tanto sul piano dell’impegno diretto
delle donne nella gestione delle istituzioni, quanto su quello della partecipazione, con pari dignità
per le donne, ai momenti più significativi della vita liturgica. Un secondo tema è quello della
salvaguardia, all’interno di ciascuna cultura, di una reale libertà religiosa, la quale viene di fatto
calpestata o messa a repentaglio
quando apparati istituzionali retrivi e
ossificati neghino
all’articolata pluralità delle espressioni religiose la necessaria legittimazione. Pari dignità per le
donne, libertà e pluralismo religioso sono dunque alcuni dei temi attorno ai quali è auspicabile che
ciascuna delle citate antiche culture religiose faccia emergere un grado di consapevolezza tale da
consentirle di offrire risposte adeguate.
Stiamo vivendo in un mondo globalizzato, complesso, che attraversa una fase di profondissima
trasformazione. La globalizzazione è un processo molto destabilizzante, che l’umanità nel suo
insieme non sta agendo ma sta subendo. I cambiamenti di natura ambientale superano oggi molte
volte le nostre capacità interiori di adattarvici. Le trasformazioni che tecnologie sempre nuove e
cangianti inducono nella cultura materiale sono molto più rapide delle nostre capacità di risposta
immateriale, mentale e culturale. Per usare un’espressione cara a Zygmunt Bauman, da pellegrini
del mondo diventiamo dei turisti, e la società va per gradi assomigliando più a un albergo che a una
casa. Si vanifica il concetto di appartenenza, “le zone della stabilità personale” diventano sempre
più incerte a misura che si svuotano le istituzioni destinate a regolare la vita sociale. Assistiamo a
un collasso del linguaggio morale: alla parola “devo” si sostituisce il termine “voglio”, mentre
osserviamo un trasferimento delle responsabilità per l’educazione, la salute, il welfare, dalle
famiglie e dalle comunità al mercato. Nell’era globale, la dimensione morale del mercato sconta il
fatto che l’idea di scambio, che è il cuore dell’economia di mercato, è sì efficiente nel creare la
ricchezza ma non nel distribuirla. In tanto il mercato si rivela inaccettabile in quanto esso non offre
un sostegno alla vita sociale ma la indebolisce attraverso la rottura dei legami di solidarietà e il
crescente divario tra i ricchi e i poveri. Il risultato è che siamo davanti a un massimo di insicurezza
con il minimo delle risorse per affrontarla. Sembra che la globalizzazione e l’insicurezza che essa
crea siano fuori del nostro controllo.
Una delle ricadute più paradossali e generali della globalizzazione
è quella che chiamerò
“balcanizzazione endemica e pervasiva di genti e territori”. Allorché, attorno al 1990,
la
dissoluzione dell’Urss pose termine a decenni di guerra fredda, vi fu chi fantasticò sulla ‘fine della
storia’ e sulla nascita di un nuovo ordine mondiale. In realtà, ci stiamo ora rendendo conto che il
pianeta Terra ─ un pianeta molto densamente popolato e sempre più piccolo ─ è dominato da un
disordine globale rischiosissimo, nelle cui pieghe si celano e si scaricano tensioni economiche,
politiche e socio-culturali d’ogni natura, che nessuno sembra in grado di governare o anche soltanto
di censire.
Sullo sfondo di tali tensioni, le culture che oggi si incontrano, si confrontano o si scontrano, sono
quelle di Paesi come il nostro, appartenenti al Nord opulento e tecnologico del mondo che,
costituendo poco più di un decimo dell’umanità, consuma oltre l’80 per cento delle risorse del
pianeta, assieme alle culture di Paesi in cui vivono, o da cui transitano, le avanguardie migranti
delle moltitudini del Sud del mondo, alle quali non rimangono se non le briciole, la disperazione e
la rabbia. Si tratta di un incontro denso di problemi fra le culture dei Paesi ricchi, le cui popolazioni
non sono più disposte a sporcarsi le mani ma vogliono consumisticamente godere di servizi che non
intendono più fornire in prima persona, e le culture di immigrati delle più diverse provenienze,
pronti a fare questi ‘lavori sporchi’ che per loro, tuttavia, rappresentano l’opportunità di salire di un
gradino sulla scala della speranza. Il contributo di costoro è spesso decisivo per il funzionamento
delle economie e delle società avanzate, mediante l’offerta di manovalanza a buon mercato nelle
cucine dei ristoranti, nell’assistenza agli anziani, nella raccolta dei pomidoro, nei cantieri
dell’edilizia e così via.
Devo purtroppo anche rilevare che, in particolare lungo le rive del Mediterraneo, vi sono qua e là
poteri, nazioni, popoli, gruppi umani (e relativi eserciti o corpi armati) che non esitano a fare ricorso
a forme di efferata ‘violenza sacra’ esercitate dagli uni contro gli altri; gruppi umani che, nel
combattersi ferocemente tra loro, sembrano accomunati da una medesima sventura, quella d’essere
condotti – nell’era della globalizzazione – da leader miopi e provinciali, espressi da classi dirigenti
che non hanno la levatura per vedere in grande; guide politiche di profilo culturale bassissimo, che
tendono a balcanizzare le genti e i territori sui quali esercitano il loro potere, sollecitando, in
ciascuna delle popolazioni confliggenti, pulsioni in chiave squisitamente ‘tribalistica’, associate
alle forme di ‘idolatria’ che tutte le ‘tribù’ (anche quelle moderne) sogliono coltivare nel proprio
seno. Mi riferisco in particolare al fatto di privilegiare
la più perversa e regressiva delle
superstizioni: quella di disumanizzare l’‘altro’, di ritenere che la vita e la morte dei figli della
propria tribù abbiano un valore superiore alla vita e alla morte dei membri della tribù avversa. “Gott
mit uns” sembrano dichiarare con serena incoscienza tutti coloro che prendono parte a questa turpe
gara a fare e a farsi del male: siano essi ebrei, cristiani o musulmani. Ciò che tutti costoro hanno in
comune è l’adesione ideologica a un imperativo religioso; la disposizione a sacrificare vite umane
sull’altare di un principio assoluto; la convinzione che le leggi fatte dagli uomini valgano meno
della legge che si suppone elargita da Dio, dal ‘loro’ dio tribale; la certezza superstiziosa di credersi
alla vigilia di tempi messianici, attribuendosi perciò un ruolo nell’edificazione del Regno di Dio.
Nel contesto della crisi economica che da vari anni sta flagellando il mondo intero, il nostro Paese
risulta essere ora ai primi posti nelle classifiche Ocse per la disoccupazione giovanile: elevatissimo
è in particolare, da noi, il numero dei giovani inattivi, i cosiddetti ‘Neet’, che non sono né occupati,
né a scuola né in formazione. Ciò detto, rilevo che l’opinione pubblica nazionale suole mettersi in
allarme allorché nelle regioni del vecchio glorioso Lombardo-Veneto la percentuale dei giovani
disoccupati tra i 15 e i 24 anni si eleva sino al 25 per cento, mentre il fatto che in regioni come la
Campania, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna quel livello tocchi punte persino
superiori al 50 per cento, cioè pari a oltre il doppio del livello registrato nelle due felicissime regioni
del Nord, non costituisce neppure una notizia.
Quello squilibrio statistico che un’opinione pubblica spesso sapientemente balcanizzata suole
guardare con un’indifferenza sorda e sovrana è in realtà il segnale di un’antica, profondissima
ingiustizia strutturale che, con i suoi frutti avvelenati, quali la disoccupazione di lungo periodo e la
diffusione capillare della criminalità organizzata, penalizza da generazioni le regioni del nostro
Mezzogiorno: un’ingiustizia strutturale i cui effetti rovinosi andrebbero quotidianamente denunciati
da associazioni d’ispirazione etica, da gruppi di cittadini attivi sul territorio, da movimenti di
protesta nonviolenta, ai quali le nostre tre grandi culture religiose
potrebbero, tutte insieme,
insegnare che la giustizia (tzedakah in ebraico) è una e indivisibile. L’ingiustizia presente da
qualche parte mette a rischio la giustizia ovunque.
Dico: tutte insieme le nostre tre correnti religiose, giacché nutro la speranza che gruppi coalizzati e
consensuali di fedeli delle più varie appartenenze, gruppi comprensivi (perché no?) anche di
eventuali ‘infedeli’, sappiano dare vita a forme nuove di spiritualità, scegliendosi alcuni obiettivi
comuni attorno ai quali siano disposti a unire le loro energie. Penso a obiettivi del tipo: impegno
per ridurre il numero delle persone viventi in condizioni di degradante povertà lottando contro le
cause ad essa soggiacenti, quali le malattie evitabili, la mancanza di accesso a un’educazione di
qualità, la corruzione, la sopraffazione mafiosa, la discriminazione delle minoranze etniche e di
altri gruppi minoritari privi di potere e di difese. Penso anche ad azioni volte a promuovere un
nuovo modello di crescita economica sostenibile, che tenga conto della necessità di porre un freno
al cambiamento climatico e ai suoi guasti, e di tutelare e rimettere in sesto, ove necessario,
l’ambiente naturale.
Dare vita a forme nuove di spiritualità significa riscoprire il bisogno di giustizia che aveva animato
il patriarca Abramo (non fu lui a contestare il diritto di Dio a distruggere Sodoma se lì vi erano dieci
giusti?). Ma significa soprattutto, per noi oggi, una disposizione a condividere le nostre paure e
vulnerabilità per riscoprire insieme la speranza. Il mondo contemporaneo ha disperatamente
bisogno di un’alleanza della speranza, che non consiste in un semplice ottimismo, nell’ingenua
fiducia che un “happy end”, una lieta fine sia a portata di mano. Se vogliamo davvero tentare di
assicurare un avvenire più giusto e più pacifico alle generazioni future, dobbiamo convincerci che
il futuro incomincia oggi stesso, che la fonte del cambiamento è dentro di noi, che i protagonisti del
rinnovamento dobbiamo essere noi.
Grazie.