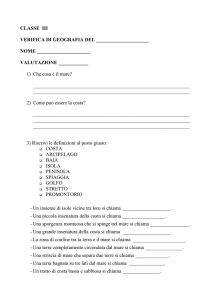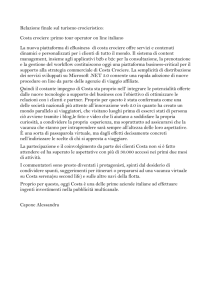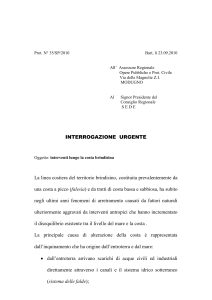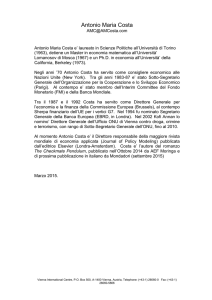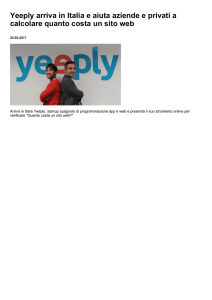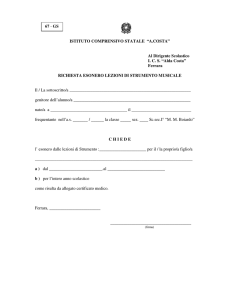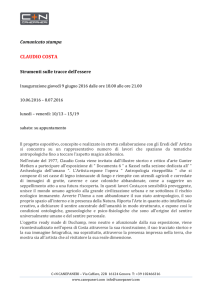REGISTRAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA, 19 OTTOBRE 1995 N° 514; SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE 70% FILIALE DI ROMA
anno V • numero 1 • 2000
SPECIALE
ORAZIO COSTA
numero 1
3
Anna Magnani in Maya
di Gantillon
regia di Orazio Costa
La scomparsa di Orazio Costa
è stata
accompagnata da un mezzo silenzio mediatico (annunci sommessi,
commenti ristretti, compianti di circostanza) che non deve sorprendere. Oltre alla ormai comprovata indifferenza del sistema per eventi e
personaggi sui quali non siano stati accesi i riflettori della notorietà
totale o del pettegolezzo cronistico, sta di fatto che la figura del regista
e pedagogo era, al contrario, un modello di rigore e sobrietà silenziosi.
Pur tuttavia, colpisce come si sia fin qui concordemente rinunciato a
lumeggiare a fondo e a far vivo il ritratto di un uomo di teatro che,
oltre a lasciare impronte profonde in oltre un sessantennio di vita dello
spettacolo, aveva formato alcune generazioni di attori e registi col suo
magistero.
Uomo di rigide discipline e segreti fervori, teorico e fautore di un teatro guidato dalla necessità di fondare su basi etiche (per usare le parole
di Luca Ronconi) il rapporto con la scena, creatore di un metodo formativo che coniugava la filologia, la spiritualità e
il recupero del patrimonio di capacità espressive e
mimiche che in ogni individuo solitamente si
disperde dopo la fine dell’infanzia, geloso custode
della propria indipendenza da ogni condizionamento esterno, sia politico che commerciale, con-
vinto assertore della decisiva importanza della formazione artistica e culturale dell’attore, al quale non si stancava di ricordare la sua missione di
rivelatore della verità e dell’essenza dell’uomo, Costa ha pieno diritto,
oggi che la sua presenza è affidata alla memoria collettiva, a una rinnovata attenzione storico-critica che individui e precisi nella sua figura e nella
sua opera un capitolo fondante del teatro contemporaneo.
Gli scritti raccolti a cura dell’Eti (che di Orazio Costa fu fiancheggiatore
e partecipe in più di una circostanza) in questo fascicolo monografico,
vorrebbero sfuggire al criterio dell’”omaggio” per quel tanto di deferente
e quasi convenzionale che è all’interno di questa parola. Essi vorrebbero
rappresentare piuttosto un concreto contributo, non certo esaustivo ma
già indicativo, alla miglior conoscenza di una figura e di un’opera intorno alle quali mancano quasi totalmente studi e analisi soddisfacenti.
Un primo e frammentario approccio, dunque: in attesa della ricognizione approfondita da svolgere in quel grande zibaldone di pensieri, argomenti e ricordi che sono i Quaderni, entro i quali è
racchiuso il percorso artistico, culturale ed esistenziale di un uomo verso il quale, come giustamente
viene rammentato in uno di questi scritti, il teatro
italiano ed europeo ha contratto un debito che in
gran parte attende ancora di essere onorato.
IL CORAGGIO
DI UNA SCELTA
ETICA
ORAZIO COSTA REGISTA
numero 1
4
numero 1
DI
ORAZIO COSTA
(DA ALCUNE LETTERE DI SILVIO D’AMICO)
di Alessandro d’Amico
elle estati del 1936 e del 1937 ad allestire i quattro spettacoli della Biennale
(Baruffe, Ventaglio, Bugiardo, Romeo e
Giulietta) si trovarono insieme –
anche se a livelli assai diversi – il neoregista Renato Simoni, il “tecnico” Guido
Salvini, il giovane apprendista Orazio Costa.
Costa aveva 26 anni ed aveva appena conseguito il diploma in regia (con un testo subìto
più che scelto: In portineria di Verga)
all’Accademia d’Arte Drammatica fondata e
diretta da Silvio d’Amico. Di quel suo primo
tirocinio in terra veneziana tenne al corrente
in alcune lettere d’Amico, con il quale aveva
già un rapporto privilegiato, iniziato dieci
anni prima, quando s’era presentato, ragazzo,
accompagnato dalla madre, a chiedere d’essere ammesso alla Scuola di Recitazione
“Eleonora Duse”, diretta da Franco Liberati e
dove d’Amico insegnava Storia del Teatro;
rapporto fondato su profonde affinità mai
intaccate dai momenti di disaccordo.
La prima lettera da Venezia è dell’8 luglio 1936,
durante le prove delle Baruffe e del Ventaglio.
«Caro Professore, se tardo a scriverLe è perché le
cose interessanti da dirLe non sono molte.
Le prove sono già molto avanzate, essendo stati
attaccati tutti e tre gli atti delle commedie successivamente, senza preoccupazione alcuna di
completare e fissare una parte prima di passare
alle altre, con i risultati malfermi che non è difficile immaginare.
La regia di Simoni, come Lei sa benissimo, si
fonda sulla interpretazione veristica del mondo
goldoniano; e non si può negare che le Baruffe
pur con il loro sottostrato di ben architettate
combinazioni, possano inquadrarsi in una cornice veristica. Ma tale interpretazione rivela le
sue debolezze quando, nelle ballettistiche vicende del Ventaglio il regista trovandosi di fronte
allo svenimento di Evaristo è tentato di abolirlo
e in ultima analisi, ridotto di alcune battute
caratteristiche, è costretto a modificarlo per non
disturbare l’andamento dell’azione.
N
il pensiero di riuscire a far di loro qualche cosa di
veramente profondo: sarà già moltissimo se si
riuscirà a farli fare qualche cosa col più esteriore
ed imposto atteggiamento; ma quanto all’espressione dei sentimenti attraverso la parola, in
modo che essi acquistino un rilievo, temo che
non varrà nemmeno la pena di richiedergliela:
qualunque nostro allievo è diecimila volte spiritualmente più trattabile dei migliori fra questi».
Ricordo che gli attori che suscitano queste reazioni si chiamavano Benassi e Cervi, Andreina
Pagnani e Evi Maltagliati, tutti apprezzati in
altri luoghi del carteggio. Non era dunque in
discussione la loro qualità, ma la disponibilità a
essere “spiritualmente trattabili”. Costa era già
acceso dall’intenzione manifestata da d’Amico
di organizzare una compagnia formata esclusivamente da ex allievi dell’Accademia. E appena
poche settimane prima, a Padova, aveva vissuto
un’anticipazione di quella formula partecipando all’allestimento del Mistero firmato da
Tatiana Pavlova (ma secondo Costa fu opera di
d’Amico), in cui disciplina e duttilità avevano
vinto su tecnica e virtuosismo. Quanto al “non
metodo” di Simoni, che procedeva dal particolare al generale, costruendo per improvvise
intuizioni, era troppo lontano dal già ferreo
ordine mentale di Costa. La cui attenzione era
del resto volta agli attori più che al regista.
Prosegue infatti la lettera: «Lei sa che io rinuncerei immediatamente al teatro se dovessi contentarmi di creare spettacoli puramente visivi, sia pure
nel miglior senso della parola. E poiché ogni mio
sforzo tenderà a rinnovare il tono delle parole ed il
senso delle battute, pongo ogni mia attenzione nel
modo con cui quelle sono oggi parlate e queste
superficialmente intese. A furia di osservare riuscirò, spero, a identificare con precisione quella
orribile cadenza teatrale retaggio di chi sa chi, che
per quasi tutti gli attori è oggi l’unica intonazione
della battuta e che per quei due o tre che creerebbero una propria intonazione ad ogni battuta è
una indimenticabile forma che falsa ogni migliore
intenzione. Ma non sarà questo, sebbene difficilissimo, il più duro compito: v’è quello di riuscire a
trovare la maniera di dare all’attore la coscienza
del compito suo e di fargli comprendere che la
buona accentazione della battuta non è affatto il
massimo a cui deve tendere ma il minimo che si
ha il dovere di pretendere da lui; che una delicata
dizione e una raffinata appoggiatura non sono
null’altro che materialissimi mezzi, dei quali deve
sapersi servire per rivelare, sulla guida razionale
delle parole, il sublime irrazionale intuìto dal
poeta. Per questo a me pare che manchi un poco
nella nostra scuola uno studio più interiore che
non sia quello puramente tecnico, e che potrebbe
essere dato dallo studio della psicologia (o della
Psicologia) e soprattutto dall’interpretazione della
poesia. Per questo credo anche che agli allievi, specialmente ai più giovani, dovrebbe essere proibito
anziché reso gratuito l’ingresso ai teatri (d’Amico
aveva ottenuto questo privilegio per gli allievi
dell’Accademia in tutti i teatri di Roma), mentre ai più preparati potrebbe essere consentito soltanto con l’obbligo della più minuziosa critica,
5
Orazio Costa REGISTA
IL TIROCINIO
In verità poi l’interpretazione veristica assunta in
partenza, subisce qualche modifica e addirittura
delle trasformazioni di compromesso nella concertazione musicale della pantomima del Ventaglio
e qua e là in altre scene delle due commedie.
Simoni ha avuto occasione di difendere calorosamente la sua interpretazione con il pittore
Selvatico, sostenitore delle necessità stilistiche,
gridando che lo stile goldoniano non esiste, che è
un’invenzione dell’Ottocento che vedeva il
Settecento secondo l’interpretazione dei De
Goncourt. I quali avevano sott’occhio le pitture
di Fragonard e dimenticavano o non conoscevano quelle di Longhi…
È d’altra parte strano che con intenzioni così
realistiche la regia non si sia interessata più a
fondo alla creazione dei caratteri anche se appena accennati, anche se inesistenti, per giustificarsi e materiarsi.
Ma la più curiosa delle interpretazioni goldoniane è quella dei comici veneziani, i quali, eredi di
chi sa quale imbastardita tradizione, avendo recitato molte volte le Baruffe son venuti riempiendole di soggetti, di lazzi, di frizzi di antichissima,
certo, origine, ma così discordanti con lo stile goldoniano; talora così fuori d’ogni preoccupazione
di tempo e d’ambiente; e quasi sempre così estranei
al personaggio che li deve eseguire, che è un vero
orrore. Non si arriva a comprendere come essi
abbiano creduto non solo opportuno, ma necessario infarcire in tal modo quelle scene già così vivaci di tanto bestiali scempiaggini. E bisogna vedere
come ci tengono e come soffrono quando Simoni
abolisce quelle… creazioni che a loro paiono più
sacrosante del testo del Vangelo e a tal punto che,
batti e ribatti, qualcuna son riusciti a farla passare, e temo che si ripromettano di farne passare
ancor di più nei giorni di rappresentazione».
È un Simoni colto nel momento di avviare
una riforma, di affrontare nella concretezza
della scena la questione fin allora dibattuta in
ambito letterario (e alquanto confusamente)
sul “realismo” di Goldoni. E di affrontarla
anche sul terreno più ostico: il Goldoni
deformato dagli attori veneti.
L’anno successivo fu la volta del Bugiardo.
Altro resoconto di Costa a d’Amico (7 luglio
1937). «Il tono generale delle prove di quest’anno mi pare, forse mi sbaglio, un po’ inferiore a
quello dell’anno passato: Simoni è sempre quel
sentimentale spirito entusiasta ricco di intuizioni
e di trovate, ma assolutamente privo di metodo.
Pensi, tanto per dirne una, che non ha nemmeno
una volta letto la commedia agli attori: e soltanto accidentalmente gli capita di chiarire l’interpretazione che ne fa e lo spirito dei personaggi.
Quello che a tratti e saltuariamente egli viene
dicendo sarebbe stato più che sufficiente a inquadrare senza pericolo di sviamenti dal lavoro una
prima volta per sempre; ma così, mi pare, che
non faccia altro che creare impaccio alle tonde
menti dei comici distolti ogni momento dalla
non assimilatrice loro digestione.
Quando mi trovo vicino agli attori perdo sempre
un poco di quel tanto entusiasmo e coraggio che
ho e che mi sento, pensando quanto sia utopistico
numero 1
6
In questa foto vediamo
un giovanissimo
Orazio Costa attore
in uno spettacolo
goldoniano realizzato
nel ‘37 dalla Scuola
Eleonora Duse
non tanto delle forme esteriori della
regia, abbastanza facile, ma dei toni
particolari e più ancora di quel
famoso tono generale difficile da
identificarsi».
Sull’Accademia, della quale non
fa più momentaneamente parte
né come allievo né come docente,
Costa ha idee non sempre concordanti con quelle di d’Amico.
A cominciare dalla scelta di
Tatiana Pavlova come insegnante
di regia, della quale non condivideva lo pseudostanislavskismo e
tanto meno certe manifestazioni
di gusto.
Venezia era stata un’esperienza utile ma non
esaltante per chi, nonostante la giovane età,
aveva coscienza delle insufficienze teoriche e
pratiche della scena italiana. Fu certo questa
evidente insoddisfazione nell’allievo che sentiva più vicino alla sua concezione del teatro, a
spingere d’Amico nell’autunno del 1937 a una
decisione rivoluzionaria per i tempi: quella di
inviarlo con una borsa di studio all’estero. Fu
scelto Jacques Copeau, anche per l’amicizia
che lo legava a d’Amico. Copeau non aveva
più una scuola ma accolse il giovane italiano
(perfettamente bilingue) consentendogli di
assistere a tutte le prove dell’Asmodée di
Mauriac che stava mettendo in scena alla
Comédie. Fu un incontro decisivo che si prolungò in Belgio, dove Copeau tenne una serie
di letture di classici, e dove Costa poté avere
frequenti dialoghi col maestro sull’arte, la letteratura e il teatro. Di tutto ciò informò come al
solito d’Amico in una lettera del marzo 1938
(pubblicata ora nel n.42 di “Ariel”), nella quale
si intravedono alcune componenti primarie
del futuro regista e didatta: lo studio della
fonetica e della tecnica respiratoria, l’interpretazione basata su una rigorosa esegesi del testo,
le letture pubbliche di testi poetici e drammatici, la passione per il canto gregoriano.
Di ritorno in Italia lo attendeva il progetto di
d’Amico per la Compagnia dell’Accademia
entrato nella sua fase realizzativa. Qui l’accordo con il maestro fu perfetto: sui criteri guida,
sul repertorio (salvo Alfieri, amato da Costa e
mal sopportato da d’Amico), sugli attori e i
registi, tutti ex allievi della scuola. Anche se per
Costa la prevista autarchia della formazione
avrebbe dovuto essere totale e riguardante tutti
i settori, compresi gli scenografi e i costumisti,
e addirittura gli elettricisti: ogni volta che il
tema ricorre nella corrispondenza con
d’Amico – il quale aprì a delle eccezioni: per
esempio scritturò Tino Carraro, non proveniente dall’Accademia – Costa si inalbera in
una strenua difesa del “territorio” da ogni
estraneo (“basteremo noi stessi”; “non abbiamo bisogno di nessuno”). Posizione estrema,
ma anche coscienza di un pericolo reale, che
infatti si verificò: gli spettacoli esemplari della
Compagnia dell’Accademia - Donna del
Paradiso, Re Cervo, Questa sera si recita a soggetto - furono tutti nella prima stagione, 193940; quando l’anno successivo d’Amico cedette
la direzione all’”estraneo” Corrado Pavolini,
perse immediatamente la sua identità.
A Costa non restò che iniziare una carriera di
regista al servizio di enti o compagnie. Nel
1941 la Biennale di Venezia gli commissiona la
regia del Poeta fanatico: un Goldoni in lingua e
in gran parte in versi, una commedia fra le
meno note e lodate. Scrive a d’Amico (22
luglio) che tutto nell’organizzazione va di traverso salvo… gli attori che «si sono dimostrati
verso di me pieni di attenzione di cortesia e perfino d’una almeno apparente gratitudine. Mi pare
che Ninchi [Annibale] vada bene e così anche la
Palmer (se non fosse la poca avvenenza) specialmente per quel che riguarda il movimento. E tutti
gli altri seguono abbastanza bene l’insieme, tranne forse, per ora almeno, il nostro Crast che ho
dovuto prendere per la parte di Lelio e alla quale
non si sente portato. Non vi ho detto di Baseggio
perché veramente merita un posto a parte, anche
per l’interessamento particolare che mette nel lavoro. Certo se vi sarà un successo [che ci fu, e notevole] lo si dovrà in grandissima parte alla sua
maschera [Brighella]. Ho inventato per lui, e lui
stesso ha portato un certo contributo alle invenzioni, moltissime cose che lui realizza sempre, bisogna
riconoscerlo, come se fossero partite dalla sua fantasia. Ho avuto delle prove veramente divertenti
in cui gli attori hanno messo tanta volontà e felicità di fantasia che è stato per me un vero grande
piacere compiere il mio ufficio di suscitatore di
idee e di discriminatore di effetti».
Insomma: un idillio, inatteso: il solo a far le
bizze fu proprio un compagno d’Accademia,
Antonio Crast.
Il carteggio con d’Amico naturalmente continua. Forse gli accenni più interessanti son
quelli relativi a progetti restati tali. Come un
film sulla Vita di Cristo tratto dal libro dell’abate Ricciotti, che Costa immagina di girare
nella campagna romana, con tutti non attori
(1941); o un Aminta con la Morelli-Silvia:
«non è quella descritta dal satiro (ah no!) ma è
brava e può somigliare ad un’aspra piccola
Diana» (1942); o un Filippo di Alfieri “adattato” e subito respinto da d’Amico (1944).
16 marzo 1944. Roma occupata,
Costa è a Comunanza, presso Ascoli
Piceno, nella casa di campagna di una
cognata: «Come usciremo da questa
tragedia, se ne usciremo? E come avremo
la forza di metterci al lavoro enorme
della ricostruzione e di ritornare al lavoro più facile e felice che abbiamo così
inopinatamente interrotto? Quando si
pensa che ormai la ricostruzione non
potrà più essere relativa al solo nostro
paese ma dovrà riguardare gli uomini
come un tutto unico, viene da tremare
al pensiero che a tutti noi incomba un
compito così vasto. Io sono da sei mesi
ormai in esilio. Non so se ho fatto bene a
isolarmi. Talvolta penso persino di ritornare a Roma, poiché il peso della solitudine in cui
mi trovo m’è quasi insopportabile. Ma poi penso
che non saprei resistere a quello della visibile schiavitù e continuo a restare qui dove leggo e scrivo e
m’illudo di preparare lavoro per quando sarà possibile. Studio Ibsen, Alfieri e Cechov. Mi sono letto
le raccolte di teatro sacro del De Bartholomaeis e
del Bonfantini. Ho trovato questo teatro (salvo le
“laude” e qualche sparsa grazia lirica perduta qua
e là) insopportabile e stramorto. Eppure il teatro
sacro dovrebbe essere domani l’unico teatro. Ma
bisogna rifar tutto daccapo, poiché la nostra irreligiosità d’oggi ha bisogno di ben altra forza».
Cosa esattamente intendesse con queste ultime parole si troverà spesso a spiegarlo; e nel
modo più chiaro quando (1960) contestò
«l’insanabile incompatibilità fra “sacro” e “teatro”» sostenuta da Chiaromonte.
Intanto gli anni dell’apprendistato paiono già
un lontano ricordo.
(Le lettere qui citate sono conservate
nel Fondo d’Amico presso il Civico Museo Biblioteca
dell’Attore di Genova, che ringrazio)
numero 1
7
Flora Carabella
e Rossella Falk
durante le prove di
Sei personaggi
in cerca d’autore
L’ARCANGELO
CON LE SCARPE
VIBRAM
di Luigi Squarzina
on è tempo di analisi, è tempo di elegia
per l’artista appena scomparso che ha
saputo far fronte come pochi al dettame
del maestro di tutti noi, “dovete amare
il teatro e non voi stessi nel teatro”, un
viatico nutriente ma di aspro sapore per un pellegrinaggio lungo e difficile. Silvio d’Amico era
maestro di Costa e anche suo compagno di
banco nel senso spirituale, del comune ascolto
prestato alla voce di Copeau; così intimamente
coesi che nella fase di consuntivi Orazio ha
potuto muovere a Silvio un rimprovero di
fondo che per essere stato da lui stesso affettuosamente definito “infantile” non rimane meno
netto: “Quando ho deciso di fare teatro io stavo
andando verso il cinema. Colpa anche di
d’Amico di non aver capito”.
Ma io vorrei parlare da testimone ancora investito dal ricordo di alcuni degli spettacoli che
ho visto.
Li ritrovo nel numero speciale dedicato a Costa
dalla rivista “Comunicazioni Sociali”, luglio settembre 1998, a cura di Alessandra Ghiglione
e Gaetano Tramontana, con una teatrografia
meritoria (nella quale sorprende veder recitare
Eros Pagni nel 1942 in Fermenti: anche se è
l’inno di O’Neill all’adolescenza, Pagni si diplomerà all’Accademia nel 68/69). Delicata è la
questione che potrebbe sorgere dalla cronologia
delle stagioni cruciali 1943/44 e 1944/45;
“Comunicazioni Sociali” (come la bella voce
“Orazio Costa” della Enciclopedia dello
Spettacolo) colloca con esattezza nel febbraio e
nel giugno ‘43 Il piccolo Eyolf al teatro Quirino
e Hedda Gabler all’Eliseo, poi nel giugno ‘45
all’Eliseo l’accoppiata Merimée - De Musset.
Se con i due Ibsen del ‘43 Costa ritmava i mesi
che preparavano l’armistizio del clima di disfatta incombente che già si era sentito dopo
Stalingrado attorno all’Opera da tre soldi, saggio
dell’Accademia (insegnante di regia Guido
Salvini) con cui si diplomava Vito Pandolfi e in
cui agitavamo tutti, futuri attori e futuri registi,
da Gassmann a Salce a Mazzarella alla Padovani
a chi scrive, nel ‘45 con lo spettacolo dell’
Ottocento francese egli partecipava in prima
linea alla rivoluzione culturale che rinnovava la
nostra scena dopo la Liberazione, nel momento
fatato del teatro-come-vita. Si dirà: volevi parlare di elegia, dunque di poesia, e cominci con la
filologia? Ma, pochi anni dopo gli spettacoli
che ho nominato, questa seconda si sarebbe
manifestata anche da noi come filologia anche
dello spettacolo contemporaneo, dimostrandosi indispensabile alla prima al punto di fare da
levatrice a un teatro di contaminazione e di
citazione, teatro-sul-teatro. Conservo in me
immagini vivide e tuttora stimolanti sia dello
Eyolf che di Hedda, messinscene, in una Italia
dell’oscuramento a lungo scusa dalle correnti
guida, ben all’altezza della regia europea tanto
più avanzata della nostra; per Hedda, dopo il
suicidio di Sarah Ferrati e l’accordo agghiacciante della tastiera su cui crollava e il cinismo
della battuta finale di Giulio Stival, “Queste
cose non si fanno!”, noi allievi registi del primo
anno potevamo discutere tra noi se lo spettacolo intendesse presentare un’eroina in lotta
impari contro i pregiudizi del suo tempo o la
sconfitta di un estetismo superomistico che
alludeva al totalitarismo vacillante. Nei toni di
bianco verde e oro di scene e costumi (Tullio e
Valeria Costa) il palcoscenico era al tempo stesso ipnotico e straniante, ambiguità rivelatrice
per la quale nel gennaio ‘45 noi fummo in
grado di ammirare senza gridare al miracolo
inatteso gli epocali Parenti terribili di Visconti.
Non mi ero formato sotto il suo magistero
eppure Costa fu il primo a darmi lavoro appena finita l’Accademia. Nel 1945 il diploma di
regia era più un pericoloso identikit che un
passaporto. Né Guido Salvini né Ettore
Giannini a cui mi ero proposto come assistente avevano niente per me; Costa mi disse di sì e
partìi ipso facto per Milano. Su suo consiglio
Orazio Costa REGISTA
N
numero 1
8
Una scena
del Don Giovanni
di Molière
Compagnia
Piccolo Teatro
della Città di Roma
più da fratello maggiore che paterno, gli copiai
le inconfondibili scarpe Vibram con le suole di
gomma dura a carro armato, provvidenziali
nella poltiglia invernale di quella Milano 1945
quasi senza riscaldamento né mezzi di trasporto. Andava in scena il secondo spettacolo della
Compagnia Borboni - Randone - Carnabuci Cei di cui Costa era direttore, Vento notturno
di Ugo Betti. Il primo era stato un grande successo milanese, Giorni senza fine di O’Neill, un
O’Neill alla ricerca di Dio giocato su uno
sdoppiamento, lo scrittore John Loving e il suo
cattivo dèmone, Randone e Carnabuci. Io ero
assistente non alla regia - non ce n’era nessuno
- ma alla Compagnia. Randone mi parve
eccelso nella parte bettiana dell’anziano solitario che comunica a distanza con un’altra solitudine. I due spettacoli che avevo il compito di
seguire in tournée ottennero a Firenze lusinghiere recensioni da parte di Eugenio Montale,
critico teatrale (competentissimo!) del quotidiano di Firenze che riprendeva le pubblicazioni. Scrisse Montale sulla “Nazione del
Popolo”: “Orazio Costa, uno dei migliori
nostri registi e dei più colti, ha tratto eccellenti
effetti dal nuovo lavoro di O’Neill, facendo
centro naturalmente sul personaggio sdoppiato”. Quanto a Betti, Montale giudicò “la commedia.....certo fra le sue migliori”, la regia
“abile e intonata” e Randone “attore fra i nostri
migliori”. Le scenografie consistevano di alcuni tralicci per O’Neill, verniciati di bianco su
un panorama di panno nero, e di una parapettata di tela per Betti; i tramonti li facevo io
girando lentamente a mano un paio di padelloni. Da raccontarla, quella tournée del pri-
missimi dopoguerra, un misch masch di piazze
che ci portava a recitare una sera a Faenza e la
sera dopo ad Asti viaggiando su treni affollati
all’inverosimile (se un passeggero o una passeggera erano colti da un bisogno ce li dovevamo
passare di spalla in spalla fino alla toilette,
senza potercene lamentare come i festaioli
romani del Capodanno 2000); nei convogli in
penombra che correvano su ponti di fortuna
del Genio militare, invisibili ai viaggiatori, ci
sentivamo librati nel vuoto, come le scelte artistiche di Costa al di sopra delle contingenze
sfavorevoli che non potevano inficiarne la validità; e di una di quelle scelte ci inorgogliva
essere latori. Dopo aver allestito altri due spettacoli, una commedia irlandese diretta da Vito
Pandolfi (dove recitai anch’io) e un Pirandello
messo insieme dalla Borboni, la Compagnia si
numero 1
Parenti terribili viscontiani, coetaneo e collega
d’ Accademia.
Venne poi in via Vittoria, sull’esempio di via
Rovello a Milano, l’avventura del Piccolo
Teatro della Città di Roma, non riconosciuto
tale né dal Comune né dal Sottosegretariato
allo Spettacolo. I cattolici al potere nello Stato
e nella capitale aiutavano poco un regista sinceramente e dichiaratamente religioso che a
onor del vero ben poco gli somigliava; non fu
sufficiente l’influenza di Silvio d’Amico, il
quale d’altronde non poteva avere solo quel
pensiero tanto più che con Costa l’Accademia
procedeva sulla giusta strada: non bastarono la
compattezza della Compagnia quasi tutta di ex
allievi, un ensemble bellissimo (anche per le
grazie delle giovani attrici), il più prossimo che
Costa sia riuscito a riunire alla sua concezione,
9
Orazio Costa REGISTA
sciolse assai prematuramente finendo senza
eutanasia per improvviso forfait del capocomico. Era tipico della intransigenza di Costa
avere proposto un repertorio austero in una
Italia che desiderava solo tirare il fiato, ed è storicamente da rimarcare - a correzione di certi
luoghi comuni sulla regia che sarebbe venuta
imponendosi a suon di allestimenti - che il
nuovo stava nascendo soprattutto dal rigore,
dalla tensione, dalla convinzione di offerte
rischiose; questo a pochi mesi dal momento in
cui lo stesso Costa a Roma avrebbe potuto
disporre di mezzi sufficienti per una raffinata
Carrozza del SS. Sacramento accoppiata a un
elegante e commovente Candeliere dove a fianco di Andreina Pagnani si rivelava Giorgio De
Lullo attor giovane, confrontandosi nello stesso Teatro Eliseo con l’Antonio Pierfederici dei
scrisse Giorgio Prosperi, “tra l’ordine monastico e il sodalizio medievale” - ma erano ragazzi
allegri e innamorati; e quanto più sorprendenti e ispirati erano stati i Sei Personaggi del ‘48
con i giovanissimi Rossella Falk (quelle gambe
lunghissime e tornite che uscivano dal “vestitino” nero aderentissimo mentre cantava da
sciantosa sul pianoforte), Tino Buazzelli,
Gianrico Tedeschi, Giancarlo Sbragia, su un
palcoscenico presentato a rovescio, rispetto alla
pur autorevole messinscena di un anno e
mezzo prima con tanto di Ferrari, Pilotto e
Tofano; non bastò la serietà del repertorio. È
stato notato che la metodologia mimetica di
Costa, su cui non è mio compito soffermarmi,
sembrava trasparire dai suoi spettacoli meno
chiaramente di altre, storicistica, epica, critica,
di gruppo, di immagine, di strada, di cantina,
neodadaista, neobarocca, decostruzionistica, di
metateatro, di contaminazione, povera, provocatoria, crudele e tante ancora, del cui avvicendarsi però si dovrà pur discutere altrettanto in
termini di maggiore o minore aderenza delle
messinscene ai presupposti teorici.
Privilegiando il momento emotivo del ricordo
voglio citare due uscite del Piccolo Teatro passato da via Vittoria a via Sicilia, dal teatrino
dell’Accademia al Teatro delle Arti: Le Colonne
della società (1951), l’Ibsen, ispiratore di molta
drammaturgia moderna, con al cento un formidabile Tino Buazzelli la cui ammissione di
responsabilità, isolata in un cono di luce, non è
dimenticabile, e due anni prima (1949) il
capolavoro alferiano di Costa, Mirra, affidata a
una lacerata lacerante Anna Proclemer inguainata in un corpetto da cui stentava a prorompere la femminilità, ancorata a un tormentoso
coulisson, forse il miglior costume mai disegnato da Valeria Costa (l’ascetico Orazio era
un più che sapiente valorizzatore della bellezza
muliebre) - Anna, uscita più dalla ribalta del
GUF o delle Arti di Bragaglia che non da
Piazza della Croce Rossa eppure vicinissima fin
dall’esordio allo spirito dell’Accademia, protagonista, con la Falk, anche della Dodicesima
notte, 1950, dove campeggiavano il Malvolio
di Randone e il Festa di Tedeschi.
Via Rovello gli dette spazio. Nel maggio 1955
io ero alla prima di Processo a Gesù. Era una
delle volte in cui Fabbri aveva scritto con convinzione; Costa, con Teresa Franchini
(“Lasciateci Gesù!”), Antonio Crast e Augusto
Mastrantoni seppe rendere convincentissima,
al limite, aureo in quel caso, della mozione
degli affetti, la pur scontata assoluzione finale
del Messia. Non ho visto, anche se oggi mi
sembra strano, nessuno degli spettacoli in cui
Costa dispiegava la sua vocazione all’uso del
coro, ambito in cui l’eccellenza gli veniva riconosciuta fino alla benevola o invidiosa presa in
giro; la coralità era patrimonio dell’Accademia;
ma da quel Processo a Gesù, retto da attori di
grande professionismo, emanava una musicalità vocale d’insieme e un contrappunto di gesti
(alcuni proprio “suoi”, esorcistici) che solo un
mago dei cori poteva conseguire.
numero 1
10
DRAMMATURGIA SCENICA
DELL’INVISIBILE
di Claudio Meldolesi
I Dialoghi delle Carmelitane
di George Bernanos
uno degli spettacoli
storici di Orazio Costa
numero 1
ilvio d’Amico doveva aver intuito la
riluttanza della regia a farsi materia
d’insegnamento quando, nei primi
anni Trenta si preparava a fondare
l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica a Roma. Appare sintomatico il fatto
che chiese di farsene professori, prima, a
Copeau e, poi, alla Pavlova, che supponeva
S
iniziata al metodo Stanislavskij, dato che da
vent’anni ormai fallivano in Italia i tentativi
d’importare quella risorsa, benché non fossero mancati suoi notevoli esploratori ingenui. Comunque, se la scelta della Pavlova si
rivelò inadeguata, bastò a fornire i primi
necessari orientamenti al talento di Orazio
Costa. Ma fu poi questo allievo d’eccezione,
perfezionatosi a Parigi alla scuola copeauiana, a farsi fondatore dell’insegnamento registico italiano e guida artistica globale di
quell’istituzione.
Il suo cattolicesimo era diverso da quello,
essenzialmente francescano, del presidente
dell’Accademia e la sua personalità era troppo
forte perché non si determinasse qualche
imprevedibile corto circuito con lui; ma direzione istituzionale e direzione artistica furono
da loro esemplarmente combinate, naturalmente grazie anche agli attori maestri di recitazione, in qualche caso ancora segnati dal
magistero della Duse. Come fosse una compagnia, questa scuola era un luogo di differenze intime, a distanza dalla normativa fascista. Si potrebbe dire, a questo punto, delle
svolte che l’Accademia d’Arte Drammatica
conobbe e trasmise al teatro italiano di metà
secolo, come del ruolo avuto allora dagli
uomini di teatro cattolici nella disgregazione
del trasformismo ideologico del regime, avendo agito Costa su ambedue questi terreni da
protagonista; ma più strategico si sarebbe
rivelato il suo merito nella precisazione della
novità artistico culturale che si andava formando in Italia. Etico fu infatti il suo Gestus
di fondatore, cresciuto al contatto della fede
come dell’organicità scenica appresa in
Francia. Non a caso, al contrario di tanti
nuovi dirigenti culturali cattolici, Costa, per
la particolarità del suo percorso non fu mai
protetto dai governi democristiani, fin dal
tempo in cui il Piccolo Teatro della Città di
Roma da lui fondato nel 1948 fu costretto a
precoce chiusura.
Non sorprende così che le sue realizzazioni
degli anni Cinquanta risultino alla distanza
dialettiche con quelle del comunista Visconti
per fermenti prossimi all’esistenzialismo. Ma
una non mediata assunzione di responsabilità
anche istituzionali tendeva poi a qualificare i
suoi incontri da artista con il testo. E se
Alessandro d’Amico ha espresso qualche dubbio sulla definizione di “regia a spettacolo
unico”, con cui chi scrive ha cercato di fissare
questa segreta concordanza con Visconti e, in
parte, con l’Eduardo regista, resta comunque
il senso di questa singolare contemporaneità
di ricerche, segnata da marcanti coinvolgimenti individuali.
In Costa bastavano le ambientazioni corali, le
verticalizzazioni dei nodi drammatici o le
modalità di partizione drastica della partitura
testuale (prossime a quelle di Stanislavskij) a
creare delle sintomatiche continuità di spettacolo in spettacolo. Sembrava gareggiare allora
la forma ricorrente dei suoi spettacoli con la
varietà delle scritture e degli ordini dialogici:
si trattava di una ricerca comparabile con
quella originaria che aveva indotto Copeau a
optare per una scena unica, ospite di
Orazio Costa REGISTA
11
numero 1
ilvio d’Amico doveva aver intuito la
riluttanza della regia a farsi materia
d’insegnamento quando, nei primi
anni Trenta si preparava a fondare
l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica a Roma. Appare sintomatico il fatto
che chiese di farsene professori, prima, a
Copeau e, poi, alla Pavlova, che supponeva
S
iniziata al metodo Stanislavskij, dato che da
vent’anni ormai fallivano in Italia i tentativi
d’importare quella risorsa, benché non fossero mancati suoi notevoli esploratori ingenui. Comunque, se la scelta della Pavlova si
rivelò inadeguata, bastò a fornire i primi
necessari orientamenti al talento di Orazio
Costa. Ma fu poi questo allievo d’eccezione,
perfezionatosi a Parigi alla scuola copeauiana, a farsi fondatore dell’insegnamento registico italiano e guida artistica globale di
quell’istituzione.
Il suo cattolicesimo era diverso da quello,
essenzialmente francescano, del presidente
dell’Accademia e la sua personalità era troppo
forte perché non si determinasse qualche
imprevedibile corto circuito con lui; ma direzione istituzionale e direzione artistica furono
da loro esemplarmente combinate, naturalmente grazie anche agli attori maestri di recitazione, in qualche caso ancora segnati dal
magistero della Duse. Come fosse una compagnia, questa scuola era un luogo di differenze intime, a distanza dalla normativa fascista. Si potrebbe dire, a questo punto, delle
svolte che l’Accademia d’Arte Drammatica
conobbe e trasmise al teatro italiano di metà
secolo, come del ruolo avuto allora dagli
uomini di teatro cattolici nella disgregazione
del trasformismo ideologico del regime, avendo agito Costa su ambedue questi terreni da
protagonista; ma più strategico si sarebbe
rivelato il suo merito nella precisazione della
novità artistico culturale che si andava formando in Italia. Etico fu infatti il suo Gestus
di fondatore, cresciuto al contatto della fede
come dell’organicità scenica appresa in
Francia. Non a caso, al contrario di tanti
nuovi dirigenti culturali cattolici, Costa, per
la particolarità del suo percorso non fu mai
protetto dai governi democristiani, fin dal
tempo in cui il Piccolo Teatro della Città di
Roma da lui fondato nel 1948 fu costretto a
precoce chiusura.
Non sorprende così che le sue realizzazioni
degli anni Cinquanta risultino alla distanza
dialettiche con quelle del comunista Visconti
per fermenti prossimi all’esistenzialismo. Ma
una non mediata assunzione di responsabilità
anche istituzionali tendeva poi a qualificare i
suoi incontri da artista con il testo. E se
Alessandro d’Amico ha espresso qualche dubbio sulla definizione di “regia a spettacolo
unico”, con cui chi scrive ha cercato di fissare
questa segreta concordanza con Visconti e, in
parte, con l’Eduardo regista, resta comunque
il senso di questa singolare contemporaneità
di ricerche, segnata da marcanti coinvolgimenti individuali.
In Costa bastavano le ambientazioni corali, le
verticalizzazioni dei nodi drammatici o le
modalità di partizione drastica della partitura
testuale (prossime a quelle di Stanislavskij) a
creare delle sintomatiche continuità di spettacolo in spettacolo. Sembrava gareggiare allora
la forma ricorrente dei suoi spettacoli con la
varietà delle scritture e degli ordini dialogici:
si trattava di una ricerca comparabile con
quella originaria che aveva indotto Copeau a
optare per una scena unica, ospite di
Orazio Costa REGISTA
11
numero 1
12
Shakespeare come di Eschilo o Dostoevskij.
Ambedue sembravano aver cercato nel
“prima” l’identità artistica dei loro scavi.
Costa essenzializzava il corso testuale distinguendo fra i portatori di azioni e gli altri, in
modo che questi agissero come un coro informale, anche se poi egli dirigeva lo spettacolo
con modalità complesse, da regista internazionale come da specialista della drammaturgia in lingua italiana. Un italianista pronto a
ogni sconfinamento viene da pensarlo oggi, e
filologicamente agguerrito dal bisogno di
precisione che la scena richiede a tutti i suoi
specialisti consapevoli: a lui in particolare
perché appassionato a investigare gli ultimi
lembi di sapere strappati all’inconoscibile,
essendo quest’ultimo un elemento distintivo
dello spessore delle sue messinscene.
Le decantazioni corali e le acquisizioni filologiche - quasi sempre di prima mano - venivano da lui giuocate direttamente sul terreno
dell’espressivismo per connotare quel vuoto:
che il pudore della fede rendeva passibili di
significazioni ulteriori da parte di ciascun
spettatore. Una presenza silenziosamente attiva sgorgava dalla serie dei richiami sacri e collegava le partiture di spettacolo in spettacolo,
nonostante Costa non avesse comunicato di
perseguire questo intendimento nemmeno
agli interpreti. Dove non cedeva a resistenze
convenzionali, agiva infatti come un officiante di un rito maggiore, non commensurabile
alla natura dei presenti, anche dopo il distacco dalle prove.
Dal loro interno, così, queste dinamiche rappresentative tendevano a surdeterminazioni
espressioniste, e a questa condizione naturalmente si collegava il metodo mimico, con i
suoi richiami primordiali ad alberi, tempeste,
scimmie, eserciti contrapposti e sangue. In tal
senso sembra fondarsi la definizione di “regia
a spettacolo unico” riguardo a Costa; e anche
se essa fosse poco accolta, questi richiami
continuerebbero a richiedere una concettualizzazione in sede saggistica. Si potrebbe parlare, anche, di “drammaturgia scenica dell’invisibile”. Inquietante era la bellezza che producevano le dinamiche rappresentative di
Costa, anche se potevano trovare solo in
forme di spaesamento il loro spazio in rapporto al dialogo.
Ciò lo fa pensare quale regista storico nella
distanza italiana; e questa collocazione trova
conferma nella radicalità delle sue realizzazioni sceniche maggiori, che erano tali da rifug-
gire dalle teorizzazioni scritte. Pur essendo un
uomo di scena dal raro sapere e un letterato
come pochi competente delle drammaturgie
segrete del teatro italiano, Costa ha pubblicato pochissimo sul suo lavoro. Preferiva elaborare le sue idee in quaderni privati; e non solo
per non avallare l’immagine diffusa nell’ambiente che lo voleva eccessivamente studioso.
Fin dai primi anni da professionista si era
dato il costringimento di non creare con
intelligenza estetica, e ciò aveva fatto trasparire tratti di duplicità nelle sue messinscene,
restando un creatore della scuola di Copeau.
Sembrava così organicamente predisposto al
lavoro sui frammenti testuali, per cui non ci
si sorprese che diventasse poi inventore di
inconfondibili spiazzamenti nei testi che rappresentava; ma la sua immagine al lavoro finiva così per distanziarsi da quella del regista
comunemente noto e apprezzato.
Chi scrive lo ricorda nei primi anni Sessanta
intento ad esperimenti estremi di messinscena
con i suoi allievi, all’Accademia; sicché drammi
poco più che naturalisti di Fabbri o di Muñoz,
per scatti grotteschi di senso, sembravano riformularsi al suo contatto; mentre poi negli spettacoli restavano solo dei segni discontinui di
tale interferenza drammaturgica del regista.
Era questo soprattutto un modo di restare
presente in incognito nelle messinscene, che
già Copeau aveva praticato. Mentre originale
era il suo modo di far rivedere la vita in scena
attraverso una particolare distanza. L’umanità
rappresentata da Costa si presentava così al
pubblico già predisposta al tragico, e lo spettacolo dal suo punto di vista consisteva in sforzi
di fede per plasmare cristianamente questa
condizione. Insofferente al limite del prevedibile, anche in senso confessionale, Costa cercava di scoprire scoprendosi a se stesso, coinvolgendosi nella storia del teatro occidentale,
fino a sembrare un messaggero del vuoto di
cui parlavamo, in Adelchi come nel Mistero
della Natività, Passione e Resurrezione di Nostro
Signore e ne I Dialoghi delle Carmelitane di
Bernanos come in Spiritismo nell’antica casa di
Betti, che portò in scena anche da interprete.
E poiché le sue regie vivevano di forti codificazioni, tanto da sembrar prossime a certi esiti
orientali, questo fermento debordava anche
nei suoi spettacoli da Ibsen e O’Neill, da
G. B. Shaw e Cechov, come da Molière e
Metastasio, da Goldoni e Alfieri, potevano
produrre esiti di segno originario anche in
contesti spettacolari tradizionali.
La disposizione ad attraversare i testi che gli
erano affini più e più volte, col tempo, lo
portò poi a creare dei topoi trasversali di temi
e strutture linguistiche che istituivano veri e
propri filoni nel suo repertorio; ed è questa
trasversalità che oggi molti suoi spettatori
rimpiangono, anche fra quelli estranei al suo
bisogno di far mondo con la fede. L’intima,
radicale coerenza dei suoi scavi non ha però
avuto il seguito cui sembrava destinata sulle
nostre scene, nemmeno nel lavoro dei suoi
allievi. Tuttavia, al fianco dei creatori rimasti
prossimi al suo scavo - come Claudia
Giannotti, Paolo Giuranna, Roberto
Herlitzka o Pino Manzari -, sono incomprensibili fuori dal suo magistero certi approdi di
Ronconi o di Barberio Corsetti.
Ciò rimanda alla fondazione della drammaturgia registica italiana che Costa operò insieme a Visconti, per sintomatici eccessi interpretativi: anche se la formazione filologica in
Costa tendeva a riassimilarli al dettato testuale; a queste transizioni, del resto, egli si era
dedicato fin dalla sua tesi di laurea in Lettere
sui dialoghi nei Promessi Sposi, discussa sessantatre anni or sono, cui fece immediatamente seguito la corrispondente trasposizione
drammatica. E lungo tutta la sua attività egli
valorizzò le frontiere del teatro, anche all’inverso, facendo sentire “romanzesco”
Shakespeare e “lirico” Calderòn. Gli bastava
fare incontrare con purezza ritmo testuale e
tono interpretativo per acquisire alle scene
queste scritture come fossero apolidi. E il
senso di queste ibridazioni può oggi essere
rintracciato nei suoi scritti pubblicati da
Giacomo Colli in “Una pedagogia dell’attore.
L’insegnamento di Orazio Costa” (Roma,
Bulzoni, 1989). Ma il lettore dovrà integrare le
sue parole con il senso di luminosità che traspariva talvolta dal suo ostinato fare scenico.
Un’altra immagine da
I Dialoghi delle Carmelitane
«Inquietante era la bellezza
che producevano
le dinamiche
rappresentative di Costa
- dice Meldolesi - anche se
potevano trovare solo
in forme di spaesamento
il loro spazio in rapporto
al dialogo»
Orazio Costa REGISTA
numero 1
13
numero 1
14
I due suonatori
in costume
in Ipazia di Mario Luzi
numero 1
15
SINTESI
Un momento
della Vita nuova
Per Luzi «la potenza
drammatica chiusa
nelle perfette forme
di quell’opera
giovanile di Dante
venne tutta in luce
come drammaturgia
nuda e sapiente»
MEMORIALE
DI UN’AMICIZIA
di Mario Luzi
icostruisco con meraviglia il corso
della mia amicizia con Orazio Costa
Giovangigli. Constato che, per quanto
sembrasse sempre esistita aveva nella
cronologia oggettiva una data abbastanza recente. In questa materia il paradosso
è di casa. Ciò che appare a noi e cioè la durata interiore soggettiva conta più di quella stabilita dalle misure convenzionali del tempo.
Così non mi veniva mai pensato – e credo
neanche a Orazio – che la nostra frequentazione fosse nata da pochi anni.
Conobbi Orazio quando nei suoi programmi
didattici di drammatizzazione di testi letterari
decise di affrontare con i suoi allievi la Vita
nuova di Dante.
Ero stato fino ad allora contrario per principio alle conversioni teatrali di opere nate in
altra forma e struttura. Quella recita a cui
Orazio mi chiese di assistere mi indusse a
cambiare parere: la potenza drammatica
nascosta negli eventi interiori e chiusa nelle
perfette forme di quell’opera giovanile di
Dante venne tutta in luce come drammaturgia nuda e sapiente. Fu una rivelazione nuova
di un libro a cui ero molto devoto.
Da allora cominciammo a tenerci al corrente,
di noi, del nostro lavoro. Nel 1978 Orazio mi
comunicò che avendo adottato nella sua
scuola come testo di quell’anno la mia Ipazia,
desiderava concludere il corso con un saggio
di recitazione pubblica e mi chiedeva il consenso e la collaborazione. Quel saggio tenuto
in un salone dell’Educandato della SS.
Annunziata a Poggio Imperiale divenne poi la
prima ufficiale all’Istituto del Dramma
Popolare a San Miniato. Non avevo mai scritto per il teatro se non molti anni prima, antefatto dimenticato, pietra oscura. Neanche
scrivendo Ipazia secondo una morfologia
drammaturgica avevo pensato davvero a una
possibile rappresentazione.
Ebbi allora modo di ammirare la sua lettura
affilata, aderente, precisa: questa offriva e
questa esigeva dagli attori; da là doveva sprigionarsi l’energia della recitazione. Dalla
intelligenza effettiva doveva nascere il pathos.
E su questo mi pareva implacabile. Qualche
attore di grido sopportava male la sua regia.
Tuttavia lo ammirava. Del resto era stato il
maestro di quasi tutti all’Accademia.
Ci ritrovammo poi affiancati nella preparazione di Rosales per il teatro di Genova che
esordì però al Maggio fiorentino, nel 1983,
alla Pergola.
Ci furono poi occasioni innumerevoli di collaborazione a partire dalle letture dantesche
nella chiesa di Badia che curò meticolosamente per anni. Anche io lessi qualche canto
della Commedia davanti a quel pubblico, in
quella atmosfera.
Ci furono anche vagheggiamenti, sogni che
rimasero tali. Un desiderio inappagato di
Orazio fu che io mi cimentassi con Emmaus.
Era un tema vertiginoso di cui si parlò più
volte. Ma io non lo sentivo in forma drammaturgica, ma piuttosto come un assoluto
simbolico. Lui però insisteva e io non rinunziai del tutto al progetto, intanto gli anni passavano.
Il fatto è che Orazio era, sì, un grande uomo
di teatro e aveva insegnato il teatro a tutta la
mia generazione e alle seguenti, ma lo era in
una visuale più ampia e certa di poesia. Era
dottissimo nella letteratura poetica di ogni
età e la composizione di poesie occupò non
poca parte del tempo che l’attività teatrale gli
lasciava libero. In anni recenti scelse con
l’aiuto di Sauro Albisani alcuni gruppi delle
sue poesie e ne fece un volume cospicuo a cui
stesi una breve prefazione. Con un fermo
risentimento stilistico soggettivo passavano in
quelle pagine parecchie delle fasi di ricerca
della poesia novecentesca in Italia e in
Europa. La sua aristocrazia naturale e ben
coltivata traspariva subito.
Di essa poteva accorgersi anche chi lo ascoltasse leggere i testi prediletti. Era d’una efficacia sobria ma molto incisiva. Ricordo che
durante un grande raduno di giovani a
Palazzo Vecchio in cui si parlò di Dante e di
Rimbaud si riuscì a tirarlo su dalla platea
dove si trovava per curiosità o per caso e io lo
persuasi a leggere l’ultimo canto del Paradiso.
Aveva problemi di voce, corde vocali allentate, era ancora in terapia. Ma quella lettura
roca e tesa, intellettivamente vibrante, soggiogò quell’affollatissimo uditorio e rimase
nella risonanza interiore dei presenti quando
si disciolsero.
Orazio Costa REGISTA
R
numero 1
16
SIAMO STATI
IRRICONOSCENTI
VERSO ORAZIO
di Luca Ronconi
ia per mancanza di tempo e di abitudine, sia soprattutto per una certa qual
sfiducia nelle mie qualità di scrittore, da
sempre mi riesce difficile mettere su
carta i miei pensieri: per lo più - e certo
se così non fosse nella mia vita non mi sarei
trovato a fare il regista - preferisco ricorrere al
teatro per parlare di chi o di quanto mi sta a
cuore; quando però dall’Ente Teatrale Italiano
mi è arrivato l’invito a stendere un breve contributo in ricordo di Orazio Costa a poche settimane dalla sua morte, vincendo d’acchito
tutte le mie più profonde remore nei confronti
dell’esercizio diretto della scrittura, ho subito
accettato la proposta nonostante la circostanza
fosse quanto mai “a rischio”: non di rado infatti, specie in un “autore” inesperto quale io
sono, al di là di ogni buona intenzione la sincera volontà di dar voce al dolore per la scomparsa di una persona cui si era legati, mantenendone vivo il ricordo, finisce, fissandosi in
discorso, con l’impantanarsi tra le secche delle
facili frasi fatte - non per nulla, ma è già questo
un luogo fin troppo comune, si sa che spesso
di fonte all’enormità e all’eccezionalità di un
evento come la morte, l’unico possibile commento è il silenzio. Fatti tutti questi preamboli,
perché dunque - e io per primo me lo sono
chiesto - non ho esitato un istante nel rispondere alla sollecitazione del professor Tian?
La prima ovvia risposta è che per chiunque in
Italia ami il teatro, sia come “fruitore” sia come
“operatore”, rendere omaggio a Orazio Costa
all’indomani della sua scomparsa, era sicuramente un atto dovuto. Non sono uno storico
della scena e non spetta quindi a me render
conto in dettaglio dei debiti che buona parte
dei protagonisti del teatro italiano del dopoguerra hanno contratto nei confronti di Costa,
ma credo sia sotto gli occhi di tutti l’importanza dell’apporto che Costa ha dato alla crescita
della civiltà teatrale italiana nella seconda metà
del secolo che si è appena concluso. Compagno
di strada di Silvio d’Amico e allievo assistente di
Jacques Copeau, promotore e protagonista
S
numero 1
17
Orazio Costa REGISTA
Il giovane
Luca Ronconi
attore in Candida
di G. B. Shaw
«Con Costa
- dichiara oggi
il regista ho condiviso
la passione per la
parola-in-scena.
In fondo alle
origini della mia
visione del teatro
come momento
di conoscenza
c’è anche l’idea
costiana del teatro
come “misura
dello spirito”»
numero 1
18
della “rivoluzione” teatrale, che a partire dai
tardi anni Trenta segna l’avvento sui palcoscenici patri della figura del “regista” - parola e figura
nei confronti della quale egli, d’altra parte, conservò un’ironica “distanza” per tutta la vita -,
pedagogo di non comune carisma impegnato
con rara abnegazione nelle più diverse avventure didattiche - dal pluridecennale insegnamento in Accademia a quello presso il Centro
Sperimentale di Cinematografia, dalla creazione del Centro di Avviamento all’Espressione di
Firenze all’apertura della Scuola di Teatro di
Bari -, maestro a vario titolo di quasi tutti i più
acclamati interpreti della nostra scena (e non
solo), da Tino Buazzelli a Nino Manfredi, da
Paolo Panelli a Glauco Mauri, da Monica Vitti
a Rossella Falk, da Umberto Orsini a
Giammaria Volonté, da Gianrico Tedeschi a
Giancarlo Sbragia o a Gabriele Lavia - per non
citare che alcuni nomi a caso dallo sterminato
registro dei suoi allievi -, Costa ha lasciato una
traccia indelebile nel panorama teatrale italiano
degli ultimi decenni. Probabilmente considerazioni di questo genere già sarebbero sufficienti a
spiegare in assoluto il desiderio, o forse meglio
la necessità di ricordare il lungo viaggio attraverso la scena di Costa, ma non bastano a far
luce sui motivi più veri che mi hanno spinto a
scrivere queste righe.
Abbandonando il punto di vista generale a
vantaggio di una prospettiva più personale,
devo subito cominciare con l’ammettere che
per primo appartengo alla gran massa degli
numero 1
uomini di teatro italiani che non possono
negare i propri obblighi di riconoscenza nei
confronti di questo grande Maestro. Nel biennio 1951-52 /1952-53 ebbi Costa come insegnante di recitazione in Accademia e in quegli
anni mi trovai pure a seguire le sue lezioni di
regia; subito dopo il mio debutto come attore
sotto la guida di Squarzina in Tre quarti di
luna nel 1953, proprio diretto da Orazio
Costa mi trovai poi a cimentarmi nella mia
seconda prova d’attore in una messa in scena
di Candida di George Bernard Shaw prodotta
dal Teatro Stabile di Roma nel 1954. Il successivo appuntamento professionale - ma questa
volta a ruoli invertiti - col mio ex insegnante
risale a una ventina d’anni dopo la messa in
scena shawiana appena ricordata, quando volli
cioè Orazio come attore nella versione televisiva di Orlando furioso. Al di là delle profonde
differenze di gusto e di orientamento culturale
che ci hanno separati, non posso e non voglio
nascondere che Costa ha ricoperto un ruolo
determinante nella mia formazione teatrale.
Certo non mi sono mai riconosciuto nel
metodo Costa, ma da Costa ho imparato la
necessità di fondare su basi etiche (più ancora
che mistiche) il rapporto con la scena, il piacere di analizzare le questioni interpretative risolvendole di volta in volta secondo le loro irriducibili specificità nell’ambito di una robusta
“quadratura” intellettuale e, pur se forse sulla
base di diversi presupposti estetici, con Costa
ho condiviso la passione per la parola-in-scena.
In fondo alle origini della mia visione del teatro come momento di conoscenza c’è anche
l’idea costiana del teatro come “misura dello
spirito”, alle radici del mio approccio empirico
all’esperienza registica ci sono i ricordi di certe
lezioni di Costa e di certi suoi suggerimenti su
come “scartocciare” - mi si passi il termine logicamente i problemi di senso; forse il mio
rispetto quasi maniacale del testo non poggia
sulla fede nel logos, ma sicuramente la cura
attenta che cerco di dedicare alla restituzione
teatrale della parola non è troppo lontana dal
rigore con cui Costa “leggeva in scena” Ibsen o
Molière, Goldoni o Alfieri o i classici del teatro
religioso medioevale. È proprio per questa via,
ossia attraverso un aperto riconoscimento di
quanto ho appreso da Orazio Costa, che posso
arrivare a parlare del senso autentico di queste
mie frammentarie note.
A fronte della sincera ammissione dell’influenza che Costa ha avuto sul mio percorso teatrale,
influenza che a dire il vero non ho mai voluto
negare o celare, c’è da parte mia un’acuta percezione dell’ingratitudine che, di fatto, ho riservato, e forse in questo non sono ahimé stato il
solo, a questo grande uomo di teatro. Sia chiaro
che chiamando in causa la società teatrale italiana - o quanto meno parte di essa - nel mio
discorso non intendo sottrarmi a quelle che
sono e so essere le mie personali responsabilità,
né, men che meno, voglio accusare qualcuno in
particolare, ma sforzandomi di essere il più possibile lucido vorrei cercare di rendere il giusto
riconoscimento a Costa, tentando, per quanto
possibile, di trarre anche da un avvenimento
doloroso come la sua scomparsa un insegnamento o per lo meno un motivo di riflessione.
Credo sia fuor di dubbio che, fatte alcune debite eccezioni, il teatro italiano, di cui torno a dire
io per primo faccio parte, si sia mostrato nei
fatti, anche se certo non per deliberata cattiva
intenzione, irriconoscente verso Orazio Costa,
che proprio al teatro italiano ha consacrato l’intera esistenza: l’isolamento in cui non si può
negare Costa abbia vissuto negli ultimi anni
della sua vita è lì a dimostrarlo, costringendoci
a prendere posizione su quale sia l’essenza dei
nostri costumi teatrali. Sicuramente Costa per
primo, con quel suo inconfondibile e un po’
aristocratico distacco ha contribuito in un certo
qual modo a creare la situazione che ho appena
denunciato, ma lungi dall’essere una giustificazione dell’operato di chi, come me, non ha
saputo o voluto dimostrare appieno la propria
gratitudine ad un tale maestro, proprio quest’ultima osservazione ci fornisce nuovi soggetti
di meditazione. In una società teatrale dominata da una certa “scioltezza”, da una certa affettazione di cordialità, i modi severi e austeri di
Costa, certo talvolta fors’anche un po’ pedanti,
ma sempre rispettosi e dettati da un solidissimo
codice morale, non sono stati mai più di tanto
accettati e capiti. Ma una società teatrale di
questo tipo può darsi una “tradizione”? E ancora: può esistere una vera civiltà teatrale in mancanza di una tradizione? E in ultimo: Costa
non ha forse cercato per tutta la sua vita di fondare a suo modo proprio una “tradizione”? Ma
allora che risultati hanno prodotto i suoi sforzi?
Certo questi interrogativi non possono non
lasciare in chi li pone una profonda amarezza,
ma in questa sorda inquietudine, in questa
insoddisfazione che essi provocano, sta la loro
necessità, la loro urgenza. Ed è anche perché ci
ha aiutato a porci simili domande che dobbiamo ringraziare Orazio Costa, questo maestro
un po’ distante ma sempre generoso, che con la
signorile eleganza e la discrezione che gli sono
state proprie per l’intera vita, ci ha da poco
lasciati per sempre, trasmettendoci come sua
preziosa eredità, più ancora che un modello di
teatro, un esempio di vita.
Orazio Costa REGISTA
19
«Costa non è stato
solo un modello
di teatro ma anche
un esempio di vita»
numero 1
20
IL RESPIRO
MISTICO
DEL POVERELLO
di Paolo Emilio Poesio
ell’estate del 1950, l’Istituto del
Dramma Popolare di San Miniato
decise di commemorare Jacques
Copeau, il grande regista spentosi in
Francia il 20 ottobre dell’anno precedente. L’omaggio non intendeva onorare solo
la memoria di uno dei maggiori innovatori
della scena moderna, ma anche ricordare che
a lui, a Copeau, si era ispirata la pattuglia di
intellettuali cattolici che aveva fondato
l’Istituto nel 1947, con l’intento di mettersi al
servizio di “un’arte cristiana e popolare nel
senso più augusto dei due vocaboli”, come
ebbe a scrivere Silvio d’Amico. In molti, per
di più, ricordavano gli spettacoli di Copeau a
Firenze negli anni dell’anteguerra: la celeberrima Santa Uliva nel 1933 nei mistici chiostri
di Santa Croce, il Savonarola di Rino Alessi in
piazza della Signoria (1935), l’As you like it di
William Shakespeare (il cui titolo era stato
tradotto da Paola Ometti nel toscanissimo
Come vi garba), nel Giardino dei Boboli
(1937). In quest’ultima occasione Copeau
aveva voluto al suo fianco il giovane Orazio
Costa, che, oltre a diplomarsi in regia
all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica,
aveva anche voluto recarsi in Francia per
lavorare con Copeau e i suoi allievi.
Ciò detto è facile capire come e perché
l’Istituto del Dramma Popolare, una volta
deciso che l’omaggio al Maestro scomparso si
sarebbe concretato nella rappresentazione di
uno dei non molti suoi testi drammatici - e
precisamente l’ultimo in ordine cronologico,
Il Poverello (Francesco d’Assisi) -, ne affidò la
regia a Costa, iniziando così una collaborazione che sarebbe poi durata, fra alti e bassi,
parecchi anni.
Lo spettacolo doveva andare in scena il primo
giorno di settembre; e nell’ultimo scorcio di
agosto (per quanto non toccasse a me di
recensire l’avvenimento per il giornale in cui
allora lavoravo) non seppi resistere alla tentazione di andare a salutare Costa impegnato
nelle prove finali. Ricordo di quei giorni i
N
brevi ma interessanti colloqui con il regista
così come ricordo nitidamente le emozioni
suscitate in me dalla rappresentazione, emozioni delle quali trovo traccia nelle sgualcite
pagine di un taccuino. Nella piazza antistante
il duomo e il palazzo vescovile si levava una
gigantesca struttura che richiamava alla
mente le “macchine” e gli “ingegni” delle
sacre rappresentazioni. Struttura nuda, ideata
dalla sorella di Orazio, Valeria, e portata a
compimento dal Santonocito: ma suggerita,
io penso, da Orazio stesso che nei diversi
piani voleva si snodasse la storia di Francesco
e dei suoi seguaci, i fraticelli non sempre consci di quanto fosse alta la prova alla quale
erano chiamati. Nei piani bassi si svolgeva la
vita quotidiana, nei piani alti era la dimora
celeste degli angeli. Cielo e Terra: a coniugarli, direi meglio a fonderli in un’atmosfera e in
una tensione quali di rado si raggiungono in
teatro pensava la lucida, vigorosa regia di
Costa, che non disponeva di attori di grido
(con l’eccezione di Evi Maltagliati già famosa
nel teatro italiano), ma disponeva di un fitto
gruppo di giovani (molti dei quali destinati a
raggiungere traguardi eccellenti, da Rossella
Falk a Giancarlo Sbragia, da Nino Manfredi a
Enrico Maria Salerno, da Ignazio Bosic a
Renzo Giovampietro, da Renato De Carmine
a Glauco Mauri, da Edmonda Aldini a
Marina Bonfigli), giovani che, in buona parte,
erano stati suoi allievi all’Accademia
Nazionale d’Arte Drammatica. Così come lo
era stato quell’Antonio Pierfederici che si era
rivelato nei Parenti terribili di Cocteau con
regia di Visconti e che ora si trovava ad affrontare il personaggio di Francesco d’Assisi e sulle
cui spalle riposava il peso dell’intero dramma
in una fluviale abbondanza di parole.
Ho detto dramma, ma in effetti il testo del
Poverello è più il testo di un poema che non
quello di un fatto prettamente destinato alla
rappresentazione; Costa si era dunque trovato a risolvere un doppio problema: da un
lato il rispetto assoluto e totale dello spirito
e della parola di Copeau, il rifiuto di ogni e
qualunque superfetazione scenografica, la
rinuncia alle facili scappatoie iconografiche
e dall’altro la necessità di trasmettere allo
spettatore il grande respiro mistico capace di
creare quella “comunione” che è il fine desiderato di un’arte cristiana e popolare.
È vero che Copeau si era premurato di lasciare la più ampia libertà di azione a chi un giorno avrebbe messo in scena Il Poverello, ma la
devozione - mai venuta meno - di Costa
verso il suo Maestro poneva limiti invalicabili
e impediva ogni sia pur minimo intervento
materiale sul testo originale. Di qui la rinun-
zia a effettuare drastici tagli alla fin troppo
lussureggiante verbosità, di qui la necessità di
“riscrivere” registicamente la vicenda umana e
sovrumana di Francesco. Il che ha significato
innanzi tutto contrapporre alla staticità di un
testo poetico, ma anche incline all’eloquenza
per l’eloquenza, una visione dinamica degli
accadimenti, trovando un ritmo serrato, un
continuo dipanare discorsi e azioni, tanto da
dare l’impressione che non ci fossero pause,
anche quando in realtà la sola voce di
Francesco bastava a dare la sensazione che persino la natura concorresse a colmare con il frusciare delle foglie e i refoli rapidi di un vento
non più estivo i silenzi interiori del piccolo
folto popolo di personaggi stupiti e sconvolti.
Non so come Costa fosse riuscito a insufflare
negli attori una sorta di febbre, un bisogno
quasi rabbioso di scolpire le parole e di supportarle con una gestualità generosa e controllata insieme, ma so che si ebbe l’impressione
di trovarci dinanzi ad una compagnia di eccezionale compattezza nell’adesione completa
non alla necessaria disciplina, ma addirittura
alla più segreta vena creativa del regista.
In assenza dei tradizionali “effetti” destinati
ad assicurare la positiva disposizione d’animo
nel pubblico facilitando l’applauso, Costa
aveva fatto ricorso ad un uso intensivo del
suono in tutte le sue varianti: due cori, uno
drammatico e uno liturgico, avvolgevano in
un alone gioioso e mistico il succedersi degli
eventi: dalla predica agli uccelli agli incontri e
scontri del Santo con Satana o con i fraticelli
in vena di insofferenza per la durezza della
Regola, via via sino al solenne, commosso
finale del trapasso di Francesco dalla vita terrena a quella celeste. E poi il suono delle voci,
del singolo e dell’assieme, voci che chiudevano in perfetta misura il gesto nel rapporto
costante con la parola. Ma la cosa più sorprendente era il senso di genuina freschezza
emanante dallo spettacolo proprio come
emana dalle pagine dei Fioretti, una freschezza che ci faceva avvertiti dell’intima adesione
e di Copeau e di Costa al richiamo francescano per un ritorno alla parola del Cristo, con il
conseguente rigetto di ogni forma di asservimento ai beni materiali.
Penso che buona parte del pubblico fosse
venuta quella sera a teatro pensando di assistere a una sceneggiatura della vita di Francesco
d’Assisi: e se dapprima vi fu dello stupore, a
poco a poco l’emozione, la commozione, l’entusiasmo ebbero il sopravvento, dimostrando
quanto fosse vero l’asserto di Costa secondo il
quale “il teatro è l’unica forma di attività
umana rimasta a parlare dell’uomo all’uomo,
mediante la realtà dell’uomo”.
numero 1
21
Orazio Costa REGISTA
Orazio Costa legge
Il Poverello
di Jacques Copeau
numero 1
22
osta ha sempre considerato la Pergola
un luogo familiare, tanto da scegliere di
venirci a vivere, dopo una lunga, anche
se discontinua, frequentazione artistica.
L’aveva inaugurata dopo la ricostruzione successiva alla guerra con i Sei personaggi
in cerca d’autore e l’aveva a più riprese utilizzata per preparare alcuni dei suoi spettacoli,
dai primi allestimenti per il Festival di San
Miniato fino al Rosales di Mario Luzi.
Sentiva così di contribuire a mantenere viva
quella che riteneva fosse la vocazione originaria del luogo: teatro sperimentale, spazio
ideale per la ricerca e l’invenzione di nuove
forme teatrali, come, secondo lui, dimostrava
la storia, dall’invenzione del melodramma
alla ricerca di Craig e della Duse su Ibsen per
la nascita del teatro moderno.
L’“aura” del Teatro ben si accordava con la sua
idea di sacralità dell’evento teatrale, tanto che
spesso, dopo aver visto spettacoli che non
gradiva, esprimeva apertamente il suo disappunto chiedendo che lo si “riconsacrasse”.
Probabilmente è per questo che alla fine degli
anni Settanta, in quegli anni straordinari che
videro a Firenze le presenze di Gassman,
Kantor, Eduardo, quando, dopo aver insegnato per alcuni decenni ad attori in Accademia,
decise di propagare il suo Metodo Mimico,
scelse la Pergola come punto di partenza ideale per la realizzazione del progetto: negli uffici
situati sopra l’atrio del teatro il Centro di
Avviamento all’Espressione cominciò la sua
attività d’informazione sul Metodo nel ’79.
Informazione e non formazione, centro di
avviamento e non scuola. Queste le finalità di
una struttura che, grazie all’ospitalità dell’Eti,
fra il ’79 e il ’92 realizzò oltre 250 corsi, per
più di 4.000 allievi, in tutti i quartieri di
Firenze e in molte altre città della Toscana e di
altre regioni, con una diffusione tanto capillare, che si può senz’altro considerare una delle
esperienze pedagogiche in campo teatrale fra
le più significative degli ultimi anni.
Per lui fu comunque solo un punto di partenza, un modo per ricominciare, ancora una
volta, a interessarsi dell’uomo a prescindere
dal teatro. Come Copeau, di cui si considerava indegno allievo, il suo unico, vero interesse
era quello di formare uomini, non attori.
Col recupero, l’esercizio, l’affinamento dell’istinto mimico, riconoscere, liberare, perfezionare, le forme, le forze, le interazioni organiche
dell’espressività naturale e riscoprirne il coerente armonico confluire nella parola vivente e in
ogni altro linguaggio in cui si manifesta l’inesauribile incontro dell’uomo con la realtà.
Questa la sua scoperta, non invenzione, un
metodo - non metodo, applicabile a qualsiasi
campo dell’espressività umana, attraverso il
quale giocava a interpretare tutto: il mondo
come un gran teatro determinato, inventato,
plasmato dall’uomo sotto la spinta del suo
istinto primario, quello di “farsi altro da sé”,
l’impulso alla trasformazione, al cambiamento, al “mettersi nei panni di” che ogni forma
C
ORAZIO COSTA
E IL TEATRO
DELLA PERGOLA
di Marco Giorgetti
Orazio Costa
prova un cappello
a Flora Carabella
durante le prove
di Sei personaggi
in cerca d’autore
di vita possiede innato e di cui “informa”
tutta la propria esistenza.
Era la sua sola certezza, che coltivava come il
possesso di una chiave che poteva aprire tutte
le porte e di cui propagava generosamente l’utilità, come un bene prezioso alla portata di
tutti, e per la quale, anche se non si definiva
Maestro, continuava a vedere giovani aspiranti attori, a consigliarli o a sconsigliarli, con la
sincerità di cui molti lo hanno poi ringraziato.
Una volta conclusa l’esperienza del Centro,
fin dal ’93, sempre alla Pergola dove ormai
abitava, continuò a lavorare a progetti che
sempre di più, secondo quanto gli tornava da
Copeau, ponevano al centro di un percorso
formativo il neofita, non l’attore. Fino a quello ultimo, perseguito fino a pochi giorni
prima di morire, di una compagnia di dilettanti che, partendo dalla lettura di Dante,
giungesse alla realizzazione di un Amleto corale, nella sua nuova traduzione.
Nelle rare occasioni che aveva di tornare sul
palco leggeva. Aveva scoperto che la “lettura a
voce alta” poteva offrire al pubblico altrettanto che una messa in scena completa.
«Riaprire il libro di Pirandello per ricominciare a leggere». Questo raccomandava ripetutamente. Leggere come unica possibilità di
ricominciare a fare il teatro.
È probabilmente per questa convinzione che
ha dato vita, sempre col Centro di Avviamento
a molti cicli di letture: “Lecture Dantis” che
ripristinavano la tradizione iniziata da
Boccaccio nella Chiesa della Badia Fiorentina,
letture di autori contemporanei in collaborazione col Gabinetto Vieusseux, drammatizzazioni con un forte elemento oratoriale.
Ed è senz’altro per questa convinzione che ha
scritto e pubblicato poesie, anch’esse presentate in lettura alla Pergola, durante una serata
alla quale hanno partecipato molti suoi ex
allievi attori. Pochi giorni prima di morire
aveva ancora molti straordinari progetti, vivi,
reali, e nel ripercorrere a memoria testi drammatici o poetici era sempre prodigo di straordinarie rivelazioni, di illuminazioni che aprivano direzioni impensate all’interpretazione
di ogni autore, il cui merito attribuiva non a
sé ma al suo Metodo. Progetti, idee, che restano alla Pergola, negli stessi locali in cui, dopo
l’attività del Centro, viveva, dove ha voluto
lasciare il patrimonio inestimabile dei documenti di oltre sessant’anni di teatro, premi,
menzioni, riconoscimenti giunti da ogni
parte del mondo, che non aveva mai esposto
e di cui non parlava volentieri. Considerava i
premi la consacrazione di un risultato finale,
mentre riteneva di dover ancora raggiungere
il risultato iniziale del suo percorso artistico.
L’unico premio che avrebbe considerato tale,
rispondeva a chi gli offriva l’occasione di una
serata d’onore, sarebbe stato quello di tornare
sul palcoscenico a leggere Alfieri per un pubblico di bambini. Solo una delle molte cose a
cui ha lavorato con straordinaria lucidità fino
al suo ultimo istante di vita.
numero 1
23
Orazio Costa E IL TEATRO DELLA PERGOLA
Roberto Herlitzka
in una scena
della Vita nuova
numero 1
24
Un’immagine
di Venezia salva di
Massimo Bontempelli
dai Quaderni di
Orazio Costa
Gli esercizi di scrittura dei registi di teatro solitamente si limitano alla pratica ordinaria delle
“note” dettate per illustrare e giustificare il proprio spettacolo. Più di rado accade che un regista
rifletta in modo metodico e continuativo sul proprio e l’altrui lavoro, proponendo in maniera
più distaccata una “idea del teatro”, una visione prospettica e consapevole di un mestiere che
abbraccia l’intero orizzonte del palcoscenico.
Orazio Costa Giovangigli cominciò a tenere il suo diario a 35 anni, quando era da poco terminata la seconda guerra mondiale, e da allora a pochi giorni prima della sua scomparsa ha
continuato a registrare pensieri, propositi, osservazioni, memorie, riflessioni, polemiche e sogni,
accumulando per poco più di mezzo secolo quarantasei “Quaderni” numerati, tuttora inediti,
vergati a mano con calligrafia rapida e instancabile. Diario di lavoro culturale ed esistenziale:
un flusso così costante e disteso non lo ritroviamo in nessuno dei grandi registi del ‘900, eccezion
fatta per colui che Costa considerò il suo maestro, Jaques Copeau, autore di quei “Registres” che
tuttora costituiscono fonte preziosa per la conoscenza e la comprensione del teatro contemporaneo.
Le pagine che qui pubblichiamo sono quelle scritte nelle ultime settimane di vita di Costa dal
29 agosto al 4 novembre 1999. Della fine imminente non vi è alcun presagio; se non forse
quelle singolarissime frasi in cui lo scrivente dice che “prova a contarsi”: una specie di ricognizione precisa e simbolica di varie parti del corpo enumerate più con il ricordo e la visione che
non con la percezione diretta. Questa ricapitolazione di alcuni luoghi della persona fisica sembra quasi il tentativo di raccogliersi e conoscersi in vista di un traguardo certo, anche se non
ancora visibile: una voglia di “espandersi nell’oltre” che è anche un’attesa. Questo presentimento di un evento imminente e decisivo non frena il bisogno di interrogarsi, spiegarsi e raccogliersi che è il filo conduttore di tutti i Quaderni. Dieci giorni prima della sua scomparsa, Costa
scrive una frase che potrebbe essere il motto di ogni sperimentazione: “ho provato: ma devo verificare”. La frase concerne un tema di lavoro che è stato centrale negli ultimi anni di vita del
regista: “verificare al più presto uno stile più compatto in una definitiva versione dell’ Amleto”.
Renzo Tian
dai Quaderni di
Orazio Costa
Q
46 (1)
Oggi 29 agosto inauguro questo Q 46, mentre continuo a usare il lento Q 45, che spero
dedicare un po’ definitivamente all’Amleto....
Q
46 (2)
Forse potrà valere la pena di verificare le più
recenti osservazioni intorno al metodo mimico
e particolarmente su “Il verso dell’uomo”,
cominciando da un elenco, sul quale ritornare:
Q
46 (3) 2.IX.99
Nel ricordo intenso di rapporti anche non
durati c’è una verità, una forza, che fanno il
senso di particolari momenti della vita, la
sequela dei quali non può non far pensare a
quei sèrti di preziose “margherite” di cui gli
antichi si costellavano il firmamento appropriandoselo.....
Q
46 (4) Intanto 2.IX.99
Nonostante il continuo lavoro di condurre il
luogo scenico alla necessaria rispondenza con
le intuite visioni dei diversi momenti della
rappresentazione, sia stato il mio impegno
più normale, non posso dire di averlo razionalizzato al punto di poterne definire, anche
teoricamente, il procedere. Ciò che sono tentato di fare in questa occasione. Penso che in
ogni diverso caso finisca per prevalere un
momento iniziale che forse potrebbe esser
faticoso e addirittura inutile pretendere di fissare a priori, anche perché è forse giusto e
fatale che la lunga e spesso antica famigliarità
con le idee conduttrici del soggetto sia la
matrice delle idee originali che spesso diventano il contrassegno della genialità del regista
o dello scenografo. Così tento di rendermi
conto al meglio di un percorso che, senza
essere meccanicamente predisposto né prevedibile, possa rendermi consapevole della personalità del mio intervento e in qualche
modo anche di certe caratteristiche, diciamo
estetiche, dell’augurata unità dell’operazione
complessiva della poesia drammatica.....
Q
46 (5) 2.IX.99
Or è qualche giorno (conservo la data precisa) la TV mostrò la stupenda visione del più
smagliante prodotto dell’aspirazione al moto
nelle altitudini celesti che pur essendo alle sue
prime prove non poteva non promettere
all’uomo stupendi viaggi in tutta tranquillità.
Si trattava di una grandiosa ala volante tenuta
sospesa dalla forza di un volo ottenuto dall’energia solare unita alla resistenza dell’atmosfera. Opera che forse unita all’altra da tempo
vilmente abbandonata del dirigibile, avrebbe
messo fine alle stragi di passeggeri sacrificati
alla ignobile preponderanza soprattutto economica della energia petrolchimica.
Ricordo con una nostalgia assieme di gioventù, di amicizia e della mia solita cara indignazione, il rigoglio e la fine dei voli areonavali (forse c’è stata una parola più giusta creata dal mago Gabriele inventore dei “Velivoli”)
soppressi con la speciosa scusa del pericolo....della lentezza....dell’ingombro ai tempi
in cui si osò spingere le superbe navi d’argento oltre il Polo.
C’era una bella storia allora dell’amico pittore
polacco Shoja Schaechter, poi ribattezzato
Sebastiano, che mandava poesie e pitture
romane a una sua bella amorosa imparentata
con la famiglia Zeppelin.
Io “tifai” allora per la sopravvivenza dei dirigibili.
Q
46 (4).
In questo caso la prima idea impostasi come
soluzione dell’alternarsi delle azioni è stato
l’uso di un “principale” formato da strisce
verticali di tessuto trasparente in grado di
captare la proiezione dei più diversi elementi
scenografici.
La formazione a strisce consente l’attraversamento del principale stesso da parte di attori
presenti sulla faccia anteriore messi in grado
di scomparire così come quello da parte di
attori attivi nella parte posteriore messi in
grado di apparire con il simultaneo concorso
del cambiamento delle proiezioni.
Q
46 (6) 3.IX.99
L’opportunità o la necessità dell’uso di praticabili potrebbe esser prevista in un secondo
piano.
Q
46 (7) 5.IX.99
Se non si può ulteriormente semplificare.
Q
46 (8) 5.IX.99
Quasi mi meraviglio (eppure sono qui per
questo) di aver continue novità in questo
benedetto Amleto. Oggi mi rendo conto che
il confronto col personaggio è quasi certamente la volontà di proporsi un vero ritratto
personale con le sue ambizioni e contraddizioni. Ci sento addirittura un’aura dantesca
in questo parlare di sé a confronto con personaggi storici ed altri viventi giudicati (salvati
o condannati) a vario titolo.
21 ottobre - sera
Non mi dispiace di riprendere questo Q 46
in occasione della rarissima visita di Pino del
19 ottobre.
Ho molte cose da dirmi che voglio salvare.
E intanto, per non perdere le mie manie di
osservazione debbo cercare di capire o di
sapere (perché non può non esser caduto
sotto l’occhio di molti osservatori) se una
certa misura del tempo che tutti sperimentiamo è mai stata proposta per unità in qualche
modo controllabile... Si tratta di quel minimo lasso fuggevole che corre (quando cadiamo e temiamo di farci male) tra la perdita del
controllo e il contatto con la solidità che riesce ad arrestarci... È qualcosa di molto prossimo all’ATTIMO (recentemente e forse non a
caso divenuto assurdamente ATTIMINO) la
cui misurazione non può non aver tentato
più o meno consapevolmente fisici e matematici, oltre che tutti noi nei frequenti
momenti delle perdite di controllo....
dalle 20 del 28.X
Provo a contarmi; sento appena, ma d’esserci
dovrei essere certo. Mi scordo. Ricordo le
lunule rosa dell’unghie; le noci delle caviglie,
i polpi dei diti, i ponticelli sulle arcate piante.
Le mazze cardiache dei talloni e di lì, i tondini, gli stinchi i nudi ginocchi e le anche quadrate, i glutei rotondi, le multiple rotule e
vertebre, le coste, la chiglia frangiflutti, pulsante d’ali implose vogliose di espandersi nell’
“oltre” ch’è il loro destino...
29.X
Forse non nuocerebbe lasciare che diverse
consistenze di presenza si muovano con una
certa libertà.
Resta fermo che primaria rimane quella in
cui decido di risiedere “ufficialmente”. Ma
consentendo che altri momenti trascorsi o
addirittura nuovi si alternino serenamente....
31.X
L’ossessione del volto così onnipresente ha
imposto la necessità del ritratto e particolar-
mente dell’autoritratto. Da tempo ho pensato
a ritrovarne documento nella poesia di Dante
la cui Commedia è quasi l’Odissea al volto di
Dio (di Gesù e di Me).
Ma con tutta la visione televisiva, fotografica
che ha invaso il nostro “campo visivo” mi
accorgo oggi (!) che si tratta solo di un ossessivo eccesso in cui a causa della predominante
presenza del volto altro (cioè quasi unicamente del volto di altri... di tutti gli altri) finisce
per perdersi proprio il volto di Me... che è
forse quello che tuttavia è quello “in cui
siamo”. E vien da chiedersi, con avida insistenza “dove sia” “in che consista” questo
VOLTO MIO, che raccogliamo e riconosciamo nelle nostre mani. Noi (Io) ce lo riconosciamo unico al contatto, lo vediamo persino,
alla denuncia dello SPECCHIO; ma della
consapevolezza del suo consistere che è “psichicamente plastica” non abbiamo alcuna
possibile rappresentazione.
Né si può sperare che venga una nuova
dimensione (con chi sa quale tecnica astratta)
a rappresentare questa realtà che siamo soli a
conoscere, tanto da esser capaci di modificarla dirigendone certi movimenti che sappiamo
capaci di significati e di corrispondenze. E
quella che si chiama più usualmente “mimica” ha un vocabolario estremamente vario e
addirittura vasto a seconda di una istintività
di cui siamo padroni e non sempre precisi
conoscitori anche perché i vocaboli di questa
suprema tecnica dell’esprimersi sono sempre
da inventare.
31.X
Forse con molto ma necessario ritardo sto
arrivando a distinguere Mimesi e Mimica
(ciò che ogni buon vocabolario avrebbe
dovuto impormi fin da principio...).
Impormi sì, per la presunzione di farmi
distinguere nettamente un comportamento
originario d’imitazione istintiva e forse
incontrollabile proprio certi organi fisiologicamente atti ad assumere del tutto spontaneamente aspetti simili ad altri organi o a
fenomeni.
Sì ci vuole tutto il coraggio possibile per chiamare la parola che ci occorre
per evocarla
per suscitarla
per scovarla lì dov’è rintanata
per stanarla. Per INVENTARLA
e ciò con la sola guida d’un significato
Eppure.... LA PAROLA o la conosci o l’hai
E IMPARARE significa questo?
Mimesi termine filosofico
Mimica termine della lingua parlata
Praticamente culmini miei di una realtà di cui
solo l’Io è consapevole per esperienza personale della quale non può far a meno fin dai greci
e continuerà a essere finchè non venga scoperta e accettata una “scrittura” plastica come in
qualche momento avevo previsto.... Continua
Forse sento con particolare evidenza, che la
pulsione mimica è un fatto unico, strettamente privato, non trascrivibile per assoluta
mancanza d’una scrittura leggibile, ma tuttavia largamente descrivibile mediante sensazioni fisiche assai variamente trasferibili a vari
livelli lirici. La mancanza è una trascrizione
unica, obbliga e invita la fantasia a moltiplicarsi in poesia.
3.XI...
Tento, (è un continuo tentare) di ordinare le
carte sparse secondo una sorta di catalogazione, che ne qualifichi la pratica utilità: anche
oggi
4.XI
Ho provato: ma devo verificare.
Verificare al più presto uno stile più compatto in una definitiva versione dell’Amleto.
Una scena del
Mistero della Natività,
Passione e Resurrezione
di Nostro Signore
L’ESPERIENZA DEL METODO
MIMICO
RACCONTATA IN FILM
di Maricla Boggio
lto e diritto, il volto mobilissimo, candidi i capelli ricciuti, le mani nel gesto
che precede le parole a rivelarti, come
mai prima hai saputo, te stesso e il
mondo, con quella voce aristocratica,
affettuosa, velata di tristezza o aperta al riso,
la voce del maestro di innumerevoli voci del
teatro: Orazio Costa era così.
Dal teatro la sua nascita è segnata in maniera
giocosa, favolistica. Mentre sua madre era
prossima al parto, ad un balcone sul retro dell’appartamento in cui abitava la famiglia si
affacciava di tanto in tanto un’amica venuta
ad assisterla, per darne notizia alle donne che
si sporgevano dai ballatoi dei palazzi circostanti, come da palchi profilati sui cortili. Col
passare dei giorni nelle donne cresceva l’impazienza, finché a sorpresa in un fulmineo
apparire la donna lanciò il festoso grido “È
nato!”. L’annuncio venne accolto da un
applauso entusiastico che risuonò tutt’intorno dalle case. “È stato il primo applauso della
mia vita!”, raccontava Costa ridendo.
La formazione teatrale di Orazio Cosa inizia
all’età di sette, otto anni: “Quando in genere
l’individuo viene cacciato dalla zona della
fantasia, io invece ci sono entrato grazie al
gioco infantile, che per me è stato quasi sempre il teatro”. Sedicenne frequenta lo Studio
“Eleonora Duse”, che divenne poi l’Accademia per l’impegno di Silvio d’Amico.
Giovanissimo regista va a Parigi, a seguire
Jacques Copeau. L’idea base che gli deve è che
l’attore deve essere educato proprio mirando
all’uomo e non alla cosiddetta arte, alla finzione esterna; si forma un uomo, e si forma
un possibile artista. Nell’arco di quasi set-
A
tant’anni Costa firma la regia dei testi di più
alto valore drammaturgico della produzione
mondiale di ogni tempo. In parallelo, Costa
mantiene ininterrotta la pratica dell’insegnamento. L’Accademia lo chiama alla cattedra
di regia nel 1944, dove rimarrà per più di
trent’anni. Alieno da esibizionismi protagonistici e nemico di superficiali effettismi, Costa
va approfondendo sempre più un’indagine
sull’attore e sul testo, riportando all’uomo
tutto quanto l’universo. È un metodo che si
affina attraverso ragionamenti, sperimentazioni, esperienze sul campo; non è una tecnica né una pratica; non vi sono estranei movimenti di pensiero, teorie filosofiche e scientifiche da Bergson a Morin a Monod, in un
intrecciarsi di elementi che fanno intravedere
un’umanità in crisi, alla ricerca di modalità di
comunicazione non prevalentemente tecniche, che riconducano l’uomo ad una centralità perduta e di cui ha profonda nostalgia; un
metodo che si applica nelle prove, ma anche
fortemente teorico: esso si rivolge alla razionalità delle persone e insieme ad una loro
sensibilità latente, che la mimica fa riemergere valorizzando l’espressività del corpo che a
sua volta influisce sulla voce. È, in definitiva,
un insegnamento diretto a curare la dimensione metaforica del discorso.
La grande scoperta di Orazio Costa è che la
mimica copre assolutamente qualunque attività
dell’uomo. Ma l’uomo - paradossalmente - in
genere non si accorge dei fenomeni mimici
spontanei che avvengono in lui. L’indagine
prosegue scoprendo che il linguaggio fa parte
della manifestazione mimica, perché nel
momento in cui il pensiero vuole manifestarsi al di fuori del soggetto pensante, deve per
forza dare sfogo a quella sorta di pressione
che è prodotta dall’impulso mimico, una
sorta di danza. Se la danza è un’arte ben visibile, danza è anche il pensiero del poeta che
scrive le sue fantasie traducendo in parole il
moto interiore dell’ispirazione; è danza il
grido del personaggio tragico che sente irrefrenabile l’uscire da sé dell’emozione, o il
dolore contenuto nel personaggio del dramma borghese dall’apparenza indifferente; è
danza l’impulso del regista che dà corso
all’interpretazione degli attori con la sensibilità suggeritagli dalla lettura meditata ed
emozionale del testo.
“È un processo di lavoro che si basa sul fatto
che l’uomo ha come facoltà primaria di reagire di fronte alla realtà con l’adeguamento
di tutto il proprio essere fisico e spirituale,
tanto da divenire la realtà stessa. - questa in
sintesi è la definizione che Orazio Costa dà
della mimica - L’uomo s’immedesima spontaneamente nella realtà; vivere si può dire
che sia proprio immedesimarsi”.
Ero stata sua allieva in Accademia, poi regista assistente in congressi internazionali Essen, Venezia - e per il Songe d’une nuit
d’été al Rideau de Bruxelles. Addestravo gli
attori alla mimica e poi Costa provava con
25
Orazio Costa PEDAGOGO
ORAZIO COSTA PEDAGOGO
numero 1
numero 1
26
numero 1
loro. Del Sogno aveva già realizzato a Roma
al Teatro Quirino, con gli allievi
dell’Accademia, una regia interamente
mimica; anni dopo Renzo Tian la definì una
rappresentazione anticipatrice del Sogno di
Peter Brook. Fu da quelle esperienze vissute
a stretto contatto con il Maestro che nacque
l’idea del film. Era necessario fare in modo
che il metodo mimico potesse essere conosciuto non soltanto dai pochi che lavoravano con Costa, né bastava scriverne a livello
saggistico. Il mezzo più adatto, forse, era un
racconto filmico, a cui lo stesso Costa prendesse parte. Andammo scegliendo insieme
luoghi e persone, antichi allievi e ragazzi
nuovi, attori e gente comune, critici, poeti,
studiosi. A metà degli anni Ottanta Orazio
Costa, dopo aver lasciato l’Accademia, dirigeva i corsi del MIM - Centro di
Avviamento all’Espressione di Firenze, aperti a chi volesse arricchire la propria creatività, pur senza intenti teatrali; nel contempo
aveva realizzato a Bari un progetto, a lungo
vagheggiato, di una scuola per attori interamente mimica. Presso l’Istituto del Teatro
dell’Università La Sapienza di Roma dei
suoi allievi tenevano corsi di mimica, frequentati da studenti di diverse facoltà, dove
si sperimentava l’immedesimazione perfino
nella pittura e nella musica.
Lavorando al progetto delineammo un percorso attraverso il quale mostrare come il
metodo mimico, partendo dal respiro e percorrendo le forme più primitive della nostra
fisicità, consentisse all’essere umano di
“diventare” tutti i fenomeni che gli si presentassero - aria fumo nuvola pioggia grandine
pietra e così via -, per passare poi agli esseri
animati - piante e animali -, arrivando alla
sonorità vocale e ai concetti astratti verbalizzati, fino a giungere alla parola del poeta
attraverso il suo percorso emozionale, e in
esso immedesimarsi mediante la propria sensibilità. La Ricerca e Sperimentazione della
Rai manifestò curiosità al metodo. Ottenni
due troupe cinematografiche e un periodo
ampio dedicato alle riprese.
Al MIM di Firenze riprendemmo delle persone che non avendo mai praticato il teatro
arrivavano ad esprimersi creativamente. Una
giovane operatrice lavorava con dei bambini
della scuola materna, che si divertivano un
mondo a “fare” la nuvola, la grandine e l’acqua che scorre. Tutto quel festoso agitarsi
portava anche al risultato di sbloccare i bam-
bini da inibizioni congenite o indotte da
situazioni familiari. In una scuola media, in
mezzo ai ragazzini che con trascinante entusiasmo mimavano il fuoco, il preside e gli
insegnanti affermarono che la mimica aveva
giovato agli alunni anche nel rendimento
dell’italiano e della matematica, in tutti
essendosi accresciuta l’osservazione e la partecipazione. Nei quartieri, giovani e adulti,
guidati dagli operatori, “diventavano” vulcano, vento, pioggia, fino ad affrontare, nei
corsi più avanzati, l’immedesimazione in
parole e poesie. Avevamo invitato degli ex
allievi di Costa, che raccontavano ai ragazzi
della loro esperienza con il Maestro, rievocando lezioni e spettacoli. Gabriele Lavia
descrisse il lavoro mimico sulla battuta del
Messaggero dell’Edipo. Roberto Herlitzka
mostrò diverse possibilità espressive nell’interpretazione della Divina Commedia,
Renato De Carmine rievocò Il Poverello di
Copeau che aveva interpretato con un Costa
poco più che trentenne. Edmonda Aldini si
rifece allieva mimando la vite e le fiere
dell’Aminta, di fronte a una platea di ragazzi
estasiati. Inserimmo anche delle scene tratte
da riprese televisive di spettacoli costiani. Via
via Orazio Costa in dialogo con me andava
chiarendo le modalità operative del metodo.
In un incontro Paolo Emilio Poesio parlò del
ruolo primario del Costa educatore accanto
all’operosità del regista, attorniato da attori
come Tino Buazzelli, Rossella Falk, Paolo
Panelli, Antonio Pierfederici, che era stato il
suo Francesco nel Poverello di Copeau.
Mario Luzi assistette alla mimazione di una
sua poesia e lui stesso ne lesse una, dopo aver
convenuto che forse la dimensione teatrale,
da lui affrontata in quell’ultimo periodo,
aveva in qualche modo influito sul suo percorso lirico. La scelta delle sequenze e il
montaggio saranno lunghi e complessi, con
l’obiettivo di delineare lo sviluppo progressivo del metodo.
Il film proseguì alla Scuola di Bari; la ricchezza espressiva della mimica vi si manifestava in molteplici modi, dalla coreografia
mimica - dove ognuno si esprimeva liberamente immedesimandosi nella musica -, alla
mimazione degli ulivi secolari della campagna circostante, dove a grappoli i ragazzi vi
si paravano dinanzi in un muto riscontro,
fino alla discesa alle infere grotte di
Castellana, dove Costa invitò a mimare l’apparente staticità delle stalattiti, in realtà in
silenzioso millenario movimento, cogliendo
le forme circostanti in stretta analogia con
una sconosciuta interiorità personale. Ci
furono i momenti rapiti dell’immedesimazione nelle giraffe e nelle antilopi, nei pellicani e nei fenicotteri, adeguandosi al ritmo
dei quali si veniva accettati come compagni.
In mezzo a quella varietà di creature e insieme ai ragazzi, Orazio Costa, immemore
delle cineprese, zufolava i sibili degli uccelli
e mimava il passo cadenzato degli elefanti in
perfetta sintonia con loro. Anche a Bari, in
alternanza con le forme della natura, filmammo le fasi mimiche attraverso cui interpretare un testo poetico partendo dalla
mimica corporale per arrivare poi unicamente alla voce. L’apporto di attori affermati convalidava via via la sorprendente creatività del metodo. Nino Manfredi spiegò
quanti fasci di paglia e di fieno gli erano toccati da allievo, e come le formiche e i gatti
delle sue esercitazioni avevano influito poi
sui ritmi dei suoi personaggi cinematografici. Un teatro di accentuata spiritualità si
profilò con Massimo Foschi, che apparve
nell’Adelchi televisivo e quegli stessi versi
ridisse dal vivo, mentre Francesca Benedetti
ridiede vita alla donna offesa e umiliata protagonista di Vento notturno di Ugo Betti, e
affermò l’importanza della straordinaria
castità e pregnanza poetica dell’interpretazione costiana della parola.
A Roma Costa iniziò le prove del Mercante
di Venezia per il Festival di Taormina, un’occasione ideale per mostrare il metodo nelle
sue applicazioni più alte, della mimica
drammaturgia. Gianrico Tedeschi era
Shylock e Paola Gassman Porzia. Tedeschi
riconosceva che Costa aveva portato in teatro una coerenza totale nel suo modo di
vedere la vita e di viverla. Paola rievocò il
frenetico avvicendarsi degli allievi nel Sogno
mimicamente realizzato dal Maestro. Le
prove del Mercante avevano il sapore di una
ricerca continua, di una volontà di scoperta
protesa ad un approfondimento dell’opera
poetica. Costa disse che nel testo shakespeariano andava scoprendo la dimensione dell’allegoria, e la mimica non ne era certo
estranea. Rifulgeva la parola, in quello spettacolo; me ne accorsi nel buio del Teatro
Romano, a Taormina. Come diceva il
Maestro: “Tutti gli effetti del teatro convergono verso la parola come espressione di
profonde radici d’anima”.
Orazio Costa PEDAGOGO
27
Gabriele Lavia,
uno dei più celebri
allievi di Costa
numero 1
28
IL CORO
CELLULA MADRE
DEL TEATRO
di Pino Manzari
orse bisognava venire dalla provincia,
con le acuminate aspettative di chi crede
a portata di mano la realizzazione del
sogno, che ha da sempre sognato, per
scoprire Orazio Costa e la novità del suo
magistero. L’Accademia “Silvio d’Amico” cui
finalmente approdavamo, ci offriva maestri
validi di buon nome e sicura esperienza, maestri “all’antica italiana” che proponevano testi,
battute, intonazioni e gesti della loro pratica
scenica… qualcosa cioè, che nel nostro piccolo ambito provinciale avevamo tutti un poco
sperimentato.
Orazio Costa, già dal primo incontro, ci
rimandava a noi stessi, proponeva di fare di
noi stessi il nostro laboratorio, come se il formarsi come artisti comportasse lo scoprire e il
costruire in noi una diversa umanità.
Non ci chiedeva di “fare il teatro”, ma con
paziente sapienza, senza traumi, grado a
grado, ci rendeva profondamente consapevoli
che la maggior parte del nostro dire e del
nostro agire da “teatranti” rivelava “strumenti
usati male che conservano spesso il sentore di
marciume dei precedenti padroni che li avevano profanati” .
Orazio Costa come tutti i veri innovatori,
tagliava corto con le ipertrofie teoriche e le
dispute verbali che affliggono un’arte in crisi,
ma ci riportava all’origine del nostro fare teatro: al nostro desiderio d’essere più vivi; di
vivere, in una sola, più vite, al nucleo primo
dello spirito mimico che inabita ogni uomo.
Lui considerava questa rivelazione del luogo
originario, che il teatro ha perso di vista,
lasciandolo cadere nell’oblio, un dato assolutamente intuitivo, qualcosa che si deve credere
F
semplicemente perché l’esperienza la dimostra
vera, e ci chiedeva di farci piccoli, per trovare il
coraggio di tornare a “giocare a fare che sì è…
qualsivoglia realtà”. Ci raccomandava uno
“studium”, un amore, una passione “euforica”,
piena di voglia d’esserci, libera da inibizioni,
ma mai solo frivola e disimpegnata… Ci suggeriva di adottare l’atteggiamento dell’infante
che gioca e rigioca la sua scoperta del mondo
con un’attitudine pienamente gioiosa e insieme grave d’insospettata concentrazione. Il
Maestro ci sospingeva a riprendere contatto
con il grande libro della Natura, con l’infinito
gioco di interazioni che si rivelano nel cosmo,
come se potessimo arrivare a fonderci con l’inesauribile varietà di fenomeni e parvenze in
continuo moto, rivivendole nella libera, plastica “danza” di tutto il nostro corpo: microcosmo fatto a specchio, coscienza consapevole
della vita del macrocosmo. L’ascolto attento e
l’osservazione, è la base di ogni attività critico
– interpretativa e fonda l’espressione, è sottesa
ad ogni creatività con la maturata consapevolezza dei più vari ritmi, dell’alternarsi delle
diverse tensioni, delle variazioni dello spazio –
tempo, delle crucialità significanti negli eventi.
Il flusso vitale si incontra con l’inerzia, con la
nostra personale e sociale finitezza e tende a
condensarsi in stereotipie, in cerimoniali
sociali, o peggio a fissarsi in stanche formule
che finiscono col mortificare la generosa, fluida forza della vita: spetta, allora, all’artista
ritrovare il giusto “mimema”, il gesto globale,
portatore di senso e verità.
Allora questo cammino così articolato che in
teoria può sembrare arduo e scosceso ma alla
prova è continuamente soccorso dalla memoria organica della specie umana e dalla segreta
e spontanea sapienza del corpo, ricrea la sinergia corpo – voce in ricchezza di ritmi, di timbri e di toni, di risonanze vocaliche e vibrazioni e percussioni consonantiche. Il corpo,
ricomposto in unità, consente di incontrare la
“temperie” cioè il groviglio complesso che l’artista sorprende nel profondo di sé e poi tenta
di tradurre fuori di sé con gli strumenti propri
all’arte che pratica. Siamo ancora una volta ad
un momento di origine, a una genesi, al
prima della parola poetica, dei segni dei suoni
dei materiali, nel crogiuolo interiore della singolarità dove confluiscono le più diverse emozioni, percezioni ed esperienze per potersi fondere in unità ed esprimersi. Ho voluto fare
presenti questi primi passi di quarantuno anni
fa nell’arte dell’attore sotto l’attenta guida di
Orazio Costa come un antidoto prezioso alla
nostalgia che mi assale di un’arte che sembra
ritrarsi da noi quanto più la cerchiamo, e perché vorrei ancora sentire viva la voce che ci
diceva allora “parlare, recitare è gioia di appartenere ai pensieri che vorremmo trasmettere”.
Orazio Costa pur così rigoroso ed esigente con
se stesso, pur convinto della necessità di lavorare attorno a nuclei originari attentamente
individuati, non imponeva schemi o regole di
esecuzione, accettava il lavoro che ognuno
produceva e se correggeva era solo per la via
dell’arricchimento dell’osservazione rivelandoci quanto era sfuggito alla nostra attenzione. Mi resta da ricordare solo un’altra realtà
originaria dimenticata dal teatro per colpevole oblio ma largamente utilizzata da
Orazio Costa nel suo insegnamento e nelle
sue regie: la recitazione corale. Il Coro cellula
madre del teatro, il Coro scomparso per economia ma comunque diventato oggi impossibile per eccesso di protagonismo e di individualismo, triste testimonianza della condizione di un’arte che è, e rimane, collettiva,
che è per natura esperimento e proposta di
collettività all’opera.
Il Coro è quella singolare realtà che permette
di constatare che è possibile cospirare, cioè
con – spirare, respirare insieme, fisicamente,
mentalmente, moralmente persino che può
esserci unità realizzata dall’accordo delle più
varie sensibilità di tutti i componenti quando sappiano mettere fra parentesi l’io convinto e compiaciuto di sé, per il noi a cui
pure apparteniamo. Mi domando: non voleva farci scoprire anche questo il nostro
Maestro? Non ci educava a lasciar morire il
nostro narcisismo per spingerci a più convinte e volute solidarietà?
Un antico detto si è compiuto ancora una
volta: "Colui che fa imparare le parole della
Sapienza al figlio del suo prossimo è da considerare come colui che lo ha generato" perciò
con umile e filiale riconoscenza mi sento di
rispondere alla domanda come ha fatto Lui in
una sua poesia: "…perché sia sempre nascita… …ritessersi, infaticati angeli a se stessi,
firmamenti nuovi".
Anna Proclemer
ed Ave Ninchi
in Mirra di Alfieri
Orazio Costa PEDAGOGO
numero 1
29
numero 1
30
Orazio Costa al lavoro;
nella foto accanto,
lo vediamo insieme
a Paolo Panelli
e Tino Buazzelli
IN ASCOLTO
DEL
VENTO
E DELLA PIOGGIA
di Luigi Maria Musati
a vicenda terrena di Orazio Costa si è
conclusa pochi mesi fa, in quella Firenze
che aveva eletto come sua nuova residenza dopo i lunghi decenni romani. La
morte fisica dell’uomo che con Silvio
D’Amico, Mario Apollonio, Paolo Grassi,
Giorgio Strehler, Luchino Visconti e
Alessandro Fersen ha creato in Italia il teatro
contemporaneo, uno degli ultimi rappresentanti di quella generazione di registi e “dramaturg”, resterebbe un evento triste, ma
meno doloroso e drammatico se non fosse
avvenuta nel quadro desolante di un oblio
immeritato, che né queste poche righe né gli
ossequiosi necrologi, né gli scarni appunti
giornalistici o le trasmissioni ultranotturne
della RAI possono dissimulare.
I perché di questo oblio, i perché della sostanziale ostilità dal teatro italiano nei confronti
dell’opera di Costa dopo i trionfi dei suoi
primi decenni di regista, debbono essere
oggetto di un’analisi che spetta ormai agli storici e che esula certamente dalle possibilità
offerte da questa occasione. È però questione
L
seria e grave, che va ben aldilà delle contingenze e dei problemi di carattere personale o individuale. Non si tratta di celebrare opere o
uomini, tanto più quando hanno così ben
dimostrato di saper far a meno di visibilità e di
futili onori; tanto meno si tratta di riparare a
torti storici ormai irreparabili; si tratta di capire, di riflettere e di pensare. Una simile analisi
è necessaria al teatro italiano per tornare a
capire se stesso e potrebbe essere il serio punto
di partenza di un diffuso dibattito di pensiero
sull’agire teatrale, che da troppo tempo
manca, sovrastato dall’affanno dell’agire quotidiano, dalla futile logica degli schieramenti,
dalla frenesia di celebrare i trionfi del “contemporaneo” e “le magnifiche sorti e progressive”.
Dal punto di vista dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, che deve a
Orazio Costa non meno che a Silvio
d’Amico la sua identità storica e spirituale,
questo dibattito si focalizza su quella che è
la più autentica, complessa e discussa eredità costiana, quel Metodo Mimico, che da
qualche anno, in accordo con il Maestro,
chiamiamo in Accademia “Mimesica”.
Il Metodo Mimico è la vera “opera” di Costa
e ne ha accompagnato tutta la vita, dalle
prime esperienze con Copeau, all’insegnamento in Accademia, alla fondazione della
Scuola di Bari e del MIM di Firenze, agli ultimi anni di magistero individuale dalla sua
casa in Via della Pergola, assiduamente frequentata dagli allievi di tutte le generazioni.
Nata in una scuola di Teatro e per la scuola di
teatro, la Mimica divenne ben presto un processo che non riguardava gli attori, quanto
tutti gli uomini e non la pedagogia teatrale
soltanto, ma ogni disciplina dell’apprendimento. Strumento di autocoscienza attraverso
l’Arte, strumento di un’ascesi che soltanto per
equivoco può essere confusa con la mistica,
via al dialogo delle anime attraverso la gioia
espressiva del corpo, nella ricerca di un arcanum nascosto nel secretum della natura originaria dell’Uomo, la Mimica è proteiforme
come i processi che vuole determinare. Costa
non ne ha mai definito i confini come non ci
ha lasciato un saggio dedicato al Metodo.
Ancora qualche tempo fa, discutendone con
lui l’opportunità, ci diceva che forse ne avrebbe potuto scrivere una sorta di breviario, ma
soltanto in forma di poesia: non sappiamo se
tra le sue carte se ne potrà trovare almeno la
bozza. Per ora, dal punto di vista della parola
scritta, restano alcuni articoli, derivati da
interventi in vari convegni. Ma restano
soprattutto, inediti, i Diari, vero monumento
dal lavoro costiano, materiale dove appunti
biografici, diario di lavoro, diario di sogni e di
incontri, schizzi, poesie si mescolano in un
tutto organico, un monumento che vorremmo non restasse sconosciuto, anche se ci rendiamo conto della difficoltà anche semplicemente redazionali che ne comporta una pubblicazione, non per questo meno necessaria.
Da parte nostra ci impegniamo a non abbandonare la ricerca sul Metodo, e anzi, di
approfondirla e potenziarla, quando le nuove
condizioni che finalmente la legge consentirà
all’Accademia ci permetteranno di aprire quel
Corso di Pedagogia Teatrale che ci sembra
sempre più necessario e che ad Orazio Costa
intitoleremo. Intanto lanciamo a tutto il teatro italiano l’invito a progettare e costruire
insieme quel Centro di Alti Studi sul Metodo
Mimico che sarebbe l’unico degno modo di
onorare il Maestro scomparso.
Quando Costa, nel 1978, lasciò l’insegnamento in Accademia, senza mai interrompere il dialogo con chi nell’Accademia lavorava,
replicava, deliberatamente o no, il gesto del
suo Maestro Copeau, metteva in atto la strategia del seminatore che vuole uscire dal
campo coltivato e arricchisce il gesto dall’abbandono e del dissolvimento del seme in
qualunque terreno, secondo la volontà dei
venti e delle piogge, delle stagioni e dell’attenzione o della disattenzione degli uomini.
C’era in questa scelta una intuizione radicale
del senso e della forza del teatro che non sopporta di essere rinchiuso nei teatri e circoscritto nelle professionalità e di chi, come
nella parabola degli invitati a nozze, cerca i
suoi interlocutori fuori dal cerchio degli
interlocutori privilegiati. Ma, a differenza di
altre esperienze che a questa assomigliano,
questa scelta non cancellò in Costa l’attenzione al teatro come lavoro del regista e dell’attore nei limiti, anche più convenzionali, del
mestiere, il suo desiderio di essere “regista” o
“coordinatore”, come preferì in un certo
periodo. La ricerca di “ciò che è in alto” non
lo determinò mai al disprezzo di “ciò che è in
basso”. D’altra parte come sarebbe stato possibile un simile abbandono per chi viveva in
quell’orizzonte Mimico, in cui “ciò che è in
alto è come ciò che è in basso”? Checché ne
abbia pensato qualcuno, in Costa non vissero
mai istanze di isterica e luciferina purezza,
quanto le storiche contraddizioni di un’epoca
di cui fu protagonista e vittima.
Nella fedeltà alla Tradizione dell’insegnamento come processo fondato sulla trasmissione della parola e nella concezione della
vita come opera e dell’opera come vita sta, a
nostro modo di vedere, il segno più evidente
dell’importanza di Orazio Costa come maestro del teatro del Novecento. Nel complesso
e labirintico edificio del Metodo la sua eredità per il Teatro Italiano.
Orazio Costa PEDAGOGO
numero 1
numero 1
32
Un momento
del Don Giovanni
di Molière
con Massimo Foschi
e Paila Pavese
LA DANZA MIMICA
TRA ARTE
E SCIENZA
di Alessandra Niccolini
uando incontrai il metodo mimico,
nei primi anni Ottanta, rimasi sorpresa nello scoprire quanto fosse vicino al
pensiero di Isadora Duncan, la grande
danzatrice e innovatrice dei primi del
Novecento. Mi affascinava l’idea della
Duncan di rifondare la danza partendo dalla
relazione che intercorre tra il corpo e l’ambiente in cui è immerso.
Mi parve che la proposta pedagogica di
Orazio Costa offrisse un contributo concreto
nella stessa direzione.
Fin dal primo incontro con il Maestro parlammo della danza e della possibilità che lo
strumento mimico poteva offrire per esplorare le potenzialità espressivo-creative del corpo
e della voce umana. Parlavamo spesso dei
rischi di ingabbiare la creatività con un ecces-
Q
so di formalismo e di formalizzazione.
Ricordo una sera, nella sua casa di via dei
Ginori a Firenze, quando mi parlò a lungo
della musica inscritta in regole matematiche e
di come non sempre si presti bene alle necessità espressive del corpo, in particolar modo
quando il corpo esplora linguaggi diversi da
quelli suggeriti dalla mente.
Nei nostri colloqui riportavo sempre la mia
esperienza di insegnante e parlavo del mio stupore nello scoprire capacità espressive insospettate negli allievi che incontravo con il
Centro Avviamento all’Espressione di Firenze.
L’insegnamento per il Centro fiorentino è stata
per me un’esperienza di grande arricchimento
per la possibilità che mi ha offerto di confrontare la metodologia mimica con tante persone
diverse, spinte da differenti motivazioni.
Di colloquio in colloquio il discorso con il
Maestro si ampliava e si faceva sempre più
profondo e, al tempo stesso, si faceva sempre
più strettamente pedagogico e didattico, stando al suo fianco nei frequenti corsi e laboratori
che il Maestro teneva con giovani allievi attori.
Nel 1985 Costa mi propose di insegnare
danza nella Scuola d’Espressione e
Interpretazione Scenica di Bari, diretta da
Pino Manzari. La sfida che Costa mi offriva
era quella di mettere in pratica il frutto dei
nostri colloqui e di dar vita ad una didattica
per la danza attraverso la mimica.
La sfida che mi veniva offerta era davvero
grande, ma ciò nonostante accettai.
I fondamenti del progetto didattico per la
“danza mimica” possono essere riassunti in
pochi punti essenziali:
numero 1
- allenare le capacità creative con lo stesso
impegno e rigore con cui un danzatore allena
la tecnica;
- far apprendere nuovi movimenti facendoli
scoprire con la mimica, anziché imitando
movimenti già formalizzati;
- rispettare le differenti tipologie corporee
degli allievi, invece che omologare le diversità
ad un unico modello corporeo ideale;
- scoprire la forma sonora della propria
danza, lasciando fluire il suono della voce
del danzatore in sinergia con il corpo in
movimento.
Durante gli anni trascorsi a Bari l’incontro
con il Maestro si è effettuato “sul campo”,
quando una volta al mese, per una settimana,
era presente alle lezioni. In questo modo la
collaborazione si è stretta e consolidata.
L’incontro con Costa e l’insegnamento della
mimica non hanno mai smesso di aprirmi
curiosità, di pormi domande e di spingermi
ad esplorare altri campi dello studio.
"La danza è generata dall’organicità della
materia": questa frase di Costa per molto
tempo ha continuato a “danzare” nei miei
pensieri, fino al giorno in cui mi spinse ad
aprire un libro di neurobiologia e da quel
giorno non ho più smesso di aggiornarmi su
alcuni ambiti scientifici.
È incredibile come le ultime ricerche sia nel
campo delle scienze cognitive che in quello
delle neuroscienze sembrino confermare
tante riflessioni fatte con il Maestro e, in particolare, sostengano l’idea di Costa di proporre come modello per la pedagogia le modalità
operative dell’apprendimento umano.
Dal 1993 insegno presso l’Accademia
Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio
d’Amico”. Il contributo che gli studenti stanno dando alla mia ricerca didattica è di grande sollecitazione ed il loro interesse è uno stimolo per chi opera con la pedagogia costiana
a proseguire il cammino.
Alcuni tra gli studenti che più si appassionano allo studio della mimesica (così viene
chiamato l’insegnamento del metodo mimico all’Accademia “Silvio d’Amico”), mi chiedono spesso dove poter proseguire lo studio
intrapreso.
A questa loro richiesta non ho trovato una
risposta.
Mi auguro che si possa presto rispondere
concretamente alla richiesta di questi e tanti
altri giovani.
Orazio Costa PEDAGOGO
33
numero 1
34
GIOCARE
CON IL LINGUAGGIO
di Paolo Giuranna
razio Costa fu nominato insegnante di
regia all’Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica nel 1944. Da questa data
insegnò ad allievi attori e registi per
mezzo secolo senza interruzioni. La
lunghezza della pratica di didatta, l’originalità del metodo, la coerenza fra insegnamento e attività di regista, hanno fatto sì che l’operare di Costa sia stato consegnato alla storia dello spettacolo sin dal 1956. In un’arte
che si svolge nel tempo e, per sua intima
disposizione, è irriproducibile, la testimonianza sul metodo costiano dell’insegnamento teatrale è di necessità sintetica e
astratta; anche l’enunciazione del principio e
la corrispondente esemplificazione appaiono
fatalmente riduttive o inadeguate. Lo stesso
Costa, facondo espositore delle sue tematiche, ha esitato ad organizzare e fissare in uno
scritto un processo intimamente connesso
all’immediatezza del vivente e alla formazione attiva dell’allievo attore, finendo poi per
lasciare ad ex allievi il compito di una enunciazione sistematica, tesa almeno alla informazione della sua attività. Ma su ciò ch’egli
ha finito per chiamare “mimica”, oltre alle
presentazioni del metodo mimico agli atti di
vari convegni internazionali e nazionali di
scuole d’arte drammatica, vi è una vasta
serie di osservazioni, pensieri, appunti, ch’egli ha consegnato a quaderni-diario redatti
giornalmente - dal più vario contenuto letterario, filosofico, poetico e teatrale -, che
coprono l’intero arco della sua esistenza e
che costituiscono un lascito di estremo interesse culturale.
Costa osservava nell’uomo un istinto, una
disposizione genetica - più o meno conscia,
O
più o meno esplicita, più o meno compulsiva
- a conoscere il mondo per imitazione, per
mimesi, per immedesimazione. L’uomo che
esce di casa in una giornata di sole o sotto un
cielo coperto di nubi avrà due diversi comportamenti, due atteggiamenti istintivi, due
diversi modi di camminare, di muoversi. Se
guardiamo i suoi movimenti, essi ci daranno
notizie del tempo, poiché anche nello spettatore agisce la mimesi e l’immediata comprensione di essa. Questa disposizione mimica è un’attività conoscitiva e insieme un’espressione, un prelinguaggio, costituisce ciò
che nel discorso è insieme soggetto, verbo,
complemento e aggettivo. Quel camminare,
quel movimento non solo dice: “oggi è una
bella giornata”, ma anche esprime la qualità
radiosa, ridente, fiduciosa e così via. L’uomo
imita perché si immedesima.
Quando Costa esortava i suoi allievi all’imitazione, in gesti semplici e abbandonati a
quell’istinto, di un ulivo, di una nuvola, di
una candela, di una spiga o di un campo di
grano, di una formica o di un formicaio,
faceva notare come quel gestire immedesimato fosse già una immediata metafora di
un uomo che soffre o che gioisce, che aspira
o che teme, che medita o si affanna e come
costituisse una espressione che già conteneva
un racconto, una lirica, un personaggio, lo
spunto di un dramma. Ma di più: secondo
Costa la parola, la lingua stessa, contiene, in
una metamorfosi dal gesto al suono, l’incipit
mimico, il principio dinamico della mimesi.
In una straordinaria varietà di accostamenti,
di inviti e sollecitazioni, la lezione di Costa
tendeva alla individuazione e ad una controllata liberazione dell’istinto mimico, così
ch’esso subito apparisse un giocare, un
“joeur”, un “to play”, e fosse via via evidenziato, reso più plastico, raffinato e poi abbandonato perché le forze della mimesi fluissero
nella parola alla quale avrebbero apportato
dinamica, colore, plastica, nuova originaria
vitalità espressiva.
La difficoltà stava proprio nel passaggio alla
parola. I suoni alfabetici erano di già un
gesto preciso, un’espressione di per sé insignificante, non sentivo nessun bisogno di
farne altri, prima, con il corpo. Anzi ostacolavano, irrigidivano il parlare. Eppure mi
divertivo con quelle imitazioni. Dinamica,
colore, plastica e vitalità espressiva erano dati
dal linguaggio stesso, dai suoni alfabetici che
compongono le parole: la parola era assai
diversa dalla “cosa” che mimavamo.
Osservavo qualche tempo dopo, ad esempio:
per tutti, il concetto, il significato che in italiano dò alla parola “alba” è: la prima luce che
sorge dal buio della notte; ma in inglese quel
significato diventa “dawn”, in francese “aurore”. Il significante, l’espressione, insomma i
suoni alfabetici modificano l’esperienza del
significato con una serie diversa di suoni, cioè
di immagini. Ogni popolo, ogni lingua ha
un’esperienza immaginativa diversa per un
Orazio Costa insegna
il metodo mimico.
«Mi divertivo
con quelle imitazioni
- dichiara Giuranna Dinamica, colore,
plastica e vitalità
espressiva erano dati
dal linguaggio stesso,
dai suoni alfabetici che
compongono le parole:
la parola era assai
diversa dalla “cosa”
che mimavamo»
Orazio Costa PEDAGOGO
numero 1
35
numero 1
36
concetto che è uguale per tutti. Ma questa
esperienza immaginativo - uditiva è quanto si
compie in ogni poesia e, la poesia, come ci
insegnava Costa, è intraducibile. Se una poesia dicesse soltanto “alba”, tradotta in spagnolo o portoghese diventerebbe “madrugada”,
in tedesco “morgendammerung”: suoni,
immagini, insomma poesie assai diverse.
Se mimo un cavallo a un inglese, sì, forse lui
mi comprenderà, ma tradurrà i miei gesti in
horse. La mia mimica del cavallo, se avesse
un valore espressivo così fondamentale e
generale, dovrebbe far comprendere all’inglese i suoni della parola cavallo.
Questo vuol dire che il linguaggio aggiunge
qualcosa al mero significato mentale, al concetto. La parola “cavallo” è molto più espressiva di qualunque mimica dell’animale cavallo. La parola “cavallo” è già una “mimica”.
Ma una mimica sonora.
Orazio Costa
e Marina Bonfigli:
prova di costume
dei Sei personaggi
in cerca d’autore
di Luigi Pirandello
In conclusione, se il linguaggio, la parola
contiene gesti - suono originari, archetipici
che rendono diversa l’esperienza del concetto, del concetto uguale per tutte le lingue, il
concetto stesso è molto più ricco di quel che
crediamo; il concetto “alba” contiene aurore,
morgendammerung, dawn, madrugada e
così via nelle centinaia di lingue esistenti.
Cosa si deve fare? Cercare quali sono i gesti
oggettivi dei suoni alfabetici e quale è il loro
misterioso senso e valore espressivo per tutte
le lingue...
È stata ancora più esemplare la lezione di
Costa ai soli registi (l’Accademia stessa, del
resto, fu fondata da Silvio d’Amico con lo
scopo di introdurre, in modo diremmo istituzionale, la figura - e fin’anche il nome del “regista” in Italia). La lezione si basava
sull’individuazione di “colpi di scena” e
“nodi drammatici” di un testo teatrale.
Codesti colpi di scena e nodi drammatici
costituivano per Costa la direzione e le
variazioni e gli apici del movimento “mimico” del testo sino alla sua meta, istituivano la
sua dinamica e insieme il suo significato. La
composizione di questo movimento, rilevata
in scena nei modi e forme più diversi a
seconda della concezione, tendenza e gusto
dell’allievo, costituivano la base, la struttura
per una vera comprensione e un reale godimento artistico di un dramma. Questa let-
tura drammaturgica a volte veniva esemplificata da Costa con una vera e propria dizione drammatica, che egli chiamava “indicativa”, di tale intelligente e convincente espressività da risolvere qualsiasi dubbio o incertezza o problema interpretativo. Per altro,
tutta l’analisi del testo era corredata da
Costa con una ricchissima e mai divagante
serie di osservazioni - e risposte a quesiti
degli allievi -, che spaziavano dalla letteratura alla storia, dalle arti figurative alla psicologia, dalla cronaca al rito.
La lettura critica e poetica del testo, il confronto - al bisogno - delle traduzioni, lo studio del linguaggio, le caratteristiche dei personaggi e delle azioni, la temperie delle
varie scene, tutto era esaminato con precisione ma anche con delicatezza, perché non
si perdesse il sentimento dell’organismo
vivente - non solo di un messaggio, non
solo di un significato -, che era per lui un
testo teatrale.
Troppo resterebbe da dire prima di ricordare
come le lezioni di Costa fossero spesso di già
teatro. Ma quando erano solo lezioni, accadeva che l’interesse degli allievi confluisse sul
compagno che veniva esercitandosi, per
accompagnarne il progresso o incoraggiarne
le incertezze. Il suscitare questo interesse fra
gli allievi dà la misura non solo dell’insegnante, ma del Maestro che era Orazio Costa.
numero 1
37
COSTA MI HA
INSEGNATO
A SCRIVERE
intervista ad Andrea Camilleri
di Katia Ippaso
ricordi si affastellano e si incrociano con
riflessioni sull’arte e la vita. Paesaggi
umani si innestano su paesaggi naturali.
La figura del maestro emerge da una
giornata di sole, oppure da un pomeriggio piovoso. Le impressioni avanzano con
una loro precisa temperatura, nel racconto
di uno scrittore di culto, affabulatore d’eccezione, regista, sceneggiatore, poeta, forse
il solo in Italia capace di scatenare veri fenomeni di fanatismo, un uomo cresciuto,
anche lui, alla scuola di Costa. «C’era una
giornata magnifica - dice Andrea Camilleri,
nella sua lingua musicale, fatta, come quella
che ha inventato sulla pagina, di parole
materiche e respiri umoristici e suspensequel primo giorno che misi piede
all’Accademia, mentre dentro c’era un
ambiente buio, cupo, illuminato solo da
qualche lampadina».
I
Il teatrino di via Vittoria dovette sembrare
un luogo d’iniziazioni segrete, un posto non
salutare, al ragazzo di Porto Empedocle che
già da qualche anno mandava «da quel
sommergibile affondato che era la Sicilia
strani messaggi in forma di poesia al resto
d’Italia, che più d’uno raccoglieva». Anche
perché, come racconta, in quel piccolo
angolo di una grande e stordente città, ci
capitò un po’ per caso: «Avevo scritto una
commedia, nel ’47, intitolata Giudizio a
mezzanotte, che vinse il premio Firenze. La
giuria era presieduta da Silvio d’Amico, che
mi scrisse poi incoraggiandomi a sostenere
l’esame all’Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica come allievo regista. Devo dire
che durante il viaggio di ritorno da Firenze
a Porto Empedocle, che allora durava tre
giorni, rilessi la commedia e mi sembrò
ignobile. Così la buttai dal finestrino. Era
l’unica copia. L’anno dopo andai a fare l’esame, ma finalizzando tutto alla possibilità
di frequentare quegli ambienti letterari
romani che mi parevano chissà cosa.
Sennonché mi trovai di fronte Orazio
Costa, cioè a dire uno dei cervelli più acuti
che abbia mai incontrato in vita mia».
Il primo incontro non fu rassicurante.
Dominava, al contrario, un clima inquisitorio e punitivo che ancora adesso Camilleri
ricorda con nitidezza: «Ho conosciuto
Costa alla fine del 1949, quando vinsi il
concorso all’Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica come allievo regista…Allora si
Orazio Costa INTERVISTA AD ANDREA CAMILLERI
Una scena da
Il Poverello di Copeau;
nella foto piccola,
Andrea Camilleri
numero 1
38
A
IST
ERV
INT
AND
CAM REA
ILL
ERI
Nel ricordo di Andrea
Camilleri «Il Poverello
fu uno spettacolo
memorabile,
il più bello a cui abbia
mai assistito»
portava una tesi scritta e non ci fu un
punto, dico uno solo, della mia tesi (il tema
era Così è se vi pare di Pirandello), sul quale
Orazio si trovasse d’accordo. Costa, che era
un trentacinquenne elegantissimo, aveva
un’aria che diventava sempre più distaccata
e inquisitoria. Dopo un’ora e mezzo, mi fermai. D’Amico mi chiese perché mi ero
bloccato, ed io gli risposi che non vedevo
per quale motivo dovessi farmi torturare
dentro una stanza buia quando fuori c’era
un sole bellissimo. D’Amico mi incoraggiò
ad andare avanti. Con Costa restammo in
disaccordo fino all’ultima domanda. Lui mi
chiese quale titolo avrei scelto se avessi
avuto molti soldi a disposizione per fare
una regia. Pare che tutti rispondessero
Edipo re, Amleto. Io risposi La Vedova allegra. Orazio disse: “Non è una risposta
seria”, d’Amico disse: “E’ una risposta serissima”. Così me ne andai, convinto di non
farcela. Abitavo in un alberghetto in via del
Lavatore, ma decisi di andarmene ad Ostia
da un mio amico. Dopo dodici giorni,
comprai il biglietto per tornare in Sicilia ma
mi venne l’ispirazione di passare da via del
Lavatore: trovai un mucchio di telegrammi
di mio padre che disperatamente mi cercava
per comunicarmi che ero stato preso
all’Accademia con la massima borsa di studio. Ero l’unico allievo ammesso».
Il giovane, enigmatico maestro iniziò così la
sua opera di “dirottatore”, non lavorando su
corde emotive, private, ma affidandosi piuttosto al modello della relazione intellettuale: «Fu la sua cultura letteraria a fare da grimaldello presso di me. Detto questo, dopo
due mesi decisi di lasciare l’Accademia perché non potevo stare tutti i giorni dentro
una stanza con un individuo che era un iceberg dal punto di vista umano».
Camilleri, che aveva solo ventiquattro anni
e nessuna dichiarata vocazione masochista,
stava per tornare ai cari luoghi, non senza
conflitti, quando apparve sulla sua strada
una signora che gli farà cambiare idea, e
grazie alla quale inizierà un rapporto d’arte
e d’amicizia destinato a non spegnersi.
Quella donna era la madre di Costa.
«Un giorno – continua lo scrittore siciliano
– mi telefonò la signora Costa: “Vorrei
vederla senza che Orazio sappia”. Presi il
treno e andai a Napoli. Mi trovai di fronte
una vecchietta che mi disse: “Ho saputo da
Mario Ferrero che lei vuole andarsene. Ma
non può farlo. Darebbe un grandissimo
dispiacere a mio figlio Orazio, ed io non ho
nessuna voglia che mio figlio Orazio abbia
dei dispiaceri”. Mi apparve, dal suo racconto, un altro Costa: un Costa più umano,
che ogni sera si confidava con sua madre,.
Così decisi di rimanere. Ma ben presto,
per altre ragioni, mi buttarono fuori
dall’Accademia».
La relazione maestro-allievo si trasformò
così in una collaborazione artistica, quando,
nel 1950 Camilleri divenne assistente di
Costa al Piccolo Teatro della Città di Roma.
Ma soprattutto iniziò un’intesa, una complicità, una pratica di reciproco ascolto che
si nutriva di forti scontri («La mia non
voluta laicità mi faceva rifiutare certe forme
di calvinismo teatrale di Orazio») e paterne
riflessioni. «Più volte intervenne nella mia
vita privata. Io andavo a chiedergli spesso
consiglio, convinto che le sue parole fossero
sempre disinteressate e dettate da un affetto
profondo per quello che lui era stato capace
di vedere in me».
«Mi leggeva le sue poesie, i suoi diari – continua l’autore di best-seller come Il ladro di
merendine o Il birraio di Preston – e quella
cosa meravigliosa che erano i suoi diari dei
sogni. Quando mi sposai e nacque la mia
prima figlia, volle fare da padrino. Poi ha
cominciato a frequentare la mia casa di San
Miniato, a passare Natale con me,
Capodanno con me. Eravamo capaci di fare
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipscing elit, sed
diam nonnumy eiusmod
tempor incidunt ut
labore et dolore magna
aliquam erat volupat.
Ut enim ad minimim
veniami quis nostrud
exercitation
Orazio Costa INTERVISTA AD ANDREA CAMILLERI
numero 1
39
numero 1
40
Quando si apre il sipario, vediamo apparire
due personaggi che nessuno ha descritto. Li
vediamo in quel momento e desumiamo
tutto dal modo in cui parlano. Ora, a me
succede di scrivere i dialoghi e da questi
desumere l’aspetto fisico dei personaggi: è
quasi una prassi teatrale e non letteraria.
Faccio uso, per esempio, di quelli che
Orazio chiamava i colpi di scena minuscoli
che però preannunciano eventi importanti:
tutti i miei romanzi sono costruiti secondo
una tecnica teatrale anche se teatrali non
sono. Più in generale è confluita nel romanzo l’idea dello spettacolo, nel senso che io
non riesco a scrivere un capitolo in senso
tradizionale, ma per sequenze».
E sopravvive soprattutto il ricordo di uno
scambio sincero che se non alterò molto le
forme del parlarsi (Camilleri ha continuato
a dare del lei al suo maestro per tutta la
vita), portò ad una comunicazione sotterranea, al sincronismo dei sogni, a quel sentirsi anche a distanza, fin quasi ad uno scambio d’identità, come testimonia l’ultima
telefonata: «Mi chiamò una settimana
prima di morire. Con una voce bellissima,
squillante: “Ti cercherà un ragazzo che in
partenza voleva fare una tesi di laurea su di
te, poi si è convinto a farla su di me. Spero
di farlo tornare alla vecchia idea, quindi
preparati”. Avevamo poi stabilito che una
mia giovane amica che abita vicino Firenze,
a Natale sarebbe andata a prenderlo in macchina per portarlo da me. Gli anticipai infine che il romanzo che stavo scrivendo (La
gita a Tindari, Sellerio) l’avrei dedicato a
lui. Perché racconto, tra le altre cose, il rapporto mimico di un uomo con un albero».
AND
CAM REA
ILL
ERI
ostinato, vive il successo con stupore.
Quando improvvisamente l’Italia si svegliò,
qualche anno fa, e collocò i suoi romanzi
(non solo quelli con Montalbano protagonista) alle vette delle classifiche, lo scrittore
parlò di un complotto, di una cospirazione.
E ancora oggi ama ripetere che continua a
scrivere come se i suoi fossero mille lettori e
non centinaia di migliaia. Come Costa, è
uno che segue la propria voce fino in fondo
e che ama ridisegnare, raffinare, i contorni
di un’esistenza non gregaria, convinto del
fatto che le mediazioni servano a poco.
«Sì, questo atteggiamento me l’ha insegnato
lui – confessa – Ma lui mi ha insegnato ben
altro: mi ha insegnato a scrivere. Mi spiego
meglio. Quando Orazio prendeva un personaggio da un testo e ti diceva in che modo
lo si poteva far vivere, il suo esame era così
esaustivo, così completo, il ricavo era così
assoluto, che alla fine il testo era come un
guscio vuoto. Lui diceva: questo personaggio lo devi pensare in modo tale che entri a
casa tua, che lo incontri la mattina dopo
che sei stato in bagno. Ecco, con i miei personaggi cerco di vivere così».
Non avevano le stesse idee politiche, Orazio
e Andrea. Orazio era cattolico ("ma più che
altro era cristiano"), Andrea era di formazione laica. Orazio fu pesantemente contestato
dagli allievi, nei cosiddetti anni di piombo;
Andrea si metteva a dormire e ad occupare
con loro. Eppure, nel ricordo di Camilleri,
lo scontro non fu tra conservazione e rivoluzione. Tant’è vero che lo stesso Dario Fo,
chiamato dai ragazzi dall’Accademia a tenere
dei corsi, rimproverò i ragazzi: “Non pensate
di aver fatto la cosa giusta”. «In verità – ricostruisce Camilleri – Costa non fu cacciato,
se ne andò».
E cosa pensava il maestro dei libri dell’ex
allievo? «Sì, gli davo da leggere i miei manoscritti. Gli piacevano moltissimo anche se
un po’ si terrorizzava rispetto a certe scene
erotiche o blasfeme, che però, diceva, riusciva ad accettare perché le descrivevo con
ironia e divertimento».
Le tracce di quel lontano “dirottamento”
non si sono però perse per strada.
Sopravvivono nella scrittura: «L’unico maestro che ho avuto e che sono disposto a
riconoscere come tale è Orazio Costa. Cosa
conservo del teatro? La mia aspirazione di
scrittura che è già ne La concessione del
telefono o Il birraio di Preston è di arrivare ad
una sorta di sguardo extra-diegetico.
A
IST
ERV
INT
le tre, le quattro del mattino, parlando non
solo di teatro, ma anche di politica, letteratura, di noi stessi. Questo filo non si è mai
interrotto: la distanza può avere indebolito
la frequentazione ma non la profondità dell’affetto. Proprio perché eravamo lontani, in
realtà accadevano episodi misteriosissimi.
Mia nipote nacque prima di quanto si pensasse. Alle sette del mattino squillò il telefono. Orazio era a Firenze e mi disse: “Ho
sognato una grande gioia nella vostra casa.
Cosa è successo?”. Ci capitava anche di
avere una contemporaneità di sogni».
Ci fu, poi, ad un certo momento, una consegna, una trasmissione di ruolo: «Quando
lui se ne andò dall’Accademia, designò me
come suo successore per l’insegnamento di
regia, che ho svolto dal ’74 al ‘98. Sapeva
che designava l’ex allievo più infedele al suo
rigore teologico del teatro».
Stranamente, Costa non andò mai a vedere
uno spettacolo di Camilleri (come regista
ne ha firmati più di cento), il quale però
ancor oggi legge quest’assenza come un
“atto d’amore”: «Spiegò a mia moglie che
temeva che non gli piacessero».
A Camilleri invece quelli di Costa piacevano
molto, e ne individuava già allora il tratto
d’autore, la firma, nella capacità che il maestro aveva di “sopraelevare il tono di un
testo”: «Le racconto un episodio che forse
nessuno sa – continua lo scrittore – Quando
nel ’50 mise in scena Il poverello di Copeau,
assistetti ad un’irruzione di Silvio d’Amico
che voleva sconsigliare Costa dal rappresentare quel testo: gli sembrava un elenco
telefonico. Orazio lo mise in scena lo stesso
e devo dire che è lo spettacolo più bello che
abbia mai visto in vita mia. In virtù di quella capacità che Costa aveva di scoprire la spiritualità che ogni atto di teatro contiene.
Voglio fare un esempio. Nel finale del primo
tempo, Francesco, finalmente spoglio dei
vistosi abiti da ricco, indossato il saio fatto
di juta, scalzo, con un bastone in mano, felice della trovata povertà, faceva un urlo
sovrumano (con il quale Tonino Pierfederici
rischiò di rimetterci i polmoni), poi spezzava il bastone sul ginocchio, e cominciava a
ballare da solo seguendo un suo pensiero.
Credevo che ci avrebbero linciato. Invece ci
fu un momento di commozione e di applauso a scena aperta. Costa aveva il coraggio
dello spirito».
Camilleri, come Costa, è una figura controcorrente. Come il suo maestro, è schivo,
numero 1
41
Orazio Costa INTERVISTA AD ANDREA CAMILLERI
Una scena
della Vita nuova
di Dante
numero 1
Tullio Pinelli
Quel mondo giovanile acceso
e militante di tanti anni fa
Ci sono persone con cui non
ci si rivede quasi mai, di cui si
sente solo parlare per anni, ma
alle quali si può pensare come
si pensa ad un amico, certi di
poter ristabilire con loro
un’immediata intesa al primo
ritrovarsi.
Questo era per me Orazio Costa.
L’avevo conosciuto in tempi
molto lontani, tra il 1938 e il
1941; era allora, con Wanda
Fabro e Alessandro Brissoni,
uno dei primi tre registi usciti
dalla Scuola d’Arte
Drammatica, portatori di quel
rinnovamento teatrale al quale
li aveva avviati Silvio d’Amico,
e sotto le ali di Silvio d’Amico
avevamo formato una cerchia
di amici intorno a Wanda
Fabro: Orazio Costa, Diego
Fabbri, Giorgio Prosperi,
Achille Fiocco, tutti giovani,
tutti in pieno fervore di
creazione e di speranze, tutti,
ovviamente, antifascisti.
Ci si trovava la sera in casa
di Wanda, in Corso d’Italia,
ciascuno aveva scritto qualcosa,
o preparava qualcosa
o qualcosa proponeva;
le discussioni erano
vivacissime, anche accese.
Ricordo, per esempio, che una
sera, aspettando l’arrivo degli
altri, Wanda ed io eravamo
tanto impegnati a discutere
il mio ultimo dramma, Lotta
con l’Angelo, che non avevamo
sentito i ripetuti squilli del
campanello di casa.
Era proprio Orazio Costa,
molto sorpreso che non gli
fosse stato aperto. Poi, a
disperdere quel nostro mondo
giovanile vennero le tragedie:
l’inattesa, dolorosissima
scomparsa di Wanda Fabro, la
guerra sempre più incalzante,
il fatale 8 settembre del ’43,
M
de em
di or
ch ie,
e d te
ei stim
co o
m ni
pa an
gn ze
id ,
iv
iag
gio
M
LBU
L’A
DEI
RIC
ORD
I
42
l’occupazione tedesca.
Dopo, ciascuno prese e seguì
la sua strada e gli incontri
furono quasi sempre casuali.
Due sole volte ritrovai Costa
non per caso, ma purtroppo
mai come regista di uno dei
miei testi.
Nel 1949 fu rappresentato
al Teatro delle Arti, sede
del Piccolo Teatro di Roma
di cui Costa era direttore,
il mio dramma La leggenda
dell’Assassino, ma la regia
fu affidata ad
Alessandro Brissoni.
E in epoca molto successiva
avvenne che gli organizzatori
del Festival teatrale di San
Miniato ci imposero come
condizione assoluta per la
rappresentazione di un altro
mio dramma, Santa Marina,
di cui Orazio avrebbe voluto
essere il regista, che la parte
della protagonista fosse
accettata da Giulietta Masina,
in quel periodo purtroppo
impegnata in un film.
Fu una grande occasione
perduta, e Orazio Costa rimase
per me, nel mio ricordo, quel
nuovo, promettente regista che
incontravo la sera in casa di
Wanda Fabro, con gli altri
giovani amici ormai scomparsi.
Rossella Falk
“Era convinto che avessi
sprecato il mio talento
andando dietro agli americani”
Come tutti sanno, ho
frequentato l’Accademia d’Arte
Drammatica e ho avuto la
fortuna di avere dei grandi
maestri. Al primo posto in
assoluto metto Orazio Costa,
seguito da Wanda Capodaglio.
Quando feci il saggio di terzo
anno, scelsi di fare una
Giovanna di Lorena. Orazio
non era molto d’accordo
perché mi diceva che
cominciavo a dimostrare un
sospetto amore per i testi
moderni. Comunque alla fine
ha acconsentito e fu un
bellissimo esame… C’era un
legame molto forte tra noi due;
forse lui nutriva per me un
sentimento che andava al di là
del rapporto maestro-allieva,
ma non l’ha mai espresso né
dichiarato. Nel ’48 mi diede la
grande occasione di recitare nel
ruolo della Figliastra nei Sei
personaggi in cerca d’autore di
Pirandello che debuttò alla
Fenice di Venezia, per andare
poi in tournée a Parigi e a
Londra. Subito dopo,
fondammo il Piccolo Teatro
della Città di Roma: all’inizio
c’erano Buazzelli, Panelli,
Manfredi. Lo fondammo noi
due, anche con le nostre forze
finanziarie…Che cosa mi ha
insegnato? Il senso della logica
e della precisione, che non
bisogna dare niente per
scontato…Veniva sempre a
teatro a vedermi. Ma continuò
a non essere d’accordo con le
mie scelte. Diceva che avrei
dovuto fare tutta la vita Fedra,
Medea, personaggi classici. Io
gli dicevo: “Orazio, mi
annoiano. Preferisco fare
Tennessee Williams, David
Hare, Peter Shaffer. Faccio il
teatro anche per divertirmi”.
Insomma, ha sempre pensato
che avessi sprecato il mio
talento. Quand’è venuto a
vedere l’ultima volta Master
Class con Maria Callas, ero
quasi sicura che questa volta ce
l’avrei fatta. Invece commentò:
“Ma è possibile che una come
te che sa recitare così bene
va a parlare della Callas?”.
Per lui era assurdo…
numero 1
43
Del bisogno di oltrepassare
i propri limiti
Ad un attore che recalcitrando gli
disse: "Non posso andare oltre i
miei limiti", Orazio Costa
rispose: "Per sapere quali sono i
propri limiti bisogna
oltrepassarli" (a quell’attore il
concetto parve così lampante che
da allora in poi lo fece suo,
commettendo moltissimi errori
ma, forse, anche spostando un
po’ più in là i propri limiti). Ad
un altro che gli obiettava:
"Perché fa rimanere Paolo e
Francesca così distanti durante
tutto questo ardente dialogo
d’amore?", "Perché se si
avvicinassero non parlerebbero
più". E a chi gli domandava:
"Non dovrebbe Gesù Cristo
apostrofare Marta con tono
meno angosciato? Dubita forse
che tra poco Lui stesso le
restituirà Lazzaro?", "Gesù non è
angosciato per se stesso, ma per
Marta, che forse dubita di Lui".
Gli insegnamenti di Costa erano
spesso così: semplici, chiarissimi,
addirittura elementari, e ti
facevano vedere le cose come per
la prima volta, perché così lui
sapeva vederle. Suscitava, con il
suo esserci, immagini indelebili,
esempi non ignorabili. La sua
presenza era per questo, ad una
persona egocentrica, quasi
dolorosa, ma per quella nostra
parte che sa e vuole apprendere,
una fonte senza uguali.
Secondo me la sua dote più
irresistibile, come uomo di
teatro, era l’eccelsa virtù di
attore. La sua recitazione,
quando insegnava o dirigeva,
apriva mondi a cui non si poteva
più rinunciare, che si dovevano
restituire, sempre a proprio
rischio, ma a volte raggiungendo
risultati insperabili.
Mi sono sempre reso conto,
studiandolo, che la via per
arrampicarsi almeno ai piedi di
quel monte era la tecnica, che lui
possedeva più di chiunque altro,
ma che preferiva inculcare solo
nel suo abc, forse giudicando il
virtuosismo una conquista meno
urgente che non il ritrovamento
della propria sorgiva e
proteiforme creatività. Per Costa,
infatti, l’origine della recitazione
sta nella prima attenzione che si
rivolge al mondo, quando,
ancora perfettamente aperti e
integri, invece di guardare le cose
si diventa la cosa che si guarda.
Personalmente non ho mai
potuto seguire questo metodo,
cervellotico come sono e
timoroso di guardare la vera
natura di me stesso e di tutto;
ma l’ho in qualche modo
assorbito osservando lui che
recitava, un po’ come chi impara
il cinese studiandolo parola per
parola. Il risultato, teatralmente
parlando, non saprei
raccomandarlo a tutti, ma non
mi scema certo nostalgia per
quest’uomo che a volte
diventava nuvola, a volte
montagna, che dicendo un
verso, una battuta, una parola
apriva menti e palcoscenici alla
vita, e che un giorno, bellissimo
d’autunno, mi disse: "Quando
sarò morto Dio mi punterà il
dito contro e mi domanderà
“Dov’eri tu e che facevi la
mattina del giorno tale del tale
anno?” “Ero alla RAI di Firenze,
Signore, a lavorare”, risponderò
io. “Vergognati!” tuonerà il
Signore, “Io avevo mandato una
giornata stupenda, da passare nei
prati, e tu l’hai trascurata!”".
Immagino che adesso il
rimprovero glielo abbia già fatto,
e che lo abbia perdonato.
Gabriele Lavia
Nino Manfredi
“Mi ha insegnato a lavorare
sulla mia timidezza”
Tutti i giovani pensano
di essere degli attori
drammatici…Quando
frequentavo l’Accademia, Costa
un giorno mi chiamò sul
palcoscenico per recitare il
monologo di Amleto. Mi accorsi
che i miei compagni stavano
ridendo. Così ho interrotto la
prova. Quando è finita la
lezione, mi prese sotto braccio e
mi disse: “Non te la devi
prendere se i tuoi compagni
ridono, perché tu hai una nota
in più, l’ironia”. Costa mi ha
fatto capire quello che io ero
veramente: né un attore
totalmente drammatico né un
attore totalmente comico. Mi
convinse che avevo la capacità
di affrontare i temi seri facendo
nascere un sorriso sulla bocca
della gente. Costa formava
soprattutto degli attori di
cinema, perché insegnava a
lavorare sulla mimica anche
facciale… Io allora ero
abbastanza timido. Quando lo
dissi a lui, mi rispose: “Allora tu
puoi diventare un grande attore
perché hai la possibilità di
trasferire questa timidezza sul
personaggio”. Ci ha insegnato a
recitare con lo sguardo… Ci
faceva lavorare su i ritmi di una
formica, di un cane, di un
gatto, della natura animale,
perché il pubblico, diceva, non
sa che cosa state facendo ma
osserva i ritmi che ciascuno di
noi ha dentro e che può quindi
riconoscere.
Un macchinista lo chiamò
il “ciclista di Dio”
Costa ha incarnato
all’interno del teatro
italiano, per intere
generazioni, la figura del
maestro, così come non ne
esistono più. Forse perché
non è più possibile ripetere
un’esperienza di quel tipo.
Lo dico al di là della
validità del suo metodo. Ho
fatto due spettacoli di teatro
con lui (Edipo re e Romeo e
Giulietta) e poi molti
drammi in tv: Adelchi, Il
Gabbiano, il Filippo di
Alfieri e tanti altri…Giorni
prima che morisse, è venuto
a vedere un mio spettacolo,
La mite di Dostoevskij. Ho
parlato con lui a lungo del
Misantropo di Molière di
cui devo cominciare le
prove, e devo dire che
ancora una volta mi ha
folgorato per la sua visione
così moderna della regia.
Voglio ricordare un
episodio. Orazio, che aveva
un fisico così sottile, veniva
alle prove con una tuta da
ginnastica e le scarpette da
mimo coi lacci. Un
macchinista, vedendolo,
s’inventò un’espressione
magnifica: “E’ arrivato il
ciclista di Dio”. In effetti
lui sembrava un ciclista e
mi piace immaginare che sia
volato in cielo dal buon Dio
in bicicletta, così come
succede in Miracolo a
Milano o in E.T..
Orazio Costa L’ALBUM DEI RICORDI
Roberto Herlitzka
numero 1
44
Una delle ultime sere
di Carnevale
di Carlo Goldoni
numero 1
La liturgia della parola
I momenti più importanti della
mia vita di attrice sono legati a
Orazio Costa. Tale è stata
l’importanza di questo incontro,
che gli sono rimasta
profondamente vicina fino alla
fine della sua vita. Orazio Costa è
stato un maestro, cioè qualcuno
che ha trasmesso e concepito un
“suo” modo di dare teatro; ed è
stato un uomo profondamente
religioso. La sua idea di teatro e
la sua religiosità si manifestavano
nel suo insegnamento e nella fede
nella sacralità della parola. Che è
non solo un mezzo per
comunicare, ma è “verbo”, la più
alta espressione della spiritualità,
e attraverso la preghiera – e per
Costa anche attraverso la ritualità
del teatro – mette l’uomo in
rapporto con Dio. Si può capire
come tutto questo, nella pratica,
si traduceva in un rispetto
assoluto della parola del testo,
che veniva scandagliata in ogni
sua possibilità, fino a toccarne il
nucleo più profondo ed
espressivo, fatto sempre di una
unione di pensiero e sentimento,
significato ed emozione.
Basterebbe vedere i miei copioni
– Francesca da Rimini, Adelchi,
Il gabbiano, Tre sorelle, Ifigenia –
in cui ogni parola ha un suo
segno – cesura, sottolineatura,
commento -, per capire il senso
di quello che ho detto.
DEI
RIC
ORD
I
M
LBU
L’A
“Era un padre
con figli ribelli”
Ho partecipato a diciotto
spettacoli diretti da Costa, tra
teatro, televisione e cinema, e
quindi è il regista con il quale
ho lavorato di più…Quando ho
fatto l’Accademia, in certi
momenti ho cercato di
appoggiarmi a lui, anche se
Costa era abbastanza chiuso,
restio a concedersi umanamente.
Nel lavoro, però, mi ha dato
tantissimo. Nel tempo, siamo
venuti a maggiore confidenza.
Ricordo un episodio. Nel ’70,
portammo l’Orlando Furioso di
Ronconi a Parigi, ed io mi davo
più del dovuto, tanto che
dovevo ricorrere ad iniezioni di
glucosio. Costa era in quegli
stessi giorni a Parigi per una
serie di conferenze. Venne a
trovarci nei camerini. Mi cercò,
mi prese sotto braccio e mi
disse: “Ho saputo che tu ti dai
troppo. Ma ricordati, figliolo:
uno dei doveri principali degli
attori sono le repliche. Non
puoi togliere al pubblico di ogni
sera quello che puoi dare al
pubblico di ogni sera tutte le
sere. Questo non è cinema, dove
tu puoi anche morire. È teatro.
Non morire tutte le
sere”…Costa era un maestro in
senso totale. Ne ho conosciuto
solo un altro: Strehler. Erano,
Costa e Strehler, depositari di un
sapere che comprendeva tutto
quello che riguardava il mondo
dello spettacolo e non solo
quello… Costa era un padre, e
come tale, aveva dei figli, anche
ribelli. Non mi perdonò mai
di aver preso un altro impegno
quando c’era nell’aria (ma
tardavano ad arrivare i
finanziamenti) una ripresa del
Don Giovanni.
Una volta mi disse, benevolo e
rassegnato: “Tanto tu fai sempre
quello che vuoi”.
Ilaria Occhini
M
de em
di or
ch ie,
e d te
ei stim
co o
m ni
pa an
gn ze
id ,
iv
iag
gio
Massimo Foschi
“Voleva che ci vestissimo
bene per andare a cena
da Shakespeare”
L’ho avuto come insegnante
all’Accademia nel ’75 - ’76, cioè
nell’ultima sua stagione da
docente. Fu un rapporto segnato
dalla devozione per il grande
sapere e dall’agonismo (che sono,
secondo Nietzsche, i due elementi di forza di un rapporto
maestro-allievo). La devozione e
l’affetto derivavano da una mia
formazione classica fondata sul
Romanticismo tedesco e francese. Per questo seguivo con passione le sue lezioni. C’era, però,
qualche discordanza. Il metodo
mimico di Costa, che era basato
su assunti nobilissimi, per certi
versi mi sembrava poggiare su un
principio vetero-psicanalista che
è il seguente: c’è un luogo represso, che è il corpo, se lo liberiamo
uscirà l’anima. Mi sembrava un
principio vittoriano. E per uno
come me che si era formato oltre
che sul Romanticismo tedesco
anche sui Rolling Stones, tutto
ciò sembrava un po’ stonato…
Mi ricordo in particolare una
bellissima lezione sui silenzi di
Cechov, innervata da una polemica nei confronti del famoso
Giardino dei ciliegi di Strehler
che aveva, secondo lui, coperto le
pause con tutte quelle magnifiche soluzioni sceniche( il trenino, l’armadio che si apre, la carrozzina) che indubbiamente
tenevano a ridare tessuto connettivo a qualcosa che invece doveva
rimanere sconnesso. …Una delle
più grandi lezioni che ho ricevuto da Costa è sicuramente quella
legata al suo senso di nobiltà. Ci
diceva sempre: “Se voi foste invitati domani sera a casa di
Shakespeare, vi mettereste il
vestito migliore o il peggiore?”
Tutti rispondevano: il migliore.
E lui spiegava: “Allora, per mettere in scena Shakespeare, facciamo finta che siamo
invitati alla sua
tavola.
Andiamo in
maniera concia”. Naturalmente
si riferiva all’atteggiamento complessivo da
tenere nei confronti di
un’opera.
45
Il sogno di lavorare coi sogni
Sulla linea ferroviaria RomaMilano la sosta Firenze per me
era un punto fermo. Per tutti
questi anni andare a trovare Costa
nella sua casa a via Ginori
e poi alla Pergola
era un momento nel quale
confrontarmi con la mia scelta
di fare teatro. Costa era prima
di tutto un maestro, non solo per
me ma per gran parte del teatro
italiano. Era anche e soprattutto
un uomo in lotta contro
l’establishment, un uomo
indipendente e mai rassegnato.
Lentamente si è chiuso in questa
sua casa tra i suoi ricordi, ma non
ha mai perso la voglia di fare. Fino
all’ultimo sperava di poter lavorare
come regista e di lavorare con
i suoi sogni. Quando mi sono
laureata, ho deciso di scrivere la
mia tesi sul suo Metodo, il Metodo
Mimico; è stato il mio modo di
ringraziarlo per ciò che mi ha
insegnato.
Non dimenticherò mai certe sue
riflessioni: “Il teatro è l’unica forma
di attività umana rimasta a parlare
dell’uomo mediante la realtà
dell’uomo” diceva Costa.
E poi: “L’essere uomo con una
coscienza particolarmente esagerata
di ciò che ci fa uomini, di ciò che
ci fa metri della natura, questa
coscienza è l’essere attori. Può
essere una semplice coscienza
motoria, una semplice
consapevolezza della duplicità e
pluralità del nostro essere…”.
E poi ancora: “La mimazione si
realizza attraverso un dono delle
intuizioni, delle corrispondenze,
e presuppone il riconoscimento
di una fraternità con gli esseri e
le cose, l’esistenza di una
correlazione fra diversi, che avviene
istantaneamente, come se si
trattasse di un parlare-pensare, ma
è indipendente dalla ricerca delle
parole, una ideale comunicazione
diretta”.
Per lui il vero mestiere da insegnare
era il mestiere del diventare uomo:
“Armati della nostra unica figura
- diceva - noi riusciamo ad essere
tutti interi, specchi sensibilissimi
del tutto che, senza perdere la sua
infinita varietà, diventa uomo,
riempendolo di consapevolezza
e d’infinito”.
Orazio Costa L’ALBUM DEI RICORDI
Tiziana
Bergamaschi
Umberto Marino
IN QUESTO NUMERO
EDITORIALE
Il coraggio di una scelta etica
ORAZIO COSTA REGISTA
Il tirocinio di Orazio Costa di Alessandro d’Amico
L’arcangelo con le scarpe Vibram di Luigi Squarzina
Drammaturgia scenica dell’invisibile di Claudio Meldolesi
Sintesi memoriale di un’amicizia di Mario Luzi
Siamo stati irriconoscenti verso Orazio di Luca Ronconi
Il respiro mistico del Poverello di Paolo Emilio Poesio
ORAZIO COSTA E IL TEATRO DELLA PERGOLA
di Marco Giorgetti
INEDITI
Dai Quaderni di Orazio Costa commento critico di Renzo Tian
ORAZIO COSTA PEDAGOGO
L’esperienza del Metodo Mimico raccontata in film di Maricla Boggio
Il coro cellula madre del teatro di Pino Manzari
In ascolto del vento e della pioggia di Luigi Maria Musati
La danza mimica tra arte e scienza di Alessandra Niccolini
Giocare con il linguaggio di Paolo Giuranna
INTERVISTA
Costa mi ha insegnato a scrivere a colloquio con Andrea Camilleri, di Katia Ippaso
MENSILE D’INFORMAZIONE
DELLO SPETTACOLO
anno V • numero 1
L’ALBUM DEI RICORDI
DIRETTORE RESPONSABILE
Renzo Tian
Memorie, testimonianze, dediche dei compagni di viaggio:
VICEDIRETTORE
Tullio Pinelli, Rossella Falk, Roberto Herlitzka, Nino Manfredi, Gabriele Lavia,
Massimo Foschi, Umberto Marino, Ilaria Occhini, Tiziana Bergamaschi, Anna Proclemer,
Glauco Mauri, Renato De Carmine
Katia Ippaso
COMITATO DI REDAZIONE
Giovanna Marinelli
Ilaria Fabbri
Ninni Cutaia
Donatella Ferrante
COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO
REDAZIONALE E MARKETING
Angela Cutò responsabile
Giuseppe Commentucci, Cinzia Raffio
COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE
Silvia Taranta
Roberta d’Agostino stager
UFFICIO STAMPA
Andreina Sirolesi
PROGETTO GRAFICO
Fausta Orecchio
IMPAGINAZIONE
Silvana Amato, Simone Tonucci
STAMPA
Futuragrafica
FINITO DI STAMPARE
Febbraio 2000
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO
Maricla Boggio, Alessandro d’Amico, Marco Giorgietti, Paolo Giuranna, Mario Luzi
Pino Manzari, Claudio Meldolesi, Luigi Maria Musati, Alessandra Niccolini
Paolo Emilio Poesio, Luca Ronconi, Luigi Squarzina, Renzo Tian.
ETINFORMA, DIREZIONE E REDAZIONE
Eti • via in Arcione 98, 00187 Roma
tel. 06.69.95.11 fax 06.67.97.443
e.mail: [email protected] • http: //www.enteteatrale.it
(pagine web Angelo Ponti)
PER LA VOSTRA PUBBLICITÀ SU ETINFORMA
ETI • Ufficio Promozione tel. 06.69.95.12.34/82