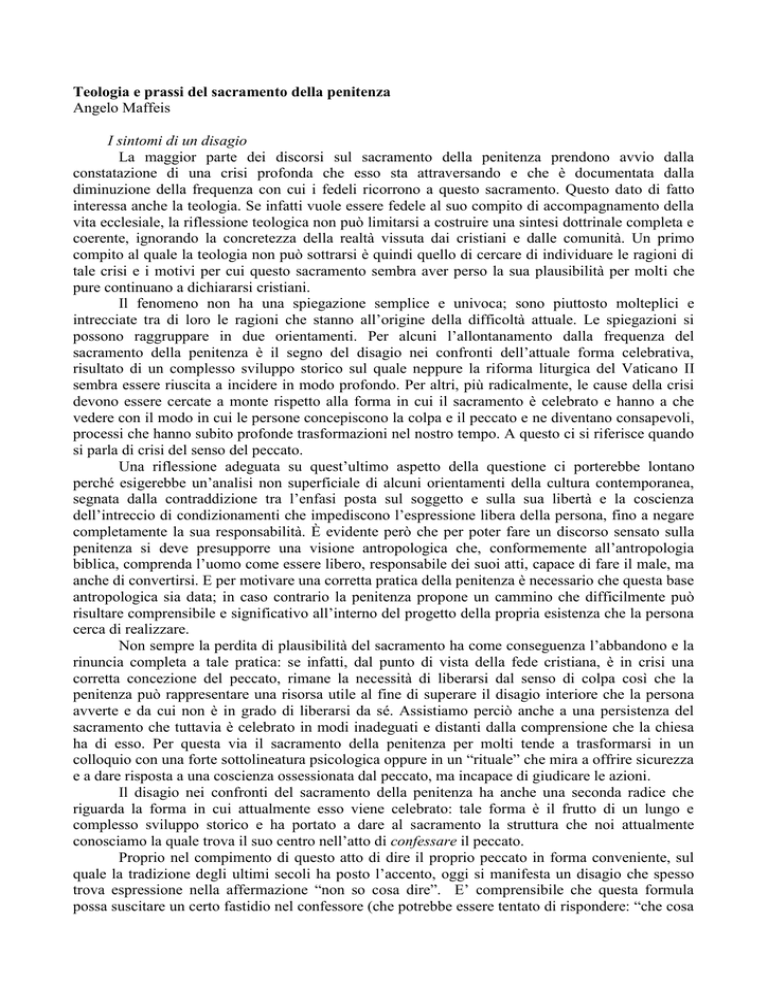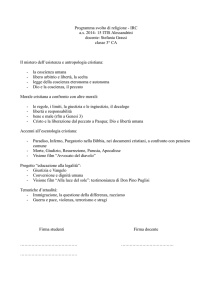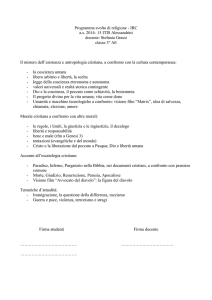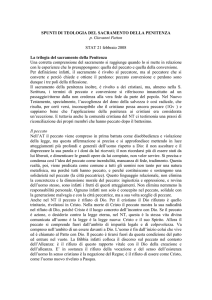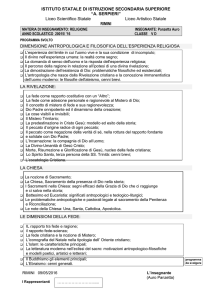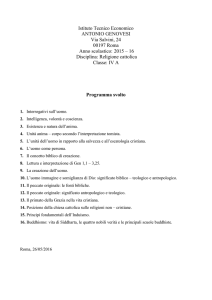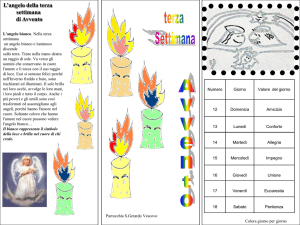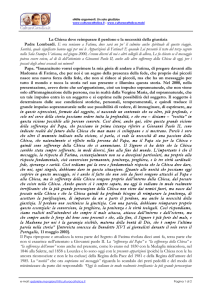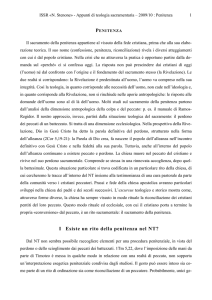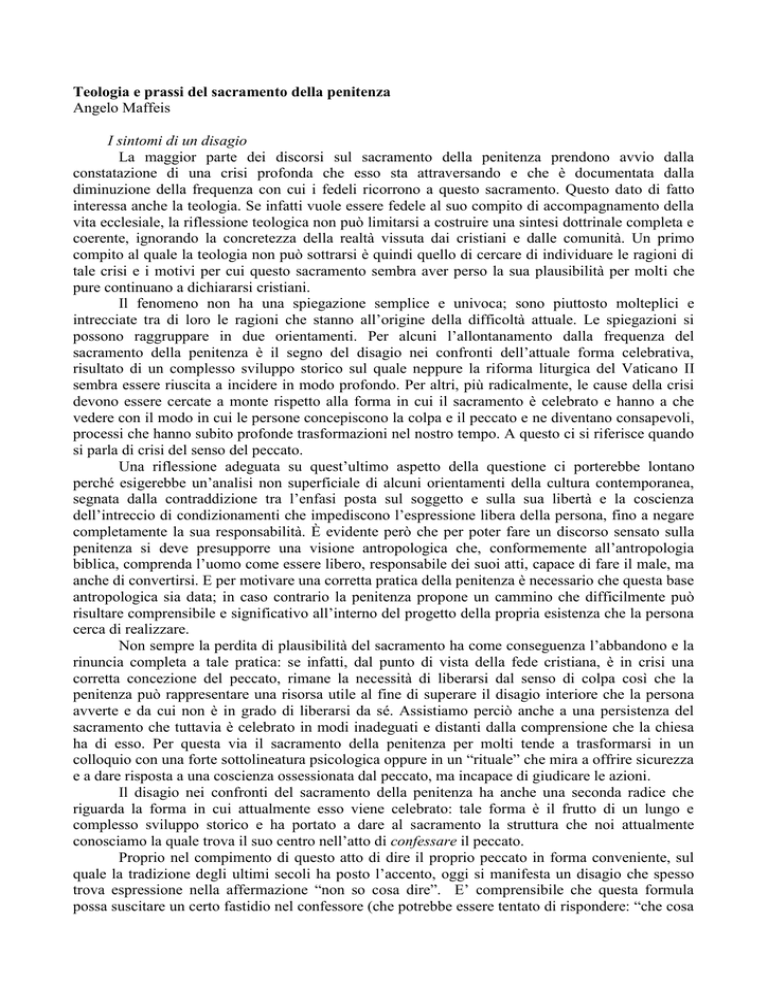
Teologia e prassi del sacramento della penitenza
Angelo Maffeis
I sintomi di un disagio
La maggior parte dei discorsi sul sacramento della penitenza prendono avvio dalla
constatazione di una crisi profonda che esso sta attraversando e che è documentata dalla
diminuzione della frequenza con cui i fedeli ricorrono a questo sacramento. Questo dato di fatto
interessa anche la teologia. Se infatti vuole essere fedele al suo compito di accompagnamento della
vita ecclesiale, la riflessione teologica non può limitarsi a costruire una sintesi dottrinale completa e
coerente, ignorando la concretezza della realtà vissuta dai cristiani e dalle comunità. Un primo
compito al quale la teologia non può sottrarsi è quindi quello di cercare di individuare le ragioni di
tale crisi e i motivi per cui questo sacramento sembra aver perso la sua plausibilità per molti che
pure continuano a dichiararsi cristiani.
Il fenomeno non ha una spiegazione semplice e univoca; sono piuttosto molteplici e
intrecciate tra di loro le ragioni che stanno all’origine della difficoltà attuale. Le spiegazioni si
possono raggruppare in due orientamenti. Per alcuni l’allontanamento dalla frequenza del
sacramento della penitenza è il segno del disagio nei confronti dell’attuale forma celebrativa,
risultato di un complesso sviluppo storico sul quale neppure la riforma liturgica del Vaticano II
sembra essere riuscita a incidere in modo profondo. Per altri, più radicalmente, le cause della crisi
devono essere cercate a monte rispetto alla forma in cui il sacramento è celebrato e hanno a che
vedere con il modo in cui le persone concepiscono la colpa e il peccato e ne diventano consapevoli,
processi che hanno subito profonde trasformazioni nel nostro tempo. A questo ci si riferisce quando
si parla di crisi del senso del peccato.
Una riflessione adeguata su quest’ultimo aspetto della questione ci porterebbe lontano
perché esigerebbe un’analisi non superficiale di alcuni orientamenti della cultura contemporanea,
segnata dalla contraddizione tra l’enfasi posta sul soggetto e sulla sua libertà e la coscienza
dell’intreccio di condizionamenti che impediscono l’espressione libera della persona, fino a negare
completamente la sua responsabilità. È evidente però che per poter fare un discorso sensato sulla
penitenza si deve presupporre una visione antropologica che, conformemente all’antropologia
biblica, comprenda l’uomo come essere libero, responsabile dei suoi atti, capace di fare il male, ma
anche di convertirsi. E per motivare una corretta pratica della penitenza è necessario che questa base
antropologica sia data; in caso contrario la penitenza propone un cammino che difficilmente può
risultare comprensibile e significativo all’interno del progetto della propria esistenza che la persona
cerca di realizzare.
Non sempre la perdita di plausibilità del sacramento ha come conseguenza l’abbandono e la
rinuncia completa a tale pratica: se infatti, dal punto di vista della fede cristiana, è in crisi una
corretta concezione del peccato, rimane la necessità di liberarsi dal senso di colpa così che la
penitenza può rappresentare una risorsa utile al fine di superare il disagio interiore che la persona
avverte e da cui non è in grado di liberarsi da sé. Assistiamo perciò anche a una persistenza del
sacramento che tuttavia è celebrato in modi inadeguati e distanti dalla comprensione che la chiesa
ha di esso. Per questa via il sacramento della penitenza per molti tende a trasformarsi in un
colloquio con una forte sottolineatura psicologica oppure in un “rituale” che mira a offrire sicurezza
e a dare risposta a una coscienza ossessionata dal peccato, ma incapace di giudicare le azioni.
Il disagio nei confronti del sacramento della penitenza ha anche una seconda radice che
riguarda la forma in cui attualmente esso viene celebrato: tale forma è il frutto di un lungo e
complesso sviluppo storico e ha portato a dare al sacramento la struttura che noi attualmente
conosciamo la quale trova il suo centro nell’atto di confessare il peccato.
Proprio nel compimento di questo atto di dire il proprio peccato in forma conveniente, sul
quale la tradizione degli ultimi secoli ha posto l’accento, oggi si manifesta un disagio che spesso
trova espressione nella affermazione “non so cosa dire”. E’ comprensibile che questa formula
possa suscitare un certo fastidio nel confessore (che potrebbe essere tentato di rispondere: “che cosa
è venuto a fare?”). Eppure essa può essere interpretata come il sintomo delle difficoltà che il
penitente incontra nel formarsi una coscienza chiara del peccato e nel dare una forma ecclesiale al
cammino di conversione. Quando si cerca di portare alla luce quello che si cela, o potrebbe celarsi,
dietro l’espressione “non so cosa dire”, alcuni aspetti si segnalano come particolarmente
significativi.
La fatica nel dire il peccato riflette spesso l’incertezza sui contenuti materiali della norma
morale. La difficoltà nel dare un nome al peccato è infatti in molti casi il risultato del modo in cui è
definita la norma morale. In questo ambito due aspetti appaiono problematici: da un lato la legge
morale è presentata nella sua pretesa normativa senza che sia illustrato il suo legame diretto con
Dio, dall’altro il rapporto con Dio è descritto senza prestare particolare attenzione al valore morale
in esso contenuto o, meglio, riferendosi a figure così generali dell’agire morale che non sono capaci
di suggerire alla coscienza del credente che cosa sia effettivamente comportamento buono nella
concretezza della sua situazione e in quali forme il bene sia effettivamente praticabile.
Le ragioni che determinano questa situazione sono diverse. Si può osservare anzitutto la
perdita della rilevanza etica delle norme sociali di comportamento, anche in conseguenza del fatto
che la persona si trova a vivere in contesti assai diversi (famiglia, lavoro, divertimento, ecc.) nei
quali si adegua di volta in volta a norme di comportamento diverse. Da questa frammentazione
degli ambienti vitali deriva una grande difficoltà a costruire una sintesi unitaria e a percepire il
valore morale delle norme in rapporto ai significati decisivi per la vita; esse tendono piuttosto ad
essere viste nella loro contingenza e nella loro finalità limitata di regolazione dei rapporti in un
particolare ambito. A questo si aggiunge il fatto che la predicazione (morale) corre a volte il rischio
di essere generica, richiamando a valori come l’amore del prossimo, il servizio agli ultimi, la
solidarietà, il perdono, la giustizia, senza però prestare attenzione al contesto reale in cui la
realizzazione di questi valori deve compiersi.
La formula “non so che cosa dire” può dunque essere rivelatrice di superficialità, ma non
necessariamente esprime la consapevolezza di essere senza peccato. Essa, al contrario, potrebbe
nascondere la difficoltà a dire in modo adeguato la propria situazione spirituale e di conseguenza
rappresentare una richiesta di aiuto per celebrare in modo adeguato il sacramento della penitenza.
L’incertezza nel riconoscimento della colpa rappresenta perciò una richiesta da interpretare
piuttosto che una dichiarazione di innocenza.
Le osservazioni presentate mostrano che sono due i principali nodi problematici della pratica
attuale della penitenza, cioè l’aspetto antropologico legato alla coscienza del peccato e alla
realizzazione di un cammino di conversione dopo che si è raggiunta questa consapevolezza, e
l’aspetto ecclesiale, legato alla forma in cui questa conversione si realizza con la partecipazione
decisiva della comunità cristiana. Su questo secondo versante, la domanda oggi ricorrente è la
seguente: perché è necessaria la mediazione della chiesa per poter ottenere il perdono di Dio? Non è
possibile ottenere lo stesso risultato anche chiedendo perdono direttamente a Dio?
La chiesa primitiva
Il Nuovo Testamento rivela che fin dalle origini le comunità ecclesiali si sono trovate a fare i
conti con la presenza del peccato al proprio interno e hanno cercato di dare risposta ai problemi che
tale situazione poneva e di offrire vie percorribili per la conversione del peccatore. Questo non è
affatto un esito scontato, dato che per la chiesa primitiva il sacramento per eccellenza della
conversione è costituito dal battesimo, che segna una rottura netta con il passato e l’ingresso in una
vita nuova. In linea di principio, per chi è stato inserito definitivamente in Cristo mediante il
battesimo e appartiene alla chiesa non ci dovrebbe essere un ritorno al peccato. Di fatto però la
comunità sperimenta che questo accade anche al proprio interno e che vi sono battezzati che, pur
vivendo nel popolo dell’alleanza, con il loro agire rifiutano la comunione con Cristo in cui sono
costituiti e si pongono quindi in contraddizione con la vocazione del popolo di Dio del quale
continuano a far parte. Come reagisce la comunità cristiana a tale situazione?
Nel contesto del discorso ecclesiale del vangelo di Matteo (Mt 18), che per gran parte si
occupa del modo in cui la comunità deve affrontare il peccato che scopre presente al suo interno,
troviamo alcune indicazioni che si riferiscono probabilmente a un processo disciplinare che veniva
messo in atto nei confronti di un membro che si era reso colpevole di peccati gravi. Il testo che
abitualmente viene interpretato come riferito alla correzione fraterna (Mt 18, 15-17) riflette proprio
questo procedimento graduale che mira a far prendere coscienza della situazione in cui il peccatore
si è posto con la propria colpa e a suscitare la sua conversione. Tanto le indicazioni circa il modo di
procedere, come il detto di Gesù su potere di legare e sciogliere (Mt 18, 18) si comprendono sullo
sfondo della prassi vigente nelle comunità giudaiche nelle quali, per determinate colpe, era prevista
l’espulsione temporanea dalla comunità (legare) e la riammissione (sciogliere) dopo un periodo di
tempo.
La novità della ripresa neotestamentaria di questa prassi disciplinare, più che dalle concrete
modalità di esercizio, è data dalla comprensione specificamente cristiana della natura della
comunità dalla quale si è espulsi e nella quale si è riammessi: si tratta della comunità che è chiamata
a partecipare alla salvezza escatologica del regno di Dio (si dovrebbe richiamare qui la stretta
connessione esistente tra il regno di Dio annunciato da Gesù e il popolo di Dio al quale l’annuncio è
rivolto e che Gesù raccoglie attorno a sé). Nell’interruzione della comunione con la chiesa quindi è
implicata anche la possibilità per l’uomo di accedere alla salvezza. Un analogo modo di procedere è
attestato dalla lettere paoline.
Dalla testimonianza del Nuovo Testamento risulta che le comunità ecclesiali si sono trovate
molto presto di fronte alla situazione di cristiani che commettevano peccati, anche molto gravi (cfr.
p.es. le lettere di Paolo). Per il cristiano si tratta di una condizione paradossale, che contraddice
apertamente la novità battesimale e la santità che dovrebbe contrassegnare la vita di coloro che sono
entrati a far parte del popolo di Dio. Di fronte a tale situazione la chiesa non assume però un
atteggiamento rigorista e non abbandona questi fedeli al proprio destino. Essa mette invece in atto
una serie di interventi con la finalità di indurre i peccatori alla conversione.
Non meno importante è la consapevolezza, fondata sulla promessa di Gesù (cfr. oltre a Mt
18, 18 anche Gv 20, 23), che la chiesa ha di disporre dell’autorità necessaria per riammettere i
peccatori, reintegrandoli nella comunità della salvezza, e la convinzione che tale azione non ha un
effetto limitato all’ambito della disciplina ecclesiale ma ha una profondità tale da coinvolgere il
rapporto con Dio, operando efficacemente il perdono del peccato. In questo modo la chiesa si
manifesta come segno efficace della misericordia di Dio.
L’evoluzione storica della penitenza
La penitenza canonica (chiamata in questo modo perché era regolata dai canoni dei concili e
dagli scritti di alcuni vescovi ai quali si riconosce un valore normativo) della chiesa antica
rappresenta sostanzialmente uno sviluppo che si colloca nella linea della disciplina ecclesiale già
attestata nel Nuovo Testamento. Con il diffondersi del cristianesimo il livello morale delle comunità
si abbassa e si pone in modo sempre più urgente il problema di una risposta pastorale adeguata. La
penitenza canonica, che riceve la sua strutturazione dal IV al VI secolo, è una istituzione complessa,
che comporta aspetti giuridici, liturgici e pastorali. I fedeli che si sono resi colpevoli di peccati gravi
sono esclusi dalla comunità ecclesiale con un intervento del vescovo e questa condizione di
separazione si manifesta nell’impossibilità di partecipare all’eucaristia, che costituisce il centro
della vita comunitaria. Al vescovo spetta il compito di suscitare la volontà di conversione e di
guidare l’itinerario penitenziale. Quando il peccatore si presenta per chiedere il perdono, egli viene
aggregato all’ordine dei penitenti e dovrà svolgere per un certo periodo le opere penitenziali che gli
sono assegnate (preghiera e digiuno). Al termine del periodo di penitenza avviene la riconciliazione
ad opera del vescovo e la riammissione alla comunione eucaristica.
Tra i problemi che determinano la crisi della penitenza canonica, il principale è
rappresentato dal suo carattere irripetibile: ad essa si poteva essere ammessi soltanto una volta
durante la vita. Sulla questione del carattere originario o meno del principio dell’unica penitenza, la
discussione è stata assai accesa negli ultimi secoli. Le ragioni dell’unicità della penitenza sono
diverse. Probabilmente un peso rilevante l’ha avuto la prospettiva escatologica del Pastore di Erma,
che rivolge un invito pressante alla conversione; poiché la fine del mondo si avvicina, non è
possibile indugiare ma ci si deve affrettare ad approfittare della unica (perché ultima) possibilità di
ottenere il perdono che è data. Il principio dell’unicità della penitenza sopravvive anche quando la
prospettiva della fine del mondo si allontana e diviene funzionale a far comprendere che non c’è
seria conversione che non sia anche definitiva (e quindi è incompatibile con una ricaduta nel
peccato).
Coloro che erano passati attraverso la penitenza rimanevano inoltre soggetti, anche dopo la
riconciliazione, a numerose limitazioni. Tutto ciò determina la tendenza a rimandare la penitenza
alla fine della vita e porta in definitiva a uno snaturamento del suo significato perché diviene di
fatto non più accessibile nelle condizioni normali della vita cristiana.
Il vuoto lasciato da questa trasformazione della penitenza in sacramento dei morenti
costituisce il terreno favorevole per lo sviluppo di una forma alternativa di penitenza. Tra il VI e
l’VIII secolo i monaci irlandesi introducono in Europa un nuovo modo di celebrare la penitenza che
ha origine dalla pratica della confessione monastica, simile alla direzione spirituale.
La penitenza “privata” prevede la confessione dei peccati fatta a un sacerdote il quale
impone delle opere penitenziali da compiere per un tempo determinato, trascorso il quale si ritorna
per ricevere l’assoluzione. Il vantaggio principale di questa nuova forma rispetto alla penitenza
canonica era dato dalla possibilità di accedere ad essa più volte nella vita; oltre a questo la nuova
prassi si rivela meno complessa della precedente e, gradualmente, si verifica un’estensione dell’uso
del sacramento al quale ormai si ricorre non più soltanto per ottenere il perdono dei peccati gravi
ma anche per i peccati quotidiani o veniali.
La confessione individuale nasce dunque come risposta alla necessità di adeguare la forma
celebrativa a una mutata situazione storica in cui la penitenza canonica diventava di fatto
inaccessibile per i fedeli. Tale evoluzione comporta però che si paghi un prezzo:
l’individualizzazione della penitenza con il conseguente oscuramento della sua dimensione
comunitaria ed ecclesiale, tanto nella celebrazione come nella riflessione teologica. In questa
prospettiva la situazione del peccatore e del penitente non viene più percepita in relazione alla vita
della comunità ecclesiale e al suo centro rappresentato dalla celebrazione dell’eucaristia, ma quasi
esclusivamente in riferimento alla condizione morale del peccatore e all’azione della grazia di Dio
che lo giustifica.
La chiesa santa e i peccatori
L’elemento primario che fonda la dimensione ecclesiale della penitenza è rappresentato dal
fatto che essa non è il sacramento della conversione in senso generico, ma è il sacramento della
conversione del battezzato peccatore. Nel soggetto che si converte e chiede la remissione del
peccato è presente dunque un dato permanente, che lo qualifica in modo irreversibile, e che implica
un legame con la chiesa stabilito dal battesimo. Se la relazione con la chiesa per il battezzato non è
un elemento accessorio nel suo rapporto con Dio ma costituisce il luogo concreto dell’alleanza e
della comunione con Dio, allora, quando il peccato compromette la verità di questo rapporto con
Dio anche la sua appartenenza alla chiesa soffre una diminuzione poiché il battezzato viene a
trovarsi in contraddizione con il mistero di santità che la costituisce.
Da questo punto di vista è assai significativo il modo in cui la Costituzione Lumen gentium
tratta il tema dell’appartenenza alla chiesa. Su tale questione vi sono state lunghe discussioni che
vertevano principalmente sul rapporto tra i criteri esterni di appartenenza (triplice vincolo della
professione di fede, dei sacramenti e della obbedienza alla gerarchia) e i criteri interni (la vita di
grazia), con la problematica connessa dell’appartenenza o meno dei peccatori alla chiesa. Il
Vaticano II avverte l’insufficienza di una determinazione puramente giuridica dei criteri di
appartenenza alla chiesa, pensata come realtà che o esiste pienamente o non c’è affatto (dentro o
fuori) e in LG 14-16 opta per l’assunzione di un modello di pienezza oppure realizzazione
imperfetta, ma pure esistente, dell’appartenenza al popolo di Dio. Quando parla della «piena
incorporazione» al popolo di Dio (LG 14) dispone i criteri su due livelli: quello interiore è dato dal
possesso dello Spirito di Cristo, quello esteriore è dato dalla «sua struttura e i mezzi di salvezza in
essa istituiti». Il peccatore continua a far parte della chiesa secondo i criteri visibili (e anche per
l’irrevocabilità del battesimo), ma il suo peccato lo pone in contraddizione con la vocazione alla
santità che egli è chiamato a vivere come membro della chiesa e che costituisce l’elemento decisivo
perché si possa dire che egli ne fa pienamente parte.
Quanto si afferma in nel II capitolo della Lumen gentium sui criteri di appartenenza al
popolo di Dio trova conferma nella trattazione del tema della universale vocazione alla santità nella
chiesa nel capitolo V della LG. In esso la santità non è descritta come una sorta di perfezione che la
chiesa possederebbe per se stessa; essa è santa in forza della sua unione con Cristo suo sposo che
continuamente le comunica la santità ricevuta da Dio (cfr. Ef 5, 25-26). Il Vaticano II dunque
riprende la nozione biblica di santità, intesa come caratteristica che appartiene originariamente a
Dio, e che viene comunicata all’uomo. In questo contesto l’idea della comunicazione della santità
divina non fa altro che esprimere in termini diversi quanto l’inizio della Lumen gentium afferma
circa l’origine della chiesa dalla Trinità. La comunicazione della santità divina è in ultima analisi la
salvezza operata dal Padre in Cristo e nello Spirito che riunisce il popolo della nuova alleanza,
anche se l’uso di questo concetto sottolinea come tratto peculiare l’esigenza di risposta a questo
dono da parte del popolo, risposta che si traduce in una vita conforme al dono ricevuto. La santità
della chiesa non è dunque soltanto un dato oggettivo, essa esige anche una risposta personale, una
realizzazione nella vita cristiana concretamente vissuta. A ben vedere è proprio verso quest’ultimo
aspetto della santità che tende tutto il discorso: infatti gli elementi costitutivi della chiesa, che
costituiscono la sorgente della sua santità, sono orientati a costituire l’identità fondamentale del
cristiano nel popolo di Dio, ma questo dato oggettivo esige a sua volta quella che potremmo
chiamare una appropriazione personale o esistenziale.
Nel V capitolo la LG recupera quindi alcuni elementi centrali della antropologia cristiana e li
integra nella sua concezione ecclesiologica. Ciò significa che tutto quanto appartiene alla istituzione
ecclesiale non ha altro fine che essere a servizio della appropriazione personale del dono della
grazia, per mezzo della quale soltanto la persona umana diventa ciò che è chiamata ad essere in
forza della sua vocazione. Tutta la realtà della chiesa è a servizio di questo incontro personale tra la
grazia di Dio e la libertà della persona umana che è chiamata ad accoglierla. D’altra parte però
questa accoglienza, che rappresenta la realtà più intima e personale che possa esistere, contribuisce
al tempo stesso a rendere la chiesa luogo della santità e ambiente nel quale anche ad altri diviene
possibile realizzare questo incontro. In questo modo il dinamismo della grazia non ha come
obiettivo solo la salvezza e l’esistenza cristiana personale dei fedeli, ma anche l’edificazione della
chiesa.
Riconciliazione con Dio e riconciliazione con la chiesa
Questa struttura della vocazione cristiana e l’inseparabile legame che essa ha con
l’appartenenza alla comunità ecclesiale determina anche il processo attraverso il quale è possibile il
superamento del peccato: l’alleanza con Dio non può essere recuperata che insieme e attraverso il
recupero della piena verità della propria appartenenza alla chiesa. Il cammino di conversione
attraverso il quale il battezzato peccatore cerca la riconciliazione con Dio non può perciò non avere
un carattere ecclesiale. Sull’altro versante, la chiesa riaccoglie il peccatore ed è cosciente di
adempiere in questo modo la sua vocazione di essere testimone della misericordia di Dio. Nell’atto
di accoglienza del peccatore la chiesa manifesta la propria obbedienza a Gesù e insieme la
consapevolezza di essere comunità che è segno efficace della riconciliazione che Dio offre al
mondo.
K. Rahner riflette in modo suggestivo sul carattere ecclesiale della riconciliazione del
peccatore chiedendosi quale sia il significato del potere di “legare” e di “sciogliere” di cui si parla
in Mt 16, 19 e 18, 18. I manuali di teologia spiegavano il legare come rifiuto di dare l’assoluzione;
questa interpretazione riduce il legare all’astensione dal compiere un atto, cioè l’assoluzione, che
rappresenta il fine cui propriamente mira la penitenza. In realtà, nel linguaggio del Nuovo
Testamento legare significa qualcosa di più, cioè escludere dalla comunità, mettere al bando. Il
battezzato che ha peccato appartiene ancora alla chiesa, ma la sua appartenenza incancellabile è
privata del suo vero e intimo senso. Il peccatore infatti continua ad appartenere alla chiesa secondo
le dimensioni visibili, ma a questo non corrisponde più il possesso della grazia. Per salvare il
peccatore la chiesa come primo atto svela nella dimensione visibile lo stato menzognero in cui il
peccatore si è posto con la sua colpa. La chiesa dice: tu membro della chiesa non sei ciò che sembri
essere per la tua appartenenza visibile.
Legare e sciogliere non sono quindi da intendere come due possibilità alternative tra cui la
chiesa potrebbe scegliere nel suo modo di procedere contro il peccatore, ma due momenti di un
unico atto, cioè della sua reazione contro il peccato. Se il legare significa rendere visibile la
situazione in cui il peccatore si trova nei confronti della chiesa la stessa azione fa percepire anche la
distanza del peccatore da Dio.
Qui si può vedere un aspetto significativo del sacramento della penitenza anche in rapporto
alla coscienza del peccato, che spesso affermiamo essere carente nei fedeli e da cui dipende una
celebrazione difficoltosa del sacramento della penitenza. Se è vero che chi si accosta al sacramento
della penitenza deve avere già una percezione del peccato alla luce della parola di Dio, è vero anche
che il momento della celebrazione del sacramento diventa quello in cui il penitente comprende
veramente che cosa significa il peccato. Esso infatti è percepito in tutta la sua realtà non
semplicemente attraverso un movimento di introspezione che la persona potrebbe compiere in modo
autonomo, ma solamente nel confronto con la parola di Dio. Ora, l’annuncio in forma personale
della parola di Dio nella celebrazione del sacramento della penitenza rappresenta la modalità
attraverso la quale la chiesa aiuta il battezzato a fare la necessaria chiarezza sul peccato e a fare
maturare gli atteggiamenti che sono necessari per la conversione. In questo senso il “dire il peccato”
è la manifestazione di questa chiarezza raggiunta e assume il carattere di vera e propria
“confessione”.
Questo processo che ha come obiettivo il raggiungimento di una consapevolezza e di una
chiarezza circa il proprio peccato, poi, non opprime la persona con un senso di colpa insopportabile
perché il momento della comprensione autentica del peccato coincide con il momento in cui si
riceve perdono. La parola con cui il penitente dice il suo peccato è strettamente legata a quella con
cui la chiesa dona il perdono.
Il cuore dell’evento sacramentale della penitenza è dunque costituito dal convergere di due
movimenti: la conversione del peccatore che confessa la propria colpa e chiede insieme al perdono
di Dio di ritrovare la piena verità della propria appartenenza alla chiesa e l’azione della chiesa che
riaccoglie il penitente e lo restituisce alla comunione con sé e con Dio. Questo duplice movimento e
l’incontro che si realizza dovrebbe essere percepibile anche nella forma in cui la penitenza vine
celebrata.
Se vale quanto abbiamo detto, la celebrazione della penitenza diviene un evento spirituale
non solo per il fedele, ma anche per il confessore. Sono decisivi da questo punto di vista alcuni
atteggiamenti ministeriali da assumere. Compiendo il gesto della riconciliazione il ministro non è
affatto strumento neutro e impersonale, esecutore di una funzione che la chiesa gli ha affidato, ma
deve lasciarsi plasmare in un atteggiamento di obbedienza all’azione che Dio Padre compie
mediante lo Spirito di Cristo. La partecipazione personale del ministero all’evento spirituale che si
compie nella celebrazione del sacramento non significa in alcun modo indurre a un’interpretazione
arbitrariamente soggettivistica dello stesso, come l’attenzione al senso oggettivo del sacramento e ai
criteri di giudizio stabiliti dalla chiesa non esclude il coinvolgimento personale. Il ministro deve
perciò vivere questo gesto sapendo che dispensa un beneficio altrui, che ha ricevuto dei criteri da
colui che gli ha affidato la missione di riaccogliere, che mentre giudica egli viene giudicato, che
mentre parla e consiglia egli è un ascoltatore dello Spirito che gli dona di edificare e consolare il
cammino dei propri fratelli. Per questo sarà da evitare ogni atteggiamento indagatore, ogni curiosità
invadente, ogni durezza gratuita. E’ invece necessario il coraggio per dire ogni cosa in tempo e
modo opportuno al fine di risvegliare le coscienze, scuotere dal torpore e dalla pigrizia, lenire le
ferite, incoraggiare e aprire la vita cristiana al cammino della virtù.
Il sacramento della penitenza nella pastorale della chiesa
Da questa concezione della penitenza deriva l’esigenza di superare l’isolamento in cui
questo sacramento spesso si è trovato per reimmetterlo nel tessuto complessivo della vita ecclesiale.
Questo principio può ispirare anche la ricerca di vie che potrebbero utilmente essere percorse (o
almeno tentate) per rinnovare la pratica del sacramento della penitenza. Affrontando questo tema ci
si addentra in un ambito difficile e in cui nessuno è in grado di dare preventivamente la certezza
dell’efficacia dei rimedi che si propongono. Se infatti la constatazione della crisi del sacramento
della penitenza si impone ad ogni osservatore, non è altrettanto facile indicare delle vie che
permettano di recuperare il senso della penitenza e quindi restituire una consistenza alla sua pratica
all’interno della vita cristiana. Alcune indicazioni schematiche possono suggerire possibili scelte
coerenti con la figura teologica del sacramento.
1. La coscienza del peccato, essenziale per la conversione e per la penitenza, si forma solo
attraverso il confronto con la parola di Dio. Tale confronto si realizza remotamente attraverso
l’evangelizzazione e la catechesi: in esse si deve ricucire il legame essenziale tra la fede e l’etica e
offrire criteri evangelici che permettano di giudicare il proprio agire. Ma l’ascolto della parola di
Dio deve trovare spazio anche nella celebrazione del sacramento; su questo la riforma liturgica ha
insistito, come del resto per gli altri sacramenti, ma nel caso della penitenza assume un rilievo
ancora maggiore proprio perché il confronto con la parola di Dio è la condizione per riconoscere la
propria verità di peccatori davanti a Dio (senza minimizzarla e senza esagerarla come si tende a fare
quando ci si affida solo a criteri psicologici).
2. Tutti riconoscono l’urgenza di valorizzare maggiormente la dimensione ecclesiale e
comunitaria della penitenza. Il modo per realizzare questa esigenza è anzitutto quello di inserire la
penitenza nella programmazione pastorale ordinaria; l’abitudine già esistente di legare la penitenza
alle celebrazioni liturgiche più importante dell’anno liturgico potrebbe essere verificata e rinnovata
al fine di offrire alla comunità cristiana un itinerario che preveda anche la penitenza come passaggio
significativo e importante, anche attraverso la proposta di celebrazioni comunitarie della penitenza.
3. Infine, è necessario far percepire che il sacramento della penitenza costituisce una risorsa
importante per il cammino spirituale personale poiché stimola e sostiene il cammino di conversione
che ne costituisce una dimensione fondamentale. Oggi si segnala spesso il limite delle proposte di
massa e si insiste sulla necessità di percorsi di fede più attenti all’individuo. Il sacramento della
penitenza costituisce uno strumento prezioso per questo cammino personale. In esso infatti la fede,
che è quanto di più personale esista, diventa criterio per giudicare l’agire concreto e stimolo per un
cammino di conversione che ha come meta la realizzazione della propria chiamata alla santità. Nel
sacramento della penitenza il cammino di conversione ha un carattere personale e insieme
ecclesiale. Da una parte infatti la tensione dei credenti verso la santità edifica la chiesa nel modo più
vero e profondo, dall’altra il credente non è lasciato solo nel suo cammino di conversione, ma è
sostenuto dalla chiesa che gli annuncia e dona il perdono di Dio.