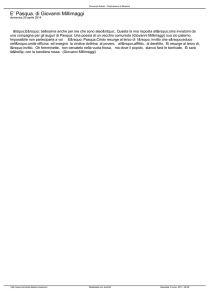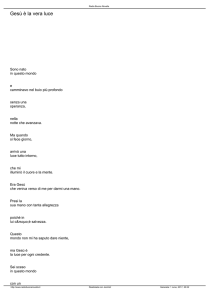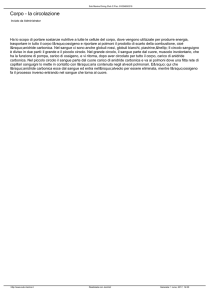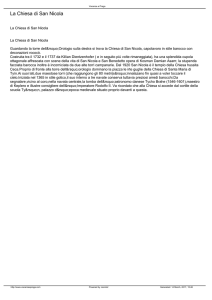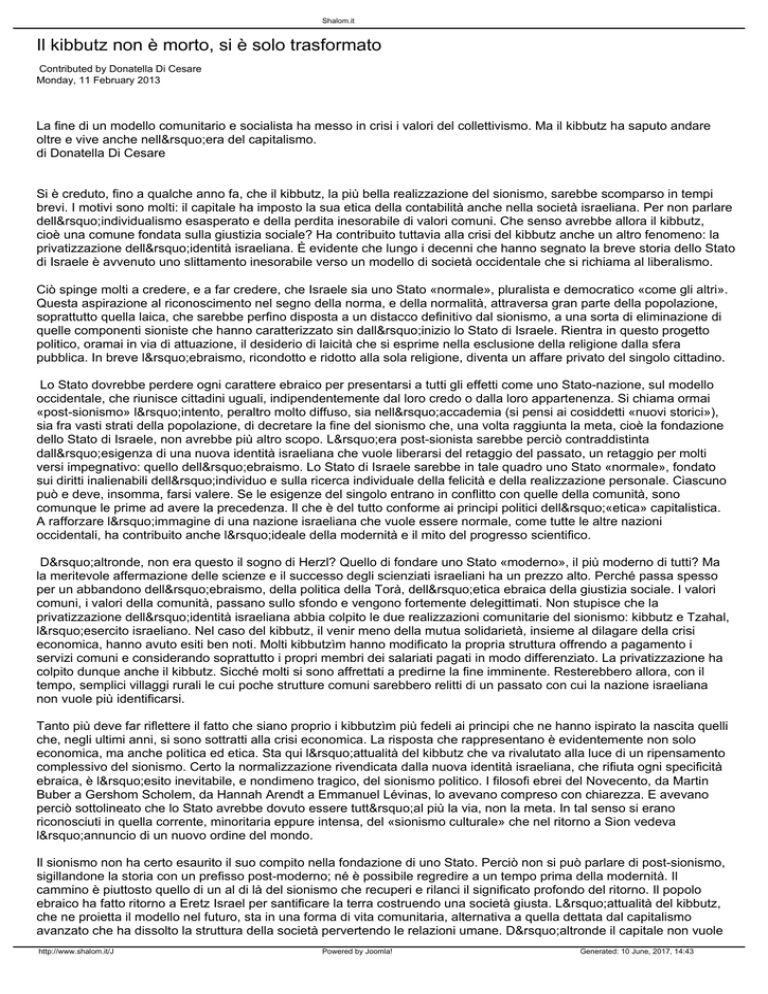
Shalom.it
Il kibbutz non è morto, si è solo trasformato
Contributed by Donatella Di Cesare
Monday, 11 February 2013
La fine di un modello comunitario e socialista ha messo in crisi i valori del collettivismo. Ma il kibbutz ha saputo andare
oltre e vive anche nell’era del capitalismo.
di Donatella Di Cesare
Si è creduto, fino a qualche anno fa, che il kibbutz, la più bella realizzazione del sionismo, sarebbe scomparso in tempi
brevi. I motivi sono molti: il capitale ha imposto la sua etica della contabilità anche nella società israeliana. Per non parlare
dell’individualismo esasperato e della perdita inesorabile di valori comuni. Che senso avrebbe allora il kibbutz,
cioè una comune fondata sulla giustizia sociale? Ha contribuito tuttavia alla crisi del kibbutz anche un altro fenomeno: la
privatizzazione dell’identità israeliana. È evidente che lungo i decenni che hanno segnato la breve storia dello Stato
di Israele è avvenuto uno slittamento inesorabile verso un modello di società occidentale che si richiama al liberalismo.
Ciò spinge molti a credere, e a far credere, che Israele sia uno Stato «normale», pluralista e democratico «come gli altri».
Questa aspirazione al riconoscimento nel segno della norma, e della normalità, attraversa gran parte della popolazione,
soprattutto quella laica, che sarebbe perfino disposta a un distacco definitivo dal sionismo, a una sorta di eliminazione di
quelle componenti sioniste che hanno caratterizzato sin dall’inizio lo Stato di Israele. Rientra in questo progetto
politico, oramai in via di attuazione, il desiderio di laicità che si esprime nella esclusione della religione dalla sfera
pubblica. In breve l’ebraismo, ricondotto e ridotto alla sola religione, diventa un affare privato del singolo cittadino.
Lo Stato dovrebbe perdere ogni carattere ebraico per presentarsi a tutti gli effetti come uno Stato-nazione, sul modello
occidentale, che riunisce cittadini uguali, indipendentemente dal loro credo o dalla loro appartenenza. Si chiama ormai
«post-sionismo» l’intento, peraltro molto diffuso, sia nell’accademia (si pensi ai cosiddetti «nuovi storici»),
sia fra vasti strati della popolazione, di decretare la fine del sionismo che, una volta raggiunta la meta, cioè la fondazione
dello Stato di Israele, non avrebbe più altro scopo. L’era post-sionista sarebbe perciò contraddistinta
dall’esigenza di una nuova identità israeliana che vuole liberarsi del retaggio del passato, un retaggio per molti
versi impegnativo: quello dell’ebraismo. Lo Stato di Israele sarebbe in tale quadro uno Stato «normale», fondato
sui diritti inalienabili dell’individuo e sulla ricerca individuale della felicità e della realizzazione personale. Ciascuno
può e deve, insomma, farsi valere. Se le esigenze del singolo entrano in conflitto con quelle della comunità, sono
comunque le prime ad avere la precedenza. Il che è del tutto conforme ai principi politici dell’«etica» capitalistica.
A rafforzare l’immagine di una nazione israeliana che vuole essere normale, come tutte le altre nazioni
occidentali, ha contribuito anche l’ideale della modernità e il mito del progresso scientifico.
D’altronde, non era questo il sogno di Herzl? Quello di fondare uno Stato «moderno», il più moderno di tutti? Ma
la meritevole affermazione delle scienze e il successo degli scienziati israeliani ha un prezzo alto. Perché passa spesso
per un abbandono dell’ebraismo, della politica della Torà, dell’etica ebraica della giustizia sociale. I valori
comuni, i valori della comunità, passano sullo sfondo e vengono fortemente delegittimati. Non stupisce che la
privatizzazione dell’identità israeliana abbia colpito le due realizzazioni comunitarie del sionismo: kibbutz e Tzahal,
l’esercito israeliano. Nel caso del kibbutz, il venir meno della mutua solidarietà, insieme al dilagare della crisi
economica, hanno avuto esiti ben noti. Molti kibbutzìm hanno modificato la propria struttura offrendo a pagamento i
servizi comuni e considerando soprattutto i propri membri dei salariati pagati in modo differenziato. La privatizzazione ha
colpito dunque anche il kibbutz. Sicché molti si sono affrettati a predirne la fine imminente. Resterebbero allora, con il
tempo, semplici villaggi rurali le cui poche strutture comuni sarebbero relitti di un passato con cui la nazione israeliana
non vuole più identificarsi.
Tanto più deve far riflettere il fatto che siano proprio i kibbutzìm più fedeli ai principi che ne hanno ispirato la nascita quelli
che, negli ultimi anni, si sono sottratti alla crisi economica. La risposta che rappresentano è evidentemente non solo
economica, ma anche politica ed etica. Sta qui l’attualità del kibbutz che va rivalutato alla luce di un ripensamento
complessivo del sionismo. Certo la normalizzazione rivendicata dalla nuova identità israeliana, che rifiuta ogni specificità
ebraica, è l’esito inevitabile, e nondimeno tragico, del sionismo politico. I filosofi ebrei del Novecento, da Martin
Buber a Gershom Scholem, da Hannah Arendt a Emmanuel Lévinas, lo avevano compreso con chiarezza. E avevano
perciò sottolineato che lo Stato avrebbe dovuto essere tutt’al più la via, non la meta. In tal senso si erano
riconosciuti in quella corrente, minoritaria eppure intensa, del «sionismo culturale» che nel ritorno a Sion vedeva
l’annuncio di un nuovo ordine del mondo.
Il sionismo non ha certo esaurito il suo compito nella fondazione di uno Stato. Perciò non si può parlare di post-sionismo,
sigillandone la storia con un prefisso post-moderno; né è possibile regredire a un tempo prima della modernità. Il
cammino è piuttosto quello di un al di là del sionismo che recuperi e rilanci il significato profondo del ritorno. Il popolo
ebraico ha fatto ritorno a Eretz Israel per santificare la terra costruendo una società giusta. L’attualità del kibbutz,
che ne proietta il modello nel futuro, sta in una forma di vita comunitaria, alternativa a quella dettata dal capitalismo
avanzato che ha dissolto la struttura della società pervertendo le relazioni umane. D’altronde il capitale non vuole
http://www.shalom.it/J
Powered by Joomla!
Generated: 10 June, 2017, 14:43
Shalom.it
avere di fronte a sé altro che individui isolati su cui esercitare un più facile dominio.
I kibbutzim restano il modello esemplare di comunità autonome e autogestite in grado di assecondare forme di vita che
possano dispiegarsi nella condivisione, nella responsabilità, nel dialogo. Non è un caso che il progetto del kibbutz,
rilanciando la keillà, fosse inteso sin dall’inizio non come un ritorno al villaggio rurale, bensì come un
oltrepassamento della metropoli, la forma corrispondente alla atomizzazione, al tornaconto, alla conflittualità, in vista di
una terza forma di vita comunitaria che scaturisse non solo da una nuova organizzazione del lavoro, ma anche da un
mutamento interno dei rapporti umani. Si comprende allora perché filosofi e politologi, economisti e sociologi, che
prendono oggi parte al dibattito da tempo avviato sul tema della comunità, guardino con grande interesse alla comune
ebraica in Israele, a quell’«esemplare non-naufragio», come lo definì Buber, che resta un punto di riferimento
nell’età della globalizzazione dove il pericolo imminente appare un illimitato potere planetario, una sorta di Stato
mondiale, mentre l’alternativa sembra una federazione decentrata di comunità.
Donatella Di Cesare
http://www.shalom.it/J
Powered by Joomla!
Generated: 10 June, 2017, 14:43
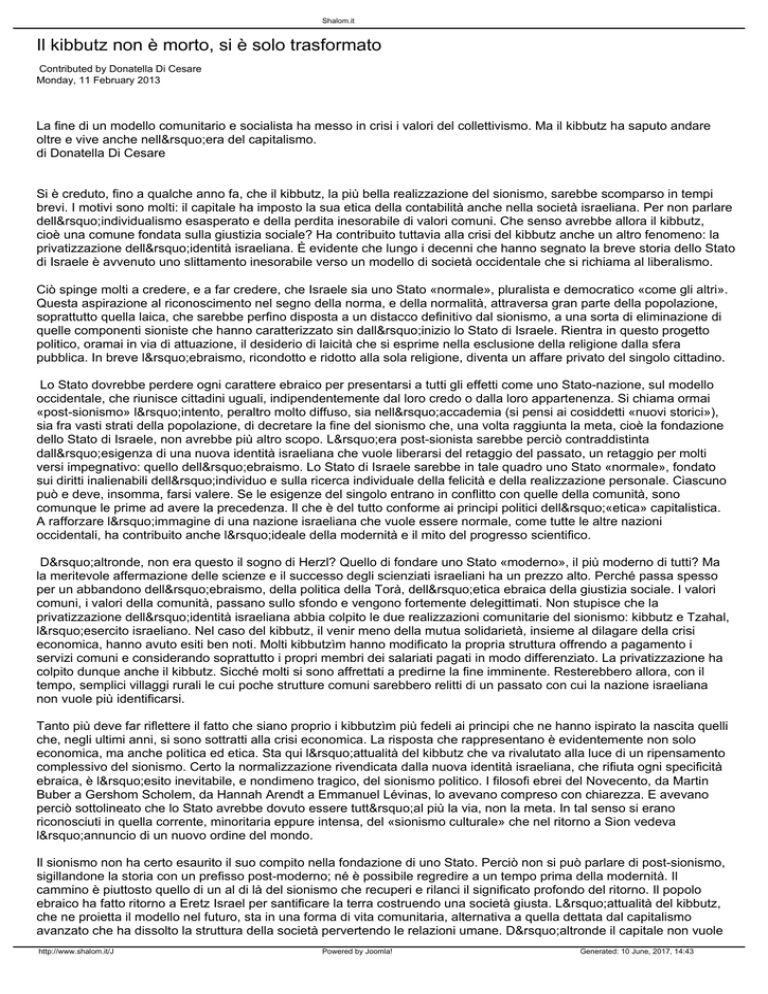

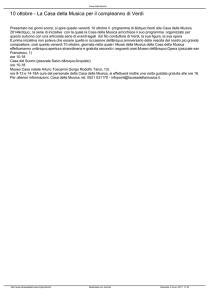
![Recensendo [cd]: "Calibrated thickness" di Uri Caine](http://s1.studylibit.com/store/data/003842205_1-7e3c5e4d085992dd2d8b768378f0a85c-300x300.png)


![Recensendo [cd]: "Mattoni" di Andrea](http://s1.studylibit.com/store/data/007525618_1-1525635c43b9484bf53d73b8a7da6ea3-300x300.png)