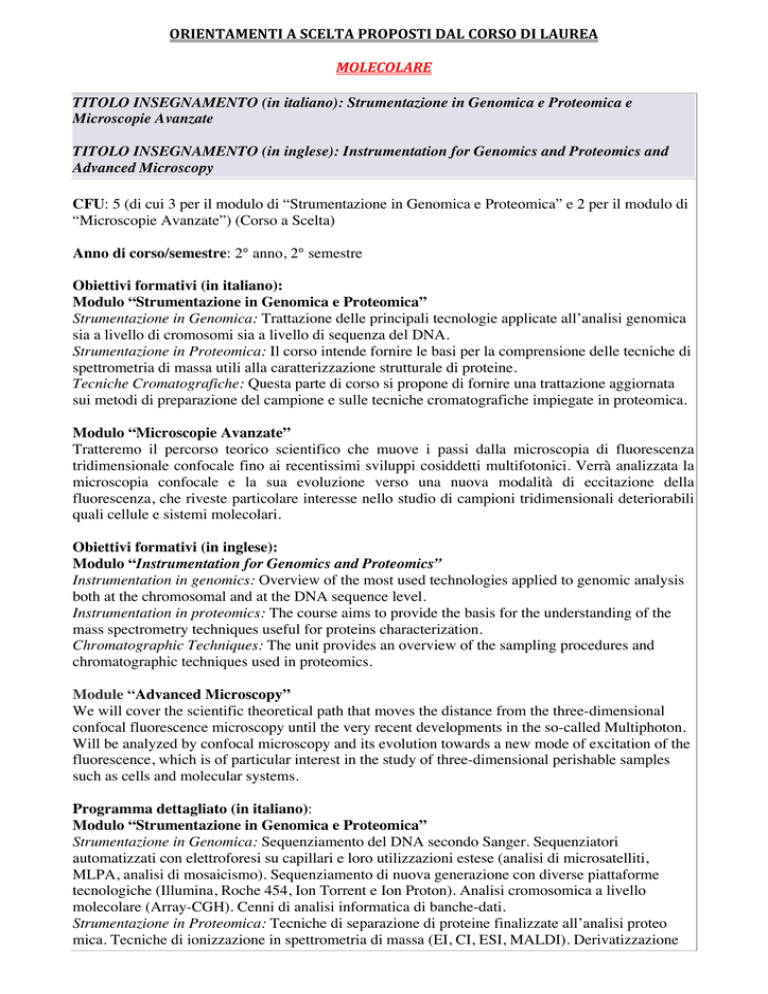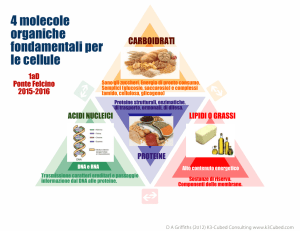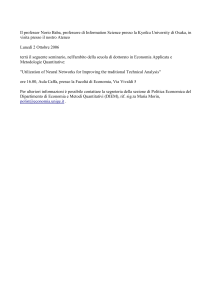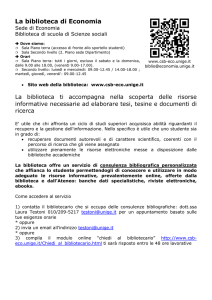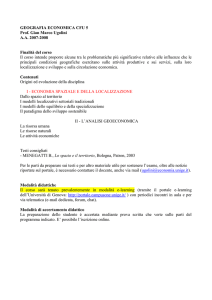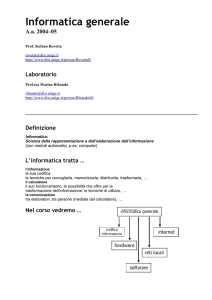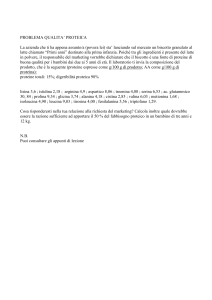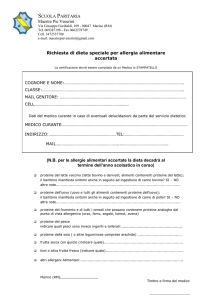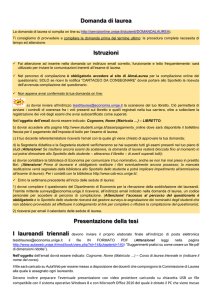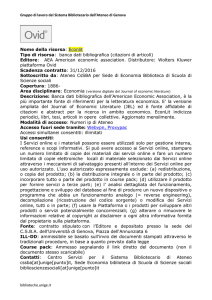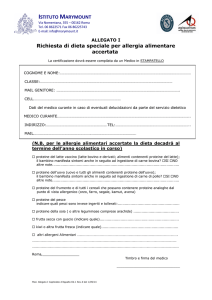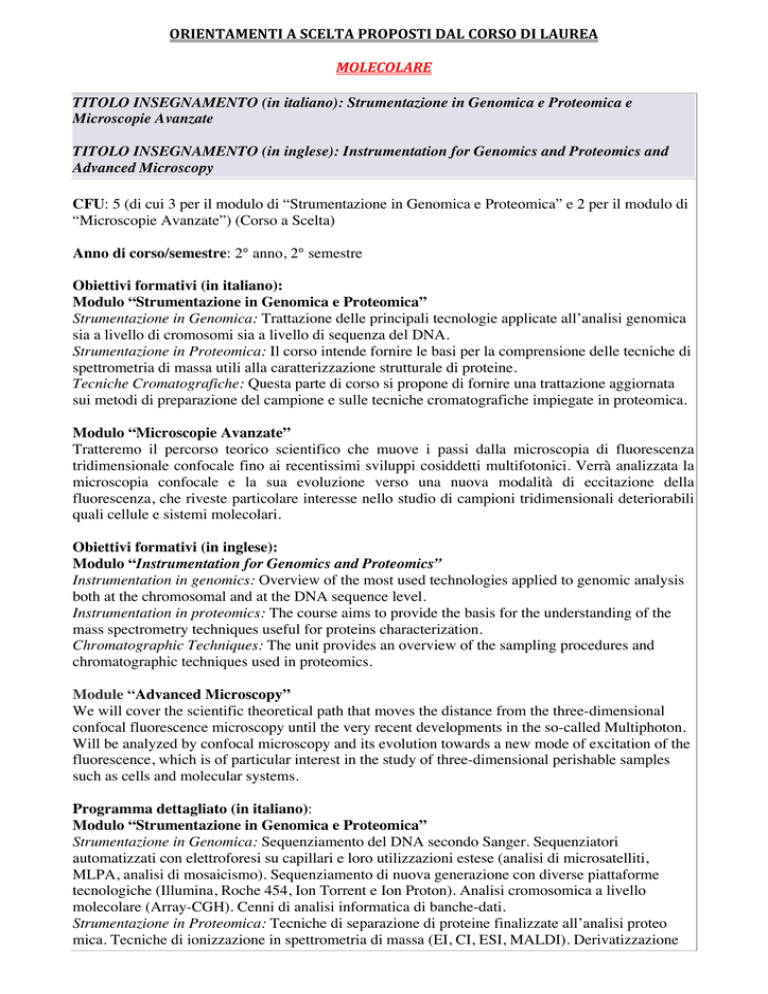
ORIENTAMENTI A SCELTA PROPOSTI DAL CORSO DI LAUREA MOLECOLARE TITOLO INSEGNAMENTO (in italiano): Strumentazione in Genomica e Proteomica e
Microscopie Avanzate
TITOLO INSEGNAMENTO (in inglese): Instrumentation for Genomics and Proteomics and
Advanced Microscopy
CFU: 5 (di cui 3 per il modulo di “Strumentazione in Genomica e Proteomica” e 2 per il modulo di
“Microscopie Avanzate”) (Corso a Scelta)
Anno di corso/semestre: 2° anno, 2° semestre
Obiettivi formativi (in italiano):
Modulo “Strumentazione in Genomica e Proteomica”
Strumentazione in Genomica: Trattazione delle principali tecnologie applicate all’analisi genomica
sia a livello di cromosomi sia a livello di sequenza del DNA.
Strumentazione in Proteomica: Il corso intende fornire le basi per la comprensione delle tecniche di
spettrometria di massa utili alla caratterizzazione strutturale di proteine.
Tecniche Cromatografiche: Questa parte di corso si propone di fornire una trattazione aggiornata
sui metodi di preparazione del campione e sulle tecniche cromatografiche impiegate in proteomica.
Modulo “Microscopie Avanzate”
Tratteremo il percorso teorico scientifico che muove i passi dalla microscopia di fluorescenza
tridimensionale confocale fino ai recentissimi sviluppi cosiddetti multifotonici. Verrà analizzata la
microscopia confocale e la sua evoluzione verso una nuova modalità di eccitazione della
fluorescenza, che riveste particolare interesse nello studio di campioni tridimensionali deteriorabili
quali cellule e sistemi molecolari.
Obiettivi formativi (in inglese):
Modulo “Instrumentation for Genomics and Proteomics”
Instrumentation in genomics: Overview of the most used technologies applied to genomic analysis
both at the chromosomal and at the DNA sequence level.
Instrumentation in proteomics: The course aims to provide the basis for the understanding of the
mass spectrometry techniques useful for proteins characterization.
Chromatographic Techniques: The unit provides an overview of the sampling procedures and
chromatographic techniques used in proteomics.
Module “Advanced Microscopy”
We will cover the scientific theoretical path that moves the distance from the three-dimensional
confocal fluorescence microscopy until the very recent developments in the so-called Multiphoton.
Will be analyzed by confocal microscopy and its evolution towards a new mode of excitation of the
fluorescence, which is of particular interest in the study of three-dimensional perishable samples
such as cells and molecular systems.
Programma dettagliato (in italiano):
Modulo “Strumentazione in Genomica e Proteomica”
Strumentazione in Genomica: Sequenziamento del DNA secondo Sanger. Sequenziatori
automatizzati con elettroforesi su capillari e loro utilizzazioni estese (analisi di microsatelliti,
MLPA, analisi di mosaicismo). Sequenziamento di nuova generazione con diverse piattaforme
tecnologiche (Illumina, Roche 454, Ion Torrent e Ion Proton). Analisi cromosomica a livello
molecolare (Array-CGH). Cenni di analisi informatica di banche-dati.
Strumentazione in Proteomica: Tecniche di separazione di proteine finalizzate all’analisi proteo
mica. Tecniche di ionizzazione in spettrometria di massa (EI, CI, ESI, MALDI). Derivatizzazione
di molecole polari per la successiva analisi in GC-MS finalizzata all’identificazione di specifiche
modificazioni post traduzionali (es. glicosilazioni). Analizzatori (quadrupolo, trappola ionica, TOF)
e sistemi tandem a più analizzatori. Applicazioni della spettrometria all’analisi proteo mica: PMF,
MS/MS, “sequenza de novo”.
Tecniche Cromatografiche:
1. Preparazione del campione.
2. Purificazione di proteine.
3. Tecniche cromatografiche ed elettroforetiche.
4. TCL , cromatografia liquida e gassosa.
5. Parametri cromatografici.
6. Ottimizzazione di un metodo cromatografico.
Modulo “Microscopie Avanzate”
Microscopia ottica in fluorescenza confocale per la visualizzazione e analisi di sistemi biologici a
livello cellulare e molecolare in 2D e 3D. Rivelazione di singole molecole con enfasi su proteine
fluorescenti (classe GFP; Dsred e fotoattivabili). Metodi F: FRET e FLIM. Sessioni sperimentali su
sistemi Nikon e Leica Microsystems.
Programma dettagliato (in inglese) (opzionale): /
Docenti:
Modulo “Strumentazione in Genomica e Proteomica”: Proff. Gianluca Damonte, Roberro
Ravazzolo, Paola Rivaro
Modulo “Microscopie Avanzate”: Prof. Alberto Diaspro
Link al CV dei docenti:
Prof. Gianluca Damonte http://www.dimes.unige.it/?page_id=93
Prof. Roberro Ravazzolo www.dinogmi.unige.it
Prof.ssa Paola Rivaro www.chimica.unige.it
Prof. Alberto Diaspro http://www.fisica.unige.it/index.php?option=com_peoplebook&Itemid=136
Orario di ricevimento dei docenti: Tutti i giorni su appuntamento, contattare i Docenti via mail:
Modulo “Strumentazione in Genomica e Proteomica”: [email protected]
[email protected] [email protected]
Modulo “Microscopie Avanzate”: [email protected]
Testi di riferimento:
Modulo “Strumentazione in Genomica e Proteomica”:
Prof. Gianluca Damonte: Dispense distribuite dal docente.
Prof. Roberro Ravazzolo:
Prof.ssa Paola Rivaro: Skoog Leary, Chimica Analitica Strumentale, Edises. Materiale fornito a
lezione e/o disponibile su Aulaweb.
Modulo “Microscopie Avanzate”:
Aula web (si/no): SI
Descrizione dei metodi di accertamento: Esame orale volto alla valutazione del grado di
apprendimento dello studente nell’ambito del corso specifico e dei corsi correlati/affini
precedentemente seguiti dallo studente.
Modalità di erogazione (lezioni frontali, laboratorio, a distanza etc.): Lezioni frontali e
laboratori
Propedeuticità: Nessuna
Sede: Genova
Modalità di frequenza (obbligatoria, facoltativa): Obbligatoria
Ore di didattica assistita:
- Lezione: Modulo “Strumentazione in Genomica e Proteomica”: 24 ore – Modulo “Microscopie
Avanzate”: 12 ore
- Laboratorio: Modulo “Microscopie Avanzate”: 8 ore
TITOLO INSEGNAMENTO (in italiano): Protein Engineering
TITOLO INSEGNAMENTO (in inglese): Protein Engineering
CFU: 5 (Corso a Scelta)
Anno di corso/semestre: 2° anno, 2° semestre
Obiettivi formativi (in italiano):
Lo scopo del corso è quello di fornire agli studenti conoscenze teoriche, ma anche pratiche sui
presupposti e le tecniche alla base dell’ingegneria delle proteine e degli anticorpi. Inoltre, una parte
del corso sarà dedicata anche all’approfondimento delle tecniche di sintesi chimica delle proteine.
Per quanto riguarda il modulo di Ingegneria proteica, verranno inizialmente ripresi ed ampliati
alcuni concettivi base relativi alla produzione di proteine ricombinanti. Quindi, verranno analizzati i
diversi approcci per ottenere proteine modificate o ottimizzate per le diverse applicazioni , le
tecniche impiegate e i sistemi di selezione/screening, utilizzando anche esempi dalla letteratura o
impiegati a fini produttivi/commerciali.
Nella sezione del corso riguardante l’ingegneria degli anticorpi verranno forniti elementi sulla
struttura tridimensionale delle immunoglobuline e successivamente saranno affrontate, seguendo
l’ordine cronologico di realizzazione, le diverse tecniche di umanizzazione, di produzione
ricombinante e di phage display degli anticorpi.
Nel modulo di Ingegneria chimica verranno esaminate le principali tecniche per la sintesi chimica
di peptidi e proteine e le applicazioni derivanti da queste tecniche.
Obiettivi formativi (in inglese):
The aim of the course is to provide students with theoretical knowledge but also practical on the
assumptions and techniques underlying the engineering of proteins and antibodies. In addition, part
of the course will be dedicated to the deepening of the techniques of chemical synthesis of proteins.
Regarding the form of Protein engineering, will initially be resumed and expanded some concettivi
base relative to the production of recombinant proteins. Thus, different approaches will be analyzed
in order to obtain modified proteins or optimized for different applications, the techniques used and
the systems of selection / screening, and using examples from the literature or used for production /
commercial.
In the section of the course on the engineering of antibodies will be given with the threedimensional structure of immunoglobulins and will be addressed later, in the chronological order of
creation, the different techniques of humanization and production of recombinant phage display
antibody.
In the form of Chemical Engineering explain the main techniques for the chemical synthesis of
peptides and proteins and applications resulting from these techniques.
Programma dettagliato (in italiano):
Il corso è composto da 3 moduli. Per ciascun modulo, ogni argomento corrisponde a circa 2 ore di
lezione
Modulo 1: Ingegneria proteica (Prof. Michela Tonetti)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Proteine ricombinanti: sistemi di espressione procariotici, eucariotici e in vitro, vantaggi e
svantaggi. Sistemi di espressione in procarioti: caratteristiche dei più comuni vettori
procariotici e dei ceppi batterici per la produzione.
Sistemi di espressione in procarioti: produzione di proteine tossiche o insolubili, espressione
periplasmica, secrezione, espressione di proteine di membrana.
Sistemi di espressione in eucarioti: lieviti, cellule di insetto e di mammifero. Caratteristiche
dei vettori di espressione eucariotici.
Sistemi di espressione “cell-free”. Esempi di tecniche
Proteine ricombinanti: ottimizzazione della produzione, controllo di qualità delle proteine
ricombinanti, purificazione ed uso delle proteine dai corpi di inclusione, proteine glicosilate.
Ingegneria proteica: concetti generali, il “sequence space”, i diversi tipi di approccio (de
novo design, rational design, directed evolution, computational design). Estensione del
codice genetico, uso di amminoacidi non naturali.
Rational design: principi e principali metodi. Mutagenesi sito specifica, domain swapping e
chimeragenesi, saturation mutagenesis. Esempi dalla letteratura.
Il rational design nello studio di proteine. Esempi di proteine terapeutiche modificate
mediante approcci di tipo razionale (muteine dell’insulina, darbepoetin, etanercept),
pegilazione ed altre modifiche covalenti.
Directed evolution: principi, creazione delle library e selezione/screening dei mutanti.
Principali tecniche impiegate: error prone PCR e metodi di shuffling.
Directed evolution: DNA shuffling e tecniche derivate, StEP, synthetic shuffling, directed
evolution e computational design, approcci combinati. Esempi pratici di applicazione della
directed evolution: resistenza al glifosato (Roundup), ottimizzazione di enzimi per
applicazioni industriali.
La selezione e lo screening dei mutanti ottenuti mediante tecniche di directed evolution. Le
tecniche di display: phage, bacterial e yeast display. Ribosome e mRNA display
La GFP come esempio di proteina mutagenizzata mediante approcci combinati. Effetti delle
mutazioni sulle caratteristiche spettrali, correlazioni tra struttura e spettri.
Modulo 2: Ingegneria degli anticorpi (Prof. Fabio Ghiotto)
•
•
•
•
•
La struttura delle immunoglobuline, il dominio immunoglobulinico, regioni CDR e FR,
l’antigen binding site, la regione costante delle immunoglobuline, cenni sulla genetica delle
immunoglobuline.
Cenni sull’uso terapeutico degli anticorpi. Gli anticorpi monoclonali, gli anticorpi chimerici,
tecniche di umanizzazione degli anticorpi: CDR/SR grafting, resurfacing,
superhumanization. Produzione di anticorpi umani in topi transgenici. Immunogenicità degli
anticorpi a scopo terapeutico.
Anticorpi in formati alternativi: frammenti scFv, proteine di fusione scFV-Fc, piattaforme di
display anticorpale, anticorpi ricombinanti derivanti da camelidi (nanobodies).
Espressione di anticorpi in vitro.
Utilizzo di anticorpi ricombinanti in terapie anti-tumorali e in tecniche di imaging.
Modulo 3: Ingegneria Chimica (Prof Enrico Millo)
•
•
•
•
•
IL LEGAME PEPTIDICO E SUA FORMAZIONE
SINTESI DI PEPTIDI IN FASE LIQUIDA
SINTESI DI PEPTIDI IN FASE SOLIDA
o strategie di sintesi tradizionali
o sintesi convergenti
SINTESI DI PROTEINE CON METODICHE CHIMICHE (PEPTIDE LIGATION)
o chemical ligation
o native chemical ligation
o expressed protein ligation
STRATEGIE DI SINTESI PER PROTEINE TRADIZIONALI E MODIFICATE
•
ESEMPI DI SINTESI CHIMICA DI PROTEINE
Programma dettagliato (in inglese) (opzionale): /
Docenti:
Prof. Michela Tonetti, DIMES, Viale Benedetto XV, 1 Genova, Tel 010-353738, e-mail
[email protected]
Prof. Fabio Ghiotto, DIMES, Via De Toni 12, Genova, tel 010-353 e-mail
Prof. Enrico Millo,
Link al CV dei docenti: http://www.dimes.unige.it/?page_id=93
Orario di ricevimento dei docenti:
I docenti del corso ricevono su appuntamento, previo contatto via telefono o e-mail.
Testi di riferimento:
Non sono al momento disponibili testi adeguati. Oltre agli appunti delle lezioni, gli studenti avranno
a disposizione del materiale didattico sotto forma di dispense e pubblicazioni dalla letteratura
scientifica.
Aula web (si/no): SI
Descrizione dei metodi di accertamento:
L’accertamento del raggiungimento degli obiettivi formativi verrà effettuato mediante esami orali.
La data degli appelli verrà concordata con gli studenti.
Modalità di erogazione (lezioni frontali, laboratorio, a distanza etc.): Lezioni frontali
Propedeuticità: Nessuna
Sede: Genova
Modalità di frequenza (obbligatoria, facoltativa): Obbligatoria
Ore di didattica assistita:
- Lezione: 40
MEDICINA RIGENERATIVA TITOLO INSEGNAMENTO: Medicina Rigenerativa e ed Ingegneria dei Tessuti
TITOLO INSEGNAMENTO: Regenerative Medicine and Tissue Engineering
CFU: 5 (Corso a Scelta)
Anno di corso/semestre: 2° anno, 2° semestre
Obiettivi formativi (in Italiano):
Il corso si propone di fornire agli studenti una panoramica dello stato attuale della medicina
rigenerativa e dell’ingegneria dei tessuti, invitandoli ad approfondire tematiche specifiche e a
sviluppare una visione critica.
Obiettivi formativi (in Inglese):
This class will offer a comprehensive view on the current state-of-the-art of regenerative medicine
and tissue engineering to the undergraduate students, asking them to examine in depth specific
topics in order to develop higher criticism skills.
Programma nel dettaglio:
Introduzione alla Medicina Rigenerativa e all’Ingegneria dei Tessuti.
Stato dell’arte della Medicina Rigenerativa degli Epiteli e dei Tessuti Connettivali.
Stato dell’arte della Medicina Rigenerativa del Muscolo Scheletrico e Cardiaco.
Presentazione di 3 argomenti da approfondire e su cui svolgere un elaborato da valutare.
Incontri docente-studente per verificare andamento elaborato.
Presentazione dell’elaborato e discussione.
Docenti: Proff. Rodolfo Quarto, Sveva Bollini, Chiara Gentili
Link al CV dei docenti:
Prof. Rodolfo Quarto: http://www.dimes.unige.it/?page_id=1094
Prof.ssa Sveva Bollini: In preparazione
Prof.ssa Chiara Gentili: http://www.dimes.unige.it/?page_id=1156
Orario di ricevimento dei docenti:
Su appuntamento, contattare i Docenti via mail:
[email protected], [email protected], [email protected]
Testi di riferimento:
Diapositive delle lezioni ed esercitazioni sostenute
Aula web: SI
Descrizione dei metodi di accertamento: Esame scritto
Modalità di erogazione: Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche in laboratorio
Propedeuticità: Nessuna
Sede: Genova
Modalità di frequenza: obbligatoria
Ore di didattica assistita: 40
TITOLO INSEGNAMENTO (in italiano): Basi Molecolari delle Patologie (modulo 1) e Terapia
Genica (modulo 2)
TITOLO INSEGNAMENTO (in inglese): Molecular Bases of Pathologies (module 1) and Gene
Therapy (module 2)
CFU: 5 (2,5 per modulo) (Corso a Scelta)
Anno di corso/semestre: 2° anno, 2° semestre
Obiettivi formativi (in italiano):
Modulo 1
Il corso si propone di focalizzare su alcune patologie come esempi-tipo di alterazioni molecolari che
sono alla base delle malattie, con particolare attenzione ai tumori, e su approcci metodologici mirati
alla comprensione dei meccanismi patogenetici e all'individuazione di nuovi bersagli terapeutici.
Modulo 2
Fare acquisire allo studente una conoscenza dettagliata dei sistemi di trasferimento genico
attualmente in uso in terapia e le modalità con cui si è pervenuti al loro impiego, correlandoli con le
conoscenze di fisiologia, biologia molecolare ed ingegneria genetica; fare acquisire una visione delle
future possibilità di applicazione della terapia genica alla luce delle conoscenze attuali delle
patologie monogeniche di maggiore incidenza.
Obiettivi formativi (in inglese):
Module 1
The course is aimed at exploring specific example pathologies as consequences of molecular
alterations, with particular focus on tumors, and at illustrating novel methodological strategies to
investigate disease pathogenetic mechanisms and identify new therapeutic targets.
Module 2
To allow the student to acquire a detailed knowledge of the current and up-to date gene transfer and
therapy approaches, along with their evolution in clinical settings, and to correlate them with the
current knowledge on physiology, molecular biology and genetic engineering technologies; to allow
the student to envisage possible future applications of gene therapy based on the current knowledge
of monogenic diseases with a relevant clinical prevalence. Programma dettagliato (in italiano): Modulo 1
Concetti generali di patologia molecolare
IL CANCRO
La cancerogenesi come processo microevolutivo. Origine clonale dei tumori. Le mutazioni
somatiche come causa del tumore. Cambiamenti genetici ed epigenetici per l'inattivazione genica.
Instabilità genetica delle cellule cancerose. Modello gerarchico della poplazione tumorale. Il
processo di metastatizzazione. Neoangiogenesi tumorale. Fattori ambientali e cancro: i cancerogeni.
Iniziatori e promotori. Oncogeni e oncosoppressori: l'esempio di Ras, Rb, Myc, p53. Terapie
anticancro e la multidrug resistance.
Le cellule staminali del cancro
IL modello dell'evoluzione clonale per la cancerogenesi. Organizzazione gerarchica del tumore: il
concetto di cellula staminale del tumore (CSC). Caratteristiche delle CSC: marcatori fenotipici,
capacità funzionali-saggi di xenotrapianto, di formazione di sferoidi-colonie, della side popoulation,
dell'attività della ALDH. Le cellule di origine delle CSC. Plasticità del modello delle CSC: il caso
del melanoma. Generazione in vitro di CSC. Strategie terapeutiche antitumorali che bersagliano le
CSC.
Il microambiente tumorale
Le cellule del microambiente tumorale: fibroblasti associati al tumore (CAF), cellule staminali
mesenchimali, macrofagi tumore-associati (TAM) e loro ruolo nel sostegno del tumore e del
processo di metastatizzazione. L'espressione di caveolina-1 nei CAF: funzioni della Cav-1 e
implicazioni della sua down-regolazione. Il “reverse Warburg effect”. Rilevanza prognostica
dell'espressione della Cav-1 nei CAF.
La leucemia mieloide cronica
Patogenesi molecolare della CML: ruolo di Bcr-Abl. Decorso della patologia. Terapie per la CML:
la rivoluzione degli inibitori della tirosino chinasi (TKI). Quali sono e come funzioano i TKI.
Valutazione della risposta alla terapia: parametro ematologico, citogenetico e molecolare. Resistenza
ai TKI: mutazioni in Bcr-Abl e cellule staminali della CML (LSC). Pathways di sopravvivenza nelle
LSC come possibili bersagli di nuove terapie. La rimozione cellulare programmata: segnali “eat
me”, segnali “non eat me” e meccanismi di evasione delle cellule tumorali.
Lecemie acute e nuove strategie terapeutiche: le cellule NK alloreattive
Concetti base del processo emopoietico. Classificazione morfologica e fenotipica delle leucemie
acute, mieloidi e linfoidi. La regolazione dell'attività funzionale delle cellule NK: recettori inibitori e
attivatori. Espressione dei ligandi per recettori NK sulla superficie delle cellule leucemiche:
differenze tra leucemie mieloidi e linfoidi. Il trapianto aploidentico di cellule staminali
emopoietiche. Concetti alla base dell'alloreattività NK: il KIR/HLA-class I mismatch. Correlazione
tra alloreattività NK e attività antileucemica: esperienza in vitro e nella pratica clinica.
LE IMMUNODEFICIENZE
Classificazione e caratteristiche generali delle immunodeficienze.
La sindrome di Wiskott-Aldrich. La polimerizzazione dell'actina come fenomeno associato al
movimento cellulare e alla formazione della sinapsi immunologica. Ruolo della proteina WAS nella
polimerizzazione dell'actina, domini funzionali di WASP. Basi molecolari della malattia: mutazioni
a carico del gene WASP. Correlazione genotipo/fenotipo: fenotipi clinici della malattia. Ruolo di
WASP nell'omeostasi linfocitaria e nell'attività funzionale delle cellule immunitarie. Terapie per la
sindrome di Wiskott-Aldrich.
FIBROSI CISTICA
Mutazioni a carico del gene di CFTR come meccanismo patogenetico della malattia. Caratteristiche
fenotipiche della malattia. Classificazione delle mutazioni di CFTR e loro correlazione con i diversi
gradi di fenotipo. Terapie convenzionali e nuovi approcci terapeutici. Analisi di composti come
possibili farmaci: concetto di correttore e potenziatore.
Modulo 2
I clinical trials basati su approcci di Terapia Genica: principi, esigenze ed ottimizzazioni;
distribuzione geografica, aspetti socio-economici e di sviluppo della tecnologia sanitaria; basi
applicative della terapia genica: principi essenziali e scelta del target terapeutico; criteri di
applicabilità; esempi di applicazione della terapia genica: trattamento di patologie quali la sindrome
da deficienza di Adenosina deaminasi (ADA), la sindrome da immunodeficienza multipla grave
(SCID e X-SCID) e l’epidermolisi bollosa giunzionale (JEB), con risultati delle terapie e
complicazioni da esse derivate.
I vettori virali utilizzati in Terapia Genica: strutture, caratteristiche, impieghi, vantaggi e svantaggi
Herpesviridae: caratteristiche strutturali del capside, delle proteine della matrice e dell’envelope
virale; struttura e caratteristiche funzionali del genoma virale: geni immediate-early (IE),early (E) e
late (L); caratteristiche e funzioni delle proteine virali; ciclo litico e ciclo lisogenico; tropismo e
specificità dei virioni; sistemi di packaging basati sull’impiego di virus helper; sistemi di packaging
helper virus-free; inserimento di transgeni nel vettore virale HSV; ottimizzazione del vettore virale
per sottotipi di cellule target: la funzione delle proteine gB e gD.
Sindbin Virus e Semliki Forest Viruses (SFV): loro impiego come vettori suicidi.
Adenoviridae: struttura del capside; struttura e funzioni del genoma degli Adenoviridae; geni E1, E2,
E3 ed E4; ITR e regione psi (ψ); effetti degli Adenoviridae e proteine coinvolte nella protezione del
virione ai danni dell’ospite; rischi associati all’uso dei vettori adenovirali in terapia genica;
potenziamento dei vettori adenovirali mediante ingegnerizzazione delle proteine del capside (es.
RGB); mediante attività promotore-specifica (promotori di tessuti tumorali); mediante “pro-drug
enzymes”; mediante “vector-spread molecules”; mediante molecole anti-tumorali; studi pre-clinici:
aspetti positivi e negativi dei risultati condotti su modelli murini;
Virus Adeno-associati (AAV): struttura del genoma virale e sua replica; esigenze della fase di
packaging e del virus helper.
Retroviridae: struttura della particella virionica; forma integrata; struttura e caratteristiche rilevanti
del genoma retrovirale e dei prodotti proteici da esso codificati; meccanismo di replica del genoma
retrovirale: generazione e duplicazione delle LTR nella forma integrata; generazione di virus helper
per linee di packaging di vettori retrovirali: strategie e vantaggi; vettori con minigene in “doppia
copia”; linee di packaging per vettori retrovirali: caratteristiche e vantaggi e svantaggi; linee di
packaging con virus helper bi- e tri-partiti; implementazione del tropismo virale dei Retroviridae:
strategie utilizzate.
Lentiviridae: struttura del virione; funzioni delle proteine lentivirali e comparazione con i
Retroviridae; proteine accessorie: struttura, codifica e funzioni di Tet, Rev, Vif, Vpi, Vpx, Vpu e
Nef; struttura del genoma e sequenze necessarie per la loro applicazione nel settore della terapia
genica: cPPT, TAR, RRE; ruolo di Nef/CD4, Tat/NfKb e sequenze SMARs; ottimizzazione dei
vettori lentivirali e problematiche connesse alle linee di packaging; efficacia dei vettori “selfinactivating” (SIN) e dei vettori integrasi-mutati; metodi di recupero dei virioni LV:
ultracentrifugazione, precipitazione con poli-lisina, cromatografia a scambio ionico; comparazione
tra HSV, AV, AAV, Retrovirus e LV; utilizzo di LV per il trasferimento terapeutico di shRNA.
Approcci di Terapia Genica mediante vettori non-virali
Trasferimento genico mediante vettori non-virali; sistemi di iniezione di DNA nudo mediante
inoculo; jet-gas; gene-gun, elettroporazione, sonoporazione, trasferimento idrodinamico, vettori
chimici; esempi terapeutici: caratteristiche del tessuto bersaglio degli approcci di terapia genica
mediante vettori non virali.
Esempi di applicazioni cliniche della Terapia Genica
nelle cellule staminali ematopoietiche; nelle distrofie muscolari; nell’emofilia; nella cura dei tumori;
nel trattamento delle patologie neurodegenerative.
Programma dettagliato (in inglese) (opzionale):
Module 1: /
Module 2
Gene therapy based clinical trials: principles, requirements and optimization: geographical
distribution, social and economical aspects and links to the present status of the sanitary system of
the industrialized countries; essential principles of the gene therapy approaches and choice of the
therapeutic target; application criteria; examples of gene therapy in the clinics: the adenosine
deaminase deficiency syndrome (ADA), the severe combined X-linked immunodeficiency syndrome
(SCID/X-SCID), Junctional Epidermolysis Bullosa (JEB) and their results and adverse events.
Vireal vectors used in gene therapy approaches: structures and characteristics, use, advantages
and/or disadvantages
Herpesviridae:structural characteristics of the viral capsid, of the matrix and envelope proteins;
structure and functions of the viral genome: immediate-early genes (IE), early (E) and late (L) genes;
viral proteins: structure and characteristics; lytic and lysogenic cycles; viral tropism; helper virusbased and helper virus-free packaging systems; transgene insertion in the HSV vector; viral vector
optimization to target cellular sub-types; function of the gB and gD proteins.
Sindbin Virus and Semliki Forest Viruses (SFV): their use as suicidal vectors.
Adenoviridae: capsid structure; functions of the viral genome: E1, E2, and E3 genes, ITR and psi (ψ)
regions; effects of the proteins involved in viral protection; risks associated to the clinical use of
adenoviral-based vectors; exploitation of the adenoviral vectors through genetic engineering of the
capsidic proteins (ex.: RGBs), through promotor-specific activity (ex. tumor-associated promoters),
through “pro-drug zymes”, through “vector-spread molecules”and through anti-tumor molecules;
pre-clinical studies: positive and negative aspects derived from murine models.
Adeno-associated viruses (AAV): structure of the viral genome and its replication; requirements of
the helper virus and of the packaging phase.
Retroviridae: viral particle structure; integrated form; structure of the retroviral genome and of the
coded proteins; viral genome replication: LTR duplication of the integrated form; helper viruses for
packaging cell lines: strategies and advantages; double-copy “minigene” vectors; packaging lines for
retroviral vectors: characteristics, advantages and disadvantages; packaging lines with bi- and
tripartite helper viruses; implementation of viral tropism: used strategies.
Lentiviridae: virion structure; function of the lentiviral proteins and comparison with retroviral
proteins: accessory proteins; structure and functions of Tet, Rev, Vif, Vpi, Vpx, Vpu and Nef;
genome structure and mandatory sequences for gene therapy applications: cPPT, TAR, RRE; role of
Nef/CD4, Tat/NfKb and SMARs sequences; viral vectors optimization and packaging cell lines;
“self-inactivating (SIN)” vectors and “integrase-mutated” vectors; methods of recovery of LV
vectors: ultracentrifugation, poly-lysine-mediate precipitation, ionic-exchange chromatography;
comparison between HSV, AV, AAV, Retroviruses and LV for therapeutic transfer of shRNA.
Non –viral approaches of gene therapy: gene transfer without viral vectors; naked DNA injection
systems; jet-gas systems; gene-gun systems; electroporation; sonoporation; hydrodynamic transfer;
chemical vectors; clinical applications: target tissue characteristics of the non-viral applications in
gene therapy.
Examples of clinical applications of gene therapyin the treatment of : haematopoietic stem cells;
muscular dystrophies; haemophilia; tumors; neurodegenerative diseases.
Docenti:
Modulo 1: Prof.ssa Grazia Maria Spaggiari
Modulo 2: Prof. Paolo Giannoni
Link al CV dei docenti:
Prof.ssa Grazia Maria Spaggiari http://www.dimes.unige.it/?page_id=93
Prof. Paolo Giannoni In preparazione
Orario di ricevimento dei docenti:
Modulo 1: da concordare col docente ([email protected])
Modulo 2: da concordare col docente ([email protected])
Testi di riferimento:
Modulo 1: Alberts et al. “Biologia molecolare della cellula”, Zanichelli ; Mendelsohn et al., “The
molecular basis of cancer”, Elsevier; Robbins e Cotran, “Le basi patologiche delle malattie”,
Elsevier.
Modulo 2: Giacca M., “Terapia Genica”, Springer-Verlag Italia s.r.l.; Cann A.J., “Elementi di
virologia molecolare”, Casa Editrice Ambrosiana.
Aula web (si/no): NO
Descrizione dei metodi di accertamento:
Modulo 1 e 2: lo studente viene esaminato oralmente; vengono poste almeno 3 domande relative ad
argomenti inerenti il modulo, a difficoltà crescente; il primo quesito è sempre relativo a un
argomento generale; ciò consente allo studente di rispondere anche se la preparazione risultasse
essere solo mnemonica. La seconda domanda prevede invece una valutazione più specifica di alcuni
aspetti dell'argomento, e la risposta implica, pertanto, un comprensione organizzata dei
fenomeni/meccanismi relativi a quello specifico argomento (es. a una patologia o all'utilizzo di
particolari proteine/vettori); la terza domanda prevede che lo studente faccia correlazioni tra
argomenti differenti del corso, ricercandone e presentandone in maniera autonoma e critica
similitudini, differenze, analogie, vantaggi e/o svantaggi, in modo da dimostrare una capacità di
visione più estesa. L’esame può proseguire con ulteriori domande di approfondimento, in particolare
volte ad accertare la propositività dello studente nel fornire soluzioni adeguate a possibili condizioni
patologiche trattabili con approcci diversi. Tale aspetto viene enfatizzato durante il corso fornendo
agli studenti numerosi esempi di applicazioni cliniche che vengono discussi coralmente ed in
maniera critica.
Gli studenti sono poi invitati a presentare, anche se in maniera facoltativa, due lavori scientifici (uno
per modulo) mediante revisione critica e presentazione che viene fatta collegialmente con tutti i
docenti e gli altri studenti del corso, in modo da esercitarsi ad una interpretazione della letteratura
corrente, ed in modo da utilizzare le conoscenze acquisiste durante il corso per motivare/criticare
opportunamente le scelte compiute ed i risultati ottenuti dagli autori. Tale presentazione non è
obbligatoria ma completa la preparazione dello studente e consente di incrementare la votazione
complessiva d’esame se giudicata positivamente dai docenti.
Modalità di erogazione (lezioni frontali, laboratorio, a distanza etc.): Lezioni frontali
Propedeuticità: Nessuna
Sede: Genova
Modalità di frequenza (obbligatoria, facoltativa): Obbligatoria
Ore di didattica assistita:
- Lezione: 18 ore per modulo
- Altro: 2 ore per modulo, presentazione di lavori scientifici da parte degli studenti; ogni studente
presenta 2 lavori, uno per ciascun modulo, inerenti alle tematiche di insegnamento; viene poi
effettuata una discussione critica collettiva. FARMACEUTICO TITOLO INSEGNAMENTO (in italiano): Farmacogenomica e Farmacogenetica e Metabolismo
dei Farmaci
TITOLO INSEGNAMENTO (in inglese): Pharmacogenomics and Pharmacogenetics and Drugs
Metabolism
CFU: 5 (di cui 2,5 per il modulo di “Farmacogenomica e Farmacogenetica” e 2,5 per il modulo di
“Metabolismo dei Farmaci”) (Corso a Scelta)
Anno di corso/semestre: 2° anno, 2° semestre
Obiettivi formativi (in italiano):
Lo scopo del corso è quello di fornire agli studenti le conoscenze su aspetti basilari della
Famacogenomica e Farmacogenetica. Particolare attenzione sarà dedicata allo studio dei
meccanismi cellulari e molecolari che stanno alla base delle variate risposte farmacologiche e
terapeutiche. Saranno riportati i più recenti sviluppi ottenuti della disciplina e le possibili
applicazioni future.
Inoltre il corso tratta di tutti i concetti fondamentali che riguardano il metabolismo di sostanze di
interesse farmaceutico e di altri xenobiotici. Oltre a descrivere le reazioni di Fase I e Fase II che
l’organismo impiega per trasformare chimicamente i vari farmaci, il corso tratta anche le principali
tecnologie usate per studiare il metabolismo, nonché i sistemi enzimatici coinvolti.
Obiettivi formativi (in inglese):
The aim of this course is to provide the students with knowledge about fundamental concepts of
Pharmacogenomics and Pharmacogenetics. The course will be focused to study the changes of
cellular and molecular mechanisms which regulate the different pharmacological responses.
Moreover, the course will underline the most interesting progresses in therapy due to this new
potential pharmacological approach and the possible future therapeutic development.
The course also provides the students with the basic concepts of the metabolism of drugs and other
xenobiotics. Besides describing the main Phase 1 and 2 reactions involved, the course deal with the
latest in vivo and in vitro technologies used to study drug metabolism, as well as the main
enzymatic systems responsible for these biotransformations.
Programma dettagliato (in italiano):
Modulo “Farmacogenomica e Farmacogenetica”
Aspetti generali e definizioni. Variabilità individuale, variabilità genetica, polimorfismi.
Polimorfismi dei targets. Ruolo dei citocromi. Farmacogenetica nelle demenze. Farmacogenetica in
ambito clinico problemi ed efficacia. Problemi etici. Farmacogenetica e sostanze di abuso.
Farmacogenetica e tabagismo. Terapie e prevenzione. Aderenze ai protocolli.
Modulo “Metabolismo dei Farmaci”
Introduzione e cenni storici. Reazioni Metaboliche di Fase I e Fase II. Aspetti stereochimici del
metabolismo dei farmaci. Fattori influenzanti il metabolismo dei farmaci. Siti d’azione del
metabolismo dei farmaci. I sistemi enzimatici coinvolti nel metabolismo dei farmaci. Il Citocromo
P450. Isoenzimi del Citocromo P450. Nomenclatura internazionale dei Citocromi P450. Principali
forme isoenzimatiche e loro substrati. Determinazione della specificità di substrato. Ciclo catalitico
del Citocromo P450. Reazioni di ossidazione (con esempi). Reazioni di riduzione (con esempi).
Reazioni di idrolisi (con esempi). Reazioni di coniugazione. Glucuronazione (con esempi).
Solfatazione (con esempi). Coniugazione con AA (con esempi). Acetilazione (con esempi).
Coniugazione con Glutatione (con esempi). Metilazione (con esempi).
Programma dettagliato (in inglese) (opzionale): /
Docenti:
Modulo “Farmacogenomica, Farmacogenetica”: Prof.ssa Anna Maria Pittaluga
Modulo “Metabolismo dei Farmaci”: Prof. Grossi Giancarlo
Link al CV dei docenti: www.difar.unige.it
Orario di ricevimento dei docenti: Tutti i giorni previo appuntamento telefonico:
Prof.ssa Anna Maria Pittaluga– Tel. 0103532049
Prof. Giancarlo Grossi – Tel. 0103538356
Testi di riferimento: I Docenti consegnano il materiale su cui studiare agli studenti.
Aula web (si/no): SI
Descrizione dei metodi di accertamento:
La verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze da parte dello studente si basa su un esame
scritto e orale approfondito, in presenza di almeno due docenti, che verte sul programma svolto
durante le lezioni frontali dei due moduli e che ha una durata media di 60-100 min.
Modalità di erogazione (lezioni frontali, laboratorio, a distanza etc.): Lezioni frontali
Propedeuticità: Nessuna
Sede: Genova
Modalità di frequenza (obbligatoria, facoltativa): Obbligatoria (frequenza di almeno i due terzi
dell'insegnamento) per entrambi i moduli.
Ore di didattica assistita:
- Lezione: 40 ore (20 ore per ciascun modulo)
TITOLO INSEGNAMENTO (in italiano): Tecniche computazionali di progettazione e sintesi dei
farmaci
TITOLO INSEGNAMENTO (in inglese): Computational techniques for drug design and
synthesis
CFU: 5 (Corso a Scelta)
Anno di corso/semestre: 2° anno, 2° semestre
Obiettivi formativi (in italiano):
Il corso si propone di fornire le principali nozioni di progettazione e sintesi dei farmaci, con
particolare riferimento a metodologie innovative.
Obiettivi formativi (in inglese):
The course aims to provide key concepts of drug design and synthesis, with particular reference to
innovative methodologies.
Programma dettagliato (in italiano):
La chimica farmaceutica oggi; Il processo di Drug Discovery; Gli enzimi; Interazione farmacorecettore; Meccanismo d’azione dei farmaci; Il prototipo; Identificazione del prototipo; Definizione
di farmacoforo; Definizione di lead; Modificazione del lead; Concetto di isosteria; Molecular
Modelling: concetti di base; Esempi di progettazione razionale; Nuove tecniche in chimica
farmaceutica: Chimica in fase solida, Sintesi di peptidi, Chimica combinatoriale (combichem),
Click chemistry; Cenni sui farmaci biotecnologici; Generalita' sulle tecniche CADD; Tecniche
protein based; Interazioni R/L; Docking: finalita' e modalita' operative; Simulazione di docking su
complessi HIV-1 RT / NNRTI; tecniche di ligand-based drug design; sviluppo di una mappa
farmacoforica.
Programma dettagliato (in inglese) (opzionale): /
Docenti: Proff. Olga Bruno, Prof. Andrea Spallarossa
Link al CV dei docenti: www.difar.unige.it
Orario di ricevimento dei docenti:
Su appuntamento, contattare i Docenti via mail:
[email protected], [email protected] Testi di riferimento:
1) F. Gualtieri, M.N. Romanelli, E. Teodori - Chimica farmaceutica dei recettori: disegno e
sintesi di farmaci e mezzi di indagine farmacologica - CLUEB, Bologna,1997.
2) Wermuth C.G., The Practice of Medicinal Chemistry, Academic Press, San Diego, CA.
3) G.L. Patrik - Introduzione alla Chimica Farmaceutica - Ed. S.E.S. Napoli.
Aula web (si/no): NO
Descrizione dei metodi di accertamento:
L’esame consta in un colloquio orale della durata di circa mezz’ora che ha lo scopo di accertare se
la maggior parte degli argomenti del corso trattati a lezione sono stati recepiti dallo studente, con
particolare riguardo alle nozioni di base di progettazione e sintesi dei farmaci.
Modalità di erogazione (lezioni frontali, laboratorio, a distanza etc.): Lezioni frontali
Propedeuticità: Nessuna
Sede: Genova
Modalità di frequenza (obbligatoria, facoltativa): Obbligatoria
Ore di didattica assistita:
- Lezione: 40 ore
NEUROSCIENZE TITOLO INSEGNAMENTO (in italiano): Neurofisiologia e Neurobiologia (Neuroscienze
Cellulari e Molecolari)
TITOLO INSEGNAMENTO (in inglese): Neurophysiology and Neurobiology (Cellular and
Molecular Neuroscience)
CFU: 5 (di cui 4cfu di lezioni frontali e 1cfu di lab) (Corso a Scelta)
Anno di corso/semestre: 2° anno, 2° semestre
Obiettivi formativi (in italiano):
Attraverso le lezioni frontali lo studente dovrà acquisire una conoscenza generale del
funzionamento del sistema nervoso e specialistica sui meccanismi cellulari e molecolari che
governano la neurotrasmissione. In particolare verranno forniti approfondite informazioni sulla
generazione e conduzione del segnale elettrico nel singolo neurone per poi passare alla complessità
delle reti neuronali. Inoltre verranno approfonditi i meccanismi alla base della plasticità sinaptica,
fenomeno fondamentale per poter comprendere dal punto di vista meccanicistico le funzione
cognitive complesse quali la memoria e l’apprendimento. L’attività di laboratorio, che seguirà alle
lezioni frontali permettera’ di acquisire i principi generali delle principali tecniche di indagine
funzionale usate in neuroscienze cellulari (elettrofisiologia, analisi funzionale di immagini e cellule
staminali). Saranno fornite non solo conoscenze teoriche e pratiche delle diverse metodologie in
uso, ma anche un’analisi critica dei limiti, vantaggi, difficoltà sperimentali, campi di applicazione e
potenziali sviluppi futuri offerti dal progredire della tecnologia, per ciascuna tecnica affrontata.
Obiettivi formativi (in inglese):
The purpose of the course is to give an overview of molecular mechanisms that regulate functions
in the nervous system with special emphasis on cellular and molecular mechanisms that regulate
neurotransmission. In particular students receive a detailed information on the generation and
propagation of the electrical signal in single neurons up to the complexity of the firing of neurons in
network. Mechanisms underlying synaptic plasticity, fundamental for higher function such as
learning and memory, will be analyzed in details. Moreover thank to the laboratory-activity, the
students will learn basic skills in vitro electrophysiology (extra- and intracellular recordings, patchclamp) and functional imaging techniques. Different recording modes and their advantages and
disadvantages will be dealt with. By the end of the course the students should be able to understand
the possibilities and the limitations of the different in vitro experimental approaches in neuroscience
research and to design experiments in which the techniques are applied in a relevant manner to deal
with up to date neurophysiology questions.
Programma dettagliato (in italiano):
Lezioni frontali. Componenti del SN: i neuroni e le cellule gliali – La barriera emato-encefalica –
Sintesi traffico e degradazione delle proteine del SNC – Trasporto assonale – Generazione e
sopravvivenza delle cellule del SNC – Fattori neurotrofici – Formazione e rigenerazione delle
sinapsi - Proprietà elettriche passive ed attive dei neuroni: canali ionici - Trasmissione ed
integrazione sinaptica: neurotrasmettitori, meccanismo di rilascio del neurotrasmettitore, recettori
postsinaptici – Plasticità sinaptica a breve e lungo termine e plasticità omeostatica- Sviluppo e
gerarchia del SN – Apprendimento e Memoria – Cenni di epilettogenesi ed epilessia.
Laboratorio. Neuroni e reti neuronali: modelli biofisici – Registrazioni Extracellulari ed
Intracellulari – Tecnica del Patch-Clamp: misurazioni in Voltage-Clamp e Current-Clamp –
Registrazione di correnti di singolo canale – Tecniche per lo studio dei processi di eso-endocitosi:
analisi funzionale di immagini, sonde fluorescenti sensibile al pH, al Ca2+, al voltaggio; misure di
capacità di membrana; tecniche amperometriche – Matrici di MicroElettrodi ed interfaccie
neuroelettroniche di nuova generazione.
Programma dettagliato (in inglese) (opzionale):
Front lessons: basic organization and cell types in the nervous system; Blood Brain Barrier:
Synthesis anf trafficking of proteins in neurons: Axonal Transport; Generation and maintenance of
cells in the CNS; Neurotrophic factors and their receptors; synapse formation, maintenance and
function; electrical signaling generation and propagation in neurons; ion channels and transporters;
Synaptic transmission and integration od synaptic signaling; Neurotransmitters and their receptors;
plasticity in the nervous system; SYanptic Plasticity; Neurogenesis and neuronal differentiation;
Patterning of the nervous system; Learning and Memory:: Epileptogenesis.
Laboratories. Biophysical model for neurons and neuronal network –Extracellular and Intracellular
recordings –Patch-Clamp: Voltage-Clamp and Current-Clamp measures – Sinbglke channel
recordings – Fluorescent imaging for Calcium signal, exo-endocytosis, valtage sensitive dyes,
Capacitance and amperometric measures.
Docenti: Proff. Pietro Baldelli, Anna Fassio
Link al CV dei docenti:
Proff. Pietro Baldelli e Anna Fassio http://www.dimes.unige.it/?page_id=93
Orario di ricevimento dei docenti: Sempre disponibili previo appuntamento da concordare via
mail: [email protected] [email protected]
Testi di riferimento:
- Fondamenti di Neuroscienze, Kandel, CEA;
- Neuroscienze, Purves, Zanichelli
- Neuroscienze Zigmond, EDISES
Aula web (si/no): SI - Tutto il materiale presentato a lezione è disponibile su aula web unitamente a
vari documenti di approfondimento.
Descrizione dei metodi di accertamento:
Colloquio con i tre docenti del corso in cui viene valuta la capacità dello studente di riferire sulle
tematiche di neuroscienze trattate a lezione. Viene inoltre valutata la capacità dello studente di
eseguire una analisi critica di una pubblicazione scientifica proposta dal docente (15 gg prima
dell’appello), relativamente a: metodologie/tecniche impiegate e risultati ottenuti.
Modalità di erogazione (lezioni frontali, laboratorio, a distanza etc.):
Lezioni frontali e Laboratorio
Propedeuticità: Nessuna
Sede: Genova
Modalità di frequenza (obbligatoria, facoltativa): Obbligatoria
Ore di didattica assistita:
- Lezione: 32
- Laboratorio: 16
TITOLO INSEGNAMENTO (in italiano): Neurofarmacologia e Neuropatologia.
TITOLO INSEGNAMENTO (in inglese): Neuropharmacology and Neuropathology.
CFU: 5 (2,5 CFU per ciascun modulo) (Corso a Scelta)
Modulo “Neurofarmacologia”: 2,5 CFU; Modulo “Neuropatologia”: 2,5 CFU
Anno di corso/semestre: 2° anno, 2° semestre
Obiettivi formativi (in italiano):
Modulo “Neurofarmacologia”: Lo scopo del corso è quello di fornire agli studenti le conoscenze
sulle principali classi di farmaci attivi sul sistema nervoso centrale. Il corso si focalizzerà ad
esaminare le principali strategie farmacologiche focalizzandosi sulla modulazione delle risposte
neurochimiche e comportamentali in grado di intervenire sui meccanismi patogenetici delle
principali patologie del SNC.
Modulo “Neuropatologia”: Il corso si focalizza sulle alterazioni neuropatologiche di alcune fra le
più comuni patologie del sistema nervoso, come la sclerosi multipla e il morbo di Parkinson. Inoltre
vengono presentati e discussi i modelli animali di malattia come l’encefalite allergica sperimentale,
e i modelli di neuropatia geneticamente determinata.
Obiettivi formativi (in inglese):
Modulo “Neuropharmacology”: The aim of the course is to provide the students with knowledge
about the main classes of drugs active on the central nervous system. The course will be focused to
study the main pharmacological strategies used to modulate the neurochemical and behavioral
responses to affect the pathogenetic mechanisms of the main CNS diseases.
Modulo “Neuropathology”: The aim of the course is to present and discuss the neuropathology of
the most common disorders of the central nervous system , such as Parkinson disease and Multiple
Sclerosis. Moreover the animal models of multiple sclerosis, experimental allergic
encephalomyelitis and of genetic disease of the peripheral nervous system will be presented.
Programma dettagliato (in italiano):
Modulo “Neurofarmacologia”: 1) Farmacologia del sistema nocicettivo (4 ore). 2) Farmacologia
del sistema cannabinoide endogeno: applicazioni terapeutiche di cannabinoidi naturali e sintetici (2
ore). 3) Terapia farmacologica della depressione (3 ore). 4) Terapia farmacologica dell’ansia:
farmaci ansiolitici, sedativi ed ipnotici (2 ore). 5) Controllo farmacologico delle psicosi: farmaci
antipsicotici tipici ed atipici (2 ore). 6) Controllo farmacologico della generazione di attività
elettrica epilettogena nel sistema nervoso centrale: i farmaci anticonvulsivanti (2 ore). 7)
Farmacologia del morbo di Parkinson (2 ore). 8) Farmacologia delle demenze ed in particolare il
trattamento della malattia di Alzheimer (3 ore). 9) Farmacologia delle malattie prioniche (2 ore).
10) Farmacologia delle dipendenze da farmaci d’abuso (2 ore).
Modulo “Neuropatologia”: 1) Neuropatologia e clinica della Sclerosi multipla; 2) Neuropatologia
e Clinica della malattia di Parkinson e dei Parkinsonismi; 3) L’encefalite allergica sperimentale; 4)
I modelli animali di malattia di Charcot Marie Tooth.
Programma dettagliato (in inglese) (opzionale): /
Docenti:
Modulo “Neurofarmacologia”: Proff. Tullio Florio, Stefano Thellung
Modulo “Neuropatologia”: Proff. Giovanni Abbruzzese, Gianluigi Mancardi, Antonio Uccelli
Link al CV dei docenti:
Modulo “Neurofarmacologia”: http://www.dimi.unige.it/Docenti.aspx Modulo “Neuropatologia”: www.dinogmi.unige.it
Orario di ricevimento dei docenti:
Modulo “Neurofarmacologia”: Tutti i giorni previo appuntamento da effettuare via mail:
[email protected] [email protected]
Modulo “Neuropatologia”: Tutti i giorni previo appuntamento da effettuare via mail:
[email protected] [email protected] [email protected]
Testi di riferimento:
Modulo “Neurofarmacologia”: S. Govoni, L. Frattola, G. Racagni, E. Smeraldi.
Neuropsicofarmacologia. UTET; F. Clementi, G. Fumagalli. Farmacologia generale e molecolare.
UTET.
Modulo “Neuropatologia”: Neurologia, Fazio Loeb.
Aula web (si/no): SI
Descrizione dei metodi di accertamento:
L’esame verrà svolto mediante colloquio in cui saranno accertate le conoscenze acquisite dagli
studenti. Particolare importanza sarà data alla loro capacità di esporre in modo sintetico ed
esaustivo gli argomenti affrontati. Saranno disponibili 3 appelli di esame per la sessione Invernale e
4 appelli per la sessione estiva. Sarà possibile stabilire appelli al di fuori dei periodi indicati previa
accordi con i docenti.
Modalità di erogazione (lezioni frontali, laboratorio, a distanza etc.): Lezioni frontali.
Propedeuticità: Nessuna
Sede: Genova
Modalità di frequenza (obbligatoria, facoltativa): Obbligatoria
Ore di didattica assistita:
- Lezione: 40 ore (20 ore per ciascun modulo)