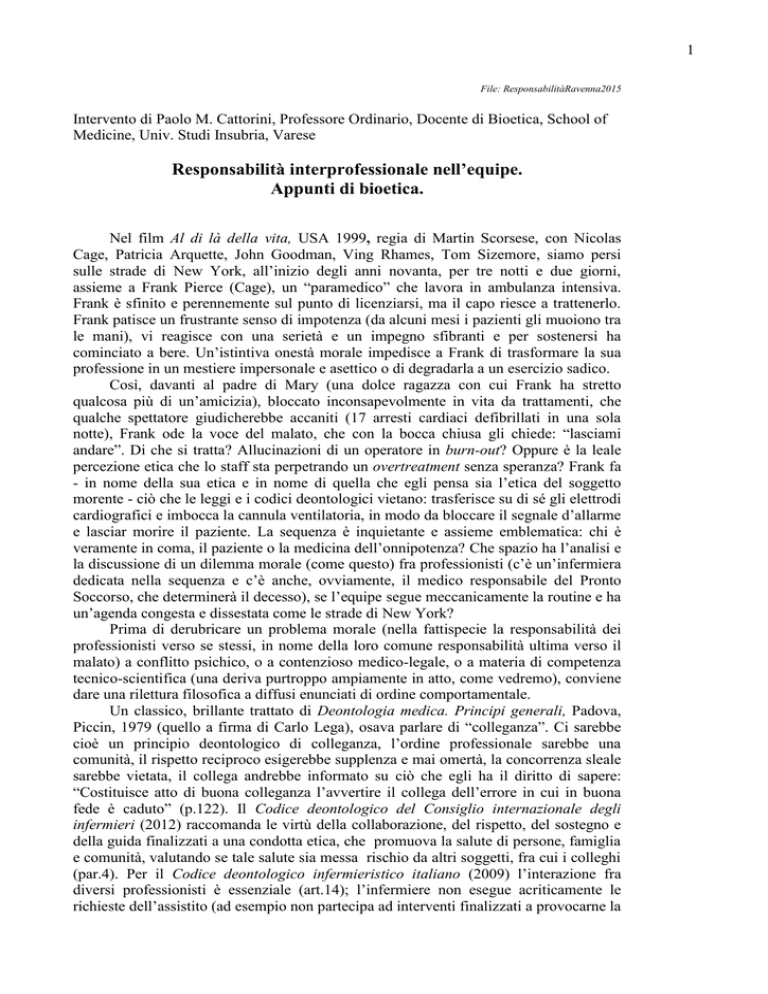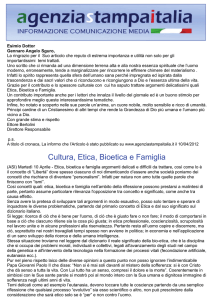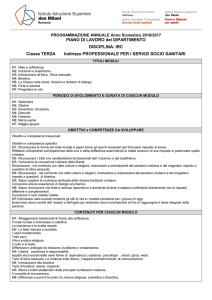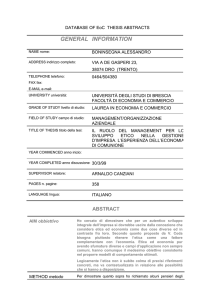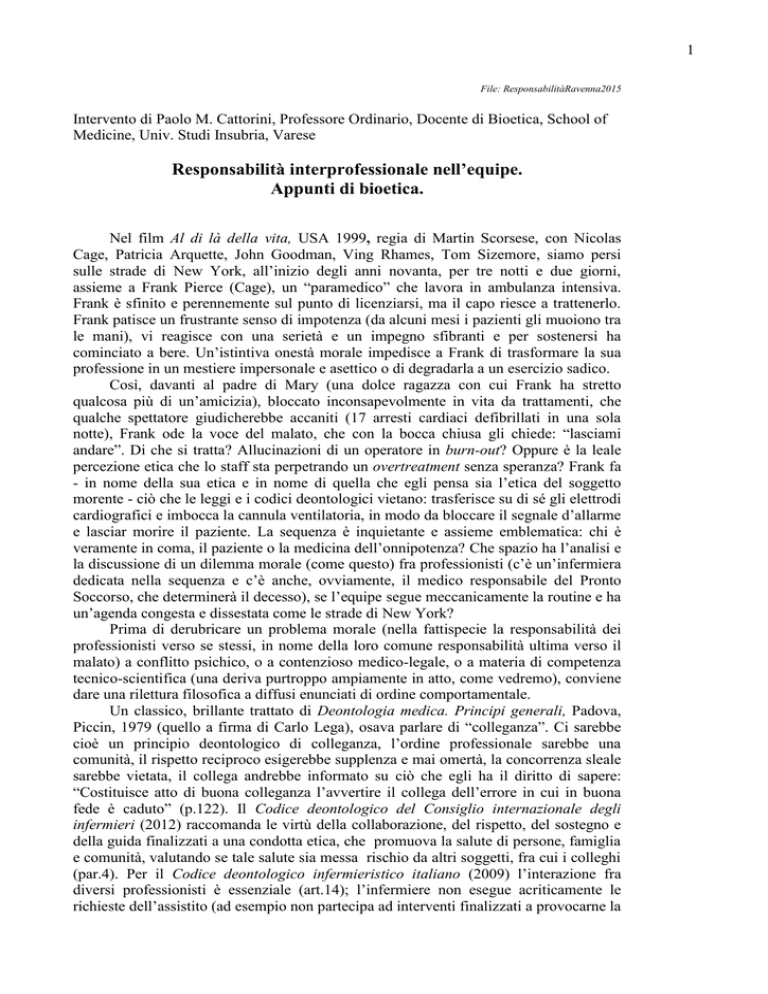
1
File: ResponsabilitàRavenna2015
Intervento di Paolo M. Cattorini, Professore Ordinario, Docente di Bioetica, School of
Medicine, Univ. Studi Insubria, Varese
Responsabilità interprofessionale nell’equipe.
Appunti di bioetica.
Nel film Al di là della vita, USA 1999, regia di Martin Scorsese, con Nicolas
Cage, Patricia Arquette, John Goodman, Ving Rhames, Tom Sizemore, siamo persi
sulle strade di New York, all’inizio degli anni novanta, per tre notti e due giorni,
assieme a Frank Pierce (Cage), un “paramedico” che lavora in ambulanza intensiva.
Frank è sfinito e perennemente sul punto di licenziarsi, ma il capo riesce a trattenerlo.
Frank patisce un frustrante senso di impotenza (da alcuni mesi i pazienti gli muoiono tra
le mani), vi reagisce con una serietà e un impegno sfibranti e per sostenersi ha
cominciato a bere. Un’istintiva onestà morale impedisce a Frank di trasformare la sua
professione in un mestiere impersonale e asettico o di degradarla a un esercizio sadico.
Così, davanti al padre di Mary (una dolce ragazza con cui Frank ha stretto
qualcosa più di un’amicizia), bloccato inconsapevolmente in vita da trattamenti, che
qualche spettatore giudicherebbe accaniti (17 arresti cardiaci defibrillati in una sola
notte), Frank ode la voce del malato, che con la bocca chiusa gli chiede: “lasciami
andare”. Di che si tratta? Allucinazioni di un operatore in burn-out? Oppure è la leale
percezione etica che lo staff sta perpetrando un overtreatment senza speranza? Frank fa
- in nome della sua etica e in nome di quella che egli pensa sia l’etica del soggetto
morente - ciò che le leggi e i codici deontologici vietano: trasferisce su di sé gli elettrodi
cardiografici e imbocca la cannula ventilatoria, in modo da bloccare il segnale d’allarme
e lasciar morire il paziente. La sequenza è inquietante e assieme emblematica: chi è
veramente in coma, il paziente o la medicina dell’onnipotenza? Che spazio ha l’analisi e
la discussione di un dilemma morale (come questo) fra professionisti (c’è un’infermiera
dedicata nella sequenza e c’è anche, ovviamente, il medico responsabile del Pronto
Soccorso, che determinerà il decesso), se l’equipe segue meccanicamente la routine e ha
un’agenda congesta e dissestata come le strade di New York?
Prima di derubricare un problema morale (nella fattispecie la responsabilità dei
professionisti verso se stessi, in nome della loro comune responsabilità ultima verso il
malato) a conflitto psichico, o a contenzioso medico-legale, o a materia di competenza
tecnico-scientifica (una deriva purtroppo ampiamente in atto, come vedremo), conviene
dare una rilettura filosofica a diffusi enunciati di ordine comportamentale.
Un classico, brillante trattato di Deontologia medica. Principi generali, Padova,
Piccin, 1979 (quello a firma di Carlo Lega), osava parlare di “colleganza”. Ci sarebbe
cioè un principio deontologico di colleganza, l’ordine professionale sarebbe una
comunità, il rispetto reciproco esigerebbe supplenza e mai omertà, la concorrenza sleale
sarebbe vietata, il collega andrebbe informato su ciò che egli ha il diritto di sapere:
“Costituisce atto di buona colleganza l’avvertire il collega dell’errore in cui in buona
fede è caduto” (p.122). Il Codice deontologico del Consiglio internazionale degli
infermieri (2012) raccomanda le virtù della collaborazione, del rispetto, del sostegno e
della guida finalizzati a una condotta etica, che promuova la salute di persone, famiglia
e comunità, valutando se tale salute sia messa rischio da altri soggetti, fra cui i colleghi
(par.4). Per il Codice deontologico infermieristico italiano (2009) l’interazione fra
diversi professionisti è essenziale (art.14); l’infermiere non esegue acriticamente le
richieste dell’assistito (ad esempio non partecipa ad interventi finalizzati a provocarne la
2
morte: art. 38) e segnala al proprio Collegio ogni abuso o condotta contraria alla
deontologia (art.43). C’è un versante attivo in questa disposizione alla cura:
“L’infermiere si attiva per l’analisi dei dilemmi etici vissuti nell’operatività quotidiana e promuove
il ricorso alla consulenza etica, anche al fine di contribuire all’approfondimento della riflessione bioetica”
(art.16).
Insomma l’infermiere non si fa “strumento” esecutivo di nessuno (collega,
direttore, utente che sia), ma vive il suo impegno di cura-della-vita/salute, portando allo
scoperto le interrogazioni etiche, in cui egli s’imbatte.
Il Codice italiano di Deontologia Medica del 2014 toglie all’art. 17 l’espressione
“eutanasia” (spesso fonte di equivoci, effettivamente), ma conserva la tradizionale
condanna ippocratica; encomia all’art. 58 la solidarietà, la collaborazione e rispetto tra
colleghi e ne estende l’oggetto anche alle competenze economiche di altri medici (il che
ha sollevato controversie: la finalità di cura dovrebbe prevalere su tutte le altre funzioni
organizzative: “a ciascuno il suo” ci verrebbe da dire); invita a comunicare all’Ordine
(art. 64) le infrazioni alle regole di corretta collaborazione e di salvaguardia delle
specifiche competenze (sarebbe interessante - commentiamo - che la FNOMCeO ci
aggiornasse sulla quantità e qualità di tali informazioni, pro bono societatis); esige
l’integrazione collaborativa interprofessionale (art. 66) e sollecita una corrispondente
formazione “mista” (ma non c’è traccia di “consulenza etica” e la parola “etica”, che
qualifica la formazione obbligatoria permanente nel precedente art. 19 del 2006, è
smarrita tra le competenze “non tecniche” nell’attuale art. 19 – se non leggiamo o
interpretiamo male).
Abbiamo menzionato la questione dell’eutanasia, quale tema deontologico che i Codici affrontano
(in certi contesti) univocamente, a fronte di un dibattito etico che è invece estremamente aperto. Abbiamo
anche accennato alle riserve sollevate da alcune organizzazioni mediche. Ebbene, la protesta di alcuni
Ordini provinciali ha riguardato altresì la versione aggiornata degli articoli 3 e 6. Ampliare le proprie
competenze in riferimento al “le innovazioni organizzative e gestionali in sanità” e “perseguire l’uso
ottimale delle risorse pubbliche e private” è parso a taluni una formulazione ambigua, che potrebbe
esporre il professionista alla dipendenza da direttive burocratiche, progetti aziendalisti, obiettivi
organizzativi privilegiati dai servizi sanitari regionali. L’inserimento all’art.13 dell’ “Autorità
competente”, quale soggetto valutante l’idoneità della documentazione scientifico-clinica necessaria per
adottare pratiche diagnostico-terapeutiche, ha alimentato le preoccupazioni di una possibile sudditanza
alle delibere di ordine giuridico1. La realtà internazionale, in effetti, è sempre più ricca e imprevedibile
della fantasia, come hanno documentato zelanti circolari di alcuni funzionari sanitari, che invitavano a
non eseguire certe sentenze della Magistratura. In simili incertezze normative, spesso dovute a
insoddisfacenti o ambigue o intempestive deliberazioni del potere legislativo, il peso di un Codice
deontologico risulterà sempre più decisivo, dal punto di vista etico-giuridico.
Il ponte tra l’etica e la deontologia dovrebbe esser rappresentato, come si sa, dal
Giuramento e in effetti quello medico-professionale del 2014 impone di “ispirare la
soluzione di ogni divergenza di opinioni al reciproco rispetto” (è il quartultimo punto,
mentre 8 anni prima c’era scritto, al quintultimo punto: “rispettare i colleghi anche in
caso di contrasto di opinioni”). Che cosa vogliano dire però queste sacrosante parole,
così rapidamente e perentoriamente incensate dall’assenso unanime della retorica
mediatica sul “rispetto” (una delle parole più abusate, logorate e consunte del lessico
sociopolitico), e così invece dilaniate dal legittimo dibattito pluralistico nelle nostre
società secolari, ciò è molto meno chiaro.
Ne consegue che, se i codici di condotta fossero scritti con l’ingenua, pericolosa
spontaneità di chi patisce la “sindrome di Leonardo da Vinci” (una patologia che il
medico-legale professor Angelo Fiori aveva diagnosticato attraverso i sintomi
1
Cfr. la rassegna stampa curata dall’OMeC Milano, 24.7.14.
3
d’onniscienza di certi sanitari), non ci resterebbe che ripetere sconsolatamente quanto
avevamo esposto in un convegno sulla consulenza etica, svoltosi nel 2105 presso la
nostra Università varesina:
«Il misconoscimento dell’attitudine, perizia e discorsività proprie dell’applicazione etica […] ha
da un lato generato un riduzionismo epistemologico imbarazzante (per cui la clinical ethics non sarebbe
“nient’altro che” una preesistente disciplina - come la clinica medica o la storia della filosofia - adattata o
riciclata a basso prezzo in confusi territori interstiziali), e ha dall’altro prodotto e disseminato una fauna di
improbabili cultori, che - immagino - abbia evocato in ciascuno di noi pensieri simili a quelli freudiani
sullo psicoanalista “selvaggio”»2
Non ci limitavamo però al lamento.
«Da qualche decennio suggeriamo che i grandi ospedali e istituti di ricerca si dotino di strutture di
questo tipo [servizi/dipartimenti di bioetica clinica], svolgenti le sei funzioni tradizionalmente ritenute
prioritarie dalla comunità scientifica: offerta di consulenza su casi o situazioni e sostegno nella redazione
di linee-guida per decisioni interne o per un’argomentata divulgazione pubblica della mission istituzionale
e dei conseguenti criteri allocativi; revisione etica dei protocolli di ricerca clinico-farmacologici; raccolta
sistematica di documenti etico-deontologici internazionali (riviste, libri, enciclopedie, commentari a
sentenze…); raccordo con dipartimenti e studiosi di etica operanti a diversi livelli (istituzionale,
regionale, nazionale, sovranazionale); sinergia con i compiti dei comitati d’etica (i due organismi hanno
bisogno l’uno dell’altro, ma non sono identici né scambiabili a piacere e un loro confronto dialettico
sarebbe, in molti casi, altamente produttivo); infine, ideazione, organizzazione e svolgimento di una
formazione permanente specifica per staff, singoli operatori sanitari o amministrativi, organismi e
commissioni miste (aventi cioè tra i loro membri sia specialisti che profani)»3.
Diversi fattori etici alimentano l’esigenza contemporanea di giustificare
razionalmente le decisioni sanitarie, in particolare al letto del malato: il pluralismo
culturale, il tramonto del paternalismo, l’interdisciplinarità dei problemi, l’alto livello di
specializzazione tecnologica. Questi, che sono assieme i caratteri costitutivi della
bioetica e le ragioni della diffusione di tale disciplina, sono anche i motivi per cui una
collaborazione interprofessionale risulta talvolta ardua da praticare.
In primo luogo infatti il mancato riconoscimento della pluralità e a volta della
franca incompatibilità fra visioni morali (all’interno dello staff oppure fra lo staff, i
paziente e l’entourage) induce a confondere conflitti etici con problemi tecnicoorganizzativi, rimuovendo pericolosamente i primi ed enfatizzando i secondi, col
risultato che il dissenso viene tabuizzato quale minaccia per l’efficienza prestazionale,
invece che come variabile fisiologicamente presente nelle professioni d’aiuto, una
variabile da affrontare, discutere ed elaborare collettivamente, auspicabilmente con
l’aiuto di esperti in bioetica clinica. Sarebbe ad esempio utile integrare la cartella clinica
di una sezione riguardante le problematiche etiche percepite e analizzate dalle diverse
figure professionali (scelta del rappresentante del malato, dichiarazioni anticipate, temi
di riservatezza, dibattiti sui criteri allocativi…).
In secondo luogo l’interdisciplinarità del gruppo professionale, che si fa
carico della sofferenza non di un organo o di un apparato, ma di una persona
integralmente intesa, deve ricorrere a prospettive tecnico-scientifiche differenti, non
semplicemente per accostare le une alle altre (questa sarebbe la semplice
pluridisciplinarità, in cui si vede un certo problema da più lati), ma per farle
interagire tra loro, cercando di scambiare o meglio tradurre vicendevolmente i molti
punti di vista. Si tratta di leggere i propri dati da un'ottica differente e di interpretare i
dati provenienti da un'altra disciplina a partire dalla propria ottica. La domanda "è
l'embrione una persona umana oppure non lo è?" documenta emblematicamente la
2
3
P.M. Cattorini, “La consulenza in bioetica clinica. Una proposta”, Medicina e Morale, 2015, in press.
Ibidem.
4
compresenza di due ordini di discorso e pratica (quello bio-medico e quello
filosofico-giuridico), confrontati allo stesso “tavolo” di lavoro e impegnati a reperire
concetti ponte e criteri intermedi, che agevolino una reciproca comunicazione e
avviino alla soluzione del problema.
In terzo luogo il tramonto del paternalismo obbliga ad aprire una
comunicazione il più possibile paritaria tra esperti (il medico è sempre più inteso
come il coordinatore di un team, piuttosto che come il dispotico, onnisciente sovrano
delle linee d’azione: leader e non invece ruler, avrebbe scritto la Arendt) e tra esperti
e profani (il medico, l’infermiere, il sanitario sono sempre più intesi come gli alleati
affidabili di un patto di cura, piuttosto che come i partner signorili, che propongono,
dispongono e occultamente “persuadono” l’interlocutore più fragile, debole,
disorientato). Nessun giudizio in merito alla proporzionalità delle cure, ad esempio,
può prescindere dall’interpretazione valoriale e dal giudizio ultimo, che pertiene al
paziente, in merito ai trattamenti disponibili, compresi quelli di sostegno vitale,
compresa la stessa idratazione/nutrizione artificiale. Ci aspetteremmo dai comitati
d’etica una ricognizione più puntuale e trasparente in merito all’osservanza concreta,
sistematica e trasparente delle quattro condizioni alle quali un consenso/rifiuto del
malato, raccolto e documentato negli spazi di cura, può dirsi valido: offerta
d’informazione, comprensione della medesima, libertà dell’avente diritto, sua
competence decisionale.
In quarto luogo il deficit comunicativo e collaborativo interprofessionale sconta le
difficoltà più latamente socioculturali della comprensione e condivisione deliberativa
nell’arena civile. Gli studiosi della società occidentale post-moderna hanno evidenziato
da tempo gli impasse più vistosi che la chiacchiera modaiola e il gossip trendy tenta di
occultare, esponendo preziose pratiche vitali e delicate fasi di transazione biografica alle
lusinghe e talora alle predazioni realizzate dai poteri più forti: quelli rappresentati da
ambigui interessi economico-aziendalistici, da un’invadente, parassitaria mercificazione
dei corpi, e da una sorta di colonizzazione iper-medicalizzante. Nemesi medica è il testo
di Ivan Illich, che andrebbe riconsegnato capillarmente ai responsabili della formazione
sanitaria.
Parlavamo di impasse. Ne esemplifichiamo alcune cifre: l’ideologia
dell’individualismo conflittualistico (homo homini lupus) che confina le relazioni a
contatti (d’indifferenza o pre-belligeranza) tra stranieri morali; la persistente rimozione
della morte; il mito del controllo forfettario sulla vita e l’illusione di un’illimitata
autolegislazione sul corpo vissuto; il disconoscimento della dignità personale di vite
(wrongful lives) segnate da dolore, vulnerabilità, improduttività, non autosufficienza; la
svalutazione sistematica del dialogo operata tanto da posizioni dogmatico-assolutistiche
quanto radicalmente scettiche in merito all’esistenza di verità etiche; la fallacia
naturalistica, che scambia il bene morale con la legalità dei fenomeni biologici o con
l’empirica registrazione di una preferenza maggioritaria; la separazione tra fede e
ragione, tra passione e intelletto, tra narrazione e logica argomentativa, e ancora tra
inclinazioni (demonizzate come arbitrarie), deduzioni sillogistiche (privilegiate come
precetti astoricamente certi) e confutazioni scientifico-sperimentali (encomiate come
l’unica evidenza credibile in ordine a una coerente presa di decisioni esistenziali).
Da tempo abbiamo sostenuto la maggior pertinenza della figura dell’alleanza
risetto a quella del contratto, quale metafora privilegiata per qualificare sinteticamente il
senso della promessa di cura, che un gruppo di professionisti stringe, esprime,
documenta, declina e rinnova in maniera articolata davanti alle originali evenienze del
decorso di malattia e di assistenza, avendo come precipuo e ultimativo obiettivo quello
di servire la persona sofferente.
5
La Postfazione aggiornata al nostro volumetto Malattia e alleanza, Firenze,
Pontecorboli, 2° ed. 20104, analizza le ragioni per cui i singoli paragrafi di un accordo
contrattuale (di cui la raccolta di patients’ informed consent attesta l’indubbia necessità)
si comprendono, firmano ed eseguono fedelmente, solo alla luce di uno scambio di
promesse umanamente coinvolgenti (la professione è molto di più di una tecnica, o di
una scienza applicata), emotivamente calde, autentiche sul piano comunicativo,
interessate a sanare le disparità tra i partner, radicate in una costitutiva dipendenza e
prossimità antropologica.
Un vizio di consenso alle cure da parte del malato, una mancata segnalazione di
un professionista in merito al comportamento illegittimo del collega (della medesima o
di una diversa competenza), un dilagante contenzioso medico-legale in tema di
responsabilità professionali, un imbarazzante silenzio in relazione ai conflitti etici, che
dividono e talora paralizzano un intero staff, sono indizi di un’incerta alleanza
assistenziale, di un confuso patto, proclamato a parole ma disatteso nella pratica. Singoli
professionisti, istituzioni sanitarie, decisori economici e politici, comitati d’etica,
associazioni di malati, cittadini e famiglie colpiti dalla malattia, tutti questi soggetti
sono chiamati a un’assunzione di responsabilità, che sia trasparente, argomentata e non
scalfita da interessi eterogenei rispetto alla promessa fondativa, di cui abbiamo parlato.
La corrosiva denuncia di Pedro Almodovar, il regista di Parla con lei, Spagna
2002, riguardava appunto un grave fraintendimento e una colpevole diluizione di
responsabilità, che inducevano un’intera equipe professionale, impegnata nell’assistenza
di soggetti in stato vegetativo permanente, a scivolare in atti mancati, scotomi morali,
sottovalutazioni impreviste, manipolazioni comunicative e illeciti “passaggi all’azione”.
Non basta poi scovare e punire il singolo capro espiatorio, se non si previene il difetto di
comunicazione empatica e di ragionamento morale, che affligge le coscienze del gruppo
di colleghi in camice bianco. Di banalità in banalità, il male, come sappiamo, si fa
orribile.
Altra bibliografia dell’Autore:
Bioetica. Metodo ed elementi di base per affrontare problemi clinici, Milano, Elsevier, 4° ed.
2011.
Bioetica e cinema, Milano, FrancoAngeli, 2° ed. 2006.
La morte offesa, Bologna, EDB, rist. 2006.
Cura, Padova, Il Messaggero, 2014.
Frasi di famiglia, Bologna, EDB, 2015.
4
Altra nostra bibliografia è indicata in coda al presente scritto.
6
Test:
1. I caratteri tipici di un comitato d’etica sono:
a. pluralismo e parità di opportunità
b. pluralismo e multidisciplinarità
c. pluralismo, interdisciplinarità e indipendenza
d. pluralismo religioso, presenza di malati, nomina da parte del Direttore sanitario.
2. le condizioni etiche di un valido consenso/rifiuto da parte dell’assistito sono:
a. maggiore età, capacità di intendere, solidità psicologica dei familiari
b. libertà e informazione
c. informazione ben data e informazione ben compresa, più una direttiva anticipata
d. informazione esauriente sul piano scientifico, empatia e delicatezza psicologica nella comunicazione.
e. informazione ben data e ben compresa, libertà, capacità di decidere (o competence)
Risposte esatte:
1. c.
2. e.