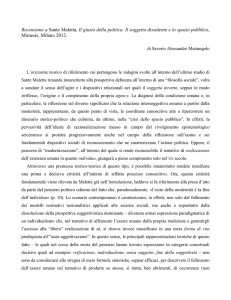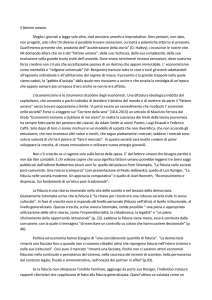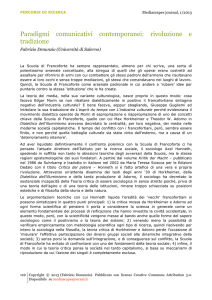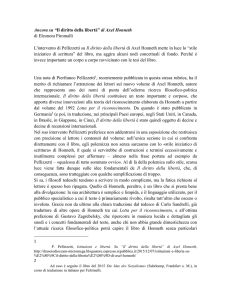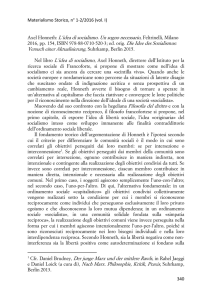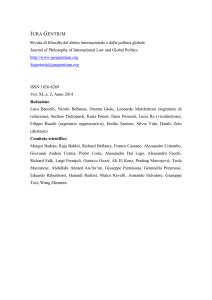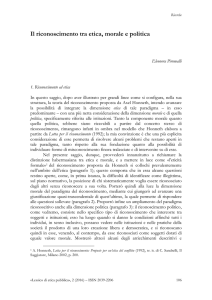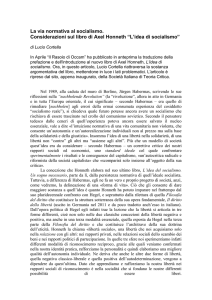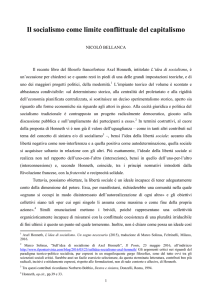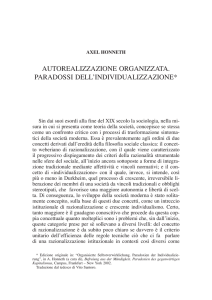Istituzioni e Libertà. Su “Il diritto della libertà” di
Axel Honneth
di Pierfranco Pellizzetti
«Se dobbiamo tener fede alla nostra identità
dobbiamo immergerci nelle nostre tradizioni
per come sono e non per come nostalgicamente
desideriamo che siano. Per noi, in quanto membri
delle società più moderne, queste sono tradizioni
di mutamento, di diversità, di controversia e di
riflessione».
Jeremy Waldron
«Il lato oscuro dell’individualismo è il suo
incentrarsi sull’io, che a un tempo appiattisce
e restringe le nostre vite, ne impoverisce il
significato e le allontana dall’interesse per
gli altri e la società».
Charles Taylor
«Libertà è parola ambigua», scriveva Michelangelo Bovero nel dizionario “Alla
ricerca della politica” curato anni fa da Angelo d’Orsi. Dunque termine polisemico,
carico di una molteplicità di significati, la maggior parte dei quali sono generici,
imprecisi ed equivoci. Di conseguenza il pensiero della/sulla Libertà è non solo
ambiguamente molteplice, ma anche contraddittorio. Oggetto di controversie
insanabili e aggettivazioni arbitrarie. Forse la meno opinabile è quella che propone
uno spartiacque tra scuole-mondi già altre volte oggetto di analoghe operazioni
tassonomiche: anglosassoni e continentali. Una divergenza relativa alla definizione
del comune concetto di individuo, tradotta in due tradizioni di pensiero. Come ricorda
l’antropologa Mary Douglas, «i filosofi francesi erano interessati alla conquista della
libertà all’interno dell’ordine sociale, al ruolo svolto dalle credenze condivise nel
conferimento dell’autorità e ai fattori che determinano la solidarietà sociale. Lungi
dal voler liquidare il concetto di individuo, essi temevano che l’atomizzazione della
società spianasse la strada alla forza bruta. […] Dal canto loro, i liberali inglesi del
diciottesimo e diciannovesimo secolo avevano un altro programma: stabilire i criteri
che avrebbero creato una sfera d’azione privata e che l’avrebbero protetta dall’azione
dello stato». In sostanza, per i francesi, critici dell’Utilitarismo, il ruolo delle norme
sociali era centrale nelle loro speculazioni, quanto era assente nel programma
filosofico-politico d’oltre Manica (e negli immaginari dominanti nelle colonie
americane).
Come ora ci conferma anche Axel Honneth (nell'appena tradotto Il Diritto della
Libertà. Lineamenti per un’eticità democratica, Codice Edizioni, Torino 2015) va
1
sempre tenuto presente che «a partire dalla rivoluzione francese lo Stato moderno è
stato per lo più concepito dai contemporanei illuminati come un organo intellettuale
[…] mediante il quale la volontà del popolo, contrattata democraticamente, trovava
un’adeguata ed efficace applicazione pragmatica» (pag. 436). La tradizione che in
terra di Francia verrà sussunta nel “fatto sociale” di Émile Durkheim, mentre in
quella di Germania acquisirà i marcati tratti statolatrici dell’egemonia intellettuale
hegeliana, cui il nostro stesso autore fa costante riferimento nella sua opera attuale.
Proprio ricordando la convinzione del filosofo di Stoccarda dell’avvenuto
compimento della storia morale dell’umanità grazie all’istituzione della famiglia
nucleare borghese, del mercato disciplinato corporativamente e – innanzi tutto – dello
Stato.
Osservando a volo d’uccello come “il trionfo della borghesia” sia coinciso con
l’instaurazione di un ordine liberal-capitalista, declinata in una sorta di narcisismo
individualista, questo ha determinato la prevalenza della tradizione anglosassone in
materia di Liberalismo sul deuteragonista continentale. Tanto da indurre autori come
Philip Pettit a circoscrivere la nozione di “libertà liberale” alla sola non ingerenza;
consegnando il restante alla categoria di “Repubblicanesimo”.
Particolarmente nel momento in cui – all’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso –
iniziò il dominio ideologico di un egoismo assiomatico. Lo stesso momento in cui si
aprì la discussione innescata dalle critiche comunitarie a tale tradizione che aveva
rimosso la coscienza del “noi”; l’attenzione prioritaria all’idea di “eguali libertà
civili”: «una società libera, la quale ha dunque bisogno di richiedere una forte lealtà
spontanea da parte dei suoi membri, sfugge alla premessa indispensabile di tale lealtà:
una forte identificazione dei cittadini intorno a un senso del bene comune» (Charles
Taylor). Critiche cui proverà a dare replica, pur nei suoi limiti di astrattezza e
formalismo, la teoria del discorso e dell’agire comunicativo di Jürgen Habemas; la
fondazione di una teoria della giustizia da parte di John Rawls, che valga per
democrazie pluralistiche in cui non vige alcun principio condiviso del bene. A fronte
– per inciso - della opposta difficoltà degli autori comunitaristi di fornire una
convincente definizione del concetto di comunità, nel mai totalmente chiarito
rapporto con “il progetto della modernità”. Aporia di cui essi stessi sembrano
consapevoli quando proclamano la loro accettazione del principio pluralistico, che
pure contrasta con l’essenza di un aggregato umano (la Gemeinschaft) che si presenta
come omologazione aggregata dal pregiudiziale consenso conformistico.
Intanto la ristrutturazione dell’ordine a Occidente evolveva verso tutt’altra sponda:
l’imposizione di un ordine plutocratico, giustificato/mascherato attraverso
manipolazioni massmediatiche e lo scatenamento di guerre tra poveri.
Movimenti e poste in gioco nello spirito dei tempi che il volume editato da Codice
declina in alta speculazione.
Ma a questo punto, rispetto alle questioni che innalzano la riflessione al ciel dei cieli
del pensiero che si compiace delle proprie sottigliezze, specchiandosi nella Verità
filosofica, l’autore di queste note percepisce il preoccupante sfrigolio della cera che
fissa le penne alle proprie fragili ali. Quindi sceglie un rapido abbassamento di quota
riportando l’esame del testo di Honneth in una dimensione più praticabile; nel
2
dibattito politico del tempo presente. Ossia, migrando verso la concreta osservabilità
del sociale. Operazione in qualche misura accreditata dal fatto che l’autore, da buon
francofortese, ha doppio passaporto: da filosofo ma anche da sociologo.
Dal punto di vista storico-sociale “Il Diritto della Libertà” è un potente sintomo di
periodi giunti al termine: quelli che Piketty chiama “i quaranta ingloriosi”, su cui
campeggiava l’affermazione fatta da una Lady di ferro dell’inesistenza della società.
Infatti il testo di Honneth è un vigoroso appello contrario: l’idea di giustizia in quanto
modo di realizzare «valori che in un certa epoca vengono generalmente accettati
all’interno di una società e sono perciò responsabili della sua legittimazione
normativa» (pag. 77). Le istituzioni come “medium della libertà”. Contro le follie
degli Stati minimi e degli anarco-liberalismi, cari a quanti propugnano la
finanziarizzazione del mondo.
Al tempo stesso il nostro autore rifiuta il principio stesso del baratto freudiano libertàsicurezza, oggi tanto di moda. Lo fa rileggendo classiche distinzioni delle libertà al
plurale - come quella proposta da Isaiah Berlin tra “negativa” (da) e “positiva” (di),
giustamente criticata da Robert Dahl («al contrario di Berlin, sono incline ad
affermare che un individuo, per essere libero, deve essere capace di esercitare sia
autonomia sia controllo») - per proporcene una tutta sua: “negativa”, “riflessiva” e
“sociale”. Questa “libertà sociale” che va in controtendenza rispetto al (declinante?)
spirito dei tempi ma che è anche la presa di distanza dalle democrazie discorsive del
proprio maestro Habermas. Perché Honneth rappresenta (con qualche pulsione
edipica?) la terza generazione della scuola di Francoforte, ben nota per l’approccio
critico e un suo non risolto rapporto con il Moderno. Ma anche per lo stile iniziatico
di scrittura; tra una sorta di marchio di fabbrica e il tic del distanziamento esoterico.
Perché quando il Nostro verga con la penna d’oca che «il processo di
autolegislazione (individuale o cooperativa) deve essere descritto come se
consentisse, attraverso il distanziamento riflessivo da tutte le norme date, di
raggiungere una prospettiva dalla quale valutare senza alcun preconcetto – e in
questo senso in modo imparziale – la generalizzabilità dei principi morali» (pag.
138), per affermare qualcosa di tutto sommato ovvio (i principi per essere fatti valere
abbisognano di approvazione generale), al lettore malizioso torna in mente il lontano
ottobre 1961; quando a Tubinga andò a congresso la Società tedesca di sociologia,
chiamando a svolgere le relazioni introduttive Karl R. Popper e Theodor W. Adorno,
l’antesignano del nostro Axel Honneth.
Le testimonianze dell’epoca riferiscono che nella prima sessione il sussiegoso
Adorno svolse il proprio intervento in perfetto stile francofortese. A seguire fu il
turno di Popper, il quale cominciò a tradurre lo script di chi lo aveva preceduto con
l’abituale pedanteria e una punta di arroganza: «la totalità sociale non conduce affatto
una vita propria, al di sopra di quella di ciò che essa raccoglie e di cui essa consiste»
diventava così nella revisione popperiana «la società consiste di relazioni sociali». E
via andare sul beffardo...
Corre ancora voce che la vicenda finì a botte, tra supporter dei due maestri: Habermas
contro Hans Albert, con Ralf Dahrendorf a fare da paciere…
3
Testi utilizzati
Aa.Vv. Comunitarismo e Liberalismo (a cura di A. Ferrara), Editori Riuniti, Roma 2000
Aa. Vv. Dialettica e positivismo in sociologia, Einaudi, Torino 1972
H. Albert, Difesa del razionalismo critico, Armando, Roma 1975
I. Berlin, Quattro saggi sulla libertà, Feltrinelli, Milano 1989
M. Bovero, “Libertà”, Alla ricerca della politica (a cura A.d’Orsi), Bollati Boringhieri, Torino 1995
R. A. Dahl, I dilemmi della democrazia pluralista, EST, Milano 1996
M. Douglas, Credere e pensare, il Mulino, Bologna 1994
J. Habermas, Teoria dell’agire comunicativo, il Mulino, Bologna 1984
P. Pettit, Il repubblicanesimo, Feltrinelli, Milano 2000
J. Rawls, Una teoria della giustizia, Feltrinelli, Milano 1983
C. Taylor, Il disagio della modernità, Laterza, Roma/Bari 1994
4