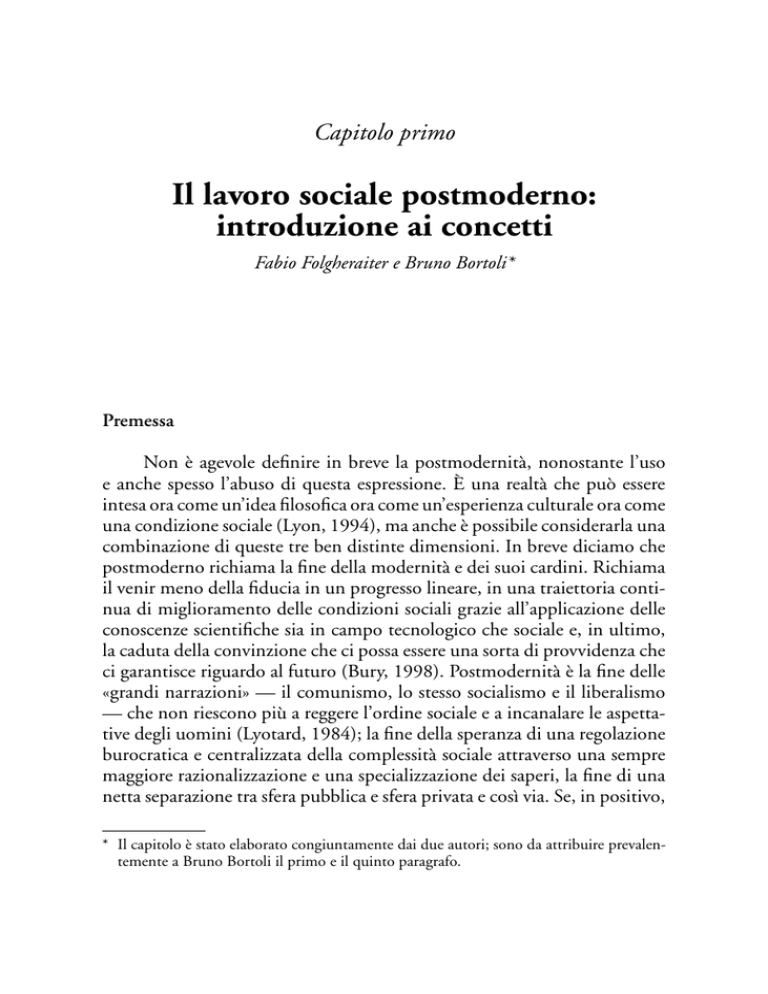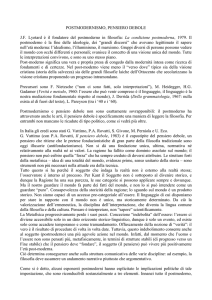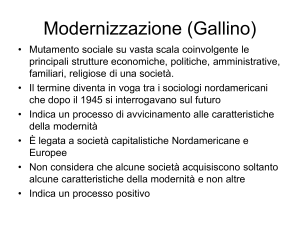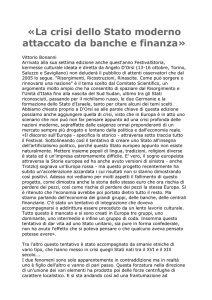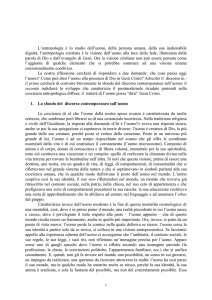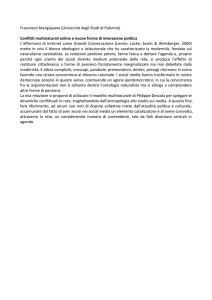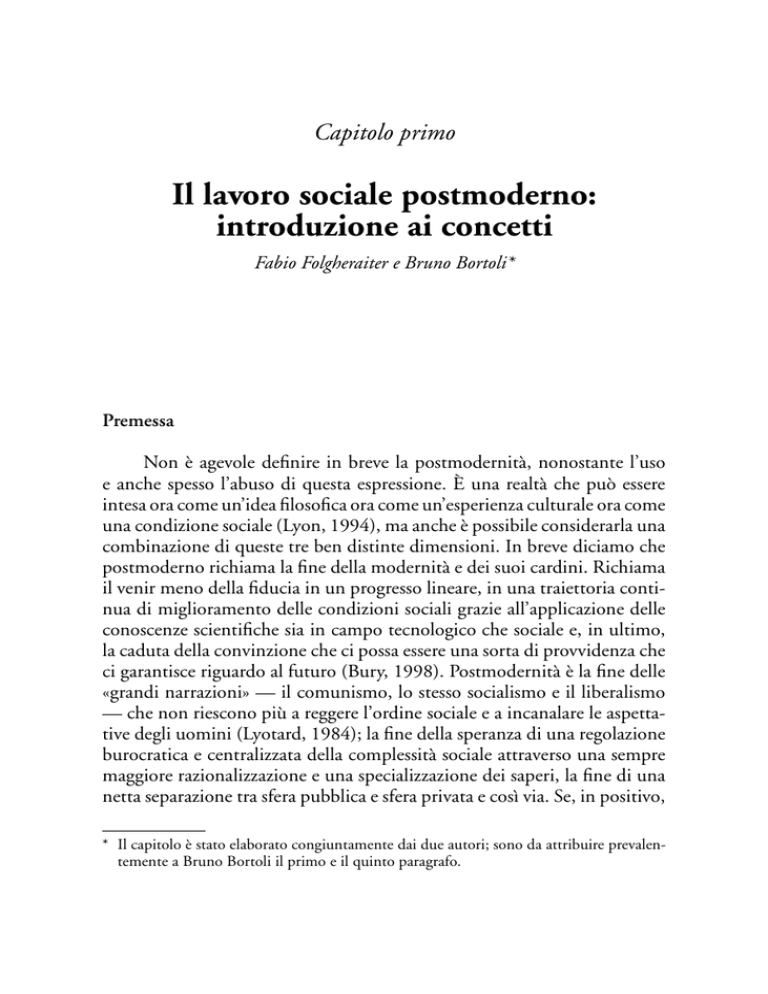
Il lavoro sociale postmoderno: introduzione ai concetti
13
Capitolo primo
Il lavoro sociale postmoderno:
introduzione ai concetti
Fabio Folgheraiter e Bruno Bortoli*
Premessa
Non è agevole definire in breve la postmodernità, nonostante l’uso
e anche spesso l’abuso di questa espressione. È una realtà che può essere
intesa ora come un’idea filosofica ora come un’esperienza culturale ora come
una condizione sociale (Lyon, 1994), ma anche è possibile considerarla una
combinazione di queste tre ben distinte dimensioni. In breve diciamo che
postmoderno richiama la fine della modernità e dei suoi cardini. Richiama
il venir meno della fiducia in un progresso lineare, in una traiettoria continua di miglioramento delle condizioni sociali grazie all’applicazione delle
conoscenze scientifiche sia in campo tecnologico che sociale e, in ultimo,
la caduta della convinzione che ci possa essere una sorta di provvidenza che
ci garantisce riguardo al futuro (Bury, 1998). Postmodernità è la fine delle
«grandi narrazioni» — il comunismo, lo stesso socialismo e il liberalismo
— che non riescono più a reggere l’ordine sociale e a incanalare le aspettative degli uomini (Lyotard, 1984); la fine della speranza di una regolazione
burocratica e centralizzata della complessità sociale attraverso una sempre
maggiore razionalizzazione e una specializzazione dei saperi, la fine di una
netta separazione tra sfera pubblica e sfera privata e così via. Se, in positivo,
* Il capitolo è stato elaborato congiuntamente dai due autori; sono da attribuire prevalentemente a Bruno Bortoli il primo e il quinto paragrafo.
14
Il servizio sociale postmoderno
ci si chiede di che cosa segni «l’inizio» la postmodernità, basta invertire
tutto quanto detto sopra e riconoscere la frammentazione delle percezioni
e delle formule organizzative, la natura socialmente costruita dei valori e
delle realtà sociali, l’incremento della riflessività degli attori sociali e delle
loro istanze soggettive (Giddens, 1994), l’accettazione della precarietà e
del rischio quali componenti ineliminabili del vivere umano (Beck, 2000;
Bauman, 1996).
Il welfare state è certamente l’emblema delle ambizioni moderne.
La sua caduta o la sua continua progressiva decostruzione in forza della
crescente sfiducia nelle sue capacità di tradurre in pratica tali ambizioni è
una delle evidenze più esplicite della postmodernità. Su questi temi l’analisi
sociologica in questi anni ci ha informati ampiamente. Rimane uno sforzo
da compiere che è quello di trasferire tutte queste suggestioni e conoscenze
nel campo delle professioni sociali. Forti ripercussioni sul modo di pensare
gli interventi riparativi derivano dal pensiero postmoderno, in quanto esso
scardina letteralmente le basi tradizionali (intuitive) su cui le azioni professionali di aiuto — in prevalenza di derivazione moderna e positivistica
— si sono in questi decenni costruite. In questa introduzione discuteremo
alcuni concetti basilari che caratterizzano la prospettiva postmoderna. Ci
riferiamo all’idea della relazione sociale, del fronteggiamento in rete e dell’empowerment, concetti fondamentali che si sono in questi anni affermati
a fronte dell’evidenza dell’incapacità dei principi tradizionali di reggere
gli assalti della complessità e della diversificazione dei problemi sociali cui
avrebbero dovuto far fronte. Prima di introdurci in tali riflessioni ripercorreremo in sintesi la vicenda storica moderna delle professioni sociali e il loro
controverso statuto scientifico.
1. Breve profilo di un’area pluriprofessionale: il lavoro sociale
Il termine lavoro sociale (social work) si riferisce alla scienza sottostante
all’insieme delle cosiddette professioni sociali, vale a dire allo studio degli
interventi di aiuto nei confronti di persone, famiglie, gruppi e comunità
ritenute «svantaggiate» rispetto agli standard sociali dominanti (Folgheraiter,
1998). Si tratta di un fronte tematico interdisciplinare che spazia dagli aspetti
tecnico-metodologici a quelli etici e deontologici, da quelli logico-episte-
Il lavoro sociale postmoderno: introduzione ai concetti
15
mologici a quelli istituzionali, organizzativi e politico amministrativi. Il
lavoro sociale è pertanto un «sapere connesso a un agire specializzato» ad
ampio spettro. Non si tratta di una professione specifica, bensì di una classe
professionale, il comune denominatore di più professioni distinte. Tra questi
specifici campi operativi vanno ricompresi sia «mestieri» tradizionali, sia altri
potenziali non ancora comparsi, per così dire, sulla scena.
La professione sociale più antica e più consolidata, che ha fatto da
matrice per altre che si sono poi successivamente differenziate e dalle quali
altre ancora si potranno differenziare in futuro, è il servizio sociale, il mestiere
«storico» dell’assistente sociale. A cavallo tra Ottocento e Novecento, nei
Paesi anglosassoni, i primi social worker (in gran parte donne) erano persone
di grande levatura e tensione etica come Mary Richmond, Edith Abbott
e Jane Addams, impegnate nella riforma sociale (Bortoli, 2004; 2004a). A
tale riforma contribuivano anche con un intervento personale indirizzato,
a livello micro, ad affrontare i bisogni quotidiani dei loro concittadini e,
a livello macro, a sensibilizzare e a proporre interventi legislativi e amministrativi volti ad affrontare radicalmente le fonti strutturali di malessere.
Sentivano il dovere di trascendere il puro sapere intellettuale e di sfruttare
il potenziale delle scienze sociali (che allora, ottimisticamente, si tendeva
alquanto a sovrastimare) per risolvere concreti problemi di singole persone
o di particolari gruppi sociali.
In questo contesto non è casuale la collaborazione di questi pionieri
del servizio sociale con alcuni importanti centri di sviluppo delle scienze
economiche e sociali, come la London School of Economics in Inghilterra
e l’Università di Chicago negli Stati Uniti. L’impegno sul campo degli assistenti sociali, con l’assunzione di responsabilità organizzative e gestionali nei
nascenti organismi deputati ad affrontare bisogni familiari, quelli dei disabili
e soprattutto dei minori in difficoltà, li rese consapevoli della funzione sociale
che esercitavano e della necessità di una loro legittimazione sociale.
Da questa esigenza ebbe inizio lo sforzo teorico volto a concettualizzare la «scientificità» del loro intervento, congiuntamente al tentativo di
definire in termini professionali i loro ruoli occupazionali (Lubove, 1965).
Fra i criteri che reggono la definizione sociologica di «professione», uno dei
principali riguarda l’effettiva possibilità di trasmissione dei saperi acquisiti.
È in relazione a tale esigenza che, contemporaneamente alla diffusione del
social work nell’ambito sanitario e scolastico, vengono istituite negli Stati
16
Il servizio sociale postmoderno
Uniti a partire dai primi anni del Novecento le prime Scuole per preparare
i professionisti del lavoro sociale (Bortoli, 1997).
Nello stesso periodo, in Europa, le fasi di costruzione dello Stato
sociale (soprattutto quelle connesse al diffondersi dei principali schemi di
assicurazione sociale) reclamano un funzionario che ne garantisca un’implementazione efficace. L’«assistente sociale di fabbrica» in Francia e in Italia,
così come l’assistente medico-sociale nei Paesi francofoni (ma qualcosa di
analogo esisteva anche in Italia con l’assistente sanitaria visitatrice dell’ONMI) rappresentano le figure professionali anticipatrici dei ruoli amministrativi
pubblici sui quali si innesterà la figura di assistente sociale come funzionario
del welfare state (Sand, 1931).
Questo accomodamento dentro gli apparati pubblici non ha tuttavia
impedito che gli assistenti sociali maturassero la percezione di trovarsi
compressi tra le logiche regolatorie delle burocrazie assistenziali e le istanze
di ordine etico-politico connaturate alla professione. Un tale sentimento
ha portato come noto alla crisi «politica» della professione, alla fine degli
anni Sessanta. Dopo un iniziale violento rifiuto della tradizione di servizio
sociale ritenuta responsabile della funzione conservatrice e consolatoria
attribuita al proprio ruolo, e dopo essersi indirizzati verso forme radicali
(Nord Europa, Paesi Bassi e Gran Bretagna) quando non esplicitamente
politicizzate (Italia), gli assistenti sociali hanno gradualmente tentato di
mediare il «doppio legame» di cui si è detto.
In parallelo, i sistemi di welfare pubblici di cui gli assistenti sociali
erano gli unici funzionari sono anch’essi entrati in crisi. Negli anni Settanta
la gran parte dei welfare state nazionali (quello italiano in modo particolare)
si sono «aperti» per lasciare maggiore spazio alla società civile, in particolare
a organizzazioni private di terzo settore senza fini di lucro (Donati, 1996).
È soprattutto in questa fase di forte espansione che il lavoro sociale si è
differenziato internamente. Accanto alla figura «generalista» dell’assistente
sociale sono comparse altre figure professionali che si sono appropriate di
funzioni di aiuto specifiche, per le quali andava emergendo una domanda
di maggiore specializzazione. In particolare si è differenziata la funzione
pedagogica-educativa, a cui è stato fatto corrispondere un operatore specifico
variamente denominato: educatore extrascolastico o educatore professionale
in area italiana, sozial pedagoge in area tedesca, éducateur spécialisé o moniteuréducateur in area francese. Tale funzione si è poi recentemente frastagliata
Il lavoro sociale postmoderno: introduzione ai concetti
17
in ulteriori rami minori, dando forma a figure professionali non ancora
pienamente accreditate, come l’animatore socioassistenziale, l’operatore di
strada, il mediatore sociale, e chissà quali ancora.
Negli anni Novanta, con l’affermarsi della liberalizzazione nel campo
dell’assistenza sostenuta dall’Unione europea (Ferrari, 2000; Folgheraiter,
2003) e già tradotta in Gran Bretagna in una radicale riforma dei servizi
sociosanitari, il lavoro sociale si è dovuto confrontare a viso aperto con le
logiche di mercato (Fletcher, 2000). L’aiuto in tale prospettiva è definito
non più come diritto di cittadinanza, bensì come bene che si potrebbe
produrre e distribuire in modo efficiente attraverso gli scambi di mercato,
anche eventualmente sostenuti dalla finanza pubblica, nei regimi detti perciò
di «quasi-mercato». Dal punto di vista delle professioni sociali (Donati e
Folgheraiter, 1999), una simile rivoluzione ha portato a un’ulteriore differenziazione nel lavoro sociale, e precisamente quella tra la macrofunzione
cognitiva dell’«acquisto e valutazione» di prestazioni specializzate da un
lato e la funzione esecutiva dell’«erogazione» delle stesse dall’altro. Molti
professionisti si trovano ancora assorbiti in questa ultima funzione, in
qualità di specialisti entro servizi sempre più esternalizzati (di mercato o di
terzo settore); in questa veste vengono richiesti per lo più nella fornitura
di prestazioni (providers). Altri invece (soprattutto gli assistenti sociali delle
amministrazioni pubbliche), analogamente a quanto succede nella sanità
con il medico di base, sono chiamati a coprire gli spazi della prima funzione
(assessment, pianificazione, acquisto, monitoraggio, evaluation), che comporta
lo sviluppo della nuova abilità di reperire sul mercato assistenziale un pacchetto individualizzato di prestazioni e di coordinarle. Questo nuovo ruolo
(o, forse, nuova professione) di micro-pianificazione assistenziale prende il
nome di case management (Payne, 1998; Bortoli, 2003). Tale ruolo si apre
verso il lavoro di rete quando da un accento prevalente sull’assemblaggio
di prestazioni si passa a una maggiore apertura relazionale.
Parallelamente a questo movimento, si è assistito a una sotterranea
(prima) e poi via via più organizzata espressione delle volontà e delle propensioni dei soggetti interessati alle cure (Barnes, 1999), cioè degli stessi
utenti e dei carers, cioè di chi si prende cura di loro più da vicino. Questi
soggetti si pongono sempre più in evidenza, anche in forma collettiva, come
interlocutori dell’ente pubblico e del mercato rispetto alla pianificazione
assistenziale o al controllo della qualità. Soprattutto, gli interessati avanzano
18
Il servizio sociale postmoderno
la richiesta di divenire diretti produttori dei servizi di cura di cui sentono
il bisogno, senza essere sottoposti a controlli amministrativi vincolanti. Le
associazioni di utenti e di familiari hanno dato vita a importanti movimenti
di auto/mutuo aiuto, in svariati campi quali le dipendenze, la psichiatria,
l’handicap mentale e fisico, ecc. Tali movimenti hanno mostrato di poter
trovare efficaci forme di collaborazione con i professionisti sociali, più
che con i servizi intesi come organizzazioni. Sono nate in questo modo
istituzioni autonome miste (cioè promosse e gestite in collaborazione tra
cittadini direttamente interessati alla produzione di care ed esperti solidali)
che potremmo definire di Quarto settore.
2. Tra sociale e sanitario: l’oggetto del lavoro sociale
Il lavoro sociale, oltre a essere definito analiticamente nella propria
differenziazione interna, può anche essere compreso per «contrapposizione»
esterna. In particolare, si definisce in contrasto all’altra importante, e forse più
popolare, area di aiuto, che è quella sanitaria (o clinica). Che cosa distingue
le sopracitate professioni sociali, prese nel loro insieme, dalle professioni
mediche tradizionali risulta intuitivamente evidente. Ma non altrettanto
chiara è la distinzione rispetto a professioni come la psicologia clinica e la
psicoterapia, le quali aderiscono al modello medico ma si occupano della
riparazione di disagi psicologici e comportamentali apparentemente simili,
se non identici, a quelli di cui si occupa il lavoro sociale. La cura di un
malato di mente può essere responsabilità di operatori sanitari (il medico
psichiatra, l’infermiere, lo psicologo esperto di riabilitazione comportamentale, ecc.) oppure di operatori sociali, come l’assistente sociale o l’educatore
professionale. E quindi dov’è la differenza? Volendo abbozzare un minimo
di ragionamento epistemologico ci si dovrebbe chiedere: qual è il differente
oggetto? (Folgheraiter,1998).
Nel linguaggio anglosassone specializzato, il termine «cura» è espresso
in due differenti accezioni, a seconda che si voglia indicare la cura sanitaria o
quella sociale. Nel primo caso si usa il vocabolo curing, che significa curare
con l’intenzione di guarire. Nel secondo si usa il termine caring, che significa
curare con l’intenzione di migliorare la qualità di vita, a prescindere dalla
persistenza o meno della patologia (o della sua stessa esistenza ab origine).
Le professioni sociali nella postmodernità
53
La natura delle professioni sociali: la visione degli utenti e la visione degli
operatori
Sono state effettuate parecchie ricerche, negli ultimi anni, nel tentativo
di comprendere ciò che i destinatari dei servizi sociali, e dei servizi alla persona in generale, ritengono sia loro di maggiore utilità (si vedano, a titolo
di esempio, Rees e Wallace, 1982; Fisher, 1983; Howe, 1993; Seligman,
1995). Quanto emerso, e che ha trovato conferma più volte, è che la variabile
più importante non è la specifica tecnica di cui si avvale l’operatore sociale,
bensì la qualità e il valore dell’esperienza che fa l’utente. Gli ingredienti essenziali del «successo», dal punto di vista degli utenti, sono stati sintetizzati
da Howe (1993) con lo slogan seguente: «Accettami, comprendimi e parla
con me». Non si tratta soltanto di riconoscere l’importanza del «creare una
buona relazione», ma anche di capire che il modo in cui comprendiamo
e affrontiamo, da operatori, esperienze di disagio o di sofferenza è legato
al modo in cui parliamo. Le parole e il linguaggio sono fondamentali per
comprendere e controllare la situazione, conferendole un senso particolare; è
questo «dare un senso», quale che esso sia, la cosa più importante. Un utente
che desideri ridefinire il proprio Sé e dare un nuovo senso a quello che gli
succede ha bisogno di immergersi nella conversazione, perché è soltanto
grazie al linguaggio che si costituisce il Sé, a livello individuale. Come ha
dimostrato l’autore citato, più che le procedure o le tecniche impiegate dagli
operatori, è l’opportunità di parlare di se stessi ciò che permette agli utenti
di comprendere adeguatamente la situazione — e quindi di modificarla.
Gli utenti concordano nel dire che l’esperienza che apprezzano di più è
l’opportunità di conversare con qualcuno. Questo li aiuta a ricostruire il
senso del loro vissuto e, quindi, li pone nelle condizioni di gestire meglio
il proprio corso di vita, modificandolo di conseguenza.
Questa opinione degli utenti si riflette, tra l’altro, negli atteggiamenti degli
operatori più esperti. Gli studi condotti negli ultimi anni da Jan Fook, sotto
questo profilo, appaiono particolarmente interessanti (Ryan et al., 1995; Fook
et al., 1996; 1997; 2000; Fook, 2000). Questo autore ha cercato di ricostruire i
vissuti degli operatori sul campo, nel tentativo di definire il loro expertise professionale a partire dalla loro esperienza concreta. In una delle ricerche citate, Fook
ha analizzato i percorsi di una trentina di operatori sociali «esperti». Per rientrare
56
Il servizio sociale postmoderno
con Patrick O’Byrne, l’idea del lavoro sociale costruttivista.
La scelta di un’espressione come «lavoro sociale costruttivista» è legata
a ragioni di ordine teorico. Nel tentativo di elaborare un modello che avesse
delle ricadute significative sul lavoro degli operatori, si è cercato di attingere
da alcune delle principali correnti teoriche che sono maturate negli ultimi
decenni: il costruzionismo sociale, gli approcci narrativi e quelli postmoderni. In tutti questi approcci assume un ruolo fondamentale la comprensione
del linguaggio, dell’ascolto, delle conversazioni e dei significati. L’idea della
comprensione come processo collaborativo, in cui i soggetti coinvolti possono
interagire tra loro, è uno dei tratti distintivi del costruzionismo sociale. Il
significato e la relativa comprensione diventano oggetto di negoziazione tra
i soggetti che partecipano al colloquio; capire e utilizzare il linguaggio in
modo appropriato, di conseguenza, è considerato un passaggio essenziale
per ogni relazione di aiuto.
La svolta costruzionista del «postmoderno» nella teoria sociale
Benché gli approcci postmoderni abbiano fatto ingresso da poco
nella letteratura sul lavoro sociale, è importante prendere atto della loro
crescente diffusione, negli ultimi decenni, in diversi ambiti disciplinari
delle scienze umane occidentali. Le questioni legate alla «postmodernità»
hanno provocato alcuni dei più importanti dibattiti teorici (e dei relativi
mutamenti di paradigma) in discipline come letteratura, filosofia, storia,
studi socio-giuridici, antropologia, sociologia e psicologia. Sarebbe scorretto,
peraltro, ritenere che vi sia un’unica matrice teorica a cui ricondurre tutti
gli approcci orientati al cosiddetto «costruzionismo».
Nella sfera accademica, la nozione di «costruzionismo sociale» ha
cominciato a prendere piede dopo la pubblicazione, nel 1967, della celebre
opera di Berger e Luckman, La realtà come costruzione sociale. Questi sociologi, ispirati dalla fenomenologia di Edmund Husserl (1975) e di Alfred
Schutz (1962; 1966), hanno descritto la vita sociale di ogni giorno come
una realtà fluida e molteplice, continuamente rinegoziata nelle interazioni
tra attori sociali diversi. La tesi fondamentale di Berger e Luckman è che gli
individui, in interazione tra loro, danno vita ai «mondi sociali» attraverso
l’attività linguistica e simbolica, e in tal modo conferiscono senso e coerenza
a un’esistenza umana che, in ultima analisi, è priva di ogni forma e direzione
56
Il servizio sociale postmoderno
con Patrick O’Byrne, l’idea del lavoro sociale costruttivista.
La scelta di un’espressione come «lavoro sociale costruttivista» è legata
a ragioni di ordine teorico. Nel tentativo di elaborare un modello che avesse
delle ricadute significative sul lavoro degli operatori, si è cercato di attingere
da alcune delle principali correnti teoriche che sono maturate negli ultimi
decenni: il costruzionismo sociale, gli approcci narrativi e quelli postmoderni. In tutti questi approcci assume un ruolo fondamentale la comprensione
del linguaggio, dell’ascolto, delle conversazioni e dei significati. L’idea della
comprensione come processo collaborativo, in cui i soggetti coinvolti possono
interagire tra loro, è uno dei tratti distintivi del costruzionismo sociale. Il
significato e la relativa comprensione diventano oggetto di negoziazione tra
i soggetti che partecipano al colloquio; capire e utilizzare il linguaggio in
modo appropriato, di conseguenza, è considerato un passaggio essenziale
per ogni relazione di aiuto.
La svolta costruzionista del «postmoderno» nella teoria sociale
Benché gli approcci postmoderni abbiano fatto ingresso da poco
nella letteratura sul lavoro sociale, è importante prendere atto della loro
crescente diffusione, negli ultimi decenni, in diversi ambiti disciplinari
delle scienze umane occidentali. Le questioni legate alla «postmodernità»
hanno provocato alcuni dei più importanti dibattiti teorici (e dei relativi
mutamenti di paradigma) in discipline come letteratura, filosofia, storia,
studi socio-giuridici, antropologia, sociologia e psicologia. Sarebbe scorretto,
peraltro, ritenere che vi sia un’unica matrice teorica a cui ricondurre tutti
gli approcci orientati al cosiddetto «costruzionismo».
Nella sfera accademica, la nozione di «costruzionismo sociale» ha
cominciato a prendere piede dopo la pubblicazione, nel 1967, della celebre
opera di Berger e Luckman, La realtà come costruzione sociale. Questi sociologi, ispirati dalla fenomenologia di Edmund Husserl (1975) e di Alfred
Schutz (1962; 1966), hanno descritto la vita sociale di ogni giorno come
una realtà fluida e molteplice, continuamente rinegoziata nelle interazioni
tra attori sociali diversi. La tesi fondamentale di Berger e Luckman è che gli
individui, in interazione tra loro, danno vita ai «mondi sociali» attraverso
l’attività linguistica e simbolica, e in tal modo conferiscono senso e coerenza
a un’esistenza umana che, in ultima analisi, è priva di ogni forma e direzione
Le professioni sociali nella postmodernità
57
precostituita. La società, infatti, non è né un sistema, né un meccanismo,
né un organismo; è piuttosto una costruzione simbolica fatta di idee, significati e linguaggio, che muta incessantemente per effetto dell’agire umano,
imponendo agli individui, a sua volta, dei vincoli e delle potenzialità per
l’azione. Si tratta di un approccio, come si può vedere, che insiste non poco
sui processi tramite cui le persone definiscono se stesse (la loro identità) e
l’ambiente che le circonda. Per fare questo, esse partecipano ai loro mondi
sociali, interagiscono le une con le altre e conferiscono significato ad aspetti
specifici della loro esperienza. Ciascuno di noi, a partire dalle interazioni
sociali della vita di ogni giorno, contribuisce costantemente alla costruzione
di tutte queste realtà sociali.
In anni a noi più vicini sono emersi con maggiore evidenza anche
gli aspetti più retorici di questo processo di costruzione: è un processo, in
effetti, in cui intervengono anche dinamiche di persuasione — di se stessi
e degli altri — che una data interpretazione della realtà sia più legittima, o più credibile, di una qualsiasi altra. Michael Billig (1987) e John
Shotter (1993), ad esempio, hanno analizzato il pensiero come processo
retorico, rispetto a cui la conversazione e il linguaggio sono gli strumenti
chiave per comprendere l’identità soggettiva. Il pensiero non è visto, cioè,
come attività privata o personale, bensì come processo «micropolitico» e
interattivo che ha a che vedere con la categorizzazione della vita quotidiana
e lo sviluppo di argomenti atti a giustificare le realtà che si preferiscono
e i corsi d’azione che si decide di intraprendere. Nella stessa prospettiva,
Potter e Wetherell (1987) sostengono che il linguaggio sia deputato a ordinare le nostre percezioni della realtà e, in questo senso, «faccia accadere»
le cose. Secondo gli autori citati, i cosiddetti «testi sociali» — per usare la
loro espressione — non sono un mero riflesso (o un «rispecchiamento»)
degli oggetti, degli eventi e delle categorie esistenti nel mondo sociale e
naturale, ma contribuiscono attivamente a costruire una versione di tutte
queste cose. Non si limitano a descrivere gli oggetti, ma li creano, e quindi
hanno ripercussioni di ordine sociale e politico. Queste «costruzioni»,
infatti, possono avere implicazioni del tutto reali per le persone che ne
risultano coinvolte. Ognuno di noi, nell’ambito dei processi di apprendimento che ci portano all’età adulta, deve imparare — se vuole che gli
altri lo ritengano persona seria e affidabile, che ha «i piedi per terra» — a
rispondere in modo adeguato a chi, per un motivo o per l’altro, potrebbe
mettere radicalmente in discussione ciò che pensiamo o diciamo. Per fare
58
Il servizio sociale postmoderno
questo, dobbiamo anche imparare a conversare con noi stessi: dobbiamo
parlare, cioè, acquisendo la consapevolezza del fatto che ciò che diciamo
potrebbe essere criticato dalle fondamenta, il che ci richiederebbe di saperci «giustificare» prontamente. Ne deriva una forma di linguaggio che è
retorica, più che referenziale o figurativa: più che limitarsi a raffigurare o
a riflettere uno stato di cose o una realtà esterna, la parola e il linguaggio
hanno l’effetto di indurre gli individui ad agire e, magari, a modificare
le proprie percezioni e opinioni. In quest’ottica, il linguaggio non solo
costituisce la realtà, ma contribuisce attivamente a modificarla.
L’interesse per il costruzionismo, nelle scienze sociali, ha trovato impulso
anche grazie all’emergere di un’ampia schiera di approcci e modelli teorici
denominati, di volta in volta, «postmoderni», «post-strutturali», «tardomoderni» e «post-tradizionali». Queste nuove correnti teoriche hanno prodotto
un terreno assai fertile per un ulteriore sviluppo del costruzionismo sociale
(Lyotard, 1984; Turner, 1990; Featherstone, 1988; Smart, 1999). Al di là
del comune orientamento culturale verso concetti come l’eterogeneità, la
frammentazione e la differenza, gli approcci «postmoderni» sono accomunati
soprattutto dalla critica della modernità. È proprio sotto quest’ultimo aspetto
che essi hanno prodotto i risultati più rilevanti, per quanto controversi.
La modernità, come categoria concettuale, fa riferimento alla costellazione dei sistemi sociali, economici e politici che si sono affermati in Occidente,
a partire dall’Illuminismo, nel diciottesimo secolo. L’assunto di fondo del
pensiero della modernità è che l’ordine umano non sia né «naturale» né
«fissato da Dio», ma possieda una natura vulnerabile e legata fortemente
alle contingenze storiche. Grazie allo sviluppo e all’applicazione della scienza, tuttavia, è possibile sottomettere la natura al controllo dell’uomo. Gli
aspetti distintivi della modernità, rispetto ai paradigmi delle epoche storiche
precedenti, si possono riassumere in questi termini: la lettura della storia
come processo caratterizzato da una direzione definita, quella del progresso;
il tentativo di elaborare categorie dell’esperienza umana di valore universale;
l’idea che la ragione possa fornire le basi per qualsiasi tipo di attività umana;
l’idea che lo Stato-nazione sia il principale protagonista di questo sviluppo,
che dovrà abbracciare l’intera società. Il principio guida della modernità
è quindi la ricerca di fondamenta stabili e universalmente provate per la
conoscenza umana. Lo scopo è identificare le «verità essenziali» sul mondo,
ma partendo dall’assunto che la verità non si esprime nella superficie delle
Le professioni sociali nella postmodernità
59
cose, ma si nasconde dietro le apparenze. I due elementi cruciali della modernità, nel periodo successivo all’Illuminismo, erano quindi rappresentati
dall’oggettività scientifica e dalla razionalità politico-economica, chiamate
a unificarsi progressivamente tra loro (Parton, 1994).
Nell’«ordine cognitivo» della modernità, ciò che più importa è produrre conoscenze, rispetto a un dato aspetto del mondo fisico o del mondo
sociale, che consentano di acquisire maggiori certezze. A quel punto diventa
possibile conferire a tali conoscenze i crismi della «verità», e assegnare quindi
ai soggetti che producono tali conoscenze (come gli scienziati o i professionisti) il titolo di «detentori della verità» — o di esperti — in merito a quello
specifico aspetto del mondo (Flaskas, 1997).
Nell’epoca contemporanea, tuttavia, si tende sempre più spesso a riconoscere che il mondo in cui tutti abitiamo è diventato confuso, instabile,
esposto a ogni sorta di incertezze — o, come altri direbbero, di «rischi». La
ricerca dell’ordine e del controllo sociale, il principio della «calcolabilità» di
tutte le cose, la fede nel progresso, nella scienza e nella razionalità — per citare
soltanto alcuni dei tratti distintivi della forma mentis moderna — sono messi
apertamente in discussione dall’effetto simultaneo di una serie di condizioni
e di esperienze che si pongono in drastica rottura con il passato. Pensiamo,
anzitutto, alle trasformazioni di ordine sociale, economico e culturale che
hanno caratterizzato l’ultimo scorcio del Novecento, in termini di: processi
di globalizzazione; aumento della rilevanza sociale dei mass media, e soprattutto dei networks globali delle tecnologie dell’informazione, che trasmettono
— e al tempo stesso trasformano — conoscenze; stravolgimenti nei modi di
consumo e di produzione; non ultimo, diffusione della consapevolezza del
rischio e dell’incertezza a cui ciascuno di noi si trova esposto. Più alla radice,
le trasformazioni di cui parliamo hanno avuto luogo a livello ontologico
(chi siamo, e che senso ha il nostro essere) ed epistemologico (in che modo
conosciamo ciò che conosciamo). È come se la promessa della modernità
— assicurare ordine, certezza e sicurezza — non fosse stata mai esaudita; si
avverte in modo via via più diffuso che non esiste alcun criterio trascendente
e universale per definire la verità (nel campo della scienza), il giudizio (per
l’etica) e il gusto (per l’estetica). La fiducia di fondo nella ragione e nella
razionalità va scomparendo, e perdono credibilità le cosiddette «grandi
narrazioni» (ossia le teorie o le spiegazioni che ambiscono ad avere portata
universale), con la loro presunta articolazione evolutiva di progresso, emancipazione e perfezione; perde consenso, parimenti, ogni tentativo di fissare
60
Il servizio sociale postmoderno
i fondamenti ultimi dell’autorità e della verità. Il rifiuto dell’idea che esista
una teoria o un sistema di valori capace di rivelare una «verità ultima», e
l’apertura alla pluralità delle verità possibili, nonché il «desiderio di verità»,
sono alcuni degli aspetti salienti associati alla «postmodernità».
La verità, in epoca postmoderna, non assume alcuna particolare consistenza: non è né «il verbo di Dio» (come in epoca premoderna), né più
corrisponde alla ragione umana (tipica della modernità), ma si rivela sempre
più decentrata e localizzata: sono possibili più «verità» tra loro diverse, in
funzione di tempi e di luoghi diversi. Il «postmoderno» tende a ribaltare
dalle fondamenta l’idea alla base della modernità: che il modo in cui si rappresenta un oggetto — per dirla un po’ schematicamente — rifletta la sua
più intima realtà. Se nulla è necessariamente o eternamente vero, allora, allo
stesso modo, nulla è sempre e comunque reale. In un mondo in cui qualsiasi cosa è sempre più mediata e ricodificata da sistemi di rappresentazione
complessi, i simboli di cui facciamo uso assumono vita propria e significati
autonomi: non sulla base della realtà che dovrebbero rappresentare, bensì
in relazione al contesto in cui sono utilizzati.
Va anche detto, peraltro, che vi sono probabilmente tante forme di
«postmodernismo», quanti sono i cosiddetti «postmoderni». In una realtà
così eterogenea, Rosenau (1992) ha individuato due orientamenti di fondo
che hanno contribuito, più degli altri, a elaborare il concetto di lavoro sociale costruttivista. L’autrice suggerisce una distinzione tra i postmoderni
«scettici» e i postmoderni «assertivi». I primi hanno una visione sfiduciata,
pessimistica, negativa, e persino oscura dell’epoca contemporanea: segnata
da frammentazione, disintegrazione, mancanza di senso, assenza di punti
di riferimento morali, disordine sociale. Sarebbe questo, per citare l’autrice,
il «lato oscuro del postmoderno»: il postmoderno della disperazione, che
si esprime con slogan come «scomparsa», «fine dell’autore», «impossibilità
della verità» e «abrogazione di ogni ordine di rappresentazione». Questa
prospettiva punta soprattutto alla natura intimamente distruttiva della
modernità: ne emerge uno scenario di inaggirabile incertezza, entro cui
dominano estraneità, disperazione e ambiguità, e non esiste alcun progetto
sociale, politico o di altra natura per cui valga la pena spendersi. Dopotutto,
se non vi è alcuna verità — come gli scettici vanno affermando — tutto
quello che ci rimane è il gioco, in una sorta di farsa: la farsa di chi gioca
con le parole e i significati.