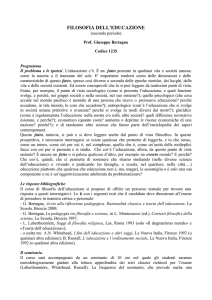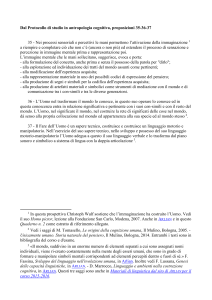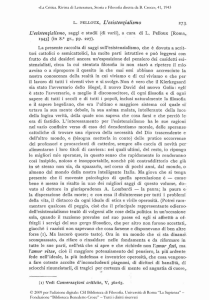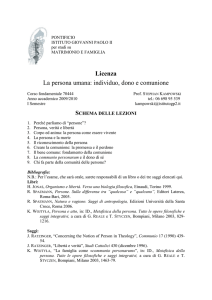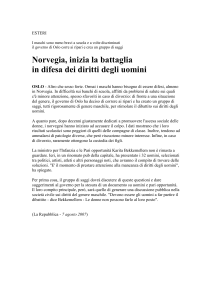RIVISTA QUADRIMESTRALE - ANNO XIV
NUOVA SERIE - N. 41 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2000
Pubblicazione quadrimestrale promossa dal Dipartimento di filosofia
dell’Università degli Studi di Lecce, con la collaborazione del “Centro Italiano
di Ricerche fenomenologiche” con sede in Roma.
Questa rivista si pubblica anche con i contributi del Ministero dell’Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, attraverso il Dipartimento di Filosofia
dell’Università degli Studi di Lecce, e dello stesso Dipartimento.
2
Direttore responsabile: Giovanni Invitto
Comitato scientifico: Angela Ales Bello (Roma), Antonio Delogu (Sassari),
Giovanni Invitto (Lecce), Aniello Montano (Salerno), Antonio Ponsetto
(München), Mario Signore (Lecce).
Redazione: Doris Campa, Daniela De Leo, Lucia De Pascalis
Comitato Scientifico e Segreteria hanno sede presso il Dipartimento di Filosofia,
Università degli Studi - Via M. Stampacchia - 73100 Lecce - tel. (0832) 336627/8;
fax (0832) 3366626.
Amministrazione, abbonamenti e pubblicità: Piero Manni s.r.l., Via Nino Bixio,
11/b - 73100 Lecce - Tel. e Fax. 0832/387057. Iscritto al n. 389/1986 del Registro
della Stampa, Tribunale di Lecce. Abbonamento annuo: Italia lire 40.000, Estero
lire 76.000, c/c postale 16805731 intestato a Piero Manni s.r.l., Lecce.
L’abbonamento, in qualunque mese effettuato, decorre da gennaio e dà diritto a
ricevere i numeri arretrati dell’annata. Un fascicolo lire 18.000, degli anni precedenti il doppio.
SOMMARIO
5
Alessandro Longo
I SENTIERI DELLA CONTINGENZA
SARTRE E LA FINE DELLE METAFISICHE
16
Aurelio Rizzacasa
IL PROBLEMA DELLA CORPOREITÀ
NEI “MANIFESTI METODOLOGICI” DI G. MARCEL
25
Stefano Berni
ALBERT CAMUS.
DAL RELATIVISMO ALLA RELATIVITÀ
31
Licia Semeraro
LA FILOSOFIA DEI “NON FILOSOFI”.
IL DIVERSO FILOSOFARE DI ALDO CAPITINI
40
Federico Leoni
LA CITTÀ DEL FOLLE
LIMITE, DELIRIO, SCRITTURA IN UN SAGGIO DI ROLAND KUHN
55
Attilio Pisanò
IL DIRITTO DEI POPOLI ALL’INDIPENDENZA POLITICA
65
Alessandra Lezzi
IL PROGETTO DI LEGGE SULLA FECONDAZIONE ARTIFICIALE
NEL DIBATTITO ITALIANO
76
Recensioni
126
Pubblicazioni ricevute
NOTE PER GLI AUTORI
La nuova serie di “Segni e comprensione”, con un nuovo editore, comporta anche alcune varianti tecniche.
I contributi vanno inviati alla Direzione di “Segni e comprensione” c/o Dipartimento
di Filosofia – Via V. M. Stampacchia 73100 Lecce. I testi debbono essere inviati in duplice
copia, su carta formato A4, dattiloscritta su una sola facciata, a doppia interlinea, senza correzioni a mano. Ogni cartella non dovrà superare le duemila battute. Il testo deve essere
inviato assolutamente anche su “floppy disk”, usando un qualsiasi programma che, però,
dovrà essere indicato (Word, Windows, McIntosh). Il materiale ricevuto non verrà restituito.
Per la sezione “Saggi” i testi non dovranno superare le venti cartelle comprese le note
bibliografiche, per la sezione “Note” non dovranno superare le sette cartelle, per la sezione “Recensioni” e “Notizie” le tre cartelle.
Si raccomanda che i titoli siano brevi e specifici. La redazione si riserva il diritto di
apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie, previa comunicazione a approvazione dell’Autore.
Agli Autori saranno inviate tre copie del fascicolo in cui appare il loro lavoro.
4
I SENTIERI DELLA CONTINGENZA.
SARTRE E LA FINE DELLE METAFISICHE
Il ’900, nella filosofia occidentale, è caratterizzato dall’abbandono diffuso
delle categorie mentali fino ad allora imperanti, che imprigionavano l’uomo e il
mondo in un regno di “essenze”, principi “universali”, “idee”. Si cessa di considerare la realtà retta da leggi assolute (divine e non) che ne governino il
senso: sia la metafisica sia la dialettica hegeliana “credevano” ad un mondo
“regolato”, ordinato sulla base di costanti sottese alla vita e al reale; Stirner
seguito da Nietzsche, nel 1800, è il primo a mettere in discussione queste certezze: l’essere è infondato, non ha ricevuto una direzione da nessuno, né da
dio né da una legge razionale, è puro fluire caotico in cui l’uomo cerca, senza
missione, senza vocazione alcuna, di costruirsi un’abitazione. È la contingenza: non ci sono realtà assolute su cui fare affidamento, ma soltanto soggettive e prospettiche. L’uomo è finalmente solo nell’universo, come già Leopardi
intuiva: la contingenza, l’imprevedibilità del reale, è una delle caratteristiche
peculiari del ’900.
L’avvento del pensiero della contingenza non è soltanto una questione filosofica: è in generale la cultura dei popoli occidentali che si trasforma, accettando la nozione di caoticità e il crollo di antiche certezze. La filosofia, insieme
ad altri aspetti dell’umano (come l’Arte e la politica), è uno dei campi della trasformazione del modo con cui l’uomo si vede e si rapporta al mondo. Il caso
e la contingenza assunti come elemento centrale di una filosofia, potrebbero
dare adito ad un’interpretazione a sfavore della libertà del soggetto, abbandonato all’imprevedibile e all’impossibilità di organizzare il suo universo. Uno
degli aspetti fondamentali della filosofia di Sartre sin da L’Essere e il Nulla è
invece proprio quello di far scaturire la libertà dalla contingenza. Sartre, infatti, è uno dei filosofi che più ha esplorato i sentieri della contingenza, ricostruendo il vero spazio dell’uomo sul nulla, ovvero sul senso soggettivo con cui
l’uomo colora l’Essere. L’uomo annulla l’Essere poiché da una parte non può
creare altra materia ed altro Essere, e poiché, dall’altra, questo è infondato e
contingente, non ha un senso univoco inscritto, quindi è malleabile in base ai
progetti soggettivi che si intraprendono. Ecco la contingenza assunta da
Sartre come premessa della libertà dal destino e dai dogmi che derivano dalla
fede in esso. La posizione dell’infondatezza dell’Essere è assunta fortemente
ne L’Essere e il Nulla (1943), in chiave ontologica: la libertà teoretica dell’uomo è possibile solo perché l’essere non ha una direzione pre-assegnata; così,
del tutto gratuitamente, e per questo liberamente, l’uomo può dargli un senso
completamente soggettivo, composto di progetti e azioni. Se l’uomo non può
più contare su nessun punto di riferimento assoluto e smette alla fine di guardarsi intorno, di costringere la novità del reale in qualcosa di artificiosamente
SAGGI
di Alessandro Longo
5
6
(e illusoriamente) familiare, è libero: solo ma senza catene nel gratuito delle
sue quotidiane creazioni. Il ragionamento di Sartre porta quindi alla conclusione che la realtà non è stata creata perché la abitassimo, ma dobbiamo accettare il nostro nomadismo interiore per raggiungere la vera autonomia intellettuale, togliere la maschera divina o razionale alla realtà per sondarne gli abissi, scoprire l’orrore dell’inumano per trovare la libertà e l’autentico.
Com’è noto, negli anni ’60 Sartre si occupa sempre più del problema della
storia: nella Critique de la Raison dialectique, in modo particolare nel secondo
tomo (postumo), Sartre ritorna sulla contingenza dell’essere, ma ora in termini storico-dialettici; senza contraddire le precedenti formulazioni dell’infondatezza, vi aggiunge la dimensione della storicità. In sintesi, Sartre analizza ora
non solo le modalità con cui il soggetto costruisce la sua realtà e libertà sull’infondatezza, ma quelle di tutto il divenire storico e degli apparati sociali.
L’essere è infondato, ma questa infondatezza non avvolge soltanto le azioni
soggettive, nei loro percorsi individuali, ma l’intera costruzione sociale, che
organizza dialetticamente i rapporti interumani. La contingenza rimane il
perno: ma solo dopo la Critique, essa alimenta anche l’analisi della storicità e
del sociale. La dialettica è la legge della storia: i sistemi sociali, economici,
politici e le soggettività che vi sono racchiuse sono in rapporto dialettico, ovvero si influenzano a vicenda. Non solo per comprendere la Storia, ma anche i
singoli uomini, bisogna fare riferimento ai rapporti dialettici: così, Flaubert è
compreso da Sartre, ne L’idiot de la famille (tra le ultime grandi opere di Sartre,
negli anni ’70), alla luce dei rapporti tra la sua famiglia e il milieu, ovvero del
secolo in cui visse, nei suoi aspetti economici, culturali ed anche letterari
(essendo Flaubert uno scrittore). La sua vita così ha risentito del fatto che il
padre era un borghese dell’800, legato ad un’idea aristocratica di famiglia ma
anche ambizioso e così via. Tutti questi insiemi caratterizzano la costituzione
di Flaubert: ma l’uomo non è solo il suo passato, ma anche il modo con cui
vive la situazione in cui è immerso. Così Flaubert va compreso anche nella
sua personalizzazione, del tutto soggettiva e libera, dell’inferno familiare e
sociale in cui nacque. Tale libertà (dei soggetti dai sistemi e dei vari sistemi,
sociali, politici, etc, tra di loro) all’interno di determinazioni dialettiche poggia,
come quella ontologica de L’Essere e il Nulla, sulla contingenza dell’essere,
che adesso diviene cifra basilare anche dei rapporti storico-sociali.
Il fulcro della questione è esplicitato meglio nel tomo postumo della
Critique, che avrebbe dovuto completare e sviluppare le questioni del primo
tomo, pubblicato nel 1960. Sartre voleva soprattutto approfondire, nel secondo tomo, la questione dell’intelligibilità della storia, cioè se questa ha un senso,
se è comprensibile in ogni caso; ed egli cerca di comprendere tutte le relazioni tra la struttura globale e le singole parti della società, per congiungerle tutte
in un nodo dialettico dinamico e rigoroso. Molti concetti rimangono però “aperti” nella stesura incompiuta, di cui è lo stesso Sartre che dice: “Pubblicati dopo
la mia morte, questi testi rimangono incompiuti, così come sono, oscuri, perché in essi formulo delle idee che non sono completamente sviluppate. Sarà
compito del lettore interpretare dove avrebbero potuto condurmi”1. La maggior
parte dei critici crede che l’abbandono dell’opera, a differenza di altre sartria-
SAGGI
ne pubblicate postume, non sia dovuto ad un’impasse concettuale insuperabile al momento dal filosofo, ma da un cambiamento di interessi da parte sua;
Arlette Elkaïm Sartre, che ha curato la critica e la pubblicazione di questo tomo
e di molti altri testi postumi, sostiene nella prefazione che le tante tematiche
abbozzate avrebbero costretto Sartre ad un immenso lavoro di ricerca, mentre egli era già rivolto ad altri progetti, come Le parole e poi il monumentale
Idiot.
La parte centrale del secondo tomo della Critique affronta proprio il tema
della contingenza, analizzandola alle radici: è necessario infatti partire dalla
base per riuscire a cogliere l’intelligibilità profonda dei processi storici e umani.
Così vi si afferma che la realtà è fatta, primariamente, di stati e di trasformazioni d’energia. Una realtà quindi fisico-chimica caotica e totalmente non
umana: è l’aspetto originario della contingenza dell’Essere. L’interiorità, ovvero il progetto umano, giunge come mediazione, autonoma, e rottura insieme di
questi stati e trasformazioni, come limite interno della dispersione dell’essere:
l’essere è il tutto di cui siamo composti ed in cui ci troviamo, una realtà in dispersione, senza ordine, in cui noi, “dall’interno”, poniamo un senso soggettivo (limitando così la dispersione). Ne L’Essere e il Nulla il limite interno era il
nulla che ogni uomo apportava all’essere, colorandolo con le sue intenzioni,
mentre nella Critique i termini divengono dialettici ed è l’intera costruzione
umana e sociale a risultare il limite interno della dispersione dell’essere.
La totalizzazione dialettica è il processo con cui la Storia costruisce un ordine provvisorio nell’essere, con i rapporti e le relazioni dialettiche tra sistemi e
soggetti (tra economia, cultura e singola vita individuale, per esempio), è un
momento del processo dell’essere, ma eterogeneo; l’essere nel suo esserdappertutto incontra il suo stesso limite, nella misura in cui “[…] al momento
della mediazione la legge di quest’essere è fare se stesso”2. L’avventura dell’uomo, la Storia stessa come prodotto umano, è interna all’Essere, è materiale, non certo di ordine spirituale o concettuale; ma, all’interno dell’Essere, la
storia istituisce una rottura, un senso, una direzione provvisoria; questo non
sarebbe possibile se l’Essere fosse chiuso, se avesse già in sé una direzione
da percorrere, un’unica visuale possibile cui tutti gli uomini fossero obbligati ad
attenersi. Come si può vedere, confrontando con quanto detto prima, il ragionamento alla base de L’Essere e il Nulla, che reggeva la libertà soggettiva, ora
si trova alla base dell’analisi dialettica della Storia, che consiste appunto in
costruzioni e sistemi in relazione reciproca e dinamica tra loro, all’interno della
contingenza dell’Essere.
L’uomo, continua Sartre, può scorgere l’Essere solo tramite il suo limite,
ovvero come limite esterno dell’interiorità (limite esterno del progetto umano)
ogni volta che l’onnipresente inerzia trafigge l’immanenza del mondo umano.
Rapportato all’uomo (per-sé), l’essere viene chiamato da Sartre in-sé, fin da
L’Essere e il Nulla; nel tomo postumo della Critique si aggiunge che l’in-sé è
solo il modo in cui l’uomo si rapporta all’essere, ovvero l’in-sé è l’essere inteso come limite esterno dispersivo dell’interiorità. Noi non conosciamo il reale
raccordo tra cosmo e in-sé: non possiamo cogliere l’essere in senso assoluto,
separato dai nostri fini, nella sua pura inumanità. È l’essere che condiziona dal
7
8
di fuori, come Universo, la totalizzazione che è insieme deviazione nei confronti della Storia e abbandono, per il suo essere finalità in un Universo indifferente ai suoi fini. La praxis produce molteplicità quantitative, nel suo campo
sintetico, e insieme l’in-sé lavorato modifica gli agenti stessi trasformandoli in
molteplicità. La trascendenza della dispersione (ovvero il rapporto dell’uomo,
inteso come colui che trascende-supera, con la caoticità dell’essere) produce
la molteplicità: questa è quindi già un prodotto umano, non è livello zero del
caos, che ci sfugge di per sé.
Alla base di questi rapporti vi è il fondamentale contrasto-interazione tra
dialettica e antidialettica, che è la molteplicità che contamina tutto, nel campo
umano, d’esteriorità attraverso indici di separazione tra gli agenti. Per comprendere questo rapporto dobbiamo partire dall’inizio, ovvero dalla vita, dall’esistenza biologica: è questo il punto della Critica dove maggiormente, credo,
Sartre collega la libertà all’organismo (“la libertà corre rischi naturali”). La vita
biologica, come organizzazione di trasformazioni d’energia guidate, è il processo unitario su cui si poggia la dialettica, basata sempre su relazioni tra molteplicità tramite l’unità e insieme moltiplicazione dell’unità tramite l’unificazione. Infatti, si può definire la dialettica “legge vivente dell’azione”, attraverso cui
i processi umani vengono scomposti in nessi di relazione dinamici; in queste
relazioni, una molteplicità di fattori viene ricondotta all’unità di un processo
(per esempio un insieme di eventi relativamente autonomi tra loro, diventano
le cause della Rivoluzione Francese); ma la molteplicità non viene mai abbandonata, gli eventi sono correlati e contemporaneamente singolari: in questa
maniera, avviene rispettivamente anche la “moltiplicazione dell’unità tramite
l’unificazione”, poiché nell’unità del processo in cui gli eventi vengono correlati, continua a vivere la molteplicità di tutti gli eventi che abbiamo unificato.
Questo meccanismo in cui molteplicità e unità sempre si intrecciano, è riscontrabile nel suo livello più elementare, nella vita biologica. L’uomo è dialettica
costituente, mentre la Storia è definita dialettica costituita: la differenza sta nel
fatto che nella Storia vengono correlati dialetticamente uomini e prassi diverse, mentre all’interno dell’organismo esiste un’unità più profonda delle parti.
Per questo si definisce il soggetto “totalità” detotalizzata (per l’infondatezza
dell’essere che impedisce all’uomo di essere una totalità piena, fissamente
coincidente con quello che compie, aderente al proprio passato e quindi incapace di novità e libertà), mentre a livello di processi storici interumani si può
parlare solo di “totalizzazioni” continuamente affiancate da detotalizzazioni,
sempre per via della contingenza primitiva che impedisce, per gli stessi motivi, che diverse soggettività possano accorparsi in un sistema perdendo la loro
etereogenità. Riassumendo: totalità (detotalizzata) per il soggetto, totalizzazione (e detotalizzazioni) per la Storia, a causa dell’infondatezza dell’essere
che non permette la coincidenza tra noi e il nostro essere (il nostro passato,
ciò che siamo) e ancora di più è separato il rapporto tra i soggetti all’interno di
un complesso sociale che mai potrà essere considerato, à la Rousseau, un
iper-organismo di elementi fusi tra loro omogeneamente.
La dialettica dell’organismo poggia sulla base del bisogno: in lui la trascendenza è reintegrata, nell’espletazione del bisogno, in immanenza, e la
SAGGI
temporalizzazione in ripetizione circolare. L’organismo, con il bisogno, esce
fuori di sé verso l’oggetto che vuole acquisire per soddisfarsi, ma mantiene
un’unità più intensa rispetto a quella presente tra uomini di una società, in rapporti dialettici. Non dobbiamo credere che Sartre qui imposti un modello meccanicistico ed omeostatico alla base della vita: sempre in lui l’immanenza si
unisce alla trascendenza, l’unità alla molteplicità. In altre parole, esiste creatività anche a livello di espletazione del bisogno, che è la praxis e la dialettica
più elementare.
È così che dialettica e antidialettica non si possono dissociare: nella materia, la molteplicità è sia dispersione (antidialettica) e insieme occasione per il
sorgere della praxis (dialettica), che è tale in quanto si pone come unificazione di una molteplicità mai alienabile. La praxis e la vita sono della stessa natura: ogni azione si poggia sul fatto che l’uomo è di natura fisica e produce soltanto (a differenza delle piante, almeno nella situazione attuale come noi lo
conosciamo) passive sintesi di sostanze fisico-chimiche. La praxis, tuttavia,
parte sempre come decompressione (rottura) dell’integrazione organica: le
sostanze organiche che hanno pure lo scopo di mantenere la vita, sono già un
segno iniziale di praxis, perché queste sintesi passive non sono integrate nella
vita ma sono utilizzate da essa, “marcate dal sigillo della vita”. Poiché non
sono integrate, vi è un distacco marginale tra la vita biologica e gli alimenti
che, sintetizzati organicamente, servono a perpetuare la vita: quindi la vita è
già un inizio di creatività pratica. In queste condizioni, la praxis si pone come
intermediario tra le sintesi in immanenza della vita organica e le sintesi passive dell’inerte, dalla prima riceve la possibilità di fare del mantenimento della
vita il fine ultimo e, dal secondo, la permanenza e l’esteriorità che permette la
dischiusura degli obiettivi e dei sensi. In altre parole, l’uomo come attività pratica che elabora la realtà inerte, ha come punto di partenza l’attività biologica,
da cui consegue che il punto di passaggio tra organico e pratico è il bisogno
stesso. Il ciclo biologico dell’ordine organico è esso stesso inizio della praxis,
poiché, soddisfatto il bisogno, l’ordine è ricominciato, non propriamente preservato: l’organismo cambia per rimanere lo stesso. C’è un processo orientato, ma non un progresso, come nel pieno della praxis, in quanto manca una
finalità. Il fine non è in esso ma lo infesta, già trascendenza. Il progresso, nel
suo essere irreversibile, non va inteso come crescita continua, ma in una sua
contingente e momentanea storializzazione. Così l’azione è unificazione, mai
unità, di una mai eliminabile molteplicità dispersiva. Il progresso, a differenza
di tutti i semplici processi orientati, non restaura, istituisce.
L’azione organica sul mondo, animata dal bisogno, per preservarsi, diviene, tramite il milieu terrestre, exis. L’exis è il risultato, le sintesi organiche, della
tensione della vita verso il mondo, verso l’oggetto che le serve a preservarsi.
La praxis è per prima cosa trascendenza e preservazione dell’exis: allo stadio
originario, ovvero, la praxis sostiene l’attività organica; e poiché il campo d’azione della praxis è il mondo inorganico dell’inerte, l’unità organica (il processo secondo cui l’organismo mira a ristabilire l’unità espletando il bisogno) è
data come una determinazione inorganica di un’exis organica. In altre parole,
lo stesso organismo, per la mediazione della praxis che guida la preservazio-
9
10
ne dell’exis, entra in rapporto con l’inorganico. La praxis, allora, si pone nel
suo principio come mediazione di due momenti dell’organico (l’Uno della totalità che ha se stesso come fine restauratore e l’exis organica che ne deriva)
tramite l’oggetto inorganico, che, per l’intervento della praxis, sarà materia
lavorata, pratico-inerte. Arriviamo quindi alla nozione di pratico inerte, centrale nella Critique: è cio che resta, fissato, della praxis umana, è la materia stregata che continua, inerzialmente, l’azione una volta che si è conclusa. Le strutture sociali sono un esempio di pratico inerte: prodotto materiale dell’uomo, l’aspetto inerte della fludità della vita. Non c’è un valore necessariamente negativo nel termine pratico-inerte: la negatività incorre solo quando l’inerzia del
costruito imprigiona la vita ed impedisce all’uomo di separarsi da essa
costruendo percorsi originali. Da un altro punto di vista, la totalizzazione storica è trascendenza, in campo d’immanenza, sempre creativa e alla ricerca del
controllo delle sue deviazioni, causate dal pratico-inerte.
Riassumendo, la praxis coglie l’oggetto tramite la vita, alla sua base, qualificando la vita tramite l’oggetto, perché la riveste, per la sua stessa perpetuazione, delle sintesi passive dell’inorganico. La spirale dell’attività pratica si
forgia nel tentativo di unificazione dell’unità distrutta, la praxis si prende ad
oggetto e si fa condizionamento ricondizionato del proprio prodotto praticoinerte.
Forse è questo il punto ove maggiormente praxis e vita si uniscono, nella
trattazione sartriana. Infatti, l’organismo, con i suoi bisogni vitali spinge l’uomo
verso un oggetto inorganico che possa soddisfarli; in questo modo, la prassi
umana che è un livello ulteriore di attività rispetto alla vita organica, scopre da
una parte la vita come esigenza imprescindibile perché qualsiasi altra attività
possa iniziarsi; dall’altra, la prassi inizia proprio (nel suo livello originario)
ponendosi come mediazione tra i bisogni della vita e l’oggetto inorganico da
raggiungere (ha quindi il suo cominciamento con l’espletazione del bisogno);
il risultato di questa attività pratica sarà il primo pratico-inerte, che porta in sé
il residuo dell’attività pratica, solidificata nelle cose: il pratico-inerte sarà sempre poi ripreso dall’attività pratica che cercherà di reinserire tale risultato dell’attività precedente in una nuova attività. La vita e la prassi fanno tutt’uno nell’azione, quindi l’unità collasserà sempre in pseudo-integrazione, in trasformazione orientata: “[…] l’inerzia che sostiene la permanenza delle proprietà è dischiusa dall’azione stessa come un atto che produce quella permanenza”3. La
permanenza della vita è exis, quindi come ripetizione dell’oggetto, la cui molteplicità, sempre mediata dalla praxis creatrice, sarà continuamente temporalizzata. In altre parole, le molteplicità delle sostanze saranno solo sostituite
dall’infinita divisibilità del tempo, che è la misura in cui la materia viene umanizzata. Nella storia, la totalizzazione è evento storico, mentre il pratico-inerte
è il suo rovescio inerte come apparizione dell’altro; da qui il continuo tentativo
di ripresa dell’inerte da parte dell’uomo, che cerca di riappropriarsene, sfuggendo alle deviazioni pratico-inerte, con la trasformazione pratico-storica di
esso, reale e materiale.
La praxis, ripetiamo, è passaggio dall’inorganico all’organico: la trascendenza emerge dal bisogno, come esplosione del ciclo organico e rottura per la
SAGGI
scarsità (la penuria è il motore passivo della dialettica, proprio perché è presupposto del bisogno e della lotta antagonistica degli uomini nella situazione di
scarsità); l’azione pratica produce un’efficacia inorganica governando la sua
inerzia per agire sull’inerte. Il ciclo è quello dell’adattamento, ma non meccanicistico: “Dal momento in cui l’organismo realizza modificazioni fuori alla luce di
un obiettivo, possiamo parlare di un atto. E questa definizione è sufficiente per
mostrare che le prime attività pratiche sono lontane dal cominciare con le specie umane ed anche con i mammiferi. Se solo le azioni umane ci riguardano
qui, è perché […] esse sono le uniche sulla Terra ad essere integrate in una storia. […] La necessità (derivante dall’oggetto) di ridurre prima alcuni ostacoli o
altri (tramite movimenti loro stessi separati o separabili) poi risolvere alcune difficoltà (attività preparatorie) e afferrare la materia con alcuni trattamenti o altri
(purificazione, per esempio), che manifesta essa stessa come un’esteriorità
(nell’interiorità del movimento di temporalizzazione) di ogni azione”4.
È così che il termine “negazione” importato da L’Essere e il Nulla, diventa
invenzione in quanto azione di negazione dell’organico tramite l’organismo,
che trascende la materialità inorganica della non vita, una volta attaccato dall’esteriore. La praxis è tra vita e inerte anche in produzioni più complesse,
come quelle delle macchine, che permettono di perpetrare compiti che l’organismo da solo non potrebbe. L’azione pone la sua autonomia dalla vita nel preciso istante in cui la vuole perpetuare: la creatività così è connessa all’organico, nel momento stesso della separazione tra praxis e vita.
Il blocco d’esteriorità in permanente dispersione, l’inerte massività, essendo senza parti distinte, è un insieme di quasi-unità indifferenziate. Questo si
dischiude a noi nella sua indistinzione, e non possiamo che coglierlo come
blocco pre-quantitativo, ovvero in vista della sua quantitavizzazione da parte
dell’uomo. In un caso più semplice di lavoro, l’inerte appare, inevitabilmente,
nel nostro campo, ma possiede ancora un suo coefficiente d’indistinzione: p.e.
il movimento degli occhi sulla montagna, come operazione nella sua più semplice espressione, al minimo costo; solo in relazione al suo futuro, ovvero
come preparazione alla salita, questo movimento sarà inteso come conoscenza e pensiero; l’essere si costituisce in molteplicità quantitativa da unificare ed è reso divisibile, infinitamente, con l’unità di elementi indivisibili, imposta dalla praxis: la dispersione e l’unità abitano insieme il campo pratico; non
è possibile che l’uomo colga la dispersione-caos allo stato puro e nemmeno
possa essere unità granitica, perché il suo intervento sarà sempre un tipo di
unificazione della dispersione, un’attività in cui nessuno di questi due termini
verrà mai a mancare.
La conoscenza è invenzione, le leggi del conoscere sono contigue a quelle dell’essere e del fare. La scienza si muove in base ad una struttura della
materialità e a delle esigenze attive connesse reciprocamente alle contingenze storiche e materiali. Ancora un’occasione per sottolineare le cogenze dell’inerte: la storia sarebbe completamente diversa se l’uomo potesse respirare
l’acqua o la fisica seguisse altre leggi o semplicemente la geografia del mondo
fosse stata diversa. L’uomo fa la storia, ed è fatto da essa, ma anche la storia
si sviluppa in base ad una data struttura dell’essere.
11
12
La praxis ha un oggetto, un costo in termini d’energia, che determina il
carattere d’irreversibilità dell’azione, ma i momenti di essa non sono isolati,
sono illuminati dal fine. La ragione borghese è ferma alla ragione analitica: i
soggetti sono smembrati nelle funzioni, come se ci si riferisse ad un cervello
elettronico. Gli uomini sono così macchinizzati, in un’ottica efficientista, in
base alle esigenze della produzione. La ragione analitica vede gli uomini come
se si descrivesse una partita di bridge in base alla posizione delle carte ad
ogni manche. In realtà, lo stesso progresso della scienza e delle macchine, è
comprensibile solo in relazione al campo pratico umano; con l’invenzione, al
limite, della macchina che produce altre macchine, si arriva sì a sempre maggiori determinazioni inerti inorganiche sull’organismo, ma con il fine ultimo di
rendere l’agente più capace di controllare quest’ultimo: l’organismo pratico
resta al centro, in quanto si cerca sempre di ridurre la scarsità, soddisfando i
bisogni della vita. Quello che conta è se questo fine poi si aliena in esteriorità,
come nel capitalismo, o è vissuto nella solidarietà tra uomini liberati, sostiene
Sartre. Ciò che è necessario ricordare è che, a tutt’oggi, nella storia come la
conosciamo, esiste un fine che la praxis non può trascendere, da cui si deve
partire: la preservazione della vita (si comprende anche la riproduzione). Nulla
di meccanico, nessun istinto a tergo: è solo il carattere materiale del nostro
essere finiti, cui bisogna misurarsi, vivendolo immediatamente in interiorità
(noi siamo il nostro corpo). E la perpetuazione della vita si può oggettivare,
sempre per le caratteristiche contingenti della materialità, nell’inerte.
L’organismo nega il bisogno: l’azione, riassumendo in sé l’organico, è così
negazione di negazione. L’organismo diventa agente, la circolarità della vita è
rotta con una trascendenza reale. Con la soddisfazione del bisogno, l’organico dissolve in sé l’agente, ma questo permane nell’inerte come sintesi passive (pratico-inerti), rimane come exis. E così l’azione dell’uomo è ricondizionata (shock à retour) dai suoi prodotti. Sempre di più, con la tecnologia, l’organico tende a fare da supporto all’atto, l’agente è sempre più qualificato alla luce
della sua trascendenza pratica dell’inerte. L’azione si allontana sempre più
dalla sua relazione con la riproduzione della vita, ancor di più a causa della
divisione del lavoro. In questa situazione, l’atto vorrebbe considerarsi autonomo, seguente se stesso come fine. Ma “il mondo-dei-fini-in-sé (come sintesi
inanimate) non ha sufficiente essere e può esistere solo in relazione ad una
duplice fondazione: perpetuazione dell’organismo, come un fine trascendente
all’azione; e la dialettica stessa, come una legge di trascendenza creativa di
tutti i sensi verso un fine, e come dissolvente in esso tutte le sintesi inerti”5.
Così il pratico-inerte stesso esiste solo, basilarmente, in virtù dell’esistenza di
un fine relato alla preservazione dell’organismo. Sono i bisogni a mettere in
moto la gigantesca macchina economica, ma questo non vuol dire che essa
non possa produrre crisi o che la classe dominante ponga allo stesso modo di
quella sfruttata, il soddisfacimento dei bisogni. Il lavoratore è tale per un salario necessario alla soddisfazione di questi, il profitto poggia sulla scarsità della
merce; anche l’artista deve assumere, come senso imprescindibile, il suo
mantenimento. Comunque, questo non toglie che un atto possa avere come
fine anche il raggiungimento di obiettivi diversi dalla soddisfazione dei bisogni
SAGGI
(p.e. culturali), ma rimane una base organica6, insuperabile anche in una
società senza scarsità.
Nella situazione attuale, per ciò che riguarda il carattere di pressione sul
soggetto, sono più le esigenze del pratico inerte (del “sistema” sociale) a farsi
sentire, che quelle dei bisogni (ma esse sono strettamente connesse).
Il discorso sui bisogni è importante anche in un’altra ottica, quella del rapporto potere-bisogni: per esempio, la “distinzione” deriva da questa relazione.
È noto che con questo termine Sartre indica un atteggiamento tipicamente
borghese, consistente nella (apparente) superiorità nei confronti dei bisogni
(intesi nella loro accezione specificatamente corporea). È un atteggiamento
maturato nel periodo in cui, storicamente, la borghesia, terminata la sua prima
fase aggressiva, rinsalda le sue posizioni con l’appoggio dei poteri tradizionali (circa nell’800). Uno dei drammi della borghesia consiste nel fatto che il suo
potere non è connesso a qualcosa di stabile e assolutamente dato, come la
nascita, su cui si fondano i privilegi giuridico-sociali dello status nobiliare. Le
concezioni borghesi sull’uomo sono così caratterizzate da un umanesimo
astratto, di cui parla anche nel terzo volume dell’Idiot. La distinzione, ottenuta così in parte astenendosi in parte nascondendo i bisogni, da una parte era
finalizzata ad emulare l’aristocrazia, dall’altra, alla sicurezza giuridica e formalizzata del proprio status.
D’altra parte la borghesia tiene d’occhio il proletariato (propriamente: lo
guarda, nel senso sartriano, ovvero cerca di renderlo oggetto), avverte il suo
odio e matura un contro-odio. Il sacrificio del borghese, quindi ha come fine sia
il distinguersi dalla povera gente, più legata ai bisogni e a trovare una giustificazione al proprio dominio, tramite il sacrificio nobilitante; quest’ultima cosa è
dovuta anche al confronto con l’aristocrazia, da parte della borghesia divenuta classe dirigente: a differenza dei nobili, i borghesi mancano di titoli che
diano loro una superiorità originaria e “di sangue” rispetto al restante genere
umano e quindi necessitano del sacrificio per dimostrare una forma di superiorità “di merito”, rispetto alla classe dominata.
Ancora, il rapporto potere-bisogni, può essere colto nell’influsso che ha
l’oppressione sulla sessualità dell’oppresso, come afferma sempre nel secondo tomo della Critique. Già nel Saint Genet, come sottolinea in nota, nel tomo
postumo, la Elkaïm-Sartre, si vedeva come, per il bambino, l’intrusione adulta, che eticamente era avvertita come una condanna, sessualmente veniva
avvertita come stupro. Sartre analizza le contro-finalità dell’oppressione sul
corpo e della sussunzione delle energie vitali-sessuali.
Questo discorso è continuato, come tutto del resto, nell’ Idiot: la sessualità
Flaubertiana, definita androgina, passiva, è risultato della sua impotenza, della
sua costituzione passiva. Infatti, Flaubert, per una serie di motivi (l’infanzia e
il rapporto con i familiari, la situazione sociale della borghesia dell’800, cui i
Flaubert appartenevano) si è costituito fin dai primissimi anni come soggetto
passivo, incapace di mettere in discussione la sua situazione: questa condizione si riversa anche nella sua sessualità, tendente al masochismo.
Nella Critique sono visti casi più generali e a livello di insiemi sociali: “Lo
sfruttamento del contadino –la violenta azione esercitata sul suo corpo, e sui
13
14
ritmi organici definenti il comportamento– è vissuto da lui radicalmente, a livello del sesso, come castrazione […] irreparabile deficit ” 7. Il termine incarnazione, così, rivela un suo collegamento al corpo ben oltre una mera metafora:
tutto è materia, e negli esseri viventi tutto è corpo.
La coppia pure è “sociale”, ovvero il rapporto tra i coniugi ha un ruolo e una
posizione che supera la dimensione prettamente domestica e privata: istituzionalizzata nel matrimonio, la coppia si integra in unità mediata e non-trascendibile, tramite la mediazione della società tutta nelle sue incarnazioni.
Questa è l’alienazione del soggetto nel suo essere parte del tutto-coppia. Così
vengono interiorizzate nella coppia le gerachie e le non reciprocità (p.e.
maschilismo) che fondano il campo sociale. E la non reciprocità si feticizza in
carne come erotismo.
Si noterà come il discorso sulla contingenza abbracci sempre più, in Sartre,
il tema dell’importanza della materialità, sia intesa come bisogni organici, sia
nel suo significato più cosmico e inumano. La critica ha riconosciuto la tendenza di Sartre, dagli anni ’60, ad approfondire l’analisi della storia e della dialettica (la sua cosiddetta “apertura al mondo”), ma è meno noto il crescente
interesse sartriano nei confronti della materialità e dell’inerte, che assumono
un ruolo sempre più centrale ed attivo nel suo sistema filosofico.
Adesso, rispetto a L’Essere e il Nulla, si cerca di connettere più profondamente l’azione alla materialità del corpo, mentre prima l’incarnazione e la scelta sessuale sembravano essere più soggetti ad una relazione-cortocircuito,
nel conflitto temporaneamente mediato tra carne e coscienza. L’uomo, con il
desiderio sessuale, temporaneamente “incarna” la propria coscienza, la rende
carne: ne L’Essere e il Nulla l’incarnazione era vista come fenomeno 1)temporaneo 2)in relazione alla coscienza soggettiva 3) con accenti negativi. Nella
Critique, abbiamo visto, la questione assume un ruolo più importante, più attivo e centrale e insieme si storicizza. Lo dice Sartre sempre nel tomo postumo:
“Ho già spiegato altrove come il corpo si faccia carne. Ma bisogna aggiungere anche che la carne diviene atto”8. Atto e passione, agire attraverso la propria passività sulla carne dell’altro: il desiderio si fa atto carnale, la carne nella
sua solitudine e contingenza, è trascesa verso la solitudine e contingenza dell’altro. Nell’istante della praxis sessuale, c’è insieme singolarizzazione e totalizzazione, rapporto con l’inerte e con un’altra libertà: forse, dice, è proprio
questo il momento di maggiore interdipendenza di tutti questi fattori. Da questo emerge il concetto di individuo socializzato sessualmente.
Il bisogno quindi è un elemento fondamentale della dialettica costituente
(del soggetto) e costituita (della storia), ma in generale l’inerte cosmico, come
dispersione della molteplicità, come abbiamo visto sin’ora, costituisce la vera
base della totalizzazione storico-umana. In un recentissimo testo9 Sicard
sostiene che l’estetica sartriana si apra, nelle ultime fasi, sempre più alla dimensione della materialità: l’immagine diventa per Sartre uno spazio geografico,
non il simbolo di una trascendenza. Mentre il concetto di simbolo trova il suo
senso all’esterno, l’immagine lo possiede già internamente, come realizzazione concreta di un mondo. Sartre, che prima, in opere come Imaginaire, intendeva il prodotto artistico come rappresentazione oggettivata della coscienza, in
SAGGI
un momento successivo lo studia in quanto processo materiale: questo processo verso il materiale, nella filosofia di Sartre, è un aspetto fondamentale
degli sviluppi della sua filosofia, al pari della sua nota “apertura verso il mondo
e alla storia”; è un cammino che non riguarda solo l’estetica, ma coinvolge globalmente il suo sistema filosofico, dall’analisi della storia all’etica; molti indizi a
riguardo si trovano in opere poco conosciute e postume, come appunto il
secondo tomo della Critique. Alla luce di questo, se l’attenzione alla contingenza pone Sartre a pieno titolo tra i filosofi moderni (da Nietzsche in poi), l’interesse crescente verso il ruolo attivo dell’inerte rivela un vero e proprio lato
“post-moderno” di Sartre, che lo avvicina maggiormente a pensatori come
Deleuze, come lo stesso Sicard sostiene in Immaginari di Sartre.
15
J. P. SARTRE, Autoritratto a settant’anni, Milano, Il Saggiatore, 1976, p. 88.
J.P.SARTRE, Critique de la Raison dialectique, Paris, Gallimard, 1985, Volume II, p. 338
3
Ivi, p. 348.
4
Ivi, p. 360.
5
Ivi, p. 397.
6
La stessa arte, come dice nell’Idiot, è la restaurazione dell’organico, reintegrando così i bisogni
nel campo culturale in nuove forme. E ogni azione conserva in sé, implicitamente, con un’urgenza interna, l’esistenza dei bisogni biologici.
7
Ivi, p. 268.
8
Ivi, p. 271.
9
G.FARINA, P.TAMASSIA, Immaginari di Sartre (conversazioni con Michel Sicard), Roma, Edizioni
Associate, 1999.
1
2
IL PROBLEMA DELLA CORPOREITÀ
NEI “MANIFESTI METODOLOGICI” DI G. MARCEL
di Aurelio Rizzacasa
1. Considerazioni introduttive
16
È noto che i capisaldi fondamentali del pensiero filosofico di G. Marcel sono
reperibili in tre scritti che vanno sotto il nome di “Manifesti metodologici” (i cui
dati bibliografici vengono qui riportati nelle relative “Note”). Nel presente lavoro, pertanto, prendiamo in considerazione questi manifesti a proprosito del
tema della “corporeità”, rispetto al quale il filosofo francese introduce delle
importanti riflessioni, capaci di innovare le analisi della soggettività nelle filosofie del Novecento. Comunque, per esaminare meglio la questione, è senz’altro opportuno partire da alcune considerazioni generali sulla posizione del
nostro pensatore.
Il socratismo e l’agostinismo di G. Marcel giungono –su una linea di riflessioni
che da B.Pascal si sviluppa e si perfeziona nel pensiero di S. Kierkegaard– a formulare uno spiritualismo filosofico radicato negli interrogativi ineludibili dell’esistenza umana. Da tale punto di vista, perciò, la tradizione del pensiero cristiano
viene riattualizzata in un itinerario che non prescinde dalle istanze metodologiche delle filosofie del Novecento. Così, l’esistenzialismo e la fenomenologia vengono presi in considerazione allo scopo di caratterizzare l’uomo nella sua problematicità, in un orizzonte dove il “singolo” kierkegaardiano emerge nella sua
netta opposizione all’idealismo di derivazione hegeliana.
In questa prospettiva, assumono un particolare rilievo le considerazioni che
il nostro filosofo propone in merito al tema del “corpo proprio”, distinto e contrapposto al “corpo oggetto”; ciò viene precisato allo scopo di rivalutare il corpo
vivente dell’essere umano che, nella specifica prospettiva di questa determinata antropologia filosofica, indica il momento imprescindibile dell’unità
sostanziale dell’uomo stesso, inteso, appunto, come “spirito incarnato”.
Pertanto, in senso del tutto generale, va precisato che le problematiche della
corporeità vengono affrontate da Marcel all’interno delle distinzioni tra “esser
e avere”, nonché tra “problema e mistero”. Come noto, queste quattro categorie filosofiche indicano un duplice riferimento di carattere etico-ontologico e
gnoseologico-religioso. Infatti, le prime due contrappongono l’autenticità esistenziale all’inautenticità del quotidiano, mentre le seconde individuano il limite, nonché la differenza qualitativa tra l’ambito scientifico del conoscere e l’ambito filosofico-religioso dell’apertura all’ulteriorità.
Da tale punto di vista, va senz’altro ricordato che il punto di partenza di tale
discorso è costituito, per Marcel, dalla “filosofia del concreto”; c’è però da ricor-
2. La corporeità nella relazione tra “essere e avere”
Il problema della corporeità ci permette, nella prospettiva filosofica di
Marcel, di entrare direttamente nella problematica del soggetto esistenziale.
Così, il corpo-soggetto e il corpo-oggetto si contrappongono; tuttavia, nella
fenomenologia della consapevolezza, la questione si precisa nel senso che
essere un corpo ed avere un corpo indica, a sua volta, una ulteriore contrapposizione. In questa direzione, allora, l’analisi degli elementi devianti, presenti
nella cultura contemporanea, conduce il nostro filosofo a porre in rilievo la spersonalizzazione dell’uomo contemporaneo a causa del primato attribuito all’avere ed, in particolare, all’atteggiamento dominante del possesso e alle funzioni
che lo connotano. Al riguardo, egli precisa: “L’epoca contemporanea mi sembra
caratterizzata da ciò che si potrebbe senza dubbio chiamare l’ “esorbitanza”
SAGGI
dare che quest’ultimo concetto è inteso come rivalutazione dell’immediatezza
dell’esistenza, nonché come riaffermazione del “primato della corporeità”.
Inoltre, il riferimento al concreto indica anche la radicale opposizione del
nostro filosofo ad ogni soluzione astratta, intesa a riaffermare gli assoluti filosofici universali dell’idealismo riemergente prepotentemente nella cultura filosofica della prima metà del Novecento.
Per entrare direttamente in merito alla problematica concernente la nostra
indagine, occorre anzitutto constatare che ci troviamo di fronte ad un’antropologia filosofica orientata ad addentrarsi nelle questioni specifiche attraverso la
rivendicazione del “primato dell’esistenza”. Pertanto, da tale punto di vista, viene
senz’altro posto in luce che il passaggio dall’ “oggetto” alla “presenza” indica un
approfondimento dell’itinerario riflessivo, che dalla “riflessione prima” giunge alla
“riflessione seconda”. In tale passaggio, infatti, tanto la presenza quanto la riflessione seconda individuano un avanzamento della prospettiva che, scavando
attraverso il pensiero, pone in rilievo quanto in precedenza, a livello superficiale
e immediato, poteva apparire nascosto. Infatti, a titolo esemplificativo, possiamo
avvalorare ciò considerando che la “presenza”, attraverso il momento metaproblematico del “mistero”, nell’iter filosofico di Marcel, giunge alla “fedeltà”.
Quest’ultima intesa in una dimensione etico-religiosa della fede che apre all’uomo credente privilegiati aspetti qualitativi del reale che, al di fuori di quest’ottica
non potrebbero in alcun modo essere focalizzati. Così, alla luce della “fedeltà
creatrice” si instaura, per Marcel, un itinerario ontologico nell’ordine del mistero, che trasforma l’oggetto in effigie per convertirlo, poi, in presenza.
Nell’ottica di queste riflessioni complessive, possiamo addentrarci ora nell’analisi specifica del tema della corporeità; ciò ribadendo che il corpo, nel suo
aspetto materiale e biologico (per cui possiamo affermare che l’uomo possiede un corpo) si collega necessariamente alla categoria dell’ “avere”; al contrario, se ci poniamo, come sostiene il filosofo francese, nella prospetiva dell’incarnazione, ne risulta che io sono “il mio corpo” con il quale mi rapporto a me
stesso, al mondo e agli altri; di conseguenza il corpo, come corpo proprio,
cosciente e vivente, rientra nella dimensione dell’essere.
17
18
dell’idea di funzione (“la desorbitation de l’idée de function”); prendo qui la parola funzione nella sua accezione più generale, quella che comprende ad un
tempo le funzioni vitali e le funzioni sociali”1. Di conseguenza, la morte rappresenta, nel modo più completo, l’esaurimento delle funzioni d’uso del corpo,
allorché esso, privato della vita, rimane nella sua materialità bruta. Marcel precisa questo aspetto del problema osservando che “quanto alla morte, essa
appare, da un angolo visuale oggettivo e funzionale, come messa fuori d’uso,
come caduta nell’inutilizzabile, come ‘residuo’ puro (‘déchet pur’)”2.
D’altra parte, la funzione, nella sua emergenza etico-valoriale, determina la
prevalenza dell’avere ed, allora, nell’esistenza dell’uomo, si verifica una situazione in cui la preponderanza della funzione nella vita, conduce alla disperazione, in un orizzonte spersonalizzato, naturalmente diverso da quello che in
Kierkegaard approdava alla disperazione attraverso l’estetico. Qui, perciò,l’analisi del problema dell’esistenza conduce Marcel a valutare filosoficamente le
situazioni sociologiche, di carattere negativo, presenti in alcuni aspetti della
cultura e del comportamento sociale del nostro tempo. Egli infatti asserisce
che “la vita, in un mondo regolato sull’idea di funzione, è esposta alla disperazione, sbocca nella disperazione, perché in realtà questo mondo è vuoto,
perché suona vuoto; se resiste alla disperazione, ciò avviene unicamente nella
misura in cui giocano, in seno a tale esistenza e in suo favore, certe forze
segrete che essa non ha la capacità di pensare o di riconoscere”3.
Le forze sconosciute che l’uomo è incapace di riconoscere e di dominare
quando è sommerso dall’avere e dall’efficienza delle funzioni, riconducono
all’orizzonte dell’esssere e all’ambito del mistero. Perciò il nostro pensatore
sottolinea che “eliminare o tentare di eliminare il mistero, nel mondo funzionalizzato di cui abbiamo parlato, significa far giocare in presenza di avvenimenti che rompono il corso dell’esistenza –la nascita, l’amore, la morte– quella
categoria psicologica e pseudo-scientifica del ‘tutto naturale’ che meriterebbe
uno studio particolare. A dire il vero, questo non è che il residuo di un razionalismo degradato, secondo cui la causa spiega l’effetto, cioè ne rende pienamente conto”4. Qui appare chiaro come Marcel riconduca alla categoria dell’avere anche la conoscenza positiva di ordine tecnico di un razionalismo dell’oggettività espressa nella forma dello scientismo.
Il superamento della deriva deviante ora indicata è, dal nostro filosofo,
espresso nella rivendicazione della presenza del mistero al di là di una semplice constatazione del problema. Ciò implica, per la questione della corporeità, la rivendicazione nella visione dell’ unità dell’uomo, del rapporto intrinseco
tra il corpo e l’anima, da non intendersi, tuttavia, nel senso della tradizione
metafisica medievale che poneva l’accento sul problema della sostanza. Il
nostro pensatore, invece, rivendica la centralità della presenza esistenziale
nell’interiorità dell’essere umano. Al riguardo, Marcel afferma: “È evidente che
esiste un mistero dell’unione dell’anima e del corpo; l’unità indivisibile, che si
esprime sempre inadeguatamente attraverso formule quali: ‘io ho un corpo, io
mi servo del mio corpo, io sento il mio corpo”, ecc., è esteriore ad ogni analisi e non potrebbe in nessun modo essere ricostituita per via sintetica a partire
da elementi che le sarebbero logicamente anteriori”5.
La via tradizionale, nella duplice direzione della metafisica medievale e del
razionalismo moderno, concentra l’attenzione sul soggetto, ora inteso come
anima razionale e ora inteso come soggetto pensante, attribuendo al corpo un
valore e un significato del tutto secondario. Nella cultura filosofica del Novecento,
emergono invece delle prospettive tendenti, in modo più o meno accentuato, a
rivalutare il significato e il ruolo specifico del “corpo” quale dimensione ontologico-esistenziale del soggetto umano. Nell’orizzonte riflessivo ora accennato, assume certamente un particolare significato la “via fenomenologica” husserliana che
si contrappone a quella tradizionale dando rilievo e importanza al “corpo proprio”
nella sua auto-consapevolezza e distinguendolo radicalmente dal corpo nella sua
bruta materialità. In questo itinerario di pensiero innovativo, Marcel, a sua volta,
compie il difficile tentativo di armonizzare la tradizione con le nuove istanze,
mediante la valorizzazione del soggetto personale, operando soprattutto nell’ambito dello spiritualismo francese a cavallo dei secoli XIX e XX. In questa particolare presa di coscienza, è il “corpo proprio” a costituire il nucleo intuitivo e autoconsapevole dell’intera questione; perciò la nozione di corporeità si fa presente
all’interno della nozione più ampia della soggettività spirituale. È chiaro, comunque, che, in quest’ottica, ci si pone al di fuori tanto della metafisica quanto della
gnoseologia, perseguendo piuttosto un itinerario che si colloca nell’orizzonte dell’
“ontologia dell’esistenza”, dove l’essere e il mistero promuovono la valorizzazione del soggetto personale come soggetto corporeo.
Così, in particolare, nel Manifesto metodologico di Marcel dal titolo significativo “Esistenza e oggettività”, la questione del “corpo proprio” viene affrontata a
partire dalla sensibilità, in stretto rapporto, dunque, con la sua genesi che ha le
sue radici all’interno dello spiritualismo. Comunque, approfondendo meglio la
problematica, occorre precisare che la questione del sé e del corpo proprio,
quali nuclei del soggetto personale, vengono esaminati nella linea prospettica
della fenomenologia dell’avere, a partire dal sentimento dell’amore, perseguendo un itinerario originale che muove dal rifiuto sia dell’idealismo sia del materialismo. È questa una difficile linea intermedia che ci fa senz’altro pensare ad un
processo dinamico di riflessione che evoca il pensiero di F.P. Maine de Biran.
Di fatto, è da riconoscere che l’itinerario marceliano relativo all’apprroccio
concreto al tema dell’oggettività procede partendo dal sentire, che coinvolge
in modo specifico il corpo proprio, per giungere alla certezza dell’esistere.
Il problema di fondo, quindi, è per Marcel quello di rapportare l’io con le sue
funzioni specifiche al “corpo proprio” con i suoi vissuti, oggetto fra l’altro delle
diverse forme di sensibilità, nonché delle espressioni dei sentimenti. Così, in particolare, si può rilevare che le questioni marceliane del sé e del corpo proprio
conducono ad un “dato opaco” e ad un “irriducibile” che coinvolgono, da un ulteriore punto di vista, l’indefinibilità e la presenza del ministro nella forma filosofica
del meta-problematico. È evidente che Marcel, per una via diversa, giunge al
punto-limite della connessione tra l’io e il corpo proprio che aveva, ad esempio,
fra gli altri, condotto J.P. Sartre ad intuire l’opacità dell’essere nell’emergenza dell’
“essere per sé” costituente, appunto, la coscienza del soggetto personale.
SAGGI
3. La nozione di “corpo proprio”
19
20
Da tale punto di vista, Marcel caratterizza il rapporto intrinseco tra soggetto
personale e corporeità attraverso la nozione specifica di “proprietà” che connota, appunto, l’irriducibile del “corpo proprio”. In tal modo, viene posto in luce che
l’avere non semplicemente un corpo, ma il “mio corpo”, esprime una posizione,
in parte anche di natura metafisica, concernente l’idea marceliana di “spirito
incarnato”. Qui, perciò, si verifica il superamento della concezione tradizionale
del “corpo-strumento”; al riguardo Marcel precisa che, “nella misura in cui io mi
consideri come se avessi delle comunicazioni con degli oggetti o con delle cose
separate da me, è del tutto naturale che il mio corpo mi appaia interposto fra
queste cose e me, più precisamente che mi si presenti come lo strumento per
eccellenza di cui mi servo per ricevere e per emettere dei messaggi (che del
resto possono ridursi a non essere che semplici segni, in un mondo costituito o
almeno pieno di stazioni riceventi le une in rapporto con le altre, il mio corpo fa
la funzione, come gli altri corpi, di un apparecchio di segnalazione)6.
In questo contesto, l’elemento guida delle riflessioni marceliane è quello per
cui, in modo specifico, il soggetto personale può riconoscere espressamente “io
sono il mio corpo”. Infatti, asserisce il filosofo francese, “nella coscienza che ho
del mio corpo, dei rapporti con il mio corpo, vi è qualcosa che non è resa da
questa affermazione, per cui nasce questa protesta quasi impossibile a reprimere: “Io non mi ‘servo del mio corpo, io sono’ il mio corpo”7. Il che supera radicalmente non solo la concezione del “corpo strumento” ma, più precisamente,
la nozione di “corpo oggetto” in cui questa rientra. Pertanto, “considerando il
mio corpo sia nei suoi rapporti con gli altri corpi, sia nella sua propria struttura,
io sono in presenza di qualcosa che è essenzialmente materia per un problema, e un oggetto possibile di conoscenza, anche in ragione di un ‘distacco da
me’ cui ho proceduto per isolare e definire questo insieme di termini”8. Risulta
chiaro, allora, che il corpo-oggetto è “problema” in senso marceliano, laddove,
invece, il corpo proprio, come appartenenza al soggetto, è un limite non del
tutto conoscibile che rientra nella dimensione esistenziale del mistero. Infatti, il
riferirsi al corpo proprio indica una vera e propria specificità non del tutto definibile e determinabile. Pertanto “dire ‘il mio corpo’, significa rifiutare di attribuirlo ‘a questo o a quello’. Ciò deve sembrare a prima vista oltraggiosmente paradossale: invece di dire il mio corpo, non posso chiamare me stesso, designare
‘quello’ a cui questo corpo appartiene?”9. In modo più preciso, allora, Marcel si
esprime nel senso secondo cui riferirsi al corpo proprio signifca evitare ogni
relazionalità tra i termini della definizione concettuale.
Una riprova di quanto sostenuto la troviamo in un altro significativo
“Manifesto metodologico”, allorché Marcel si espone in rapporto al corpo proprio, la problematica etico-ontologica dell’”avere”. Al riguardo, quindi, il
momento strumentale dell’ avere rischia di sopprimere la libera soggettività
creativa insita nel corpo proprio. Marcel, dunque, dichiara esplicitamente: “Io
credo che, per la loro stessa natura, il mio corpo o i miei strumenti in quanto
io li considero come posseduti, tendano a sopprimere me che li posseggo”10.
Nell’approfondire ulteriormente la questione, ci possiamo addentrare, con
il nostro filosofo, nel tema della soggettività; troviamo, allora, che il “sé”, al
quale precedentemente abbiamo fatto cenno, appare effettivamente come un
4. Il soggetto personale oltre Cartesio ed Husserl verso
la “filosofia riflessiva”
Anche per Marcel, nel quadro ricco e molteplice dello spiritualismo francese,
si pone il “problema del soggetto” come recupero della individualità personale,
affrontato in opposizione al neo-idealismo trionfante nella cultura filosofica europea. Da tale punto di vista, emerge il confronto, oltre che con lo spiritualismo ora
menzionato, anche con il personalismo che si stava facendo strada, nella cultura francese dell’epoca, su un piano etico-politico e non solo su un piano metafisico. Perciò, da tale punto di vista, si impone il recupero della centralità del
momento corporeo, nell’uomo, in polemica con il cartesianesimo della tradizione, e in un proficuo confronto con la posizione fenomenologica husserliana.
Quindi, in particolare, va ricordato che il superamento del “Cogito” cartesiano dipende dal fatto che in esso è insita la distinzione fittizia tra il pensiero e
la realtà vitale. L’uomo, invece, per Marcel, è un prodotto dell’irriducibile esprimente il mistero della condizione del suo essere decaduto. Così, la posizione
inaccettabile, per Marcel, è quella della frattura, ingiustificabile a partire dalla
sua prospettiva, tra “res cogitans e res extensa”, che invece rappresentano,
come noto, in Descartes, i due aspetti, qualitativamente diversi, del reale, che
troverebbero, appunto nell’uomo, il loro intrinseco incontro relazionale.
Il confronto con Husserl, invece, focalizza la specificità del discorso marceliano sull’uomo considerato in quanto “spirito incarnato”; infatti, mentre Husserl
fonda la sua concezione sulla coscienza intenzionale del soggetto e sul “corpo
proprio” come vissuto peculiarmente rivelativo della condizione umana vivente,
Marcel, invece, riconosce l’inadeguatezza della terminologia fenomenologica ai
fini di caratterizzare il mistero dell’essere umano, nell’ambito del quale il corpo
costituisce già parte viva e operante della “soggettività spirituale”, stabilendone
la genesi nella profondità delle espressioni tipiche sia della sensibilità e sia dei
sentimenti. Quindi, le somiglianze tra la posizione marceliana e quella husserliana risultano soltanto di superficie, mente gli itinerari filosofici sono fondamentalmente divergenti. Egli, perciò, in modo specifico, precisa, nel contesto
delle riflessioni del suo Manifesto metodologico “Esistenza e oggettività” che, a
suo avviso, “è necessario giungere ad una più diretta chiarificazione e non
ricorrere alla terminologia, spesso intraducibile, dei fenomenologisti tedeschi”12.
Del resto, non va dimenticato che il problema del “corpo proprio”, per Marcel,
non è soltanto una delle tante questioni che il filosofo è chiamato ad affrontare,
bensì è un tema fondamentale e imprescindibile, in quanto, nella ricerca di con-
SAGGI
“ispessimento” del corpo proprio. In questo senso, egli precisa che “il ‘sé’ è un
ispessirsi, una sclerosi e forse una specie di espressione apparentemente spiritualizzata, un’espressione alla seconda potenza, non del corpo nel senso
oggettivo, ma del ‘mio’ corpo in quanto mio, in quanto il mio corpo è qualcosa
che ho”11. In tal caso, quindi, si tratta, di una irruzione dell’oggettività nella soggettività che rischia di impoverire esistenzialmente quest’ultima.
21
22
cretezza della riflessione speculativa, fonda per lui le categorie filosofiche dell’
“essere” e dell’ “avere”. Infatti, il nostro filosofo asserisce che “in ultima analisi è
l’ ‘essere’ in me, che senza poter giungere ‘de facto’ sulla terra cerca di liberarsi
dalle categorie proprie dell’Avere, categorie del desiderio, dell’amor proprio, del
timore. Tutto ciò si riferisce essenzialmente a questo mio pensiero, perché in ultima analisi queste categorie sono centrate sul mio ‘corpo’”13.
Per approfondire ulteriormente l’itinerario marceliano, dobbiamo tenere presente che, nella cultura francese del Novecento, come noto, le riflessioni spiritualistiche sull’uomo e l’eredità cartesiana sul soggetto pensante si incontrano
con una nuova tendenza destinata a confluire nelle filosofie esistenziali, utilizzando anche gli apporti positivi della fenomenologia appartenente alla cultura
tedesca. Nasce, così, in questo contesto complesso, la “filosofia riflessiva”, che
si concentra sulla coscienza del soggetto. Marcel, quindi, riflettendo sulla nozione di “corpo proprio” per l’interpretazione della condizione umana, è costretto,
anche in questo caso, a confrontarsi, appunto, con la “filosofia riflessiva”.
Tuttavia, tale confronto si sposta dall’orizzonte gnoseologico all’orizzonte etico,
per cui, nella dialettica riflessiva di Marcel, lo spostamento prospettico della
coscienza rappresentativa, individuata nel passaggio dall’io all’altro, coniuga,
nell’avere, l’interiorità con l’esteriorità. È facile, perciò, comprendere che, per il
nostro filosofo, l’esercizio della “riflessione introspettiva” è costantemente focalizzato sul mistero insito nella condizione umana. Ciò coinvolge tanto la nozione di “soggetto” quanto quella di “corpo proprio” che traduce, come sappiamo,
in vissuti di coscienza la situazione dell’incarnazione della soggettività umana.
5. Considerazioni conclusive
Di fronte alla duplice e diversa determinazione antropologico-filosofica, data
da quella del soggetto, da un lato, e da quella della persona, dall’altro, Marcel
propone, in un’apertura sostanzialmente etico-religiosa della condizione umana
–non priva, tuttavia, di riferimenti ontologici– la concezione dell’uomo come
“spirito incarnato”, alla quale abbiamo fatto più volte riferimento in queste pagine. Con tale concezione, il nostro filosofo intende valorizzare la corporeità
vivente e senziente, nonché rivendicare la sostanziale unità dell’essere umano
in tutte le sue manifestazioni specifiche. Così, il dualismo anima-corpo, superato da un punto di vista ontologico, rimane, nella specifica fenomenologia degli
stati corporei e degli stati psichici, un problema aperto pur non essendo una
realtà del tutto inconoscibile. Sostiene pertanto Marcel che “ciò che comunemente –ma anche impropriamente– si chiama l’unione dell’anima e del corpo,
sembra dunque dover essere considerato una forma metafisica dell’ecceità;
essa è, come questa, un indivisibile su cui la riflessione non può aver presa: e
ciò non vuol dire che sia ‘inconoscibile’, come se supponessimo che essa
nasconda un meccanismo di cui ci sfugge il segreto”14.
Dobbiamo, comunque, tenere presente che la conoscenza, per Marcel,
approda pur sempre al “mistero dell’essere” come ad un orizzonte meta-problematico; in esso, naturalmente, gli ambiti specifici del problema, con il suo
SAGGI
limite che lo stabilisce nell’oggettività, e del mistero con le sue implicazioni
veritative, costituiscono le tappe di un itinerario di approfondimento che, radicato nell’esistenza, si apre alla “Trascendenza”.
In tale quadro di riferimento, l’analisi dell’oggettività conduce Marcel ad una
interpretazione del tutto analoga a quella che diversifica e contrappone le due
categorie ontologico-esistenziali dell’essere e dell’avere. Infatti, l’essere
oggetto o l’essere presenza dipende dalla disponibilità manifestata nella relazione intersoggettiva. Quindi, l’oggetto si pone sul piano gnoseologico della
comprensione e sul piano etico del possesso, laddove la presenza si colloca
sul piano esistenziale dell’evocazione e dell’invocazione. In tale orizzonte, si
comprende chiaramente come il nostro pensatore imposti un itinerario valoriale nel quale la riflessione si sposta dal dato opaco dell’avere al mistero
penetrante dell’essere, colto nella sua essenza più profonda, anche attraverso l’esperienza della fede religiosa. Ciò, tuttavia, non riduce le analisi marceliane sul piano esigenziale che S. Kierkegaard determinerebbe come quello
dell’ “edificante”, poiché egli, invece, vuol rimanere fedele all’ambito filosofico.
Infatti, nell’Introduzione al “Giornale metafisico”, egli rifiuta, per la sua filosofia,
la definizione di “esistenzialismo cristiano”, mentre privilegia, per essa, la definizione molto più filosofica di “neo-socratismo”.
In questa prospettiva, va valutato l’elemento fondamentale, per le nostre
riflessioni, che permette di riconoscere come l’intera filosofia di Marcel trovi, per
così dire, il suo punto di riferimento nella nozione di “corpo proprio” che è, nel
contempo, un approccio concreto alla realtà, sia di natura conoscitiva e sia di
natura ontologica. Egli riconosce, dunque, che nello sviluppo del suo pensiero,
“dalla fine della prima guerra mondiale il mio corpo è stato per me il punto di riferimento dell’Avere, caratterizzato da una essenziale ambiguità o meglio da una
interna tensione”15. Su tale linea, di fatto, emergono, come particolarmente significanti, altresì, le contraddizioni e gli aspetti del corpo proprio come luogo oscuro della filosofia. Marcel, dunque, precisa in questo modo la sua dialettica della
corporeità: “In realtà il mio rapporto con il mio corpo presenta già al massimo
questa originalità e questa duplicità: da una parte sono portato a considerare il
mio corpo come un qualcosa che possiedo e di cui posso disporre; dall’altra e in
maniera più profonda il mio corpo non vuole essere così considerato. Questa
ripugnanza viene ad essere così estrinsecata: il mio corpo non è qualcosa che
ho, io sono il ‘mio corpo’: questa affermazione è filosoficamente oscura, ma è
come una protesta del mio ‘io’ più intimo”16. In questo senso, la nozione di corpo
proprio assume, per Marcel, un carattere contraddittorio e, pertanto, egli dichiara che “affermare: io sono il mio corpo, significa essenzialmente dire: io non
sono in grado di definire un tipo qualsiasi di relazione fra i due termini ‘io’ e ‘il mio
corpo’. Io non posso dire: il mio corpo è il mio strumento, o anche: può essermi
utile rappresentarmelo così, ma riflettendo mi accorgo che questa affermazione
è falsa; in effetti il concetto di strumento riporta al corpo, poiché ogni strumento
è il prolungamento dei poteri del corpo; e mi impegnerei in una regressione
senza fine se li considerassi strumentali”17. In tal senso, allora, nonostante le difficoltà che emergono, Marcel ribadisce la sua posizione filosofica nella quale il
corpo propio rimane come una nozione di base. Egli, infatti, sottolinea: “Io sono
23
24
il mio corpo è in realtà una affermazione-base, che può essere chiarita soltanto
parzialmente, tenendo conto delle prospettive che posso ammettere alternativamente, senza che nessuna di esse possa essere ammessa esclusivamente o
definitivamente; ed è proprio questo che io considero, quando parlo di un mistero dell’incarnazione in un senso che non ha nulla di teologico”18.
È facile, dunque, vedere che l’indubbio carattere filosofico attribuito da Marcel
alla nozione di “corpo proprio” si colloca in un orizzonte del tutto particolare rispetto alla tradizione filosofica precedente. Infatti, l’impegno della sua analisi fenomenologica, considerata in un senso diverso rispetto a quella husserliana, ed esistenziale, considerata, come già ricordato più sopra, in un senso differente rispetto a quella proposta nella cultura francese da J. P. Sartre e da M. Merleau-Ponty,
assume un carattere etico-ontologico da ricondurre al rapporto essenzialmente
valoriale, ma non solo tale, delle due categorie filosofiche dell’essere e dell’avere; ciò nel senso che la prima riconduce il corpo proprio al mistero della condizione umana e la seconda ridimensiona, impoverendolo, il corpo nella situazione
anonima e spersonalizzata del mondo degli oggetti materiali.
Da tutto ciò possiamo essenzialmente concludere, in senso globale, che l’itinerario filosofico di Marcel pone in particolare evidenza tre nodi problematici:
lo stato di “essere viandante” dell’uomo (homo viator); la nozione di “sentimento corporeo” che radica il soggetto esistenziale nella concretezza del reale; l’apertura dell’essere umano alla Trascendenza che situa l’intero discorso nell’orizzonte indefinibile ed indeterminabile del “mistero ontologico”. Questi sono
indubbiamente tre momenti imprescindibili per comprendere e per focalizzare
ogni dettaglio delle analisi filosofiche marceliane, inclusa quella della “corporeità”, oggetto specifico delle riflessioni proposte nel corso del presente saggio.
1
G.MARCEL,Posizione e approcci concreti al mistero ontologico, in “Manifesti metodologici di
una filosofia concreta”, a c. di G. Vagniluca, Bergamo, Minerva Italica, 1972, p.69.
2
Ivi, p.72.
3
Ivi, p.73.
4
Ivi, p.74.
5
Ivi, pp.82-83.
6
ID., Esistenza e oggettività, in “Giornale metafisico”, trad. it. di F. Spirito, Roma, Ed. Abete, 1966,
pp.219-220.
7
Ivi, p.220.
8
Ivi, p.222.
9
Ivi, pp.222-223.
10
ID., Lineamenti di una fenomenologia dell’avere, in “Giornale metafisico”, cit., p.362.
11
Ivi, pp. 363-364.
12
ID., Esistenza e oggettività, cit., p.356.
13
ID., Presenza e immortalità, in “Giornale metafisico”, cit., p.512.
14
ID., Esistenza e oggettività, cit., pp.225-226.
15
ID., Presenza e immortalità, cit., p.512.
16
Ibidem.
17
Ivi, pp.512-513.
18
Ivi, p.513.
ALBERT CAMUS.
DAL RELATIVISMO ALLA RELATIVITÀ
L’indifferenza del protagonista de Lo straniero, Meursault, di fronte agli
eventi che lo incalzano, è l’effetto di coscienza: egli comprende che il mondo
è privo di senso e che la morale, la norma, le abitudini, non sono che miseri
veli costruiti dall’uomo per nascondere a se stesso questa fondamentale e
unica verità. In un primo momento Meursault appare un individuo normale,
con-forme, che svolge una vita regolare; ma sotto l’apparente velo di conformità (a cui l’indifferenza somiglia solo esteriormente) egli si distingue dal borghese perché è indifferente a qualsiasi delle logiche da cui è circondato. Per
Meursault la rottura dell’abitudine avviene alla morte della madre. Il dolore
scaturitosi consentirà di vedere diversamente il mondo, di produrre una differenza, avvertendo l’assurdità e la nausea dell’esistenza: di qui, appunto, la
consapevolezza di vivere conformemente, il vedersi vivere, la scoperta della
noia.
Anche a Caligola, il protagonista dell’opera teatrale omonima, muore la
donna che amava profondamente tanto da farne, sulla base della dichiarazione di uno dei senatori, una vera e propria malattia, impazzendo. Egli perde la
donna (Drusilla) che credeva unica, tanto unica e assoluta ancor più se si
pensa che era la sorella. (Camus sottolinea con tale doppio legame il carattere indissolubile e assoluto del rapporto). Caligola non impazzisce a causa di
una colpa morale –a detta di un altro senatore chiunque avesse una sorella
così bella avrebbe un concetto meno elastico della ragione di stato–, ma per
il semplice fatto che perde l’unico significato attribuitosi alla sua esistenza.
Come per Meursault, anche Caligola scopre che dietro all’assoluto c’è il niente, il vuoto, l’assurdo. Come il protagonista de Lo straniero anche lui risponde
all’assurdo con un gesto altrettanto assurdo, ma psicologicamente coerente:
l’omicidio.
Alla presa d’atto dell’assurdo e dell’assoluto si risponde violentemente: l’unica risposta plausibile ai sentimenti di angoscia e di disperazione provati.
Di fronte a questa sconcertante presa d’atto, all’incapacità di riorganizzare
un pensiero ormai cristallizzato intorno ad un’idea fissa, inadeguata a rispondere alle mutate esigenze di una nuova realtà, Caligola regredisce verso uno
stato che a lui apparirà logico e coerente, ma alle altre persone allucinatorio e
allucinante: far soffrire gli altri come ha sofferto lui attraverso il potere di cui si
serve.
Perché la differenza con Meursault risiede nella posizione che occupano: il
primo, essendo povero, sarà giustiziato dopo aver ucciso un uomo, il secondo, sfutterà a pieno il suo potere finché anch’egli non soccomberà di fronte alla
SAGGI
di Stefano Berni
25
26
rivolta. Il Caligola dunque non è soltanto un’acuta analisi dei meccanismi psicologici di ciascun individuo, ma anche una presa di coscienza da parte di
Camus del pericolo del potere istituzionalizzato e della violenza legalizzata.
Il potere rappresenta un’arma o uno strumento per difendersi e per nascondere la nausea che si avverte. Esso si attiva maggiormente e diviene dominio
e violenza quando si ha paura; allora si ha bisogno di controllare le cose, di
ordinarle (nel duplice senso del termine, comandare e mettere a posto).
L’estrinsecazione del doppio nesso potere-pazzia in Caligola sembrerebbe
di una forte identificazione col suo ruolo di imperatore potente. (Camus mette
bene in evidenza questa affinità che a molti sfugge di potere e pazzia.
Anch’essi sono tentativi di sfuggire alla consapevolezza dell’assurdo).
Caligola agisce per coprire il vuoto creato dalla scomparsa di Drusilla (atteggiamento tipico del sadico che sposta i suoi investimenti libidici su di un soddisfacimento secondario). Dice Caligola: “prima, tutto mi sembrava credibile
[…] Ora non mi rimane altro che questo futile potere”1. Come Meursault anche
Caligola si rifugia di nuovo nell’indifferenza, un’indifferenza questa volta voluta, cercata, non più inconsapevole. Di fronte allo sciogliersi dell’assoluto e allo
scaturire dell’assurdo, il tentativo è quello di reimmergersi nel fluire degli eventi, nella rimozione, nella dimenticanza. Per Caligola il fluire degli eventi sarà
porsi nell’azione, nella pura esteriorità delle cose: lo rivela implicitamente nella
misura in cui colpisce tutti, nella sua furia cieca e violenta e letteralmente priva
di senso, indistintamente. Ma lo dice anche in modo esplicito a Cherea, il filosofo di corte, il suo antagonista principale quando parlando delle azioni che gli
uomini sono chiamati a compiere sostiene che “le azioni sono tutte uguali”2.
Caligola prova a dimenticare la morte di Drusilla, benché sappia bene che
non si può veramente dimenticare ciò che si è vissuto; tuttavia, rifiuta il pensiero, gettandosi nell’azione per l’azione, illudendosi di cancellare il ricordo di
Drusilla e potendo affermare che vivere è il contrario d’amare. Ma ogni sua
azione diviene il naturale contrassegno della sua funzione, della sua maschera, della sua malafede.
Si è detto che Meursault e Caligola appaiono indifferenti, perché chiudendosi in loro stessi sembrano insensibili di fronte alla realtà. Entrambi inoltre
non comunicano più con gli altri se non attraverso la violenza, l’ultimo estremo
tentativo di comunicare, il grado zero della comunicazione, il grido di dolore
della presa d’atto dell’assurdo, la risposta spontanea di un disagio.
L’isolamento e la solitudine di Caligola sono gli stessi di Meursault: il primo
verrà condannato non perché uccide quanto perché impazzisce isolandosi dal
contesto sociale e non assolvendo più alla ragione di stato; il secondo verrà
condannato dagli altri non perché abbia ucciso un uomo ma in quanto scopriranno in lui (come in uno specchio che smaschera la loro finzione) un essere
indifferente, (non aveva pianto al funerale della madre, rivelando che il suo
conformismo era falso) minando implicitamente le basi di una società che
richiede la convinzione di determinate regole.
Occorre rilevare che a Camus la violenza di cui sono intrisi i suoi personaggi, appare sempre il rivelatore di una condizione da cui essi tentano di
uscire. La violenza è legittimata quando, chi la esercita, prova a liberarsi da un
SAGGI
potere che lo opprime e lo soffoca. Scrive Camus: “ho compreso di detestare,
più ancora che la violenza stessa, le istituzioni della violenza”. E ancora: “bisogna rifiutare alla violenza ogni legittimazione”3.
Il mito di Sisifo propone le stesse tematiche con un tentativo di risoluzione
che non si discosta di molto dalle posizioni riscontrate nel Caligola e ne Lo
straniero.
Innanzitutto perché Sisifo? Egli è costretto dagli dei a spingere un pesante
macigno in cima alla montagna, che, inevitabilmente, sotto il suo stesso peso,
torna al punto di partenza. Questa ciclicità, ripetizione coatta o eterno ritorno
sono avvertiti da Camus senza senso, inutili, assurdi; il mito incarna bene il
nostro modo attuale di vivere: la vita che conduciamo ogni giorno è assurda,
perché come Sisifo, viviamo nella ripetizione e nell’abitudine di gesti, di norme,
per lo più imposte: “si continua a fare i gesti che l’esistenza comanda, per
molte ragioni, la prima delle quali è l’abitudine”4. Di per sé l’abitudine non è un
vizio da cui occorre affrancarsi, ma diventa tale se la scambiamo per regole o,
per leggi immutabili. Inoltre essa non provoca né angoscia né dolore, anzi il
quotidiano uso e abuso che se ne fa indica proprio un suo carattere analgesico, anestetico, non permettendo di prenderne consapevolezza né tantomeno
di essere vissuta come assurda. Il suo scopo è piuttosto quello di conformare,
confermare, confortare. Ne Il mito di Sisifo Camus, ripercorrendo concettualmente ciò che era presentato solo intuitivamente nei suoi romanzi, pone le
basi filosofiche per superare la logica dell’abitudine e del conformismo. Dalla
consapevolezza e dalla rottura di tale processo normalizzante e di normalizzazione scaturisce conseguentemente l’angoscia che produce il primo vero
moto di rivolta consistente nell’uscire dalla ripetizione coatta con un gesto
assurdo: l’omicidio o/e il suicidio. Per quanto sia apparentemente contradditorio rispondere ad un mondo assurdo con un gesto assurdo, il suicidio è come
possibilità logica il tangibile contrassegno di una risposta come afferma se
stessa negandosi. “Che cos’è l’uomo in rivolta? Un uomo che dice no. Per
quanto confusamente, dal moto in rivolta nasce una presa di coscienza”5. Dire
di no è il primo tentativo di rifiutare la ripetizione, il potere, l’assoluto, la divinità, le regole di un gioco a cui non si vuole più appartenere. È come se Sisifo
lasciasse cadere il masso ai piedi della montagna e per un attimo avvertisse il
sapore della libertà e della felicità.
Ma a cosa può pensare concretamente questo eroe se non alle azioni che
da sempre ha condotto? In base a quale morale può agire se ha rinnegato
quella del suo padrone e contemporaneamente la sua? Posta su un altro
piano ancora, la domanda potrebbe essere così tradotta: come si può all’interno di un linguaggio e di un potere di cui siamo intrisi, riuscire a superarli?
Camus intuisce esattamente il problema definito da lui stesso contraddittorio
e paradossale.
Contraddittorio, perché un soggetto che definisce insensato il mondo, a
rigor di logica non dovrebe agire; paradossale perché in teoria, il soggeto, per
sfuggire alla logica del potere, dovrebbe servirsi degli stessi strumenti del
potere stesso. Caligola, ad esempio, ricevuta la promessa di Cherea, il filosofo di corte, di venire ucciso, lo taccia di contraddirsi in quanto sostiene di esse-
27
28
re giusto eppure é costretto ad un’azione di per sé ingiusta e non coerente. Il
filosofo gli risponde: “È vero. Non è logico ma sano”6.
Cherea sa bene che il potere incarnato da Caligola approfitta della logica
per autolegittimarsi. Sostiene infatti il tiranno: “Ho deciso di essere logico,
vedrete quanto vi costerà la logica. Il potere ce l’ho io. Eliminerò chi mi contraddice e anche le contraddizioni”.7 Suo malgrado Cherea è costretto ad agire
e ad uccidere Caligola: la sua azione non è stata logica perché di fatto si è
comportato come il tiranno. Nulla sembra distinguerlo apparentemente da
Caligola.
Ricapitolando brevemente l’analisi filosofica di Camus, si è visto che ci
sono stati in primis dei moti d’animo di sorpresa, di stupore, di presa di
coscienza, di scoperta del carattere assurdo del mondo. Dopo il naturale sgomento di chi scopre che il mondo è privo di senso e che la verità non esiste,
si passa ad un momento di isolamento e di indifferenza, di solitudine e di violenza quasi per preservare se stessi da altre possibili delusioni. In un primo
momento, dunque, si sceglie l’in-differenza, il nichilismo passivo, il relativismo:
l’atteggiamento psicologico cioè di chi è propenso a credere che se un valore
lo ha deluso perché non assoluto qualsiasi altro valore lo deluderà. Il relativista di questo tipo è un nichilista passivo, secondo l’accezione dello stesso
Camus mutuata da Nietzsche. Ci si rifiuta di agire o si agisce sconsideratamente in quanto ognuno dei valori, che dovrebbe motivare le possibilità di
scelta, indirizzando l’azione, appare insensato. Il relativista non vede differenze tra le varie teorie morali che gli sono proposte, rinchiudendosi in un paradossale, “tutto va bene”, la cui proposizione va letta non nel significato che
tutto procede verso il meglio, ma, sarcasticamente, che ogni cosa è la stessa
dell’altra.
Camus ne Il mito di Sisifo prova a razionalizzare l’assurdo, a convivere con
questo sentimento, legittimando l’azione, la lotta, la rivolta. Da una presa di
coscienza del relativismo di valori (per cui i valori sono tutti uguali e dunque
indifferenti) e al conseguente atteggiamento passivo, egli perviene successivamente ad una provvisoria conclusione a carattere naturalistico ed evoluzionistico. Scrive Camus: “nulla essendo vero o falso, buono o cattivo, la norma
consisterà nel mostrarsi il più efficace cioè il più forte”8. E concludendo Il mito
di Sisifo: “Anche la lotta verso la cima basta a riempire il cuore di un uomo.
Bisogna immaginarsi Sisifo felice”9.
Se la felicità risiedesse nella lotta, dovremmo vivere come dei conquistatori?
Come dei guerrieri? Dovremmo uccidere? Quanto l’uccidere l’altro incide poi
sulla nostra felicità e libertà? Anche Caligola voleva credersi libero e felice a
suo modo. Se l’omicida e il conquistatore, ma più in generale tutti gli uomini si
abbandonassero all’azione per l’azione; se questa si esaurisse in una mera
coazione a ripetere, in una semplice distribuzione gratuita di sé e degli altri; si
finirebbe per annullare l’intero pensiero e probabilmente l’umanità stessa. Il
relativismo non si discosta di molto da chi pensa di avere una verità assoluta.
Esso è una reazione all’assoluto che dimostra il desiderio frustrato discendente dalla volontà stessa dell’assoluto. Il relativista vive ancora nel vuoto
della scomparsa dell’assoluto. Paradossalmente (ma non tanto) il relativismo,
SAGGI
per cui tutti i valori sono uguali e dunque non differenti, assomiglia all’assoluto per cui una sola cosa è vera. Anche etimologicamente il termine assoluto
contiene già in sé l’idea di scioglimento di liberazione da qualsiasi vincolo.
Il superamento di una visione relativistica ed evoluzionistica è incarnato da
Cherea il filosofo amico di Caligola. Come dice Cherea, non si può spingere
l’assurdo alle estreme conseguenze; non ci si può abbandonare al potere, alla
logica, alla felicità, alla libertà, alla ragione fino in fondo.
Bisogna rimanere lucidi all’interno di una tensione tra pensiero e azione, tra
teoria e prassi. Non si può assolutizzare l’affermazione di Nietzsche secondo
cui per ogni agire occorre l’oblìo, né d’altra parte ci si deve rifugiare nella torre
del pensiero, dimenticando la vita. Entrambe le posizioni sarebbero riduttive.
Alle affermazioni di Caligola per cui tutte le azioni sono uguali, Cherea crede
che delle azioni siano migliori delle altre. Il filosofo sa bene di essere alimentato dallo stesso desiderio di potere, quasi che il sapere fosse l’altra faccia del
potere; un sapere che potrebbe diventare potere se servisse il tiranno. Più che
esserne l’alter-ego Cherea è un possibile Caligola le cui circostanze gli hanno
permesso di pervenire ad una visione più misurata e controllata della realtà.
Commenta il filosofo: “se io avessi il potere di Caligola agirei come lui, dato
che sono animato dalle sue stesse passioni”10.
Egli però è riuscito a razionalizzare la scoperta che il mondo è privo di
senso e diversamente da Caligola non è impazzito e comunque è stato
costretto a pensare. Se il mondo è privo di senso, ed è l’uomo che appone ad
esso il proprio suggello, di fronte a tale consapevolezza non si deve fuggire,
ma fare di se stessi dei creatori. La funzione del pensiero in Cherea svolge un
ruolo di mediazione tra il sentimento dell’assurdo, il desiderio distruttivo e il
desiderio di cambiare le cose. Questa capacità di equilibrio è ciò che Camus
chiamerà ne L’uomo in rivolta “il pensiero meridiano: una misura che deve
essere pura tensione”11. Un pensiero che non deve dimenticare la crisi da cui
si è originato, mantenendone viva la tensione ritornando spesso su se stesso:
un pensiero critico e creativo capace di rinnovarsi, pronto a rovesciarsi e a
spostarsi. Occorrre uno sforzo, una lucidità critica, che mantenga la rivolta
sempre all’interno della tensione tra pensiero e azione. La rivolta non è l’abbandonarsi alla distruzione, né tantomeno significa sfuggire la realtà chiudendosi nel pensiero: la rivolta non deve essere dismisura.
Il pensiero agente assomiglia a quello dell’artista che concretizza il suo
pensiero in una cosa: “l’arte può essere rivoluzionaria, poiché essa è la contestazione perpetua”12. L’artista trasforma la materia agendo, ma agisce in
base ad un’idea. La rivolta, intesa in tal senso, è creazione. Riprendendo le
parole di Nietzsche, Camus scrive: “sono miei nemici coloro che vogliono
abbattere e non creare se stessi”13. La rivolta, portata all’eccesso, è illogica:
diventa se stessa un assoluto e perde le ragioni che l’avevano condotta a
manifestarsi. Essa deve dunque, come l’arte, “tendere al relativo”14.
L’assurdo, la rivolta, il nichilismo passivo, il relativismo radicale, secondo
cui ogni valore e ogni azione sono uguali, si devono permutare e trasformare
per Camus –e questa è la sua conclusione logica alle domande fin qui postein un pensiero relativo, misurato: un nichilismo attivo. Cos’è che contraddi-
29
stingue questa relatività dal relativismo da cui comunque discende? Camus ha
capito, per dirla con Adorno, che “il relativismo ha avuto sempre insito il
momento reazionario, per quanto volesse spacciarsi per progressivo, così già
nella sofistica come disponibilità per gli interessi del più forte”15. Non intervendo, il relativismo lascia tutto com’è. Occorre agire se si vogliono cambiare le
cose e il mondo che ci circonda. “Se l’uomo non sceglie, sceglie il silenzio e la
schiavitù altrui”16.
Il pensiero deve sorreggere un’azione ma liberato da rigidi schematismi
morali e dopo essersi affrancato da costrizioni tradizionali e pregiudizi reiterati.
Agire significherà scegliere di volta in volta un punto di vista suscettibile di
variazione e perciò convenzionale, strumentale, ma non per questo arbitrario,
i cui rischi e i limiti vanno calcolati contingentemente. Il punto di vista da cui si
giudicherà il mondo apparirà assoluto per chi osserva dall’esterno ma relativo
a chi agisce consapevole della sua relatività e contingenza.
Lo sforzo di Camus è così volto ad una maggiore felicità che risiede in una
maggiore comprensione fra gli uomini tutta laica e terrena non dipendente né
da astratti dogmi religiosi, né da facili ideologie e utopie.
Soltanto la comprensione in termini filosofici della relatività potrà guidare l’umanità verso questa strada: “Le ideologie che reggono il nostro mondo sono
nate al tempo delle grandezze scientifiche assolute. Le nostre conoscenze reali
autorizzano, al contrario, soltanto un pensiero adeguato a grandezze relative”17.
30
A. CAMUS, Caligola, Milano, Bompiani, 1984, p.11.
Ibidem, p. 45
3
ID, Taccuini, Milano, Bompiani, 1963, p. 149.
4
ID, Il mito di Sisifo, Milano, Bompiani, 1947, p. 20.
5
ID, L’uomo in rivolta, Milano, Bompiani, 1957, p.18.
6
ID, Caligola, op. cit., p. 44.
7
Ivi, p.9.
8
ID, Il mito di Sisifo, op.cit., p.121.
9
Ibidem
10
Ivi, p.20
11
ID, L’uomo in rivolta, op. cit., p.328.
12
ID, L’artista e il suo tempo, ”Il ponte”, Gennaio 1955, p. 57.
13
ID, L’uomo in rivolta, op. cit., p. 313.
14
Ivi, p. 316.
15
W. ADORNO, Dialettica negativa, Torino, Einaudi, 1982, p. 34.
16
A. CAMUS, L’uomo in rivolta, cit., p. 313.
17
Ibidem, p. 322. Si potrebbe azzardare l’ipotesi, peraltro abbastanza tracciata da Camus, che
parlando di relatività egli intendesse e si riferisse proprio alla ben nota teoria di Einstein, secondo
la quale, come è noto, non si intende precisamente un relativismo. Anzi, la fisica di Einstein prevede di scegliere un punto di vista privilegiato dell’osservatore. Dunque non di relativismo si deve
parlare in Camus, bensì di relatività, cioè di una concezione filosofica che potremmo definire dei
punti di vista. Un pensiero che accompagna l’azione quanto basta per intervenire nel mondo, ma
passibile di modificarsi successivamente in base alle mutate situazioni storiche e sociali.
1
2
LA FILOSOFIA DEI “NON-FILOSOFI”.
IL DIVERSO FILOSOFARE DI ALDO CAPITINI
Ha senso parlare di una filosofia dei “non-filosofi”? Chi intendo per “non filosofi”? I “non-filosofi” sono coloro i quali, pur avendo avuto un ruolo non trascurabile nel dibattito teorico e teoretico, pur avendo contribuito ad arricchire
il percorso storico-filosofico, non hanno ricevuto il crisma dagli ambienti ufficiali. Essi hanno avuto il drammatico privilegio di essere condannati a rimanere soli, talvolta isolati, a rendere testimonianza a valori misconosciuti. Il loro
modo di far filosofia non coincide con gli abituali schemi; in loro non c’è, però,
il rifiuto della filosofia, ma di un certo tipo di filosofia; essi parlano contro quella filosofia che si è cristallizzata in schemi, formule e definizioni che sono la
negazione della vita; essi lottano contro ogni forma di dogmatismo sia esso
metafisico o scientistico, rifiutano categoricamente le false concretizzazioni e
le soluzioni formali. Per Michelstaedter “vana cosa è la filosofia se esce dalla
vita, è l’ultima illusione, è l’ultimo gioco del vecchio rimbambito”1. Lungo tutto
il percorso storico troviamo intellettuali che hanno operato per il rinnovamento
dell’uomo, lo hanno incitato ad uscire dalla piatta realtà quotidiana per realizzare in piena libertà il valore umano, lo hanno spronato a non rifiutare la categoria del bene per dare valore alla categoria dell’utile, lo hanno incitato a non
pensare che filosofia e vita siano cose separate e che il filosofo sia un “sacerdote” di una verità che non tutti possono raggiungere. Ognuno di essi ha indicato una strada diversa, un sentiero da percorrere. Nei loro scritti, però, non è
presente la sicurezza della vittoria, ma la trepidazione per le difficoltà da superare.
“Non-filosofi” sono anche Agostino, Pascal, Schopenhauer, Kierkegaard,
Nietzsche. Essi si sono contrapposti fortemente alla filosofia accademica ma,
malgrado la loro ostilità, anche se lentamente, sono stati assunti nei ranghi
della filosofia ufficiale.
Per Pascal, soltanto se si ride della filosofia si può far vera filosofia. Il filosofo sistematico è colui il quale conosce tutte le cose, può parlare di tutto, ma
si è lasciato sfuggire la cosa più importante, il senso della vita.
Per Kierkegaard la filosofia sistematica poggia sopra un fondamento ridicolo: vuole parlare in nome dall’Assoluto e si lascia sfuggire, invece, l’oggetto
concreto e reale. Si verifica, cioè, ciò che è accaduto al corvo che ha perduto
il formaggio per l’eloquenza della volpe.
Per Kierkegaard la filosofia non può essere il magnifico palazzo nel quale
l’uomo non può abitare, ma deve essere la casa dell’uomo, dell’uomo nella
sua irripetibile individualità. Per il filosofo danese, Hegel perde la soggettività
nel momento stesso in cui la pone, elevandola a momento del sistema. La
SAGGI
di Licia Semeraro
31
32
soggettività è, invece, immediata ed indeducibile e alle categorie dell’oggettività, della totalità, della mediazione sostituisce quelle dell’esistenza, della singolarità, del paradosso. Questo non vuol dire, però, che Kierkegaard contrapponga al sistema hegeliano un altro sistema perché la filosofia deve essere il
riflesso di un pensare soggettivo cioè dell’esperienza di un soggetto concreto
che vive nel tempo e nella storia.
“Non-filosofi” sono, infine, anche quegli intellettuali (letterati e ideologi) che,
pur non avendo operato all’interno della filosofia, hanno prodotto valori filosofici.
Non potendo parlare in termini generali della filosofia dei “non-filosofi”,
scelgo di soffermarmi su Aldo Capitini perché incarna perfettamente la figura
di un “non-filosofo” e perché, sebbene dalla lettura delle sue opere emerga l’esigenza di un rapporto diverso tra pensiero e realtà, e questa è un’esigenza
sentita da molti, pochissimi filosofi rileggono Capitini.
Gli anni in cui si colloca il tirocinio filosofico di Capitini, dal 1933 in poi, sono
gli anni nei quali l’idealismo italiano si rompe in varie direzioni. Egli non ne percorre nessuna, sceglie una posizione autonoma, si definisce post-umanista,
post-cristiano. Il post indica nello stesso tempo appropriazione e superamento. Col post Capitini evidenzia che sia l’umanesimo che il cristianesimo hanno
bisogno di una “aggiunta”. L’aggiunta caratterizza tutta la riflessione capitiniana: aggiungere non è solo il contrario di togliere, ma anche qualcosa in più di
correggere o riformare; aggiungere è accettare trasformando. La trasformazione è l’obiettivo di Capitini, egli vuole trasformare la realtà, la società, l’umanità così come esse si presentano. Scrive: “Quando incontro una persona,
e anche un semplice animale, non posso ammettere che poi quell’essere
vivente se ne vada nel nulla, muoia, e si spenga, prima o poi, come una fiamma. Mi vengono a dire che la realtà è fatta così, ma io non accetto. E se guardo meglio, trovo anche altre ragioni per non accettare la realtà cosi come è
ora, perché non posso approvare che la bestia più grande divori la bestia più
piccola, che dappertutto la forza, la potenza, la prepotenza prevalgano: una
realtà fatta così non merita di durare. È una realtà provvisoria, insufficiente, ed
io mi apro ad una sua trasformazione profonda, ad una sua liberazione dal
male nelle forme del peccato, del dolore e della morte”2. Ed ancora: “Chi ha
detto che ci debba essere sempre il peccato, il dolore, la morte? la prostituzione, il furto, l’odio? la vittoria della potenza, lo sfruttamento sociale, l’inaccettabile decoratività dei potenti assoluti? Non è chiusura accettare che la realtà, la società, l’umanità continui e ripeta sempre se stessa nei suoi modi fisici,
politici, sociali, biologici?”3.
Capitini non è, e non vuole essere, un filosofo nel senso classico del termine. Si serve della filosofia ma non tende alla filosofia. Se nelle sue opere fa
costanti riferimenti a filosofi antichi e moderni, se si confronta con alcune correnti filosofiche (idealismo, storicismo e marxismo), è sempre per chiarire e
riaffermare la propria personale posizione.
Egli stesso afferma che al filosofo preferisce il persuaso di cui delinea le
caratteristiche. Il persuaso non è né il sacerdote del dogma, né l’intellettuale
staccato dalla moltitudine. Il persuaso è colui che vive nella tragedia del
SAGGI
mondo ed opera per annullarla. Il filosofo, per Capitini, è quasi sempre un contemplante e lascia il mondo com’è, il persuaso è tutto teso nell’azione che trasforma o tramuta il mondo. Il filosofo è colui il quale, di fronte alla inadeguatezza della realtà, ricorrendo a Dio o alla Storia, cerca di giustificarla e finisce
con l’accettarla, il persuaso opera per trasformarla. Sostanzialmente la differenza tra il filosofo ed il persuaso sta nel fatto che il primo è un puro teorico, il
secondo è un uomo d’azione, un religioso che guarda al destino dell’uomo, al
suo rapporto con gli altri, alla realtà intera. Capitini è un persuaso religioso.
La religiosità capitiniana, basata sull’apertura e su un infinito amore per
tutti gli esseri viventi non trova corrispettivi né nella religione tradizionale della
Chiesa cattolica che accusa di essere chiusa, dogmatica, selettiva, alleata con
il potere, né nella concezione storicistica che esclude a priori la liberazione
degli individui. La religione non deve essere consolazione alle miserie della
vita e rassegnazione di fronte a quelle, ma il motore interiore, il punto di riferimento che dà la forza sufficiente per contrastare la società ingiusta e la realtà
naturale, causa di sofferenze e di morte. L’essenza della religione è consapevolezza del dolore, della morte, dell’ingiustizia sociale, ma è anche speranza
certa che tutto non si esaurisce in quei limiti perché è vicina ed intima all’uomo una realtà liberata dal dolore e dalla morte a condizione che egli si apra e
si adoperi per mettere in crisi la realtà così come è, in vista della liberazione.
Se si accetta la realtà naturale, così come essa si presenta con le sue disuguaglianze, si accettano anche le ingiustizie che la società aggiunge a quelle disuguaglianze e che, anzi, essa valorizza e sfrutta per conservarle e accrescerle. Se, in Capitini, il motivo politico-sociale è urgente, altrettanto urgente,
profondo e incalzante è quello religioso, metafisico, escatologico. L’ansia di
liberazione sociale trae motivo e vigore dall’ansia di liberazione religiosa.
Capitini non rimanda la liberazione spazialmente ad un mondo ultraterreno,
celeste, né temporalmente ad un ordine storico finale: essa si attua qui e subito, attraverso atti concreti. Da un lato guarda al presente che indaga e valuta
accuratamente, dall’altro guarda oltre i suoi limiti ad un possibile diverso. La
resistenza al male, all’ingiustizia in ogni dimensione della vita, non è sorretta
da una mera conoscenza razionale, non trae origine da calcoli o previsioni di
successo, ma dall’interno della coscienza, è il risultato, così come egli afferma, “di un pratico appassionamento” per gli aspetti carenti dell’esistenza e per
la liberazione dai limiti che essa pone.
È possibile calare questo convincimento che parte dalla coscienza nella
realtà concreta? Quale è la garanzia per una reale liberazione? La risposta di
Capitini è netta: non c’è che vivere, provare, sperimentare, lavorare. Lavorare,
però, in questa realtà “operandovi dentro” per far essere, “qui ed ora”, quell’altra realtà in nome della quale “diamo la disdetta” a questa.
Si comprende allora perché la filosofia, per Capitini, debba essere meno
teorica e più pratica, deve permettere all’uomo di “meglio comprendere le sue
assolute capacità di azione per meglio agire”, deve essere “guida delle anime”,
“agitazione delle coscienze”4; si comprende perché nelle sue opere si intreccino “spunti filosofici”, “tensioni religiose”, analisi socio-politiche; si comprende
ancora perché le sue fonti non siano esclusivamente filosofiche: accanto a
33
34
Kant, Hegel, Marx, Croce, troviamo Leopardi, S. Francesco, Mazzini e Gandhi.
Capitini si dichiara kantiano-leopardiano. Reputa Leopardi uno spirito religioso per la sua attenzione nei confronti della morte e per le continue proteste
nei confronti della natura, “madre in parto ed in voler matrigna”. La morale
positiva del Leopardi che nega il ripiegamento sia di fronte alla natura sia di
fronte alle circostanze storiche negative e che nell’ultima fase del suo pensiero si evolve in morale socialmente costruttiva, si avvicina molto a quella capitiniana. Anche Leopardi privilegia il momento del fare rispetto a quello teoretico; nessun uomo nella filosofia, nessun uomo nelle lettere potrà essere grande, se non è nato per operare sempre più grandi cose. Ma in Leopardi, per
Capitini, manca l’essenziale, c’è protesta per il dolore e la morte, ma per essi,
il poeta-filosofo non trova soluzioni; malgrado ciò, Leopardi è più religioso di
Croce perché, sottolinea Capitini, la protesta contro la morte è più religiosa
della sua accettazione5.
Da un punto di vista più strettamente filosofico Capitini, come tutti gli intellettuali italiani del suo tempo, ha dovuto fare i conti con l’idealismo, o meglio
con lo storicismo, “l’umanesimo dei tempi nuovi”. Dagli idealisti egli trae una
solida convinzione immanentistica contro la vecchia credenza di un Dio fuori
dal mondo da contemplare, venerare, servire. L’immanenza che persegue non
esclude Dio, ma ne include la presenza. Capitini denuncia, però, la tendenza,
presente soprattutto in Hegel, di identificare il processo della realtà esistente
con quello della Ragione, di presentare ciò che è reale come razionale, come
fornito di ragionevolezza. Dewey, e non solo Dewey, aveva già criticato tale
posizione di storicismo giustificatore affermando che “un mondo che sia già,
nella sua intrinseca struttura, dominato dal pensiero non è un mondo nel
quale, salvo che in contrasto con le premesse, il pensiero ha qualcosa da
fare”6. Capitini osserva, con intendimento analogo, che “la ‘religione della libertà deve servire a lasciar vivere il reale nelle sue forme […]. Non è una religione di intervento, ma di accettazione del reale”7. È assente, quindi, nello storicismo, ogni spinta al cambiamento e nell’ambito della realtà, e nell’ambito
della società. Inoltre, l’individuo crociano che nasce e muore, dopo aver dato
il suo contributo alla Storia, non è che uno strumento di cui si serve lo Spirito
e di fronte al quale tutti gli individui si annullano. La liberazione si può avere
solamente per mezzo delle opere nelle quali l’individuo si realizza. Le opere
permangono eterne, mentre l’individuo finisce. “La storia non può morire”,
commenta Capitini, “ma i morti sono ben morti”8. Scrive Croce: “Che cosa dobbiamo fare degli estinti, delle creature che ci furono care e che erano parte di
noi stessi? Dimenticarli, risponde la saggezza della vita: Dimenticarli, ci conferma l’etica. E l’uomo dimentica”9. Non c’è spazio, quindi nella filosofia crociana per i morti, ma neanche per i deboli, per gli sfiniti, per tutti coloro che non
hanno la possibilità di produrre qualcosa che faccia il suo ingresso nella
Storia. Per Capitini, invece, l’opera è sempre il frutto della coralità di tutti gli
esseri, anche lo storpio, il pallido, l’analfabeta contribuiscono alla produzione
del valore. Il valore è considerato da Capitini, non come essenza trascendente, ma come categoria pratica che ha, però, una sua “superiorità qualitativa”
che permette di riscattare la finitezza degli individui che conservano sempre la
SAGGI
loro particolarità di singoli, senza trasmutazioni metafisiche da cui l’uomo esce
annullato, superato, dimenticato proprio in quanto singolarità.
Nel marxismo, invece, Capitini scorge l’espressione di una escatologia
sociale profonda. Il marxismo, sopprimendo la proprietà privata, si sforza di
“trovare ciò che unisce veramente tutti, prima come oppressi e poi come liberati, e di stabilire finalmente un rapporto intrinseco tra l’individuo e i tutti, in
modo che il libero sviluppo […] dell’uno sia in stretta connessione con il libero
sviluppo di tutti”10. Nella trasformazione della realtà, liberata dallo sfruttamento e dal privilegio, Capitini trova il punto profetico di questo umanesimo che “ad
una concezione che dica com’è sempre la realtà (e che accusa di essere perciò ‘metafisica’) sostituisce una prassi di trasformazione radicale in una realtà
sociale liberata dal male che è lo sfruttamento”11. Marx, però, affida il cambiamento rivoluzionario ad una sola classe, il proletariato, attraverso mezzi politici tradizionali. Per Capitini questo significa delimitare il campo della realtà liberata. L’oppressione è presente non solo nel campo economico ma in tutte le
forme della “società-realtà-umanità, così come è costituita […]. Oppresso è un
salariato, ma oppresso […] è anche il condannato alla pena capitale, il nato
cieco e il morto”12. Egli ritiene impossibile che una sola classe, anche se costituisce la grande maggioranza degli uomini, che deve ricorrere all’uso di mezzi
politici appartenenti al vecchio mondo della violenza, possa liberare tutti e non
solo se stessa. Il principio che la trasformazione possa e debba compiersi
mediante una rivoluzione violenta ha portato all’applicazione di un metodo il
quale, afferma Capitini, “si è riflesso in coloro che lo hanno esercitato riducendo quegli elementi escatologici che prima erano ritenuti inscindibili. La teoria di dover usare un metodo con elementi della vecchia società (esercito,
machiavellismo, polizia, Stato, differenze gerarchiche) finché ci sono avversari all’esterno o all’interno, mostra che non è stato trovato, perché non cercato, un altro metodo, che portasse avanti il proprio nuovo, pur essendoci
ancora il vecchio”13. È questo, secondo Capitini, uno dei maggiori punti critici
del marxismo: la rivoluzione comunista è stata codificata in un insieme di istituzioni, la maggior parte delle quali risulta simile a quelle che si erano volute
distruggere. Il marxismo, come umanesimo, resta nei limiti dello storicismo,
anche se Capitini ne riconosce l’importanza storica per aver sostenuto principii fondamentali per la vita dell’uomo, quali la libertà e l’uguaglianza. Ma i limiti sono troppo grossi perché li possa accettare. Anche rispetto al marxismo,
dunque, il suo atteggiamento è, come nei riguardi di tutte le filosofie immanentistiche, un atteggiamento di accettazione e nello stesso tempo di rifiuto.
Accetta la spinta escatologica, ma rifiuta decisamente il modo e il metodo con
cui il marxismo ha attuato la rivoluzione. Inoltre, come le religioni tradizionali
danno maggiore rilievo ad atti esteriori, di inutile devozione, tralasciando di
soccorrere effettivamente coloro che soffrono, così il marxismo dà maggiore
rilievo alle questioni economiche e militaristiche tralasciando in parte il problema della liberazione di tutti gli uomini.
La liberazione, per Capitini è raggiungibile solo nella e attraverso la compresenza, da intendersi come unione ideale dei morti e dei viventi. La definisce “presenza di tutti o corale alla creazione dei valori”14. La compresenza è
35
36
la via verso la trasformazione della realtà del tutto (oggettivo, passivo, esterno, chiuso) alla “realtà di tutti”. La realtà di tutti preme perché l’attuale realtà
fenomenica che pone tanti impedimenti alla piena esplicazione dei valori, che
limita e separa, che opprime e schiaccia e dà la morte, si apra ad una realtà
liberata che sia compiutamente all’altezza delle esigenze migliori di tutti gli
esseri e li assecondi nei loro propositi di bene. Scrive Capitini: “Ho insistito
per decenni ad imparare e a dire che la molteplicità di tutti gli esseri si poteva pensare come avente una parte interna unitaria di tutti, come un nuovo
tempo e un nuovo spazio, una somma di possibilità per tutti i singoli, anche i
colpiti e annullati nella molteplicità naturale, visibile, sociologica. Questa
unità o parte interna di tutti, la loro possibilità infinita, la loro novità pura […]
l’ho chiamata compresenza”. La legge della compresenza diventa lo sviluppo
del meglio, non in una dialettica di mors tua, vita mea, ma nell’accrescersi del
valore15.
Al tema della compresenza Capitini ha dedicato l’ultima sua opera, La compresenza dei morti e dei viventi, l’opera più compita, più filosofica, ma, nello
stesso tempo, quella che presenta più incongruenze. Come rivalutare, nell’ambito della compresenza, oltre alla limitata attività dello sfinito, dello sfiancato, del morto senza nome, quella negativa del malvagio, anch’essa definita
cooperante? Capitini parla di mistero. Ma è sufficiente il ricorso al mistero per
evitare una giustificazione di tipo hegeliano che sostituisca all’astuzia della
Ragione, l’astuzia della Compresenza? E l’immortalità? È vera l’immortalità da
lui reclamata? Come prescindere, poi, dalla problematicità del rapporto io-tualtri che si esprime in direzioni alterne e contrastanti? È davvero così trainante la forza dell’amore?16
Nella visione capitiniana della compresenza l’individuo conserva la sua
importanza, ma ben più determinante diviene l’atto di amore attraverso il quale
egli si apre al “divino tu” e a tutti. Solo così l’individuo sperimenta la compresenza, “una realtà più larga e più vera” e si innalza ad un orizzonte di universalità e di totalità. Il carattere corale della compresenza non dissolve le individuali singolarità e soltanto nel suo ambito è possibile parlare di immortalità
individuale, come qualcosa che l’individuo prova, non come uno stato di personale beatitudine, ma come partecipazione ad un’opera di incremento di
valore, in un impegno personale che coinvolge tutti. “La realtà dell’immortalità
degli individui “ si legge in La compresenza dei morti e dei viventi, “non può
uscire da me affermata che in rapporto al tu, all’atto di apertura […] al tu. Cioè
se si deve affermare una immortalità, noi non possiamo affermare che quella
altrui. Solo lì, nella direzione del tu, si apre un pertugio. Tra la nessuna immortalità e l’immortalità degli altri, l’amore sceglie che tu sia immortale”17. Quello
che viene dato all’io in “sovrappiù”, è mediato dall’amore degli altri. Questo
accesso dell’individuo a quello che Capitini chiama “l’eterno presente della
realtà di tutti”, è una scelta, un atto di apertura religiosa che si sottrae a ogni
possibilità di descrizione e di teorico rispecchiamento, essendo la compresenza, come egli insiste “una nuova categoria soltanto pratica”18. Il concetto di
compresenza fonde insieme due elementi, entrambi pratici, l’infinita apertura
a tutti e l’impegno nella produzione dei valori in perpetuo incremento. Essa ci
SAGGI
porta oltre il limitato, il finito, il temporale, per essa, utilizzando le parole di
Spinoza, sentimus experimurque nos aeternos esse.
Come per Kant così per Capitini l’accesso al noumeno, all’incondizionato è
affermabile in sede non di teoresi ma di prassi, di quella “prassi per il valore
che ci unisce, ci fa compresenti”19. Kant, per Capitini è soprattutto il filosofo che
ha liberato la morale da ogni forma di utilitarismo, che ha affermato il primato
della ragione pratica, che ha sostenuto la tensione verso l’ideale che è la vera
realtà anche se irraggiungibile. Egli sottolinea che in Kant è presente implicitamente la teoria della compresenza e, per dar forza a questa sua convinzione, cita una frase kantiana: “Noi possiamo avere fiducia che, se noi fossimo o
diventassimo un giorno perfettamente ciò che dobbiamo essere o potremmo
diventare (con una continua approssimazione), la natura dovrebbe obbedire ai
nostri desideri, i quali, però, allora, non sarebbero mai insensati” (La religione
nei limiti della semplice ragione)20. Capitini commenta: “Non è l’accettazione
del mondo com’è (naturalismo) ma l’esigenza che il mondo sia piegato, prima
o poi, da noi o dall’opera altrui o insieme, ai nostri desideri puri, noi diremmo
alla compresenza, che essendo realtà di tutti e produzione del valore, ci dà la
garanzia di desideri puri, sani”21. In Kant, però, tale esigenza di trasformazione rimane irrisolta in quanto il dualismo tra realtà fenomenica e realtà noumenica non viene mai superato. Capitini, invece, opera soprattutto per la trasformazione della realtà e cerca di metterlo chiaramente in evidenza: “Nella concezione kantiana […] la trasformazione di questa natura, che è semplicemente fenomenica e la sostituzione con un’altra natura, non è determinata e resta
un postulato […]. Noi, della realtà liberata, cioè di una realtà adeguata alla
compresenza, ammettiamo di poter incontrare già anticipazioni, perché la
natura non è concepita soltanto come un insieme sottoposto a leggi inflessibili (che non sono schemi), ma la vediamo aperta all’influenza del valore a trasformarsi, a progredire verso la realtà liberata”22.
Nella nonviolenza la compresenza trova il suo modo essenziale di esplicazione. Capitini riconosce in Gandhi il suo maestro, in lui trova l’idea del metodo
non violento, impostato sulla noncollaborazione e il senso che ogni lotta per la
libertà è anche una lotta religiosa; in lui vede l’incarnazione del persuaso che
lotta non soltanto per redimere gli individui ma anche per mutare la società.
Solo partendo dall’importanza che Capitini attribuisce alla prassi si spiega
l’attenzione da lui dedicata a certi modi della condotta, a certe tecniche del
comportamento, a quelli che egli chiama “i modi pratici dell’apertura” tra i quali
annovera la nonmenzogna, la noncollaborazione e la nonviolenza.
La nonviolenza è, per Capitini, apertura all’esistenza, alla libertà, allo sviluppo di ogni essere; è lotta non soltanto contro le situazioni in cui si manifesta una violenza esplicita, ma è lotta anche contro se stessi, le proprie tendenze, i propri sogni di quiete; ma la nonviolenza è soprattutto un atto di
amore: “Il mondo ci è estraneo se ci si deve stare senza amore”23, afferma
Capitini. Manifestazione iniziale e fondamentale di questo amore, la sua prova
più concreta, è l’atto di non uccidere: “Troppe nefandezze sono oggi compiute a ‘fin di bene’; gli uomini sono considerati come cose; ucciderli è un rumore, un oggetto caduto”. Gli uomini, invece, sono ben altro che semplici ogget-
37
38
ti o mezzi per l’utilità di chicchessia, hanno in sé un valore assoluto ed irripetibile, in tutti, anche nell’essere più meschino o malvagio c’è l’esigenza e la
possibilità della vita spirituale perciò “amare queste persone infinitamente,
vederle come centro, compiacersi di ciò, chiamarle dalla parte nostra, rispettarle e adorarle così, è vita altissima, è un dovere”.
La nonviolenza, però, non può limitarsi ad agire contro l’atto violento in sé,
ma anche contro le situazioni di violenza, contro l’ordine sociale esistente che,
in tante sue leggi e istituzioni, condensa in potere e privilegi una violenza che
perdura da secoli. L’istanza morale di unità-amore con tutti diventa azione politica; la nonviolenza, allora, non è una prerogativa di singole persone, ma investe la dimensione collettiva e interviene per la trasformazione delle strutture,
di tutto ciò che socialmente colpisce e divide gli uomini. Ma perché il nuovo
ordine a cui si tende non riprenda i modi e le strutture del vecchio ordine ingiusto, per non finire di assomigliare all’avversario violento, è indispensabile condurre la lotta con animo e mezzi non discordanti dal fine. “Possiamo dire ai […]
rivoluzionari […]: noi vogliamo una società di tutti e cominceremo con l’ammazzare migliaia? Vogliamo una società amorevole e cominceremo col coltivare e stimolare l’odio? Vogliamo una società libera e aumenteremo la tirannide, l’assolutismo? Vogliamo un fine buono e pulito e useremo mezzi sporchi
e terribili? […]Esiste un legame organico tra il fine e i mezzi e l’averlo fin qui
trascurato […], usando la guerra come via alla pace, la dittatura come via alla
libertà, la violenza come via all’amore, ha esacerbato la crudeltà e l’oppressione nel mondo”24. Bisogna, quindi, ricercare mezzi adeguati al fine che si
persegue perché i termini (mezzi e fine) prendono significato e valore dal loro
attuarsi.
L’esperienza di lotta nonviolenta gandhiana ha mostrato a Capitini che è
possibile agire efficacemente, senza il ricorso alla forza violenta, utilizzando
tecniche d’azione già sperimentate. Sciopero, boicottaggio, obiezione di
coscienza, rifiuto di pagare certe tasse, disobbedienza civile, sono mezzi che
impiegati con la dovuta preparazione ed estensione possono avere la forza di
neutralizzare il più potente avversario, senza che ci sia bisogno di versare una
sola goccia di sangue del partito avverso. Principio essenziale di questa strategia è la noncollaborazione. Se le classi dominanti hanno la possibilità di
esercitare un potere ingiusto, ciò è fondamentalmente in virtù della collaborazione fornita dalla maggioranza della popolazione della quale fanno parte
anche gli oppressi. Sottrarre questa collaborazione significa esautorare la
fonte del potere oppressore.
All’enunciazione delle idee, Capitini ha fatto, sempre, corrispondere la più
intensa applicazione pratica. Da questa, però, non ha tratto i frutti che sperava, per cui si dichiara “sconfitto”. La sconfitta di Capitini si associa alla sconfitta di tutti quegli intellettuali che, alimentandosi di ideali troppo puri, hanno
cercato di scuotere una società che si nutre di violenza e menzogna. Capitini,
però, è uno sconfitto che ha, comunque, lasciato un’impronta profonda perché
molte sono le cose che ha compiuto, tentato di compiere la cui giustezza è
stata comprovata dagli eventi.
Qual è, allora, il senso della filosofia del “non-filosofo” Aldo Capitini?
SAGGI
Certamente la potenza suggestiva di un messaggio rivolto ai sentimenti e
alla coscienza, che fa leva sull’amore, non si concilia facilmente con quello
“spirito di geometria” che è proprio di tanta parte della filosofia comunemente
intesa, per cui si sarebbe tentati di trovare in un’altra sfera, quella etico-politica, il senso e il significato della sua opera. Però, la qualità morale e religiosa
dei suoi scritti non invalida la sostanza filosofica che è espressione di un filosofare diverso, inteso come sintesi di sentimento e di pensiero, di ragioni della
mente e di “ragioni del cuore”.
39
C. MICHELSTAEDTER, Scritti vari, n. 99, 1909, in Opere, a c. G. Chiavacci, Firenze, 1958, p. 774.
A. CAPITINI, Religione aperta, Vicenza, 1964, pp. 12-13.
3
Ivi, p. 13.
4
Un inedito filosofico di Aldo Capitini, “La cultura”, Anno XVI, n. 4, 1978, p. 345.
5
Cfr. L. SEMERARO, Un filosofo non scolastico della religione. Aldo Capitini, Lecce, 1983, p. 45.
6
J. DEWEY, Intelligenza creativa, Firenze, 1976, p. 62. Cfr. L. BORGHI, Personalità e pensiero di
Aldo Capitini, “Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa”, Serie III, vol. V, I, 1975, p. 278.
7
A. CAPITINI, Religione aperta, cit., 182.
8
ID., La compresenza dei morti e dei viventi, Milano, 1966, p. 67.
9
B. CROCE, Etica e politica, Bari, 1973, p. 23.
10
A. CAPITINI, Religione aperta, cit., p. 191.
11
Ibidem.
12
Ivi, pp. 193-194.
13
Ibidem
14
ID., La realtà di tutti, Trapani, 1965, p. 46.
15
ID., La compresenza dei morti e dei viventi, cit., p. 19.
16
Cfr. G. M. BERTIN, La teoria della compresenza, in Il messaggio di Aldo Capitini, Manduria,
1977, p. 496.
17
A. CAPITINI, La compresenza dei morti e dei viventi, cit., p. 245.
18
Ibidem, p. 258.
19
Ivi, p. 232.
20
Cfr. Ivi, p. 225.
21
Ibidem.
22
Ibidem.
23
ID, Elementi di un’esperienza religiosa, Bari, 1937, pp. 2O-21.
24
ID, Religione aperta, cit., pp. 9-13.
1
2
LA CITTÀ DEL FOLLE.
LIMITE, DELIRIO, SCRITTURA
IN UN SAGGIO DI ROLAND KUHN
di Federico Leoni
1. La città e il sogno
40
Nel 1952 Roland Kuhn, uno psichiatra svizzero tedesco che è stato tra i
continuatori più originali di Ludwig Binswanger, pubblicò uno scritto intitolato
Über die Bedeutung vom Grenzen im Wahn, Sul significato del limite nel delirio1. Il delirio di cui Kuhn parla in quel saggio, il delirio di Franz Weber –così si
chiama il suo paziente–, è infinitamente avviluppato e stratificato intorno all’unico tema della città. Ciò che, alla lettura, risulta più impressionante è il fatto
che nell’esperienza sconvolgente di quest’uomo, avvinto in una Stimmung
schizofrenica via via più angosciosa, impegnato nella progettazione dettagliatissima, interminabile di quella che doveva essere la città ideale, sia possibile
ravvisare un’esperienza a suo modo vertiginosa del senso dell’abitare il paesaggio familiare, a tutti comune, delle case e dei palazzi, delle strade, dei
quartieri e delle piazze, e che, in quell’esperienza, sia infine possibile ravvisare una verifica smagliante dell’osservazione fatta una volta da uno storico dell’architettura e dell’urbanistica come Joseph Ryckwert: “più che ad ogni altra
cosa”, dice Ryckwert, “la città somiglia ad un sogno”2.
Quando Kuhn lo viene a conoscere, Weber è un uomo di cinquantatré anni.
Ha alle spalle vari mestieri e ha lavorato per qualche tempo come disegnatore tecnico. Convinto che i colleghi stiano tentando di avvelenarlo, perde il
posto. Ricoverato una prima volta, ventottenne, una seconda a trentatré anni,
per alcolismo, all’età di quarantaquattro viene internato definitivamente. Da
dieci anni, al momento in cui Kuhn scrive, Weber vive rinchiuso in una casa di
cura, dove ha modo di dedicarsi, nel corso delle giornate, a piccoli “lavori di
scrittura”, come li definisce, a “immagini” e “schizzi” in cui si esprime una formazione delirante ormai vastissima, esito incessantemente ampliato e rielaborato di una stratificazione tematica in perenne deriva a partire dall’unica
immagine, essenziale, della città. Circa duecento lettere e un numero imprecisato di disegni costituiscono, insieme alle spiegazioni di volta in volta ottenute dal paziente stesso, la documentazione che Kuhn prende in esame in
questo scritto: frammenti di un progetto architettonico e urbanistico della città
futura, in cui l’umanità avrebbe dovuto vivere e prosperare, spiega Weber,
finalmente al riparo dalla sua “imperfezione”, dalla sua “incompiutezza”, dal
suo “disorientamento”. Sono infatti questi i mali che affliggono gli uomini e che,
allo stesso modo, tormentano il paziente: “garbugli di pensieri” e “seccature
2. Girotondo
Un giorno Weber avverte il bisogno di “ricongiungersi con i suoi possedimenti”, come dice, cioè con la città che va progettando e con il territorio della
sua nazione, la Svizzera. Scrive quindi una lettera all’infermiere capo del
reparto, pregandolo di aiutarlo a realizzare un viaggio senza il quale, dice, non
sarebbe possibile alcuna guarigione sua né dell’umanità. Si dedica perciò a
progettarne l’itinerario: “fino a San Gallo, Zurigo, Lucerna, Berna, Losanna,
Ginevra e ritorno verso Neuchâtel e San Gallo”.
Weber chiama questo percorso Rundreise: un viaggio in cerchio, si potrebbe tradurre, un giro in tondo. Kuhn nota la similitudine tra questa espressione
e un’altra idea del paziente, fondamentale tra quante presiedono alla strutturazione della città, secondo cui questa nascerebbe, nel tracciato del suo perimetro, da un movimento che Weber definisce Kreislauf: di nuovo una sorta di
giro in tondo, un corso circolare. Difficile, dice Kuhn, esplicitare il senso di questo Kreislauf, di questa sorta di girotondo. Intuendone l’assoluta centralità, egli
prova comunque a chiarirlo. Come nel battello che doveva servire alla
Rundreise dovevano essere possibili due movimenti, l’andare in cerchio all’interno del battello stesso, forse sul ponte, e il movimento del battello stesso che
lascia il porto, compie il proprio viaggio e rientra nel porto, così anche nella
SAGGI
della propria persona”, “svalutazione”, “faccende diametrali”, “prigionia”. Spera
che la città da lui progettata possa un giorno offrire a se stesso, a tutti, una
“restaurazione” e “una vera costruzione”, un “ordinamento stilisticamente corretto” o, come anche dice, “un inizio e una fine”, una “compiutezza” tali che “la
gioia diverrà di questa terra”.
Una gran quantità di tavole sviluppa graficamente il progetto. Kuhn ne
riproduce alcune: planimetrie, disegni di facciate, piante, prospetti vari della
città. Essa racchiude, dice ancora il paziente, “arte, artigianato, scienza e
stato”, e a questo “tesoro”, nei disegni, corrisponde una partizione minutissima degli spazi: quartieri ed edifici, palazzi e stanze sono dedicate e intitolate,
con una grande scritta in stampatello, a quelle sfere di interesse, la scienza,
l’artigianato, così come a molte altre attività: vi sono infatti biblioteche e giardini, un’agorà e un forum, un chiostro, un’accademia, un hotel.
Ciò che più colpisce, nei disegni di Weber, e ciò su cui Kuhn più insiste, è
appunto l’attenzione ossessiva e angosciosa con cui case, isolati, quartieri si
trovano delimitati e isolati gli uni rispetto agli altri. Tutto si gioca su questo tracciare suddivisioni, stacchi, partizioni. Tutto, con le parole del paziente, obbedisce ad un’esigenza di Skelettierung: un dare forma di ossatura o di scheletro, un gesto duplice che disegna sia la città sia gli uomini che la abitano, in
una sorta di specularità, di accordo proporzionato che le città esistenti negano e calpestano, ma che questa saprà finalmente instaurare “contro la guerra”
e “contro il nulla” che imperversano. Una cinta di mura garantirà la rinascita
degli uomini, racchiudendo e preservando “quanto di più bello” si possa immaginare “di fronte alla piccolezza umana”.
41
42
città, che doveva essere costruita in riva ad un mare, era presente una tale
struttura circolare. Le mura della città devono infatti riprodurre e, incarnare
questa circolarità, che gli abitanti hanno il compito di tenere viva attraverso
danze e cortei, specie di sortilegio ritualmente rinnovato per le vie, a salvaguardia della città dalla minaccia della terra desolata che la assedia.
L’“illimitato” e l’“incompiuto”, contro cui Franz Weber sente di dover lottare
sono così tenuti a distanza, fuori dalla città, e dominati con un’infinita, angosciosa insistenza sul limite, sulla traccia della delimitazione, sul segno liminare. La città, gli schizzi e i manoscritti in cui essa prende forma, i pensieri di
Weber, i suoi discorsi, nel corso del tempo, si orientano infatti sempre più decisamente ed esplicitamente all’esperienza del limite. Diviene anzi riconoscibile, e centrale, nel delirio di Weber, qualcosa come una vera e propria
Grenzproblematik, una problematica del limite, come Kuhn dice. Il malato
stesso si dice investito da un’interminabile Aufgabe der Begrenzung: letteralmente, da un compito di delimitazione. Le case vengono accostate le une alle
altre in sequenze sterminate poste ai margini dell’abitato, come fossero pietre
di delimitazione. Le vie e le piazze vengono così ossessivamente delimitate da
risultare, infine, chiuse e cieche. Nessuna via si affaccia su un’altra via, nessuna piazza si apre al resto della città. L’acribia con cui la città stessa viene
isolata dal suo territorio assume forme estreme e terribili. “Non si possono
oltrepassare i limiti”, dice Weber, “là, si cadrebbe”, “là vicino tutto ciò che è piccolo viene scorticato”.
I limiti dell’abitato sono rafforzati all’infinito. Si potrebbe dire, da un certo
punto di vista, e nonostante Weber e Kuhn parlino quasi esclusivamente di
Grenzen –cioè di limiti, di frontiere cui inerisce un rapporto positivo tra l’al di
qua e l’al di là della linea, cui appartiene, quindi, un’allusione o un rinvio dell’al di qua all’al di là del limite, e viceversa –che quelli della città sono invece,
nel senso più radicale, SchranFen– cioè confini, trincee che con l’esterno
intrattengono un rapporto puramente negativo, che agiscono e che sono esperite solo in rapporto ad un interno, ad un dentro che si vuole assoluto. Tutto ciò
che accade, dice infatti Weber, “deve accadere all’interno”; la città deve essere costruita “dall’esterno all’interno”, aggiunge; tutto è “da fuori a dentro”.
E tuttavia, o proprio perciò, il cuore della città non sta nel centro, ma nel
giro della delimitazione più estrema. Tutto si gioca su quel filo. Dapprima questa scorza, che si inoltra per chilometri opponendosi al “nulla” e alla “guerra”,
viene rappresentata da Weber come una muraglia o un fossato colmo d’acqua. Nei disegni più tardi, essa si riduce ad una cornice di colore dorato, in
accordo ad una tendenza all’astrazione e alla stilizzazione sempre più accentuate: “i piani diventano ornamento”, dice il paziente stesso, assumono, cioè,
una funzione quasi esclusivamente decorativa, tale che si può finalmente
“tracciarli in modo interessante”. Nella fase centrale dello sviluppo del delirio,
però, quella cerchia più esterna –peraltro destinata a diventare nel tempo
“angolare”, come la quasi totalità delle partizioni interne alla città– è rappresentata da un susseguirsi ininterrotto di spazi quadrati, cioè da grandi, sterminate stanze o abitazioni in cui risiederebbero personaggi che Weber definisce
“Doktorgrade”.
Nessuno vorrebbe abitare una simile prigione. Ma c’è di che pensare e di
che riflettere, nella vicenda di questo malato che firmava le sue lettere “Kaiser
Franz Weber” o, a volte, “Franz Weber, Europa”. C’è qualcosa di lancinante
nell’ossessione di un uomo –Kuhn non ne fa mai parola, ma come dimenticarlo?– nel pieno della distruzione dell’Europa, nella seconda guerra mondiale, traccia instancabilmente i piani di una nuova utopia. “Quando fuori nel
mondo domina la guerra”, scrive Weber in una delle sue lettere “allora ci si può
ritirare in questo luogo, allora si possono ritrovare in questo luogo i beni della
cultura difesi e risparmiati”.
Talvolta, tuttavia, nonostante il lavorio incessante di delimitazione e di ripartizione degli spazi, Weber sente con angoscia di non aver saputo realizzare al
meglio il proprio compito: “egli dice di perdere in questo modo la libertà, scrive Kuhn, e di cadere in conflitto con quel che cerca di tenere fuori dalla città,
con il caos”. E, prosegue Kuhn con un’osservazione insieme acuta e stranamente incongrua, “a questo proposito non sempre si distingue chiaramente di
cosa intenda parlare, se del suo proprio essere o della città”3.
Kuhn coglie qui con acume straordinario il nodo in cui si decide dell’angoscia o della salvezza del suo paziente, e della sua città. Arriva a vedere, in un
lampo, quell’unità tra città e uomo, tra disegno ed esistenza, tra scrittura ed
esperienza, tra limite e mondo, che stanno al cuore della visione delirante di
Weber. Ma vede questo nesso in un curioso capovolgimento, in cui l’intuizione si oscura immediatamente. Non sempre si distingue, dice infatti Kuhn, di
cosa il malato intenda parlare, se di sé o della città. E tuttavia, se si leggono
le parole del paziente, pur nell’incertezza inevitabile delle trascrizioni, delle traduzioni, pur nella fragilità delle scritture seconde che la psicopatologia ci offre,
appare che solo per Kuhn questa esatta attribuzione del conflitto –all’essere
della città o a quello dell’uomo?– è problematica, è rilevante, è incerta. Solo
per Kuhn, perché per Weber è invece questione sempre solo di uno stesso
gesto, in cui, ponendo il limite, tracciando il perimetro della città, si disegna,
insieme e di contro, la figura dell’uomo che la abita. Perciò il fallimento o il successo di quel gesto è il successo o il fallimento simultaneo dell’essere della
città e dell’essere dell’uomo, di Franz Weber stesso. Perciò quella sorta di indistinzione non è un difetto di senso, per dire così, del delirio di Weber, né, certo,
un difetto di comprensione da parte di Kuhn, ma, a suo modo, una necessità
inerente alle cose stesse.
Proprio Kuhn nota infatti magistralmente che la Grenzproblematik di Franz
Weber è qualcosa che va ben al di là della “semplice delimitazione dei progetti
della città fantastica”, e che essa rappresenta piuttosto la “concretizzazione” di
una specifica Daseinsform, di una specifica forma di vita, di una specifica scrittura dell’esperienza e dell’esistenza. Ed è esattamente su questa unità duplice del senso inerente all’esperienza del limite, esperienza insieme autenticamente antropologica e cosmologica, umanistica e urbanistica, che si tratta di
insistere.
SAGGI
3. “Del suo proprio essere, o della città”
43
4. Il sacro, il profano, il limite
44
Fin dall’inizio del suo studio Kuhn colloca il tema del limite entro una simile prospettiva antropologica e cosmologica, rifacendosi, ancor prima di affrontare la descrizione del caso di Weber, ad Ernst Cassirer e alla sua monumentale Filosofia delle forme simboliche. Kuhn richiama alcuni passi del
secondo volume dell’opera, dedicato al “pensiero mitico”, relativi al tema del
limite e, si potrebbe dire, all’ordinamento di mondo e di esperienze umane e
divine che il mito incontra a partire da un gesto delimitativo in ogni senso primordiale.
Cassirer rileva dapprima, in quelle pagine4, che ogni luogo, appartenente
allo spazio che egli definisce “mitico” per differenza dal nostro, “geometrico”,
che “ogni ‘qui’ e ‘là’ non è un semplice qui e là, non è il semplice termine di
una relazione generale, che si ripeta in modo uniforme nei contenuti più diversi; ma ogni punto possiede qui, per così dire, un proprio ‘accento’”.
Un accento, dunque. Cassirer chiarisce: “le linee divisorie, che la coscienza traccia e per cui il mondo si articola spazialmente e spiritualmente, si fondano […] sul fatto che l’uomo, nella sua posizione diretta di fronte alla realtà,
si limita nella sua volontà e nella sua azione, traccia per sé determinati limiti a
cui il sentimento e il volere rimangono legati”. È in questa delimitazione che si
rendono riconoscibili simili accenti, simili discontinuità di senso. E, come ancora Kuhn ricorda, riprendendo fedelmente il percorso cassireriano, la delimitazione più originaria dello spazio mitico è quella che accade nel suo differenziarsi in due campi, due territori: l’uno straordinario e terribile, eccezionale,
esecrando; l’altro ordinario, quotidiano. Il primo accento è questo del sacro
che oppone al profano, è l’accento dello spazio che si stacca in se stesso e
che, in quella traccia, in quella partizione liminare, emerge come sacro sprofondando come profano.
L’intuizione di Kuhn, per cui il “compito” di questa scrittura di limiti è tutt’uno con una specifica Daseinsform –su questa base egli potrà appunto argomentare, come infatti fa, seppure marginalmente, che qualcosa di questa
scrittura sopravvive e dà senso ancora oggi a qualcosa della nostra esperienza di spazio, e, quindi, a qualcosa dell’esperienza di spazio che la follia
talora vive– questa intuizione è, d’altra parte, presente, a suo modo, già in
Cassirer. Questi nota infatti che “nella forma di spazio che il pensiero mitico
abbozza, si esprime tutta la forma mitica di vita e può in un certo senso esservi colta”, e, riprendendo la riflessione, prima interrotta, sulla partizione tra
sacro e profano, aggiunge che la “forma” stessa del sacro trova “la sua prima
oggettivazione volgendosi verso l’esterno e presentandosi nell’intuizione di
rapporti spaziali”.
“Il sacro, ribadisce quindi, comincia in quanto dalla totalità dello spazio
viene distinta una determinata regione, separata dalle altre […]”, e a questa
pratica del limite, aggiunge, si possono ricondurre le parole templum e témenos, che in latino e in greco rispettivamente indicano il tempio, derivandone il
significato da una radice, teu, che significa appunto “tagliare”. Cassirer, a questo punto, richiama rapidamente e suggestivamente le molteplici operazioni
SAGGI
rituali di delimitazione compiute dai sacerdoti romani, sulla scia di una continuità di pratiche antichissime e, diremmo noi, diversissime quanto quelle della
religione e dell’architettura. Proprio in questa mossa cassireriana, di straordinaria profondità, l’ambito della Grenzproblematik sacrale si sposta gradualmente, o, meglio, mostra una unità di fondo rispetto al tema della città, e, in
questo spostamento, si approssima al tema kuhniano del rapporto tra esperienza del limite e delirio dell’abitare.
La partizione del cielo in quattro regioni, scrive infatti Cassirer, “secondo la
linea Est-Ovest indicata e stabilita mediante il corso del sole” e “la linea ad
essa perpendicolare tracciata nel senso Nord-Sud”, veniva esattamente trascritta, in una sorta di replica terrena, nell’incrocio tra le linee del cardo e del
decumanus, e la città stessa finiva con il coincidere, nella sua fondazione, con
questa pratica delimitativa. Solo sulla base di quelle partizioni celesti e terrestri potevano poi sorgere e orientarsi vie, edifici, piazze. Solo sulla base di
questa originaria architettura di limiti –dentro e fuori, sacro e profano, luce e
ombra, come ancora Cassirer nota, o compiutezza e caos, nell’ossessione di
Franz Weber– l’esperienza dell’uomo si iscriveva nell’esperienza del mondo.
Grandiosa architettura, per noi irrimediabilmente insensata, o, suggerisce
Kuhn, enigmaticamente riprodotta e rivissuta nella follia.
5. Le mura, il nulla, la guerra
Non si può comprendere l’angoscia irreparabile di Franz Weber, la fuga
interminabile di una delimitazione mai sufficientemente certa, se si pensa però
che il gesto del tracciare e l’accadere del limite siano questioni originariamente “antropologiche” o “psicologiche”. Perché mai, infatti, chi vive nell’angoscia
dell’illimitato non riesce a placarsi nonostante un’opera di delimitazione sempre più precisa, sempre più ossessivamente e intenzionalmente dilagante, a
suo modo sempre più mirabilmente precisa?
Invocare la follia quale spiegazione di questo apparente nonsenso è troppo semplice: proprio questa follia si tratta di comprendere, e non di presupporre. Un paio di passi di Cassirer devono allora essere richiamati. In essi si
nasconde –sia detto con timore e tremore– un inciampo segreto ma esiziale.
Il primo passo: “nella forma di spazio che il pensiero mitico abbozza, si esprime tutta la forma mitica di vita”. Il secondo: la forma stessa del sacro trova “la
sua prima oggettivazione volgendosi verso l’esterno e presentandosi nell’intuizione di rapporti spaziali”5. In entrambi è questo “esprimersi” e questo “volgersi verso l’esterno” a sollevare delle difficoltà: quasi che vi fosse anzitutto
un’esistenza mitica preesistente al suo mondo, e che un mondo neutro e incolore le si parasse di fronte, affinché essa potesse tracciarvi i propri segni e
colorarlo dei propri colori, appunto volgendosi all’esterno, in un mondo mai
prima frequentato, ed esprimendosi infine dopo una lunga vita di pura, incontaminata interiorità.
Ancora la chiusa che Cassirer pone al capitolo in questione, in cui si
addensano i risultati di molte pagine di analisi splendide, riporta alla luce la
45
46
medesima difficoltà. Scrive infatti Cassirer: “quando ciò che è puramente interiore è costretto ad oggettivarsi, a convertirsi in qualcosa di esteriore, accade
che ogni intuizione della realtà esteriore rimanga durevolmente permeata e
intessuta di determinazioni interiori”. Una volta di più sembra sia presupposta, qui, al gesto del tracciare il limite, all’emergere del mondo nella spaccatura tra sacro e profano, una interiorità intenzionale già data, già costituita
con tutti i suoi caratteri. Non si dovrebbe invece, coerentemente con le osservazioni e gli intenti di Cassirer stesso, cogliere l’insorgere simultaneo dello
“spazio mitico” e della “coscienza mitica”, la cooriginarietà dell’interiore e dell’esteriore, il loro accadere nella partizione, nel loro limite appunto? E ancora: se è nel ripartire tra sacro e profano che lo spazio mitico si dischiude per
così dire per la prima volta alla “coscienza mitica”, come Cassirer afferma,
dove mai starebbe quella coscienza prima del gesto di quella ripartizione?
Cassirer scrive che la possibilità del tracciare un limite si basa sul fatto che
l’uomo, “nella sua posizione diretta di fronte alla realtà”, “si limita nella sua
volontà e azione, traccia per sé determinati limiti a cui il suo sentimento e il
suo volere rimangono legati”. Ma è davvero necessario pensare l’uomo posto
“di fronte” alla realtà, e pensare il limite come qualcosa che l’uomo “dà” a se
stesso?
Ciascuna di queste proposizioni spiega il limite presupponendolo: “dare
a se stesso il limite”, “porsi di fronte alla realtà”, tutto ciò, messo da Cassirer
sul conto dell’uomo, del suo “spirito” –certo, questa è la forza del suo magistero neokantiano, è il rinnovarsi della rivoluzione copernicana del maestro
di Koenigsberg– presuppone tuttavia un sistema ricchissimo di partizioni
–interiore ed esteriore, sacro e profano, città e territorio, uomo e mondo–
piuttosto che spiegarne l’origine. Ed è forse proprio da questa incertezza che
nasce lo strano capovolgimento prospettico che si riproduce in Kuhn, quando egli, pur individuando con chiarezza l’identità tra il senso della scrittura
planimetrica di Weber e il senso della sua esistenza, infine dubita, trova stranamente indeterminata l’angoscia di Weber, si scopre incapace di intendere
se essa sia da riferirsi all’esserci del malato, come infatti dice, o all’esserci
della città.
Nella radicalità assoluta di questo delirio, ciò che emerge è invece precisamente lo strato di esperienza in cui scrittura dello spazio e scrittura del soggetto, limite dello spazio e limite del soggetto coincidono, come i lati contrapposti di uno stesso accadere, di una stessa traccia. Da questo punto di vista,
l’architettura weberiana è propriamente e letteralmente il sogno di una autobiografia, una scrittura del proprio mondo e un’iscrizione, in quel mondo, della
propria vita, della propria figura. Ma ciò significa, rispetto a Cassirer, rispetto
al modo in cui Kuhn si serve di Cassirer, che non è la coscienza mitica a scrivere lo spazio mitico, e che non è il folle a tracciare il proprio mondo di follia,
o che non è l’uomo, in generale, a disegnare gli spazi della sua città, più di
quanto non siano questi ultimi, cioè la città, il mondo della follia, lo spazio mitico, a tracciare i primi, a tracciare l’uomo del mito, la sua coscienza, la coscienza di Weber affondata nel delirio. È nello stesso tracciarsi del limite che sono
posti illimitato e limitato, il nulla e la città, l’uomo che aspira alla “compiutezza”
6. Il gesto, la danza, il labirinto
“Il movimento e la vita”, scrive Kuhn, “sono presenti nella città in due sole
forme. La prima consiste in feste e parate, la seconda nelle attività dei
Doktorgrade”. Di queste ultime, dei Doktorgrade, si dirà. Quanto alle “feste e
parate”, si tratta delle danze che, secondo Weber, devono garantire la sicurezza dei limiti della città, riproducendo periodicamente, attraverso le vie e le
piazze il movimento circolare, il Kreislauf, da cui la città stessa e le sue mura
traggono origine. Un primo sguardo ai piani della città, riprodotti da Kuhn,
lascia in realtà sospettare che nessuna danza, tanto meno di movimento circolare, potrebbe mai avere luogo in un simile dedalo di strade cieche, di cunicoli sottili e impercorribili, di percorsi inesorabilmente rettilinei e chiusi. L’idea
di danza, che doveva animare il Kreislauf di cui parla Weber, pare dover soccombere nella morsa di uno spazio labirintico, soffocante, minuziosamente
claustrofobico. E tuttavia proprio l’immagine del labirinto suggerisce un accesso imprevisto a questo nodo in ogni senso centrale della formazione delirante
di Weber. Proprio questa singolare scrittura di spazio –il labirinto, in cui dominano il limite imposto al cammino, l’inciampo e l’inganno, il sentiero interrotto
e l’accesso illusorio– è infatti legata, in origine, al gesto vivo e libero di una
danza. Non vi sarebbe cioè, per così dire, una assoluta estraneità tra danza e
labirinto, ma, anzi, tra loro, una familiarità segreta, che riposa sull’ininterrotto
trapassare della traccia gestuale nell’iscrizione urbanistica e architettonica, del
movimento della danza nella forma di spazio reso disponibile, e quindi abitabile, dalla danza stessa.
SAGGI
e la sua “incompiutezza” e le “seccature della sua persona”. Ecco allora che il
tracciare limiti sempre più accurati non salva infine Weber dalla sua angoscia.
Perché proprio alla scrittura del limite sembrano coessenziali una angoscia e
una lotta interminabile con l’illimitato. Non perché l’illimitato sia più vasto o
possente del limite, ma perché l’illimitato è posto con il limite e nel limite stesso; e come l’insistenza sul limite rafforza la città come un interno riparato dall’esterno, così quella stessa insistenza rafforza l’illimitato come l’esterno di
quell’interno, e ne ribadisce la presenza incombente. Ciò che appariva, da un
certo punto di vista, come un confine, volto unicamente all’interno, impermeabile all’esterno, infine e più profondamente non sta a sé, sfugge, si rivela cioè
un limite, affetto da una costitutiva duplicità. Diceva bene Kuhn, allora, in questa seconda prospettiva, le mura della città di Weber sono propriamente e inevitabilmente Grenzen, limiti, e non Schranken, confini. Il che significa anche
che nel limite città e guerra si annodano in uno, producono l’uno per l’altro
senza sosta.
Perciò quella delimitazione ossessiva, che nel delirio cresce su se stessa,
interminabilmente, nel placare l’angoscia da cui nasce anche la rinnova. Il limite ha in sé, e non fuori di sé, l’illimitato. La città di Weber, e Weber stesso, nella
loro consapevolezza misteriosa, stravolta, hanno la guerra e il nulla non fuori
dalle mura, ma in quelle mura stesse.
47
48
L’archetipo di ogni più complesso e tardo labirinto, scrive infatti Hermann
Kerr nel suo studio monumentale sui labirinti6, quello a sette spire di origine
cretese, può essere descritto come una croce, tra le cui braccia sono iscritte
quattro figure angolari e, in ognuna di esse, quattro punti. La figura complessiva risulta dal moto pendolare che, oscillando, congiunge via via tutti gli estremi individuati dallo schema dato. Una simile costruzione, a suo modo rigorosamente geometrica e astratta, non deve però ingannare, e già la semplice
osservazione della mano che compie quel tragitto, disegnando sulla carta o
tracciando sulla terra, mostra, immediatamente al di sotto della geometria, un
gesto ritmico, ciclico, il cui arco ricorda forse ancora qualcosa dell’antica
danza da cui quelle sette spire ebbero origine.
Con ogni probabilità, argomenta Kerr, quelle spire dovevano rispecchiare il senso del sorgere e del tramontare del sole, del nascere della vita e del
suo declinare nella morte, e proprio un simile tracciato di danza, messo in
scena di notte, fiaccole alla mano, un filo a dipanarsi disegnando e conservando memoria del percorso labile dei danzatori, rappresenterebbe l’originario labirinto. Labirinto dell’esperienza, prima ancora che costruzione intenzionale dell’uomo. Architettura di gesti, prima che architettura di pietra, il cui
significato abitativo non riposa altrove che in quel suo fondamento gestuale,
corporeo, pragmatico. Non è infatti mancato chi ha impiegato l’immagine del
labirinto per descrivere, suggestivamente, il dischiudersi dello spazio al
movimento del corpo, l’aprirsi dell’orizzonte del mondo in relazione all’agire
del corpo: l’unità di corpo e mondo nel loro articolarsi pratico, nel loro ripartirsi in ogni gesto, in ogni istante. Ogni spazio, è stato detto, è labirintico nel
suo disegnarsi a partire dal tentativo del gesto stesso che lo apre, a partire
dalla parzialità miope del protendersi e ritrarsi del gesto, dal suo definire e
ridefinire il proprio luogo in una ricognizione sempre imperfetta, in un afferrare o proporsi elusivo, incompiuto, e, proprio perciò, ripetibile, differibile,
riproponibile, vivo7.
Se un’originaria scrittura architettonica e un’originaria scrittura di gesti sono
legati da questa familiarità nascosta, da una ragione labirintica, ciò che nella
città di Weber riemerge è precisamente lo scontro tra la memoria di un’esperienza dell’abitare perduta, irraggiungibile, che sopravvive nell’idea di quella
sorta di girotondo ritualmente rinnovato per le vie della città, il Kreislauf, e le
rovine di quell’esperienza, il tracciato ormai inservibile e spettrale della vita di
un tempo, il suo scheletro scarno e angoloso. La scrittura vivente del gesto è
come tolta e conservata insieme, rimossa e trattenuta in questa luce autunnale, e il mobile labirinto della danza, del gesto, sopravvive prigioniero di tutte le
trappole astute e mortali dei labirinti.
7. La scrittura
Nella costruzione delirante di Weber, la scrittura di spazio che governa i
piani della città e che ne traccia i limiti, trova una sorta di doppio nella scrittura di quei personaggi misteriosi che sono i Doktorgrade, i quali vivono in gran-
SAGGI
di edifici posti sul limitare più estremo della città, ininterrottamente impegnati
in un’opera di scrittura che sembra racchiudere, nel delirio di Weber, un ulteriore, ineludibile nodo di senso. Seconda forma di vita e movimento, come
Kuhn dice, presente nella città, sola alternativa al movimento della danza e del
Kreislauf, la scrittura dei Doktorgrade consente forse un secondo accesso al
significato di quella perdita d’esperienza e di quella sua paziente e desolante
ricostruzione cui Weber è condannato.
L’essenziale, dice Kuhn, è che nella figura dei Doktorgrade si intrecciano in
una unità enigmatica la pratica del disegno e quella della scrittura, quella del
sapere e quella del limite. In questo scrivere e tracciare segni –in cui quegli
accademici e il malato stesso sono impegnati specularmente– è in gioco ciò
che Weber stesso definisce, a suo modo genialmente, come una
Existenzhortung, una accumulazione o una tesaurizzazione di esistenza. I
Doktorgrade trascorrerebbero la loro esistenza impegnati nella stesura di volumi, annualmente pubblicati, e nella realizzazione di tavole che li illustrano. Non
è dato sapere quale sia il contenuto delle loro ricerche. Weber, in proposito,
dice semplicemente che, nella loro attività, essi raccolgono e accumulano
Gedankengute, beni di pensiero, che osservano le cose del mondo “da una
prospettiva più ampia”, e che infine solo grazie alla loro interminabile opera
scrittoria la città resiste alla corrosione del deserto che, nietzscheanamente,
cresce e la stringe da vicino.
Più che al contenuto della loro scrittura, quindi, è alla sua forma che
Weber pensa, ed è a questa stessa forma che Kuhn si rivolge azzardandone una propria interpretazione. “È da rilevare innanzitutto”, scrive infatti,
“come i Doktorgrade siano in un vivo rapporto con lo strumento della scrittura e con la matita”. Essi se ne servono di continuo, li portano sempre con
sé, non se ne allontanano mai. Penne, righelli, matite sono, per loro, sempre “alla mano”, zuhanden. È una parola heideggeriana, zuhanden, e su
questa Zuhandenheit, su questo essere alla mano, letteralmente, entro un
contesto di uso, su questa utilizzabilità, come in genere si traduce
Zuhandenheit, propria degli “strumenti di scrittura”, Kuhn si sofferma a
lungo, sulla scia delle considerazioni svolte da Heidegger in Sein und Zeit.
L’interpretazione kuhniana del delirio di Weber si incentra, infatti, in ultima
analisi, sulla distinzione heideggeriana tra Zuhandenheit e Vorhandenheit,
tra enti utilizzabili ed enti semplicemente presenti, come si usa tradurre il termine Vorhandenheit.
“Il modo di essere del mezzo”, cioè dello strumento, scrive Heidegger8, “in
cui questo si manifesta da se stesso, lo chiamiamo utilizzabilità
(Zuhandenheit).” “Questa non deve però essere intesa, aggiunge, come un
carattere imposto dal nostro modo di vedere, quasi si trattasse di attribuire
cognitivamente all’‘ente’ che si mostra per primo un tale ‘aspetto’, oppure di
‘colorire soggettivamente’ una materia mondana in origine semplicemente presente. L’utilizzabilità è la determinazione ontologico-categoriale dell’ente così
com’esso è in sé”.
Solo in alcuni casi, prosegue Heidegger, in cui sulla via dell’utilizzo pratico si produce una sorta di inciampo, di disattesa, di sviamento, l’utilizzabili-
49
tà dello strumento viene meno. Lo strumento, cioè, banalmente, può non
funzionare. La sua utilizzabilità può essere compromessa. Benché solo in
maniera accidentale, su un piano ontico, come Heidegger si esprime, emerge così una seconda possibilità di manifestazione o di accesso all’ente, di
cui la teoresi radicalizzerà il significato su di un piano propriamente ontologico, cioè la possibilità, appunto, della semplice presenza, della
Vorhandenheit. “Uno strumento è guasto, un materiale inutilizzabile”, dice
dunque Heidegger: “esso si rivela solo più come semplice presenza e tale
da non poter sopperire alla mancanza di ciò che manca. Il restare interdetto, quale modo difettivo del prendersi cura, scopre l’essere solo più semplicemente presente dell’utilizzabile”.
Nella “sorpresa” e nell’“impertinenza”, come Heidegger le definisce, esperite di fronte ad uno strumento rotto o inadatto, emerge una sorta di distanza
imprevista e di sospensione. In essa, l’uso e la primitiva fiducia pragmatica
nelle cose del mondo, quotidianamente incontrate, si assottigliano. Ed è precisamente questa sorpresa che anche Kuhn rileva, definendola acutamente
come una stupefazione o uno stupire, un Auffallen, del medico di fronte a
Franz Weber, ma certo anche di Weber stesso nel suo commercio misterioso
e impossibile con il mondo delle cose.
8. “Tessile, scarpe, drogheria, farmacia, vini, liquori”
50
Le “cose”, appunto. I piani della città contengono molte indicazioni circa le
cose e le attività che dovevano esservi racchiuse: “tessile, scarpe, drogheria,
farmacia, vini, liquori”, si legge nelle tavole, oppure “botanica, chimica, matematica”, “stazione, nazione, continente, Europa”, o ancora “ferrovia, auto, strada, aereo”. Le parole, le sequenze di parole sono racchiuse, in genere, in un
rettangolo, cioè in un apposito edificio della città, spesso appartenente ai
Doktorgrade. Come nota Kuhn, “con la sistemazione di tali oggetti e concetti
nelle abitazioni dei Doktorgrade, per Franz Weber si preclude il rapporto pratico con quegli stessi oggetti o concetti”; “il loro carattere di strumento, nell’accesso che è loro proprio, è quasi completamente oscurato”; essi appaiono
infine “come semplice e nudo vorhanden”.
Molte cose subiscono questa Umgang o Umschlag –questa transizione, o
rivolgimento, come Kuhn dice, sorta di denudamento, di astrazione schizofrenica dalla concretezza delle loro possibilità strumentali. Venute meno all’esperienza del malato, queste si eclissano in quella prigione grafica che è la
città. Una gran quantità di oggetti scampati a questa distruzione, vestiti ed
arredamento, ad esempio, vengono invece completamente trascurati da
Weber. Non compaiono nella città, non vengono ricordati nei suoi discorsi, e
proseguono una sorta di esistenza sommessa e comune, giorno per giorno,
nell’esperienza del malato. Solo gli strumenti con cui i Doktorgrade scrivono,
le loro matite, penne, righelli, sono presenti nella città in una condizione ambigua e indecifrabile. Staccati dalla banalità e dal commercio strumentale quotidiano, ma non del tutto strappati a quella fiducia pratica primordiale, essi man-
SAGGI
tengono, dice Kuhn, il carattere della Zuhandenheit, ma in una forma spogliata e deformata, sono ormai impraticabili, ma non riconducibili alla categoria
della Vorhandenheit, comunemente utilizzati dai Doktorgrade, ma in un contesto d’uso privo di contenuto.
Non si conosce infatti l’argomento dei libri scritti dai Doktorgrade. La loro
scrittura è interminabile e inevitabile. Non importa, però, cosa essi scrivano.
È facile intendere d’altra parte, dai discorsi di Weber, come a questa seconda “forma” di “vita e movimento” presente nella città –la prima forma essendo quella delle danze e del Kreislauf– sia affidata la sopravvivenza dello spazio interiore della città rispetto al suo esterno desolante. Sorta di scrittura
seconda, se la prima è quella del girotondo, dei gesti, dei riti in cui il limite
della città viene periodicamente praticato dai suoi abitanti e come rintracciato e riscritto. Come le danze riproducono il Kreislauf, il giro delle mura difensive, attraverso le vie della città, rafforzandone o riconsacrandone l’esistenza, così la scrittura dei Doktorgrade, incessantemente praticata negli abitacoli
più estremi della città, tiene viva la città “accumulando esistenza”, dice
Weber. Allo stesso modo, nota ancora Kuhn, in una specularità ulteriore la
scrittura dei Doktorgrade è esattamente parallela a quella del malato, a quella di Weber. Sconcertante affinità tra la figura dei Doktorgrade e quella del
paziente stesso, che in quelle figure si è ritratto quasi come Michelangelo ha
fatto, dipingendo una pelle vuota e floscia, a propria immagine, perduta nella
folla di figure della Cappella Sistina. L’incessante scrittura urbanistica di
Weber lo tiene in vita, in bilico sulla sua angoscia, come la scrittura dei
Doktorgrade e la scrittura di mondo delle danze tengono in vita la città sul crinale della guerra che la assedia.
Proprio nell’operazione caratteristica di questa scrittura viene alla luce, dice
Kuhn, un tratto fondamentale del delirio di Weber. Se è vero che “lo scrivere e
il disegnare sono originariamente connessi con il senso del loro contenuto”,
come egli dice, proprio la scissione tra scrittura e contenuto, caratteristica del
lavoro dei Doktorgrade, rappresenta un indizio fondamentale in cui riconoscere il tratto più generale dell’esperienza del paziente. Egli appare infatti sempre
più profondamente incapace di un rapporto pratico con gli oggetti e gli strumenti dell’esperienza comune. Avviene come se l’esistenza accumulata nella
città vi fosse racchiusa, accantonata e, a suo modo, salvata, solo in quanto
sottratta alla vita di Weber. Ciò che a questa sfugge, a quella è attribuita. La
scrittura di Weber, la scrittura dei Doktorgrade, nel loro essere vuote di contenuto, svelano infine questo contenuto inerente alla loro nuda forma: esse sottraggono esperienza in quanto la accumulano, edificano la città in quanto
rimuovono la vita. O, forse più precisamente, producono l’esperienza e la vita
come ciò che dev’essere sottratto e rimosso, letteralmente mortificato, in
nome della città e della salvezza.
Follia della scrittura: ciò che “viene meno” nel “vivo e movimentato accesso” quotidiano, come Kuhn si esprime, è riposto nell’astrazione di interminabili elenchi e inventari. “Al modo di un museo”, dice lo stesso Weber con una
intuizione sinistramente profonda. Ciò che in un simile impazzire della scrittura viene alla luce –un’ovvietà, la chiama Kuhn, che la scrittura sempre
51
nasconde e che la macchina terribile della scrittura di Weber infine svela–
non è che questo: gli oggetti, nella loro utilizzabilità pratica, definiscono dei
limiti. Essi predispongono e offrono a chi li utilizzi, “la sicura delimitazione
propria del luogo del loro uso”, o, con le parole di Heidegger, “tutto ciò che
è utilizzabile in permanenza e di cui l’essere nel mondo tiene sempre in
conto nella sua visione ambientale preveggente ha per ciò stesso il suo
posto. Il ‘dove’ della sua utilizzabilità è tenuto in conto dal prendersi cura che
lo orienta in base agli altri utilizzabili. Così il sole, la cui luce e il cui calore
sono usati quotidianamente, riceve i suoi posti particolari dalla visione
ambientale preveggente in funzione di ciò che esso dona: il sorgere, il mezzogiorno, il tramonto, la mezzanotte […]. Queste prossimità regionali celesti,
questi ‘punti cardinali’, non ancora forniti di un significato geografico, offrono anticipatamente l’‘in dove’ a particolari conformazioni di prossimità, articolabili in posti”9.
9. “Hai distrutto il mondo bello, ricostruiscilo più splendido”
52
Gli oggetti, in quanto strumentalmente frequentati, dei limiti, dei tracciati,
sono essi stessi degli orizzonti, scrivono il mondo, si iscrivono in esso, iscrivono nel loro cerchio l’uomo, il soggetto che li utilizza e ne è utilizzato. E proprio il venire meno, nella follia schizofrenica, di questa loro utilizzabilità, il crollo della loro Zuhandenheit nella Vorhandenheit, l’eclissi della scrittura pratica
che in essi è comunemente all’opera, impone il compito di una nuova delimitazione, come Kuhn dice. Il compito di una nuova scrittura, l’esercizio interminabile di una trascrizione: è questa l’utopia di Weber, il sogno di una abitabilità ritrovata nel mondo, il senso impossibile della sua città. Perché già
Heidegger scriveva: “la mancanza di un utilizzabile la cui disponibilità quotidiana era talmente ovvia da passare inosservata, costituisce parimenti una
frattura”, e in tale frattura, aggiungeva, “la visione ambientale annaspa nel
vuoto”.
Esattamente questo annaspare sembra stare al fondo dell’esperienza di
Weber: una sorta di lotta in cui il mondo è come distrutto, condannato al frammento e ad una laboriosa e vana ricomposizione. Le parole del Faust goethiano –che già Freud ricordò nel caso celeberrimo di paranoia del presidente
Schreber, e che uno studioso come Henri Maldiney a ragione ha richiamato a
proposito del caso Weber di Roland Kuhn– esprimono con forza impareggiabile quella condizione. “Hai distrutto il mondo bello […]”, fa dire Goethe al coro,
in risposta alla maledizione scagliata da Faust sul mondo10, “ricostruiscilo più
splendido, ricostruiscilo nel tuo cuore”. Avviene come se una nuova figurazione di mondo e di esperienza portasse con sé anche una nuova architettura.
Non propriamente un nuovo sapere astrattamente progettuale, ma una nuova
architettura dell’esperienza, o, come Henri Maldiney si esprime in un saggio
dedicato, tra l’altro, a questo caso kuhniano, “una nuova architettura dell’esistenza”11.
Nuova, perché quello di tracciare limiti non è un compito inaudito, non è un
SAGGI
compito sollevato e imposto da quell’unico rivolgimento. Non è neppure propriamente un compito, non è qualcosa che venga assegnato da qualcuno a
qualcun altro, se non nel senso in cui la questione del limite è qualcosa cui
l’uomo è costitutivamente soggetto, una sorta –in questo senso, sì– di compito originario. Perciò anche Heidegger, a suo modo, osservava: in quell’annaspare, in quel vuoto, ecco che “il mondo ambiente si annuncia di nuovo”.
Kuhn, nel suo lessico, scrive che quando si vive un simile rivolgimento nella
propria comprensione dell’essere –nella follia, ad esempio, come accade a
Weber– l’uomo “vede improvvisamente porsi di fronte a sé il compito di tracciare nuovi limiti”.
Non è azzardato dire che questo tracciare è in ogni senso una passione
del soggetto e dell’oggetto, una tensione originariamente grafica e autografica entro cui io e mondo sono dati l’uno all’altro, ed entro cui solo stanno
quelle scritture seconde, ulteriori, cui le nostre figure di soggetti sono assegnate, quelle della psicologia e dell’antropologia: sicché scrivere e tracciare
non sono azioni che noi compiamo, animati da psicologiche intenzioni e
antropologici significati, ma gesti in cui noi e il nostro mondo letteralmente ci
compiamo –o in cui, come Kuhn mostra, noi e il nostro mondo ci manchiamo, mancando il segno. Mancando, e, perciò, vivendo l’assedio folle, anziché la libertà, di quel segno liminare che l’uno di essi– noi, il mondo –è, sempre, per l’altro.
53
R. KUHN, Über die Bedeutung vom Grezen im Wahn, in “Monatschrift für Psychiatrie und
Neurologie”, 1952, vol. 124, n. 4-5-6, pp. 354-383. Roland Kuhn nacque a Biel, in Svizzera, nel
1912. Studiò a Biel, Berna e Parigi, lavorò all’Ospedale psichiatrico di Waldau e diresse
l’Ospedale psichiatrico di Munsterlingen, in Svizzera.
2
J. RYCKWERT, L’idea di città. Antropologia della forma urbana nel mondo antico, Torino, Einaudi, 1981,
citato in M. ROMANO, L’estetica della città europea. Forme e immagini, Torino, Einaudi, 1993, p.1.
3
R. KUHN, op. cit., p. 376
4
E. CASSIRER, Philosophie der Symbolischen Formen, Bd. 2, trad. it. di E. Arnaud, Filosofia delle
forme simboliche, vol. II, “Il pensiero mitico”, Firenze, La Nuova Italia, 1964, p. 123. Su Cassirer,
cfr. C. SINI, Il simbolo e l’uomo, Milano, Egea, 1991, anche per quanto riguarda la rilettura critica
qui propostane. Cfr. anche, a proposito del tema della scrittura, così come esso riemerge in queste pagine, C. SINI, Etica della scrittura, Milano, Il Saggiatore, 1992; C. SINI e R. FABBRICHESI LEO,
Variazioni sul foglio-mondo, Milano, Hestia, 1996, e C. SINI, Teoria e pratica del foglio-mondo. La
scrittura filosofica, Roma-Bari, Laterza, 1997.
1
Entrambi i passi in E. CASSIRER, op. cit., p. 143
H. KERR, Labirinti, Milano, Feltrinelli, 1981
7
E. D’ALFONSO, Labirinto e giardino, in AA.VV., a c. di E. Franzini e E. D’Alfonso, Metafora mimesi morfogenesi progetto, Milano, Guerini, 1991, pp. 123-149.
8
M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, trad. it. di P. Chiodi Essere e tempo, Milano, Longanesi, 1969, p.
142, e, per le cit. successive, pp. 145 sgg. Sulla questione della strumentalità e del suo tramonto
nella follia, di cui è emblema indimenticabile la figura dello schizofrenico, che si osserva le mani,
muto, in uno stupore immobile e primordiale per la loro inservibilità, cfr. B. CALLIERI, Das paranoide Syndrom anthropologischer sicht, in “Zweiter Internationaler Kongress für Psychiatrie” (Zürich,
settembre 1957), Springer, Berlin-Göttingen-Heidelber 1958.
9
M. HEIDEGGER, op. cit., pp. 183-184.
10
J. W. GOETHE, Faust, parte prima, studio (II), trad. it. di B. Allason, Torino, Einaudi, 1965. S.
FREUD, Il presidente Schreber, trad. it. di R. Colorni e P. Ventri, Torino, Boringhieri, 1975, p. 87-88.
H. MALDINEY, in “Crise et temporalité dans l’existence et la psychose”, in Id., Penser l’homme et la
folie, Grenoble, Millon, 1991, p. 137, suggerisce questo stesso accostamento tra l’intento “faustiano” del paranoico Schreber, descritto da Freud, e quello, altrettanto faustiano, del paziente di
Kuhn, per il quale anche la diagnosi era stata di paranoia.
11
HENRI MALDINEY, op. cit., p. 138
5
6
54
IL DIRITTO DEI POPOLI
ALL’INDIPENDENZA POLITICA
Il modello liberale di organizzazione sociale ha da sempre cercato di limitare il più possibile le intrusioni dello Stato nelle libertà dei cittadini1; esso,
punto di riferimento per la maggior parte delle democrazie occidentali, è, quindi, per definizione, individualista, avendo come obiettivo primario quello di
garantire, il più possibile, la libertà e l’uguaglianza dei singoli cittadini. Questa
tendenza appena descritta è facilmente osservabile se si guardano le costituzioni dei Paesi liberaldemocratici, le quali garantiscono diritti civili e politici a
tutti gli individui, senza distinzione di sesso, razza, religione, cultura e così via,
ma raramente diritti collettivi. Non è sicuramente un caso il fatto che il liberalismo abbia questi contenuti così attenti alle esigenze dei singoli cittadini; esso,
figlio dell’avversione delle rivoluzioni borghesi alla disuguaglianza ed ai privilegi di alcuni individui appartenenti a particolari gruppi sociali, ha avuto, infatti, come matrice quell’individualismo, già affermatosi con l’Umanesimo2, che
trovò la sua massima espressione con il giusnaturalismo settecentesco che è
il padre culturale e filosofico della Rivoluzione francese.
Se queste sono le premesse si capisce come mai molti suoi teorici abbiano tuttora remore nel riconoscere non solo alcuni “diritti collettivi” richiesti dalle
minoranze culturali (come quelli riguardanti la facoltà di usare nelle scuole la
loro lingua madre, di avere e sviluppare una propria differenziata cultura, propri libri ecc., considerati incompatibili con la concezione egualitaria della società, su cui si basano prima i diritti individuali, e poi la democrazia3), ma anche
e soprattutto il diritto di un popolo a veder riconosciuta, allorquando ricorrano
determinati presupposti, una propria indipendenza politica, da far valere anche
contro lo stesso Stato nel cui territorio esso popolo sia presente.
L’odierna scena politica internazionale è dominata da conflitti che trovano
la loro giustificazione nelle pretese di popolazioni che cercano di affermare, in
maniera decisa, la propria identità culturale. Ed è la stessa comunità internazionale a fomentare questo tipo di conflitti, spinta da motivazioni di carattere
prettamente politico. Troppo spesso il diritto internazionale, infatti, viene strumentalizzato al fine di giustificare il sostegno dei Paesi occidentali a lotte intestine, che hanno nel sacrosanto diritto di una popolazione a veder riconosciuta universalmente la propria libertà il loro unico fine.
Il principio di autodeterminazione dei popoli, in quanto principio giuridico
ricavabile dalla prassi effettiva della generalità degli Stati, sta ampliando,
anche se in modo controverso, sempre di più i propri orizzonti, non riguardando più, come invece accadeva fino a pochi anni fa4, unicamente i popoli sottoposti ad un governo straniero (il caso del Kuwait occupato da Saddam
NOTE
di Attilio Pisanò
55
56
Hussein), bensì anche, e soprattutto, i popoli, con propria identità, cultura, religione i quali per eventi storici non hanno potuto godere di indipendenza ed
autonomia politiche. È il caso di Timor-Est, quello del Kosovo, quello del
Kurdistan o della Cecenia. In verità, la debolezza del diritto internazionale sta
tutta nel fatto che esso è in balia delle potenze occidentali le quali decidono,
spinte da motivazioni politiche più che umanitarie, dove, come e quando intervenire per far valere non il diritto di tutti i popoli alla libertà, bensì solo quello
di alcuni.
L’incontrollabile, ormai, espansione dei conflitti locali è dovuta essenzialmente a due cause. Non è un caso che a partire dal 1989 ad oggi siano esplosi ben 34 conflitti locali5, alcuni dei quali con violenza inaudita; la caduta del
muro di Berlino ha avuto come conseguenza imprevista l’improvvisa riscoperta dell’importanza dell’identità culturale sopita per decenni dalle lotte ideologiche fra Occidente ed Oriente6. Gli eventi del 1989 rappresentano, però, solo
ed esclusivamente la miccia che ha fatto esplodere un problema latente ormai
da anni: la crisi dello Stato-nazione rigorosamente sovrano entro i propri confini territoriali.
La crisi dello Stato lascia ampio spazio alla promozione di istanze non solo
sovranazionali, ma anche e soprattutto all’emergere di identità etniche, culturali, religiose ormai svincolate al principio di nazionalità. Questa situazione
appena descritta mette radicalmente in discussione il paradigma neo-positivistico dell’identificazione dello Stato sia con il diritto che con la libertà7, con conseguente riscoperta di quello che Lorenzo Scillitani8 chiama etno-giuridismo,
l’enfatizzazione del diritto quale modalità formale di affermazione politica di
istanze particolaristiche che si insinuano sempre più negli ampi spazi lasciati
dalla crisi del modello di organizzazione sociale definito Stato-nazione.
Lo Stato può definirsi (affiancando la definizione classica di “complesso
apparato politico-amministrativo avente, in virtù del monopolio legittimo della
forza, controllo pieno, esclusivo e virtualmente indeterminato, in tutto il territorio nazionale sull’applicazione delle norme e decisioni che esso stesso elabora e delibera”9) come “quella parte del corpo politico che riguarda in special
modo l’osservanza delle leggi, l’incoraggiamento del benessere comune e dell’ordine pubblico, l’amministrazione della cosa pubblica10”. L’elemento che
caratterizza in maniera inequivocabile lo Stato è l’uso monopolistico della
forza finalizzato al rispetto delle leggi dello stesso su di un determinato territorio, ma cosa accade allorquando uno, o più, degli elementi che compongono la definizione dello Stato vengono meno? Se una consistente parte della
popolazione non riconosce più lo Stato come unica fonte legislativa? Se una
parte consistente della popolazione sistematicamente non osserva gli imperativi legislativi dello Stato, dandosene degli altri che non trovano la loro fonte
nella legislazione statale? Se l’utilizzo della forza non è più monopolio esclusivo dello Stato, ma è esercitato da altri soggetti politici per far rispettare
norme che non trovano fondamento nell’ordinamento giuridico statale? Se una
parte di territorio non è più soggetta alla sovranità dello Stato? Ebbene, se
concorressero contestualmente tutte le suddette condizioni si avrebbe, sic et
simpliciter, un altro, e nuovo, soggetto politico: un nuovo Stato.
NOTE
D’altronde se si accetta la definizione democratica di Stato proposta dal
Maritain, come entità politica che ha il proprio fondamento nella volontà associativa della popolazione, allora non si avranno particolari problemi nel riconoscere che, allorquando una parte considerevole del corpo politico (“realtà concretamente e interamente umana che tende a un bene concretamente e interamente umano, il bene comune”11) non accetta le regole che gli vengano
imposte, abbia l’innegabile diritto di costituire un nuovo Stato, capace di venire maggiormente incontro alle necessità di tutti, per il raggiungimento effettivo
del bene comune. Lo Stato è in piena crisi, rischia di cadere sotto i possenti
colpi portati dai particolarismi, dalle etnie che fino ad oggi sono tacitamente
vissute all’ombra dello Stato-sovrano, onnipotente nell’ambito del proprio territorio nazionale.
È, questa, la crisi dell’idea stessa di sovranità, dovuta, per lo più, all’incapacità delle istituzioni politico-giuridiche di soddisfare le pressanti richieste di
veder riconosciute le peculiarità culturali provenienti da una società sempre
più multi-etnica. L’idea di Stato come soggetto giuridico capace di tutelare gli
interessi dei propri cittadini sempre e comunque, ormai non esiste più. La concezione della comunità internazionale composta essenzialmente di Stati
sovrani, che detengono l’autorità in maniera assoluta, l’inesistenza di remore
all’uso della forza, il principio di non ingerenza negli affari interni, sono tutti
principi di diritto internazionale profondamente mutati dall’adozione della Carta
delle Nazioni Unite e tuttora essi vengono meno al cospetto delle gross violations dei diritti umani, che ormai rappresentano una violazione di una parte
importante dello jus cogens internazionale12.
La nascita, nel 1945, dell’O.N.U. è stato il primo passo verso la comparsa
sulla scena politica internazionale di una pluralità di organizzazioni (la NATO
o l’U.E., per non dimenticare l’O.C.S.E.) che hanno sempre di più eroso l’originaria, e onnicomprensiva, sovranità degli Stati-nazione. Si tratta di istituzioni con una propria organizzazione, un proprio ordinamento, una propria vita, e
che operano in materie le quali, fino a qualche decennio fa, erano di esclusiva pertinenza dello Stato (una per tutte la difesa), e che si rivolgono, con i loro
atti normativi, direttamente ai cittadini dei singoli Stati, operando, di conseguenza, sulla stessa superficie in cui una volta esercitava la sua azione onnipotente la sovranità statale13. Furono le atrocità del secondo conflitto mondiale a far capire che una comunità di stati assolutamente sovrani non avrebbe
mai potuto garantire la pace in ambito internazionale. E se le atrocità che
attualmente si stanno perpetrando nei confronti di alcune minoranze etniche
portasse alla definitiva caduta dell’idea di sovranità? Le organizzazioni internazionali, sorte in questi ultimi decenni, sono certamente sovrane pur non
avendo un territorio sul quale espletare la loro indiscussa sovranità, e ciò non
può significare nient’altro se non che oggi la territorialità non è indispensabile
al concetto di sovranità. Ciò è dimostrato dal fatto che sono stati gli stessi stati,
membri della comunità internazionale, ad aderire, tramite volontarie manifestazioni di volontà, le quali hanno riconosciuto la sovranità ratione materiae di
questi enti sovranazionali, a tali organizzazioni che ora regolano, in via quasi
del tutto esclusiva, gli ambiti di competenza demandati. E se questo tipo di
57
58
percorso venisse oggi seguito al contrario? Sarebbe poi così “rivoluzionario”
l’atto di uno Stato che cedesse parte, o addirittura la totalità, della propria
sovranità ad organizzazioni originarie (istituzioni 14) che si siano sviluppate al
suo interno? Da un punto di vista politico certamente sì, ma da un punto di
vista teorico assolutamente no.
L’originaria nozione di sovranità constava di due soli elementi: lo Stato
aveva come elemento costitutivo un territorio nel cui ambito esso sarebbe
stato, appunto, sovrano (competenza territoriale); i cittadini erano soggetti
solo, esclusivamente, in ogni circostanza, ovunque essi si trovassero, alla
legislazione statuale (competenza personale 15). A questi due elementi, dall’immediato dopoguerra ad oggi se ne è affiancato un altro: la c.d. competenza reale (o ratione materiae) intesa come facoltà per un dato ordinamento giuridico di regolare in maniera esclusiva una, o più, materie, con possibilità di
emanare atti normativi che vincolino anche coloro che sono sottoposti ad altri
ordinamenti. Orbene, l’introduzione, nell’ambito non solo della teoria generale, ma anche del diritto internazionale16, di questo elemento caratterizzante la
sovranità, ha causato un profondo mutamento della stessa. La “competenza
reale”, infatti, è il trait d’union fra la sovranità statuale e quella sovranazionale; è il fulcro della nozione moderna di sovranità. Le organizzazioni internazionali sono sovrane, pur senza avere un dato territorio sul quale esplicare la loro
sovranità, grazie proprio a questo elemento. Gli Stati, nel momento in cui
hanno deciso di aderire ad organizzazioni sovranazionali prive dell’elemento
della territorialità, hanno implicitamente riconosciuto la possibilità che la sovranità possa essere esercitata anche a prescindere dall’esistenza di un determinato territorio. Il criterio della competenza reale ha soverchiato, rivoluzionato, e mutato nel profondo, la nozione di sovranità così come si era creata con
la nascita dello Stato moderno a seguito delle rivoluzioni borghesi di fine
Settecento; i cittadini di uno Stato, oggi, possono essere destinatari di norme
di più ordinamenti sovrani che non hanno nella territorialità un elemento costitutivo.
Non tutte le organizzazioni che sorgono accanto allo Stato sono, per il sol
fatto di esistere, sovrane. Né tanto meno l’importanza della territorialità deve
essere, tout court, dimenticata. Esiste, infatti, un ambito nel quale la territorialità gioca ancora un importante ruolo: quello delle rivendicazioni delle comunità etniche (“raggruppamenti umani basati sulla somiglianza fenotipica –somatica, linguistica, religiosa, culturale– dei loro membri”17) stanziate, appunto, su
un determinato territorio (mi riferisco, in particola modo, ai Kurdi, ai Ceceni, ai
Kosovari).
Entra in gioco, forzatamente, il concetto elaborato da Santi Romano di istituzione come “ente che servirebbe al raggiungimento di determinati scopi
sociali che verrebbe pensato o considerato come subietto di diritto18” e costituente, quindi, un ordinamento giuridico sovrano dotato della caratteristica dell’originarietà. Orbene, seguendo la definizione appena illustrata, allorquando
ci si trovi innanzi ad un corpo sociale la cui esistenza sia obiettiva e concreta,
la cui individualità esteriore sia visibile, il quale abbia una propria personalità,
una propria identità, il quale abbia sviluppato una organizzazione sociale più
NOTE
o meno complessa, con norme di condotta definite che vincolano i membri
dello stesso, orbene in questo caso ci troveremmo innanzi ad un vero e proprio ordinamento giuridico dotato di piena sovranità ed autonomia19. Anche qui
il concetto di istituzione-ordinamento giuridico sovrano viene elaborato tralasciando la nozione di territorialità; non è la presenza di un territorio a dare
legittimità ad un ordinamento giuridico, bensì l’istituzione (intesa come realtà
sociale) preesistente. Lo Stato, conseguentemente, non è sovrano perché ha
un territorio sul quale esercitare la propria potestà, bensì perché ha alle spalle un corpo politico, una società che quotidianamente legittima l’esistenza di
norme date per la regolamentazione della stessa. Ogni Stato è un’istituzione,
anzi si può dire, senza paura di smentite, che è l’istituzione più importante, l’istituzione che negli ultimi due secoli ha avuto come compito quello di regolare la condotta dei propri cittadini, sul proprio territorio. Ma se si tiene presente il fatto che lo Stato organizza una società su di un territorio, allora si potrà
affermare che, allorquando vi sia un’istituzione che agisce su di un territorio
regolando in via esclusiva la condotta dei membri di una comunità sociale,
questa sia uno Stato.
Difatti, il procedimento con cui si forma uno Stato è senza dubbio pregiuridico, è un fatto, una presa di coscienza da parte di una “istituzione” sociale
della propria esistenza, della propria autonomia, della propria libertà. Ogni istituzione si concreta in un ordinamento giuridico che può anche non trovare il
proprio fondamento nelle preesistenti leggi di uno Stato, ma che può porsi in
maniera conflittuale con lo stesso. È il caso delle c.d. istituzioni originarie che
perseguono fini generali ossia quelle in cui si attua un ordinamento giuridico
che non è posto da altre istituzioni e che è quindi indipendente e si prefigge il
compito di perseguire il bene comune20. Lo Stato è il tipico esempio di questo
tipo di istituzioni, ma nulla esclude che, proprio all’interno dell’istituzione-Stato,
possano sorgere altre istituzioni con le stesse caratteristiche o finalità. È quanto succede quando una consistente minoranza etnica, stanziata su un determinato territorio, con propria cultura (definibile in questo ambito come un fatto
sociale, un insieme di valori, tradizioni, regole e anche modelli mentali, che
caratterizzano un gruppo e che influenzano ogni membro della comunità in
ogni momento della sua vita21) comincia ad organizzarsi prescindendo da quelle che sono le norme imposte dallo Stato in cui la minoranza vive. È la nascita di un Stato in fieri.
Non ogni comunità può assurgere a “istituzione-Stato”; affinché ciò possa
accadere, in conformità a quanto poc’anzi detto, devono concorrere alcuni elementi:
1. La comunità deve essere innanzitutto etnica. Ovvero deve essere portatrice di una propria peculiare cultura, di proprie tradizioni, di propri modelli di
organizzazione sociale;
2. Deve essere organizzata in maniera tale da riuscire a difendere la propria identità culturale, intesa qui come elemento indispensabile per la libertà di
ogni individuo22. Nell’affermare l’importanza della tutela della propria cultura, si
può prendere spunto da una considerazione evidente: la richiesta di riconoscimento delle identità culturali è, oggi più che mai, un problema comune a
59
60
tutti i Paesi europei. La mancanza di un riconoscimento esplicito, con la conseguente concessione di particolari status giuridici, ha cagionato la reviviscenza del nazionalismo: non è stato forse questo il motivo scatenante della
guerra nell’ex-Jugoslavia, o della nascita dalla Cecoslovacchia di due distinti
Paesi, la Repubblica Ceca e la Slovacchia, e la causa del disfacimento dell’impero sovietico? “Le società multinazionali possono andare a pezzi perché
manca il riconoscimento dell’uguale valore di un gruppo da parte di un altro”23;
3. L’organizzazione sociale non può limitarsi alla pur importante tutela dell’identità culturale, ma deve spingersi oltre, deve, infatti, elaborare norme di
condotta che regolino la vita sociale di tutti gli appartenenti alla comunità, stabilendo anche sanzioni (con corti istituite al fine di far rispettare le suddette
norme) a carico di chi non rispetti le regole prefissate;
4. Deve avere, soprattutto, un territorio su cui esercitare la propria sovranità. Ed ecco che la territorialità, come si diceva, ritorna a giocare un ruolo fondamentale nella formazione di nuove istituzioni-Stato. Uno Stato in fieri non
può fare a meno di un territorio. Naturalmente non si tratterebbe qui di “un” territorio, ma “del” territorio che storicamente ha rappresentato la culla di una
comunità etnica che per vicissitudini storiche non possa considerarsi autonoma ed indipendente. Non è più lo Stato ad essere un prius rispetto al territorio, ma è il contrario. Da un territorio può nascere uno Stato. Il territorio non
deve essere considerato più, solo ed esclusivamente, come il luogo in cui uno
Stato esercita la propria sovranità in maniera del tutto assoluta, bensì come
l’elemento senza il quale nessuno Stato potrebbe sorgere. Il territorio ha perso
importanza nell’esercizio della sovranità di uno Stato ormai riconosciuto dalla
comunità internazionale, ma continua ad esercitare un ruolo fondamentale per
gli stati in fieri 24. Invero, la sovranità sta man mano perdendo l’elemento territoriale, ma non potrà mai esistere uno Stato senza terra.
5. La comunità, infine, deve aver sviluppato la consapevolezza di se stessa. Una nazione (come definita da Jacques Maritain) è una comunità di gente
che diventa –appunto– consapevole di se stessa “come la storia li ha fatti; che
fa tesoro del passato, che si ama per quel che è o per quel che immagina di
essere, con una specie di introversione inevitabile25”. È, questa, la coscienza
nazionale, la riscoperta della propria peculiare identità culturale, del proprio
essere in relazione ad un secolare retaggio di tradizioni, relazioni sociali,
modelli normativi di comportamento. Ma una nazione non potrà mai diventare
una istituzione-Stato se al proprio interno non riesca a sviluppare quella che il
Santi Romano definisce coscienza superiore, la quale “incarni le ragioni della
coesistenza e del sistema in cui i singoli si unificano, che fa da mediatore, che
appella al rapporto delle parti fra loro e col tutto, che è come l’incarnazione dell’io sociale26”. Lo Stato, come qui inteso, non può fare a meno di questi due
elementi: la coscienza nazionale che lo caratterizza come unico ed irripetibile
da un punto di vista culturale, e la coscienza superiore che, attenendo alla vita
sociale dei consociati, lo qualifica necessariamente come istituzione sociale,
originaria, portatrice di fini generali e, pertanto, autonoma ed indipendente.
Il problema centrale, come appena evidenziato, è quello, tutto durkheimiano, del rapporto tra individui e collettività. Quale è il processo che nei moder-
NOTE
ni Stati multiculturali può portare alla nascita prima di una coscienza nazionale e poi di una “coscienza superiore”? Quale è il processo attraverso il quale
una semplice comunità etnica può creare una vera e propria istituzione nel
senso indicato dal Santi Romano? A queste domande potremmo rispondere
rispolverando, ed in parte sviluppando, le tesi del grande sociologo francese
Émile Durkheim27, il cui pensiero si basa su una distinzione tra due tipi di
comunità sociale: quelle meno evolute, in cui regna la “solidarietà meccanica”,
e quelle più evolute, quelle moderne, dominate dalla “solidarietà organica”.
La solidarietà meccanica è una solidarietà per simiglianza, che è possibile
riscontrare nelle comunità arcaiche caratterizzate da poca differenziazione
sociale. Questo tipo di comunità è caratterizzato dall’aver sviluppato una forte
propensione alla compattezza, dovuta al predominare di una coscienza collettiva (intesa “come insieme delle credenze e dei sentimenti comuni alla media
dei membri di una società”28, e quindi come nucleo centrale della coscienza
nazionale), che viene a regolare, o meglio a determinare, la vita dei membri
della comunità in ogni sua manifestazione. La solidarietà organica caratterizza, invece, le società moderne in cui la differenziazione socio-culturale è un
elemento di primaria importanza, in cui la coscienza collettiva non è predominante, sopraffatta dal fatto che possano esistere una pluralità di individui che
abbiano sviluppato, nel corso del tempo, un’autonoma e comune coscienza.
Rielaborando il pensiero durkheimiano in chiave moderna potremmo dire che
nulla esclude che nei moderni Stati multiculturali l’incalzante differenziazione
sociale possa portare con sé l’affermarsi di una coscienza collettiva (non coincidente con quella dell’intero corpo sociale) in ambito etnico che ha nel riconoscimento delle peculiarità culturali un termine per differenziare, in maniera
evidente, una parte dal tutto. Coscienza collettiva radicata a tal punto da giungere a possedere una propria vita, capace di imporre degli “imperativi sociali”
che abbiano nella libertà e nell’indipendenza dell’etnia il loro zoccolo duro.
L’evoluzione storica, segnata da Durkheim, va dalle società a solidarietà
meccanica a quelle a solidarietà organica. Sviluppando il pensiero durkheimiano possiamo affermare che, modernamente, l’organizzazione sociale si sta
dirigendo in direzione opposta; la differenziazione sociale ha avuto come
prima conseguenza il ritorno ad una forma di solidarietà meccanica nell’ambito di alcune consistenti comunità etniche ben radicate su di un territorio, che
regolano la loro condotta di vita seguendo fedelmente gli imperativi sociali frutto della loro peculiarità socio-culturale. Vi è la rinascita della coscienza collettiva, che ben presto si tramuta in riscoperta della coscienza nazionale, con
conseguente ripresa del nazionalismo, e in affermazione del primato della
società sugli individui. Primato che è storico (perché le prime comunità erano
regolate dalla società meccanica), ma è anche logico (perché la solidarietà
organica non sarebbe esistita se non si fosse sviluppata quella meccanica).
Ciò significa, tra l’altro, priorità dei diritti collettivi sui diritti individuali e, concretamente, priorità del problema della “libertà culturale” nelle società multiculturali moderne. Libertà culturale che si può pienamente realizzare solo
dopo aver ottenuto quella politica. In altre parole, una comunità etnica, che
abbia sviluppato un propria coscienza nazionale, che abbia cominciato, con-
61
62
seguentemente ad organizzare la propria esistenza in base alle norme sociali imposte dalla coscienza collettiva, ha un innegabile diritto ad avere una propria indipendenza politica come mezzo per ottenere quella libertà culturale
sine qua non può esistere la libertà individuale.
Le possibili soluzioni a questo problema sono due: la concessione da parte
di uno Stato, che ingloba in sé una etnia con propri caratteri culturali, di una
forma di autonomia politica che permetta di regolare al meglio le necessità, i
bisogni della popolazione, oppure, ultima ratio, il ricorso (inteso qui come vero
e proprio diritto) ad una azione rivoluzionaria che consenta ai popoli oppressi
di ottenere, obtorto collo, la propria libertà, indipendenza, identità culturale.
Ciò permetterebbe ad ognuno di essere sempre se stesso, di dare libero sfogo
a quei modelli comportamentali tramandati di generazione in generazione, nel
pieno rispetto della coscienza collettiva propria di un determinato gruppo
sociale, con la benedizione di uno Stato, espressione fedele della collettivitàcorpo politico la quale rappresenti, riconosca, tuteli, garantisca i propri diritti
entro la propria ed insostituibile cultura.
A questo punto è necessario trarre le conclusioni, al fine di elaborare una
compiuta teoria che precisi a quali condizioni determinate comunità etniche
possano legittimamente vantare un vero e proprio diritto all’indipendenza politica. Innanzitutto è necessaria la presenza di una comunità etnica su un territorio. Abbiamo visto come l’elemento della territorialità, nell’ambito dell’idea di
sovranità, abbia, in questi ultimi decenni, perso man mano di importanza. Un
soggetto socio-politico è tale, si è detto, indipendentemente dall’avere un territorio o dall’essere stato privato dello stesso (penso ai kurdi, i quali innegabilmente esistono come comunità etnica, esistono come soggetto politico, avendo anche un parlamento che fino allo scoppio del caso Ocalan si riuniva regolarmente in Italia). Allorquando, poi, esso dimori su un determinato territorio
(penso al Kurdistan, territorio diviso fra più Stati nel quale vige, in maniera del
tutto esclusiva, la legge del PKK, rappresentante politico del popolo Kurdo)
che storicamente rappresenti la terra di quel popolo il quale abbia sviluppato
non solo una coscienza nazionale (penso alle molteplici manifestazioni di solidarietà espresse nei confronti di Ocalan in tutte le più importanti piazze europee da quello che è il popolo kurdo), ma anche una coscienza collettiva che
permetta di organizzare la collettività secondo il dettato di imperativi non solo
sociali, ma anche giuridici, intesi nel senso dell’amministrazione della giustizia
(penso alle immancabili corti, presenti in Kurdistan oggi come erano presenti
a Cuba nel territorio occupato dai barbudos di Fidel Castro durante la rivoluzione castrista) che sanzionano i comportamenti antigiuridici dei cittadini di
uno Stato che solo sulla carta non esiste, allora nessuno potrà sostenere di
non trovarsi dinanzi ad una nuova formazione politica, ad un nuovo Stato.
Il discrimine fra uno Stato ed una nazione è dato dalla presenza o meno di
un’azione rivoluzionaria. Nel momento in cui crescono i primi germi rivoluzionari, significa che l’evoluzione di una comunità etnica è già arrivata a formare
un’importante identità nazionale. Ogni rivoluzione, ed in particolare quelle finalizzate ad ottenere l’indipendenza politica di un popolo oppresso, ha un ordinamento suo proprio, che non trova, infatti, la sua fonte in un altro ordina-
Cfr. W. KYMLICKA, Liberalism, Community and Culture, Oxford, Clarendon press, 1989, p. 1.
Cfr. G. BETTIN LATTES (a c. di), La società degli europei, Bologna, Monduzzi, 1995, p. 32.
3
“Il concetto stesso di democrazia è inscindibile da quello dei diritti umani, se si elimina una concezione individualistica della società, non si giustifica più la democrazia come forma di governo”.
Cfr. N. BOBBIO, L’età dei diritti, Torino, Einaudi, 1992, p. 58.
4
Cfr. B. CONFORTI, Diritto Internazionale, Napoli, Editoriale Scientifica, 1996, p. 22.
5
Cfr. LORENZO SCILLITANI, Ambiguità e limiti di una teoria “etnica” dei diritti, in ‘Rivista internazionale di filosofia del diritto’, Giuffrè, gennaio/marzo IV serie-LVXXVI-1999, p.111.
6
Sull’argomento cfr. S. HUNTINGTON, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order,
trad. it. Lo scontro delle civiltà, Milano, Garzanti, 1997.
7
Cfr. V. MATHIEU, L’ideale universalistico nella concezione politica moderna, in Etnia e Stato, localismo e universalismo, Roma, 1995, pp. 15-17, cit. in L. SCILLITANI, op. cit., p. 113.
8
Cfr. L. SCILLITANI, op. cit., p.115.
1
2
NOTE
mento (quello statuale che non riconoscerà mai l’esistenza, sul proprio territorio, di un’altra istituzione originaria con fini generali come è l’organizzazione
rivoluzionaria), ma è originario e si configura, di fatto, nella sua stessa organizzazione29.
Ogni popolo ha il diritto all’autonomia politica quando ricorrano le condizioni indicate. Due sono le strade che si possono seguire per ottenere questo
risultato, una democratica e l’altra no. La prima, maggiormente conforme alla
tradizione liberale, consiste nella richiesta avanzata dalla comunità etnica di
veder riconosciuta la propria peculiarità culturale con il conseguente riconoscimento da parte dello Stato di quei diritti collettivi (come quelli riguardanti la
facoltà di usare nelle scuole la loro lingua madre, di avere e sviluppare una
propria differenziata cultura, propri libri ecc.) necessari per la sopravvivenza
della stessa. Una volta riconosciute tali rivendicazioni, l’ulteriore passo da
compiere sarebbe quello di chiedere un referendum il cui quesito riguarderebbe l’indipendenza politico-amministrativa (è la strada rappresentata dal
Quebec, dove i canadesi di etnia francofona hanno visto prima riconosciuto da
parte del governo Canadese il proprio particolare status, poi hanno addirittura avuto la possibilità di decidere, liberamente, pacificamente, democraticamente, se continuare a far parte del Canada oppure no).
La seconda via da seguire è sicuramente meno democratica, ma è quella
che al momento sembrerebbe essere l’unica percorribile. Abbiamo detto che
allorquando una comunità etnica ha formato una istituzione-Stato essa ha il
diritto di ottenere l’indipendenza politica. Ma, come accadeva nelle società
arcaiche (e la comunità internazionale per certi versi è una comunità arcaica),
quando le proprie, legittime ragioni non venivano tutelate dal diritto, le ragioni
di un popolo possono essere fatte valere tramite il ricorso alla violenza, ricorso che, alla luce di quanto si è detto, prende le tragiche sembianze di un vero
e proprio diritto, il diritto alla rivoluzione.
63
Cfr. L. GALLINO (a c. di), Manuale di Sociologia, Torino, UTET, 1997, p. 134.
Cfr. J. MARITAIN, L’uomo e lo Stato, Roma, Vita e Pensiero, p. 14.
11
Ivi, p. 12.
12
A. Cassese apertamente distingue fra modello di Westfalia e modello delle Nazioni Unite, al fine
di determinare i modelli normativi cui si è ispirata la comunità internazionale. Cfr. A. CASSESE, Il diritto internazionale nel mondo contemporaneo, Bologna, Il Mulino, 1984, pp. 455 e ss.
13
Cfr. A. TARANTINO, La sovranità valori e limiti, Milano, Giuffrè, 1990, p. 98.
14
Cfr. S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, Firenze, Sansoni, 1962, pp. 25 e ss.
15
Sull’argomento cfr. A. TARANTINO, op. cit., pp. 104 e ss.
16
Basti pensare all’art. 2 par. 7 della carta costitutiva delle Nazioni Unite, in base al quale l’O.N.U.
non deve intervenire in questioni “che appartengono essenzialmente alla competenza interna di
uno Stato”. Cfr. B. CONFORTI, op. cit., p. 141.
17
Definizione contenuta in L. GALLINO, op. cit., p. 288.
18
Cfr. S. ROMANO, op. cit., p. 27 e ss..
19
Ivi, p. 46: “Se il diritto non può concretarsi ed acquistar corpo se non nell’istituzione e se, viceversa, tutto ciò che, socialmente organizzato, viene assorbito come elemento di quest’ultima,
acquista carattere giuridico, se ne può trarre il corollario che il diritto è il principio vitale di ogni istituzione […] reciprocamente l’istituzione è sempre un regime giuridico”.
20
Ivi, pp. 141 e ss.
21
Definizione di F.GARELLI, in G. GALLINO (a c. di), op. cit., p. 213.
22
Utilizzando le parole di Amy Gutmann si può affermare che “l’unicità degli individui deriva, in
parte, dai modi con cui essi integrano, ripensano e modificano l’eredità culturale propria e delle
altre persone con cui entrano in contatto”. Cfr. A. GUTMANN, ‘Commento’, in C. TAYLOR,
Multiculturalism and ‘the Politics of Recognition’, Princeton (N.J.), Princeton University Press,
1992 (trad. it. Multiculturalismo, Milano, Anabasi, 1993), p. 16.
23
Ivi, p. 91.
24
Non è un caso che tutt’oggi fra Palestina ed Israele le più importanti divergenze riguardino l’esercizio della sovranità su fette consistenti di territorio conteso.
25
Cfr. J. MARITAIN, op. cit., pp. 6-7.
26
Cfr. S. ROMANO, op. cit., p. 18.
27
Ed in particolare quanto esposto ne De la Division du travail social, Paris, Alcan, 1893, trad. it.
La divisione del lavoro sociale, Milano, Comunità, 1962, cit. in R. ARON, Le tappe del pensiero
sociologico, Milano, A. Mondadori, 1996, pp. 297-307.
28
Cfr. R. Aron, op. cit., p. 299.
29
Cfr. S. ROMANO, Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, Giuffrè, 1953, p. 225.
9
10
64
IL PROGETTO DI LEGGE
SULLA FECONDAZIONE ARTIFICIALE
NEL DIBATTITO ITALIANO
NOTE
di Alessandra Lezzi
Procreazione medicalmente assistita e tutela del figlio
Dove è scelta, vi è sempre, più o meno riconosciuta, una dimensione morale, un appello alla riflessione, al confronto, all’impegno condiviso.
Le fasi di inizio e fine della vita, che rivestono un significato peculiare nell’esperienza umana, sono sempre più controllabili da parte dell’uomo che può
decidere come e quando operare anche medicalmente su di esse.
Per fronteggiare una situazione di infertilità e sterilità tra le coppie (la media
si aggira sul 20%), si è diffuso l’uso di tecniche di aiuto e assistenza medica
alla procreazione. Generalmente per esse si parla di “fecondazione assistita”
o, meglio, di “procreazione medicalmente assistita”: essa definisce la necessità di un’assistenza medica nel momento della procreazione, laddove si presentino problemi di infertilità o di sterilità e, quindi, la procreazione difficile o
impedita nel suo naturale svolgimento.
Si è soliti distinguere l’“inseminazione artificiale”, con cui si effettua il solo
inserimento del seme maschile nell’utero della donna, dalla fecondazione
assistita vera e propria, con la quale si interviene in maniera più complessa ed
invasiva nel processo di procreazione. Una tecnica assai diffusa è quella della
FIVET (fecondazione in vitro con embryo transfer), il cui processo prevede di
raccogliere i due gameti, maschile e femminile, consentire la fecondazione in
vitro, mantenere l’embrione per un certo numero di ore in congelatore (la
cosiddetta “crioconservazione”) per poi trasferirlo nel corpo della donna.
Si definisce “fecondazione omologa” quella nella quale si utilizzano i gameti della coppia, mentre con “fecondazione eterologa” ci si riferisce a quella per
realizzare la quale uno dei gameti, se non tutti e due, sono di un
donatore/donatrice “esterno” alla coppia.
Queste nuove possibilità di intervento biomedico generano interrogativi
sulla loro sicurezza tecnico-scientifica, sulla loro liceità etica e giuridica e sul
loro impatto antropologico e simbolico.
Fecondazione in vitro, farmaci della fertilità, iniezioni di sperma, donazione
di ovuli, embrioni congelati: la lista delle tecniche di riproduzione assistita è
sempre più lunga. Sono passati circa vent’anni dalla nascita di Louise Brown,
la prima bambina concepita in provetta, venuta alla luce nel 1978 in Inghilterra.
Ma i confini delle opzioni tecnologiche contro la sterilità continuano a spostarsi in avanti. Oggi la frontiera della fertilizzazione artificiale sperimenta ovuli e
ovaie congelate, il trapianto di Dna o la donazione di citoplasma. Anche la
65
66
menopausa non è più un limite: la barriera dei 50 anni è stata infranta varie
volte e l’italiana Rosanna Della Corte, che nel 1994 ha partorito a 62 anni grazie a un ovulo donato, ha aperto la strada alle madri ultrasessantenni.
Ormai, quando si parla di riproduzione, “biologia” e “genetica” non sono più
sinonimi di un destino ineluttabile. Filosofi, politici, religiosi e giuristi hanno un
bel discutere di etica: il desiderio di procreare sembra più forte di qualunque
legge, umana o divina1. La tecnologia, d’altronde, è l’unica arma disponibile
per combattere l’epidemia di sterilità che colpisce i paesi industrializzati da
trent’anni a questa parte. Nei soli Stati Uniti, tra il 1988 ed il 1995, le donne in
età fertile con problemi di concepimento sono aumentate del 25 per cento,
superando i sei milioni, e con loro si sono moltiplicati i centri di fertilità, le banche dello sperma e le ricerche farmacologiche e cliniche.
Così, è proprio nella procreazione assistita che si assiste con maggiore evidenza al realizzarsi di un vecchio detto: tutto quello che è tecnologicamente
possibile prima o poi viene realizzato, ma ad esso si dovrebbe aggiungere se
ciò che è realizzato è sempre eticamente lecito. La spinta a infrangere le regole della biologia non viene, comunque, da isolati rappresentanti di avanguardie culturali. I protagonisti di questa rivoluzione biotecnologica sono persone
molto comuni, che provengono da ogni ceto, razza o religione. E sono soprattutto coppie, anche se, dove la legge non lo proibisce esplicitamente, non
manca qualche single. Sono coppie che chiedono agli esperti di riproduzione
artificiale di essere aiutate a diventare una famiglia “completa”, coppie che
magari hanno già un figlio e vogliono il secondo a tutti i costi. Come i coniugi
McCaughey, che grazie alle cure contro la sterilità, hanno regalato, con una
gestazione plurigemellare, alla loro bambina di due anni ben sette fratellini2.
I punti problematici e salienti, in un’ottica morale, sono molti.
Innanzitutto: in maniera un po’ estrema, c’è chi si chiede addirittura se sia
lecito il ricorso a tali pratiche, esse sono una forma di terapia della sterilità?
Inoltre ci si domanda se si debba limitare l’utilizzo ad alcune tecniche soltanto
(ad esempio quelle omologhe, in parte ammesse anche dalla Chiesa. E di
conseguenza se si debbano escludere tecniche come la FIVET, che prospetta molti problemi rispetto all’embrione, che viene formato e manipolato in laboratorio...). A queste domande si aggiungono altri interrogativi relativi alla regolamentazione di tali tecniche fecondative: chi può avere accesso a queste tecniche: solo le coppie regolarmente coniugate, anche quelle di fatto? Esiste un
diritto del singolo ad avere accesso ad esse? E per le coppie omosessuali?
Dunque, quale immagine del corpo e della corporeità deriva da queste pratiche? Quale immagine di donna, in particolare, ne deriva? Come vengono
strutturati i rapporti parentali? Quali risvolti psicologici ne possono derivare e
quali ripercussioni sociali?
Infine, permane non risolta la questione della tutela da riservare all’embrione, che rimanda a quella, ancor più complessa, dello statuto ontologico dell’embrione. Questo è uno snodo strutturale: il nascituro3 dovrebbe essere il soggetto in nome del quale si intraprende l’intero processo e, a seconda della prospettiva che si adotta, cambieranno i parametri con cui ci si rapporta alla vicenda (e
di conseguenza anche gli atteggiamenti rispetto alla possibilità di formare, di
NOTE
congelare e di donare embrioni, di “selezionarli” e di sperimentare su di essi).
In sintesi il dilemma etico-giuridico che si formula è se esiste o meno un
“diritto al figlio” a tutti i costi.
La Chiesa cattolica afferma l’inderogabilità del principio della coniugalità e
l’inscindibilità del momento procreativo e di quello unitivo all’interno dell’atto
coniugale, quindi è di per sé contraria all’utilizzo di queste tecniche. Il
Magistero riconosce, comunque, la liceità della fecondazione omologa –e solo
di quella– in considerazione del ruolo fondamentale che la procreazione riveste all’interno della coppia. Ma le perplessità rispetto ad un utilizzo indiscriminato e senza criteri né limiti giuridici di questi interventi provengono da più
parti: si avverte infatti il rischio di espropriare la coppia del momento della
genitorialità, della sua naturalità e della sua dimensione personale e simbolica e quello di perdere il senso di esperienza complessiva che la procreazione
riveste. Quest’ultima posizione è condivisa e sostenuta dal movimento femminista, che aveva in origine accolto con entusiasmo le nuove possibilità procreative: da questa prospettiva giunge oggi un’aperta e ferma critica, dal
momento che la maternità verrebbe ridotta alla sua sola componente biologica, si introdurrebbe prepotentemente il parametro del “mercato”, esteso anche
al corpo quale “merce finale”.
È difficile, allo stato attuale, proporre delle soluzioni sistematiche, che
affrontino in maniera dettagliata tutte le implicazioni delle tecniche di procreazione assistita. D’altro canto, c’è la necessità di una qualche forma di regolamentazione di tali attività tecnico-scientifiche, un nucleo minimo attorno al
quale può essere incentrata una normativa capace di conciliare l’esigenza di
tutelare alcuni diritti/doveri fondamentali con un ragionevole spazio di opzionalità riservato alle decisioni individuali.
Mentre si vede con favore lo sviluppo di tecnologie che contribuiscano ad alleviare le sofferenze connesse ad una sempre più ampia diffusione della sterilità, si
dovrebbe sottolineare la necessità di incrementare le ricerche relative alle cause
della sterilità e alla possibilità che queste siano prevenute ovvero rimosse.
Tale ricerca appare quanto mai urgente, perché si renda evitabile il ricorso
ad una eccessiva medicalizzazione dell’atto procreativo.
Un primo approccio a tali problematiche è quello di prendere atto dell’esistenza di differenti posizioni in relazione al problema dell’inizio della vita
umana; prendere altresì atto che la legislazione vigente tutela la vita umana
fin dal suo inizio; rilevando peraltro che manca una piena tutela dell’embrione
umano fin dal concepimento, particolarmente in riferimento ai rischi connessi
alle difficoltà di impianto nell’utero e all’elevato tasso di abortività nel contesto
della fecondazione extracorporea.
Nel linguaggio comune non c’è consenso tra chi adotta il solo termine
“embrione” e chi ricorre alla dizione “pre-embrione” per indicare il prodotto del
concepimento nello stadio precedente il completamento dell’impianto in utero.
Ad addentrarsi in prima persona nei territori della riproduzione sono le
donne: il nuovo corpo tecnologico è, infatti, un corpo di donna. Tuttavia, è difficile credere che le migliaia di impiegate e casalinghe che si rivolgono alle
banche dello sperma e alle cliniche della fertilità pensino di incarnare il mito
67
postmoderno del cyborg. Il loro problema non sono i corpi multipli o artificiali e
le interazioni uomo-macchina, ma i limiti imposti da una biologia a cui rifiutano di arrendersi. Vogliono un figlio, e per averlo ricorrono alla tecnologia,
anche la più avanzata e sperimentale. Ma alla base del loro desiderio c’è un
istinto antico quanto la vita: il desiderio di maternità4.
Progetto di legge
68
In questi ultimi mesi, dopo anni di differimento della questione, è in corso
in Italia la discussione della proposta di legge sulla procreazione assistita. Da
un punto di vista legale, l’Italia si è inserita nel filone dei cosiddetti “sistemi normativi rigidi”, che ammettono una liceità limitata di queste pratiche (è questa
la linea che va per la maggiore negli stati europei, ad eccezione di Spagna e
Gran Bretagna): la procreazione assistita è ammessa in quanto atto terapeutico, finalizzato alla cura per la sterilità.
La proposta di legge –sulla quale ci sono state variazioni notevoli a seguito della discussione in Senato– in prima istanza non ammetteva la fecondazione eterologa, ma solo quella omologa; prevedeva la possibilità di chiedere
questi interventi, per coppie eterosessuali coniugate o stabilmente legate da
convivenza, in età fertile, sanciva l’importanza del principio di tutela della vita
nascente, ponendo come centrale la tutela del nascituro e affermando il divieto al disconoscimento di paternità, per garantire i bambini già nati da fecondazione eterologa. Nella legge si prevedeva anche la formazione del numero
di embrioni strettamente necessari all’impianto (per evitare che vi siano
embrioni in esubero congelati). Si vietavano inoltre pratiche sperimentali sull’embrione, quali la clonazione umana o qualsiasi altra forma di sperimentazione, e la commercializzazione di queste pratiche, proibendo la remunerazione per la cessione di gameti o embrioni nonché ogni altra forma di prestito
o affitto del corpo (la “maternità surrogata”, in particolare, altrimenti detta
“utero in affitto”).
La proposta passata al voto del Senato è stata in alcuni articoli mutata.
Nel frattempo, è stata votata una norma transitoria che prevede la possibilità di adottare gli embrioni attualmente congelati e in esubero, che dopo 3 anni
non siano più stati richiesti dalla coppia.
A circa due anni dalla presentazione del Testo unico sulla procreazione
assistita, la legge che dovrebbe regolare una pratica ormai largamente diffusa
e consolidata nel nostro Paese subisce un rinvio forse definitivo per l’attuale
legislatura. Gli emendamenti approvati al Senato ribaltano le modifiche che la
formulazione originaria aveva a sua volta registrato alla Camera, ripristinando
la liceità della fecondazione eterologa e stemperando il principio secondo cui
l’embrione sarebbe un “soggetto giuridico” a pieno titolo. La mancata approvazione dell’articolo relativo al consenso informato, ha suggerito inoltre di
riesaminare la normativa nelle Commissioni competenti in modo da verificare
la coerenza e la congruenza dell’articolato. Il conflitto parlamentare che si è
sviluppato negli ultimi anni, spesso eccessivamente ideologico e strumentale,
NOTE
non ha quindi ancora prodotto una normativa capace di rappresentare il pluralismo morale e religioso, di assicurare la certezza del diritto e di individuare
limiti ragionevoli e condivisi agli avanzamenti tumultuosi della biomedicina.
Se un progresso si può tuttavia registrare è quello dell’accresciuta consapevolezza da parte dei cittadini delle opzioni offerte dalle nuove tecniche riproduttive e di conseguenza quello di una maggiore partecipazione ai processi
politici di definizione delle regole.
A fronte di tutti questi scenari si profila l’opportunità di promuovere la libertà e la responsabilità delle donne e degli uomini e, a partire di qui, va colta l’occasione per ripensare un’etica della vita e della generazione.
La legislazione straniera in materia
Gli Stati Uniti sono il paese più liberista in fatto di procreazione assistita. In
Italia la legge va avanti a piccoli passi e tra molte polemiche. Ecco le regole
vigenti in alcuni paesi europei.
La Gran Bretagna è la nazione più all’avanguardia. A differenza degli altri
paesi è consentita sia la “maternità surrogata”, ovvero l’utero in affitto, che l’inseminazione post-mortem. I casi di fecondazione artificiale in vitro vengono
approvati caso per caso, e il padre si assume davanti alle autorità ogni responsabilità per il nascituro.
In Francia tre leggi regolamentano la procreazione assistita, ma solo le
coppie sposate o conviventi possono accedere all’inseminazione artificiale. E
per la fecondazione in vitro con seme di donatori la coppia deve dare il proprio
consenso davanti a un notaio. Non è ammessa l’inseminazione post mortem.
In Germania i figli della provetta sono appannaggio delle sole coppie sposate. Non è ammessa la fecondazione in vitro con seme di donatore né l’utero in affitto e l’inseminazione post mortem.
In Spagna le coppie sposate, conviventi e donne singole possono accedere all’inseminazione artificiale. È ammessa la fecondazione artificiale in vitro
sia omologa (con il seme della coppia) sia eterologa (da donatore) e l’inseminazione post-mortem.
In Svezia la fecondazione in vitro è ammessa solo con il seme della coppia, che deve essere sposata o convivente.
L’Austria è’ l’unico paese in cui si può avere accesso ai dati del donatore.
La fecondazione artificiale è ammessa sia con il seme della coppia che con
quello dei donatori.
La proposta di legge in materia
di fecondazione medicalmente assistita in Italia
Attualmente con le leggi emanate dalla Camera nel 1999 e il testo di legge
discusso di recente in Senato, non si è raggiunto un accordo sulla valutazio-
69
70
ne morale delle tecniche di inseminazione assistita eterologa, di fecondazione
extracorporea e di crioconservazione degli embrioni umani.
Si è comunque concordato sul proscrivere ogni pratica di procreazione
assistita ispirata a pregiudizi razziali; è stato stabilito il divieto di prelevare
gameti o embrioni per destinarli a procreazione assistita senza il consenso
esplicito dell’interessato; è stato bandito ogni sfruttamento commerciale o
industriale dei gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali e che in proposito
venga sancito il divieto di qualsiasi forma di compenso, di intermediazione e
pubblicità; è stata proibita la produzione di embrioni al solo scopo di farne
oggetto di sperimentazione e ricerca, prescindendo cioè dall’obiettivo di ottenere una gravidanza; è stata vietata: la scissione embrionaria precoce, la clonazione e l’ectogenesi a fini procreativi; la produzione di ibridi o chimere e gli
impianti interspecifici, sia a fini procreativi sia a fini di ricerca.
In uno Stato di diritto la legge non può prescindere o andare contro i diritti
assoluti, che sono alla base di qualsiasi ordinamento, come il diritto alla vita.
Da tutti è invocato uno stop agli esperimenti per far nascere vite umane al
di fuori del rapporto sessuale e di amore tra un uomo e una donna, ma molti
sono quelli che gridano per rivendicare una libertà assoluta.
La legge sulla procreazione umana è una materia così delicata e così contrastata che non può prescindere dai problemi del diritto in sé, cioè delle relazioni fra le persone che compongono una società di uomini liberi, e da una
norma giusta adeguata alla natura e alla dignità umana.
La scienza, nel campo delle manipolazioni genetiche, non ha rispettato
alcun limite. La sperimentazione sulla fecondazione in provetta, fuori quindi
dall’ambito naturale dell’incontro tra uomo e donna nell’atto sessuale, ha bisogno di regole che rispettino i diritti umani. Ogni Stato sta cercando di darsi
delle leggi e anche oggi in Italia questo sta avvenendo. Si è però scatenata
una battaglia tra chi vuole una legge permissiva e chi invece si preoccupa che
i diritti di ciascuno siano salvaguardati: primo fra tutti il bambino che nascerà.
Senza dimenticare il diritto naturale, di cui si è detto prima, e il rispetto della
Costituzione italiana, a cui ogni legge si deve uniformare.
Dall’estenuante lavoro di aggiustamenti, di compromessi tra cattolici e laici,
e anche tra sostenitori dello “stato etico” e libertari a oltranza, la legge sulla
fecondazione assistita è stata presentata, e si tratta della prima legge dello
Stato che disciplinerà una materia così complessa. La Commissione Affari
Sociali della Camera ha licenziato il 26 maggio 1999 il testo, che ha iniziato il
suo iter dal dibattito generale di Montecitorio, dove i deputati in questi mesi
hanno discusso di figli in provetta, uteri in affitto, mamme-nonne, fecondazione omologa ed eterologa, banche dello sperma.
Riproponiamo in linee generali le tematiche oggetto della legge, e ripercorriamo l’iter legislativo delle modifiche apportate in Senato, soprattutto per poter
evidenziare le problematiche etico-giuridiche che questi nuovi emendamenti
sollevano. Già dal titolo, la legge sulla “Procreazione medicalmente assistita”
corregge il tiro di una tra le tante possibili polemiche: non una legge sulla
“fecondazione artificiale”, tout court, ma una legge pensata espressamente
per tutelare, in primo luogo, la salute delle donne che hanno la necessità di
NOTE
ricorrere a queste tecniche mediche. Tentando un bilanciamento, più o meno
equilibrato, con l’altra fondamentale “tutela”, quella dell’embrione.
Secondo i fautori di tale legge non si parla di un altro modo di procreare,
alternativo a quello naturale, ma di aiuto per le coppie sterili. Solleva comunque dibattiti accesi e dilemmi etici il problema relativo all’inseminazione eterologa, soprattutto all’interno del concetto cattolico di famiglia. E nella cultura
laica, l’esclusione delle donne single dal diritto alla procreazione assistita è un
espresso attacco alle libertà. Per non parlare dello ‘statuto’ dell’embrione: persona o no5? Uno degli snodi più delicati, questo dello statuto etico e giuridico
dell’embrione, su cui la Commissione, in attesa che sia poi l’Aula a precisare
i termini del problema, ha trovato un accordo con le parole “progetto di vita”.
Vediamo da vicino questa legge. Le tecniche di procreazione assistita,
viene subito specificato, sono “finalizzate alla soluzione dei problemi della sterilità della coppia”. Il ricorso a queste tecniche è consentito “alle coppie di adulti maggiorenni di sesso diverso, coniugate o stabilmente legate da convivenza” e di età non superiore ai 52 anni. Queste coppie potranno rivolgersi a un
centro specializzato (pubblico o privato) sia per sottoporsi alla fecondazione
omologa, sia per ricorrere alle tecniche di seminazione eterologa (con gameti
provenienti da donatori). Una regolamentazione abbastanza rigorosa è prevista anche per l’aspetto “donatori”: i donatori –donne e uomini– dovranno avere
un’età compresa tra i 18 e i 40 anni, saranno tutelati dalla segretezza e non
avranno alcun rapporto giuridico con il nato. Inoltre, la legge vieta espressamente due principi contenuti nel diritto di famiglia: il diritto al disconoscimento
di paternità e il diritto della madre a non essere nominata.
Nel capitolo “divieti” sono previsti la vendita di gameti e embrioni, il prelievo di gameti post mortem, l’utero in affitto6. Un capitolo a sé è quello dedicato
alla clonazione umana e alla sperimentazione sugli embrioni. La clonazione
umana è punita con la reclusione dai dieci ai venti anni, e la sperimentazione
sugli embrioni è vietata in modo assoluto, tranne nei casi in cui sia necessaria
per motivi terapeutici e diagnostici.
I punti “qualificanti” e maggiormente dibattuti, in sostanza, sono i seguenti:
la possibilità che la coppia sterile possa ricorrere alla inseminazione eterologa, l’ammissione delle “coppie di fatto”, l’esclusione delle donne single, il limite dell’età –52 anni– oltre il quale non è possibile accedere alle tecniche, il
divieto a ogni sperimentazione sugli embrioni e alla clonazione umana.
La critica più forte alla legge riguarda l’esclusione delle donne single dalle
tecniche di riproduzione assistita. Già si parla di norma anticostituzionale, e il
dibattito è destinato a crescere. Inoltre, occorre sottolineare che questa rappresenta la prima legge dello Stato italiano a riconoscere le coppie di fatto,
una vittoria della società sulla politica, e un punto di partenza per rivedere la
legge che disciplina le adozioni, per aprirla alle coppie di fatto.
Entrando nello specifico la proposta di legge riconosce all’embrione umano
la qualità di soggetto titolare di diritti (art.1); vieta la fecondazione eterologa
(art.4); impedisce la produzione soprannumeraria di embrioni, la loro soppressione, il loro congelamento, la loro clonazione e cerca di proteggere in ogni
modo il diritto alla vita (art. 13); inoltre la legge consente il ricorso alle tecniche
71
72
di fecondazione artificiale anche alle coppie non sposate (art. 5).
Il testo di legge emendato dalla Camera ha posto dei limiti a una incondizionata procedura sull’inseminazione artificiale, che rischiava di ledere i diritti
di colui che è il soggetto primo del contendere: il nascituro.
Nel testo di legge il Parlamento italiano ha bocciato con una solida maggioranza la possibilità della fecondazione eterologa (fecondare in provetta un
ovulo con il seme di un donatore sconosciuto esterno alla coppia).
Questo diniego, senza entrare in complicanze scientifiche, può essere così
spiegato: il bambino concepito in provetta ha almeno il diritto di essere concepito da suo padre e da sua madre, e non da un padre con l’ovulo di non si
sa chi o da una madre con il seme di uno sconosciuto. Si capirebbe meglio
così che la posta in gioco non è principalmente la libertà di un adulto (oltretutto di uno solo che genera, incoraggiato dall’altro che non genera e col seme
di un terzo che non si vede), ma il diritto del bambino ad avere i suoi due genitori. Il voto alla Camera asseconda questo diritto, che è naturale. Un voto
diverso l’avrebbe violato.
In sintesi, il testo di legge ha sanzionato il divieto di utilizzare donatori
esterni alla coppia per i bimbi in provetta, ma la possibilità di ricorrere alla procreazione assistita anche per le coppie di fatto; la fecondazione è stata limitata alle sole coppie in età potenzialmente fertile; il divieto del disconoscimento della paternità per i figli della provetta nati finora e la possibilità di adottare
gli embrioni in soprannumero al momento di entrata in vigore delle nuove
norme. In ogni modo il ricorso alla procreazione assistita è consentito solo nei
casi di sterilità documentata e non risolvibile terapeuticamente. Gli embrioni
finora congelati potranno essere adottati se la coppia che li aveva fatti produrre non chiederà entro tre anni il loro impianto. Per gli embrioni privi di genitori biologici l’adottabilità sarà immediata. I centri dovranno trasmettere al
Ministero della Sanità e ai giudici tutelari due elenchi contenenti il numero
delle due diverse tipologie di embrioni. All’adozione sono ammesse anche le
coppie di fatto. La legge però vieta per il futuro la congelazione degli embrioni e prevede che ne possano essere prodotti solo tre per ogni singolo impianto. È vietata la sperimentazione sugli embrioni umani come anche la clonazione, con sanzioni severissime per chi contravviene a questa norma: da 10 a
20 anni di reclusione. I figli della provetta, comunque, potranno essere riconosciuti anche dalla sola madre, mentre scatta il divieto per il padre di disconoscere il figlio nato con il seme di un altro uomo (nei casi di fecondazione eterologa realizzati finora o praticati illegalmente). Alle coppie che chiedono di
ricorrere alla provetta devono essere spiegati, da parte del medico (e dello psicologo) i possibili effetti sanitari e psicologici della loro scelta e deve essere
prospettata la possibilità di ricorrere all’adozione o all’affidamento. Infine il
Ministero della Sanità dovrà fornire entro 90 giorni dall’entrata in vigore della
legge delle linee guida sulle procedure e le tecniche di procreazione assistita
e dovrà anche proporre un decreto sui requisiti dei centri pubblici e privati
autorizzati a praticare la procreazione assistita. Tali centri dovranno essere
iscritti in un apposito registro.
Durante i lavori di verifica della suddetta legge, si è giunti nel marzo 2000
a sancire che la fecondazione assistita sarà solo uno dei metodi terapeutici
per risolvere i problemi di sterilità ed infertilità delle coppie. Diventerà, insomma, una tecnica terapeutica come tutte le altre. A stabilirlo è stata la
Commissione Sanità del Senato che nella seduta del 3 marzo 2000, ha dato il
via al voto sugli emendamenti. La nuova formulazione prevede all’articolo 1
del testo già approvato dalla Camera, che “il ricorso alla procreazione assistita è consentito qualora altri metodi terapeutici non risultino idonei”.
L’effetto di tale modifica porta a far ricadere le tecniche sotto il diritto alla
salute.
Un primo risvolto bioetico nel momento in cui la fecondazione assistita sia
considerata una tecnica terapeutica come le altre, solleva la problematica che
non si trasformi in una facile scorciatoia, una tecnica utilizzata anche quando
non ve ne sia un reale e assoluto bisogno. Si tratta, infatti, di tecniche molto
impegnative dal punto di vista psicologico. È, dunque, necessario che ci sia
una certa selezione e soprattutto che si tenga conto dei principi etici.
Il 7 giugno scorso un voto trasversale ha fatto dividere la maggioranza.
Passa la fecondazione eterologa, vengono cancellati i limiti per l’ammissione
al trattamento e viene eliminato il riferimento all’età fertile tra i requisiti necessari alle donne per far ricorso alla fecondazione assistita: cambia, cioè, volto
il testo di legge licenziato dalla Camera.
La legge sulla fecondazione assistita è stata modificata dal Senato, con il
sì a un emendamento proposto dai Verdi sulla fecondazione eterologa. Il disegno di legge, dopo tale modifica, prevede i seguenti procedimenti:
a. nei casi di sterilità maschile potrà essere usato il seme di un altro uomo,
precisando che l’inseminazione eterologa può essere praticata solo quando è
impossibile la procreazione assistita di tipo omologo;
b. potranno procedere a tale forma di inseminazione le coppie coniugate,
ma anche le coppie di fatto, purché si tratti di maggiorenni in età potenzialmente fertile; devono essere escluse le coppie omosessuali;
c. viene eliminato il riferimento all’età fertile fra i requisiti necessari alle
donne per far ricorso alla fecondazione medicalmente assistita;
d. viene fatto divieto di praticare la fecondazione assistita dopo la morte di
uno dei due partner; pene per i medici, non per le coppie, da tre a dieci anni
di reclusione e multe fino a 300 milioni;
e. gli embrioni finora congelati potranno essere adottati se la coppia che li
aveva fatti produrre non chiederà entro tre anni il loro impianto, e vi è il divieto della clonazione degli embrioni e l’obbligo di produrne solo tre per ogni singolo impianto. Chi contravviene alla norma rischierà da 10 a 29 anni di carcere; è vietata la sperimentazione sugli embrioni umani;
Nel testo giunto dalla Camera la fecondazione assistita era consentita solo
come “ultima spiaggia”, quando tutti gli altri metodi terapeutici non fossero
risultati idonei. L’emendamento proposto ha cancellato questa restrizione
aprendo le porte alla fecondazione senza grossi limiti. Inoltre, il Senato ha
NOTE
Le modifiche al progetto di legge
73
approvato la proposta di rendere legale la fecondazione eterologa, cioè quella con i gameti di donatori esterni alla coppia. Si è approvato un emendamento che, in pratica, dà il via libera alla inseminazione eterologa, e direzionandosi
verso il riconoscimento delle mamme-nonne, tutela il diritto di avere un figlio
ad ogni costo, non certo il diritto del figlio.
Infine, l’Assemblea ha inserito nella legge la possibilità alle coppie che
ricorreranno alla fecondazione assistita di ripensarci e bloccare tutto anche
dopo la fecondazione dell’ovulo in vitro: termine ultimo per fare marcia indietro, quello dell’impianto dell’ovulo fecondato nell’utero della donna.
Considerazioni critiche sulla proposta di legge
74
Nel momento in cui la legge, come varata dal Senato con queste modifiche, dovesse venire approvata alla Camera, la situazione italiana a livello giuridico-etico rimarrebbe “pericolosamente libera”, senza regole precise.
La fecondazione artificiale viene considerata una cura contro la sterilità, in
tal modo direzionando la ricerca medica verso tale cura ed affinando nuove
tecniche di fecondazione, il valore della nascita naturale dei bambini viene
messo in seria discussione.
L’ammissione dell’inseminazione eterologa oltre a minare la dualità del rapporto uomo-donna, e il valore cattolico di famiglia, sposta l’attenzione verso il
desiderio di avere un figlio ad ogni costo, togliendo alla stessa legge ogni
attenzione ai principi morali sulla priorità del concepito. E non considerando le
implicazioni psicologiche che tali tecniche fecondative determinano nel figlio
così concepito7.
Si può ancora parlare di diritti del concepito? Si riconosce all’embrione
umano la qualità di soggetto titolare di diritto? La procreazione soprannumeraria strettamente correlata alla fecondazione assistita, anche se vi è il limite
numerico della produzione di embrioni, porta, purtuttavia, alla creazione di
embrioni e alla loro eventuale soppressione.
Il diritto alla vita dell’embrione considerato, come previsto dall’attuale ordinamento, capace di ricevere eredità, sarà tutelato, in quanto è vietato produrre embrioni ai fini sperimentali, fare selezione eugenetica, manipolazione,
scissione dell’embrione, congelamento di embrioni, produzione di ibridi.
Il compito dello Stato, e quindi di chi fa le leggi, è quello di tutelare il bene dei
più deboli, di difendere il bene al di sopra di tutto e non di guardare al volere di
pochi o tanti che dimostrano solo di voler affermare i propri diritti a discapito di
quegli degli altri. Avere un figlio è un desiderio umanissimo: avere un figlio a tutti
i costi non è un diritto, quando quei costi incidono sul diritto di un’altra persona.
In sintesi, con queste modifiche alla legge sulla procreazione medicalmente assistita la vita embrionale non è del tutto garantita. La fecondazione artificiale eterologa non risponde pienamente alla struttura antropologica e morale
della generazione umana e si configura di fatto come una delega procreativa,
non garantendo a sufficienza la vita embrionale. Anche il fatto di limitare soltanto a tre il numero degli embrioni da concepire durante la procreazione assi-
Cfr. C. CASINI, Quale procreazione artificiale, “Studi Cattolici”, n. 448, 1998, pp. 404-414.
Cfr. M. L. DI PIETRO, R. MINACORI, Quale è il rischio delle tecniche di fecondazione artificiale?, “Medicina e morale”, n.3, 1988, pp. 465-497.
3
Il problema del riconoscimento dei diritti al nascituro è stato ampiamente tematizzato da A.
TARANTINO, Sul fondamento dei diritti del nascituro: alcune considerazioni bioetico-giuridiche, in
“Medicina e Morale”, n. 5, 1995, pp. 951-984.
4
Cfr. M. L. BOCCIA, G. ZUFFA, L’eclissi della madre, Milano, Pratiche, 1998.
5
Sulla problematica relativa al concetto di persona si veda L. PALLAZZANI, Il concetto di persona tra bioetica e diritto, Torino, Giappichelli, 1996.
6
Un esempio di fecondazione artificiale mediante il ricorso a una madre surrogata è stato
oggetto della Sentenza del Tribunale di Roma del 14.02.2000. Un giudice del Tribunale di Roma,
Chiara Schettini, ha ordinato con una sentenza un procedimento di fecondazione assistita
mediante l’uso di embrione congelato attraverso la maternità surrogata, il cosiddetto utero in affitto, pratica vietata dal codice deontologico dei medici. Il ginecologo che si era opposto a procedere per ragioni di divieto deontologico è stato autorizzato a superarlo a causa del vuoto legislativo
ancora esistente in materia di fecondazione artificiale e perché potevano sussistere pericoli di
deterioramento per gli embrioni, prelevati e congelati da alcuni anni. La vicenda comincia cinque
anni fa e riguarda una giovane coppia romana che si era rivolta ad un ginecologo perché non
riusciva ad avere un figlio. La donna era portatrice di una malformazione dell’apparato genitale
che le impediva di portare a termine la gravidanza, ma non le impediva di produrre ovociti. Per
questo nel 1995 la coppia aveva espresso il desiderio di procedere per una fecondazione in provetta con utero surrogato. Il procedimento era stato eseguito solo nella prima parte (fecondazione artificiale) perché i coniugi erano rimasti in attesa di una donna disponibile a portare avanti la
gravidanza e per questo motivo sono stati congelati gli embrioni. Quattro anni dopo il congelamento dell’embrione si trova una signora disposta a portare a termine la gravidanza della donna,
ma nel frattempo il codice di deontologia medica aveva vietato ai ginecologi di utilizzare uteri in
affitto. A questo punto la coppia si era rivolta ai giudici chiedendo loro di procedere alla fecondazione con utero in affitto.
7
Cfr. R. LOMBARDI, Implicazioni psicologiche della riproduzione artificiale eterologa, “Il diritto di
famiglia e delle persone”, n.2, 1988, pp. 663-672.
NOTE
stita, per favorire l’attecchimento di almeno uno, è negativo. La dispersione
degli embrioni procurata, infatti, ha il marchio di un delitto contro la vita che
aggrava la responsabilità morale dei soggetti che praticano la procreazione
medicalmente assistita.
Comunque, l’attuale legge contiene anche aspetti positivi, che tuttavia risultano intrecciati con affermazioni problematiche, non pienamente condivisibili
sia sul piano etico sia su quello giuridico. Ecco perché, è auspicabile che il
dibattito sulla fecondazione artificiale possa comunque continuare anche fuori
dal piano della inevitabile mediazione politica e regolamentazione giuridica. In
questo senso, anche la questione dell’aborto, e della revisione della legge 194,
può così trovare uno spazio autonomo di discussione e di riflessione, a prescindere dall’attuale normativa dedicata alla fecondazione artificiale collegandosi ad una effettiva tutela della maternità e della vita prenatale che consenta
di mantenere distinti i piani della riflessione etica da quelli della politica.
1
2
75
F. CH. OETINGER, Pensieri sul sentire e sul conoscere, a c. di T. Griffero,
Palermo, Aestetica Prerint, 1999, pp. 90.
L’opera di F. Ch. Oetinger, Pensieri sul sentire e sul conoscere, del 1775,
è qui presentata in traduzione italiana, preceduta da un’ampia introduzione, in
cui il curatore, Tonino Griffero, illustra e documenta la “estetica” teosofica di
Oetinger. Il pensiero di Oetinger è caratterizzato, secondo Griffero, dalla crescente consapevolezza della natura eccezionale e imperscrutibile dell’intuizione mistica e quindi dall’idea che sia possibile accedere alla verità “attraverso
facoltà cognitive e teologiche e tuttavia universalmente umane quale il senso
comune e, più in generale, il sentire-sentimento (insieme interno ed esterno)”
(p. 7). Oetinger, teorico della “corporalità spirituale”, critica apertamente autori “recenti” come Leibniz, Wolff, che avevano conferito “un primato epistemico
a intelletto e ragione” (p. 15). Il Griffero pone l’accento sull’apologia della conoscenza sensibile (estetica), straordinariamente costante nel pensiero di
Oetinger, “pur tra le inevitabili oscillazioni tra un’esaltazione della sensibilità
qua talis e l’appello semignostico alla sua necessaria integrazione da parte
dello spirito” (p. 24). L’estetica, così, anticipa la condizione beata “più attraverso i propri elementi corporei che non attraverso quelli logici” (p. 26).
Albino Babolin
76
A. MONTANO, Storia e convenzione. Vico ‘contra’ Hobbes, Napoli, La città del
Sole, 1996, pp. 138.
Che senso ha comparare tra loro due filosofi lontani nel tempo e nello spazio con la pretesa di cogliere in essi reciproci influenze o precorrimenti o superamenti e svolgimenti dell’uno dall’altro? Un’operazione di tal genere, pure
assai comune nella moderna storiografia filosofica, rischia di scambiare possibili assonanze verbali per consonanze concettuali.
Uno dei filosofi sul quale più che su altri si è esercitato questo tipo di ermeneutica comparativa è ii nostro Giambattista Vico, messo a confronto e indagato in funzione di uomini e idee di ogni tempo e di ogni luogo. Certo, ogni
autore ha i suoi autori e scavare nelle sue letture può essere utile ai fini di una
ricostruzione della storia della sua formazione mentale, ma è chiaro che se
non è un plagiario o un facitore di centoni, assorbe e fa proprio l’altrui fino a
farlo scomparire del tutto in un concepimento autonomo ed originale. Lo ha
ribadito e provato Aniello Montano nel suo recente contributo filosofico edito
per conto dell’Istituto Italiano per gli studi filosofici, per il quale inaugura una
nuova collana di studi significativamente detta ‘Vatolliana’.
Montano ha resistito alla seduzione di talune tematiche e di talune affinità concettuali pur esistenti ed evidenti in Vico ed in Hobbes, per imbarcarsi in una più
rischiosa navigazione nella mente dei due filosofi per scoprire che cosa veramente ciascuno di loro intendeva, pur nell’apparente consonanza verbale di certe
locuzioni, dal momento che l’uno e l’altro parlavano in tempi e luoghi diversi,
RECENSIONI
diversamente nutriti ed ispirati ad altra cultura e ad altri fini. Ne è risultato un Vico
contra Hobbes, non assimilabili tra loro, ma altri e diversi l’uno dall’altro, perché
entrambi esponenti di mondi culturali diversi e, quel che più conta, I’uno e l’altro
caratterizzati da personalità umane e filosofiche ben diversamente atteggiate.
Così, a proposito dell’erramento ferino teorizzato da Vico e comparato allo
stato di natura di Hobbes come guerra di tutti contro tutti, Montano sfronda le
apparenti somiglianze conseguenti al comune punto di partenza per concludere, con felice intuito che scioglie storicisticamente il confronto, dicendo che,
a differenza che per Hobbes, per Vico l’erramento ferino “non è uno stato di
natura ma uno stato storico” volendo significare che “lo stadio dell’erramento
ferino in Vico ha sempre alle spalle uno stadio di civiltà, primitivo quanto si
voglia, ma pur sempre di civiltà”.
E così pure, proseguendo nella sua indagine, a proposito dell’origine delle
religioni, Montano smonta la tesi di una derivazione di Vico da Hobbes, ben
radicando i suoi argomenti nella considerazione che “il loro universo mentale
è troppo diverso per giustificare volute derivazioni o coincidenze”.
Non diversamente si mostra Vico contra Hobbes nella considerazione storicistica per la quale le forme di governo non sono per Vico, al contrario che
per Hobbes, occasionali, né nate ad libitum; esse, osserva Montano, seguono
il ritmo evolutivo della mente dell’uomo e, perciò, i tempi dello sviluppo della
storia. Ogni momento storico ha una forma di governo ad essa appropriata”.
Ma là dove, sorvolando qui su altri temi di studio messi a fuoco, più chiaramente pare che il filosofo napoletano si avvicini e collimi con l’autore del
Leviatano, è nella interpretazione del principio gnoseologico della conversione o, anche, della coincidenza o reciprocazione del vero col fatto.
A questo tema, poca attenzione è stata data persino dai maggiori studiosi
di Vico e solo di recente la storiografia vichiana ne ha fatto tema specifico e
approfondito di studio, ed è proprio a questo tema che Montano apporta il suo
maggiore contributo.
Non c’è dubbio che il rapporto del vero col fatto è problema centrale tanto
in Vico quanto in Hobbes, ma per lo storico il problema del problema stà nel
chiarire la portata di quei principi e il modo in cui sono utilizzati da ciascuno
dei due filosofi ai fini della propria indagine.
Gli interessi di Vico e di Hobbes, per quanto affini ed attinenti allo stesso
campo di indagine, non sono tuttavia in tutto coincidenti, considerato che se
per Hobbes fondamentale e urgente è fornire all’etica e alla politica fondamenti
saldi e certi, per Vico, invece, iI problema sta nel teorizzare come la civiltà e
la storia, nel loro processo evolutivo, scandiscano fatti e momenti dello sviluppo della mente umana, dalla quale ripetono il ritmo e la razionalità. Questa
‘disomogeneità’ di impegno culturale ed ideale segna già una grande distanza
tra i due filosofi e, a chiarimento andrebbero rilette tutte intere le pp. 96-99
nelle quali Montano taglia netta la supposta affinità concettuale delle dottrine
di Vico e di Hobbes sul principio gnoseologico del rapporto del vero col fatto
per segnalarne l’assoluta improponibilità, tal che il filosofo napoletano non può
considerare come un suo ‘autore’ il filosofo inglese o, comunque, un filosofo
del quale debba considerarsi debitore.
77
Il fare che per Hobbes si converte nel vero è, infatti, a differenza che per
Vico, un fare convenzionale, uno statuire, qualcosa insomma che si vuole che
sia, e non ciò che storicamente si fa, laddove proprio in questo sta per Vico la
reciprocazione del vero col fatto, nella verità del fatto storico o dell’evento
umano che è al tempo stesso storicità della verità. Per Hobbes, il fatto è, dunque, convenzione, per Vico è storia, storia dell’uomo che fa e che in quanto fa
conosce se stesso nella sua storia, ond’è che tutto il sapere è un sapere storico, in quanto storia dell’uomo e del suo sapere che è insieme la sua verità.
E, allora, che Vico ed Hobbes dicano pure cose simili o affini, trattino pure gli
stessi temi, convergano pure in talune locuzioni o in certi principi, resta comunque chiaro e chiarito che Hobbes meglio si definisce come filosofo della convenzionalità, mentre Vico è e resta il filosofo della storicità, il padre dello storicismo.
Mario Montuori
G. MARINI, Tre studi sul cosmopolitismo kantiano, Pisa-Roma, Istituti editoriali
e poligrafici internazionali, 1998, pp. 90.
78
I tre saggi qui raccolti riguardano la filosofia di Kant. Nel primo si affronta il
tema della concezione kantiana di una repubblica mondiale, attraverso un
esame non solo dello scritto Per la pace perpetua, ma anche della Religione
entro i limiti della mera ragione. Kant giunge a teorizzare “una forma di stato
mondiale che è la più vicina alla forma di una repubblica federale, pur nell’uso di una terminologia giuridicamente approssimativa” (p. 34). Al tempo stesso il pensiero di Kant si apre con ardimento e speranze “chiliastiche”, di “chiliasmo teologico” e “filosofico”, che oltrepassano la sfera empirica e mondana:
in questo ambito la fondata speranza di Kant mira pur sempre a un ordinamento cosmopolitico “che assicuri nel mondo il bene di una pace non dispotica bensì repubblicana” (p. 39). Nel secondo e terzo saggio l’attenzione si concentra sul diritto cosmopolitico nel progetto kantiano per la pace perpetua e
negli scritti politici. Nella seconda parte del Conflitto delle facoltà, dal titolo Se
il genere umano sia in costante progresso verso il meglio, è contenuta la più
chiara ed energica condanna della guerra, definita come il più grande ostacolo alla moralità, come l’eterna nemica del progresso; qui Kant “respinge il chiliasmo, che è da intendere come chiliasmo teologico”, sostituito dalla concezione “di un miglioramento non nell’intenzione o nella virtù, ma soltanto nell’esteriorità o nel diritto, che è quanto altrove Kant aveva definito chiliasmo filosofico” (p. 86).
Il pregio di questo volume è quello di richiamare l’attenzione su quei pensieri
che, con un misto di ardimento e di realismo, di sapienza e prudenza, “impeganvano la mente di Kant nell’ultimo decennio nella sua meditazione, che fu
anche l’ultimo decennio del secolo dei lumi” (p. 39). È interessante l’uso della
Religione dei limiti… nel contesto di un esame della filosofia politica kantiana.
Albino Babolin
Friedrich Nietzsche fu autore di oltre settanta composizioni musicali. E se
questo fatto, come è owio, non autoriza a inserire il filosofo di Rocken nel
novero dei musicisti, diciamo cosi, ufficiali, è altrettanto certo che esso non
può essere sottovalutato da parte di chi voglia scandagliare a fondo la personalità e l’opera nietzscheane. È quello che –meritoriamente– ha fatto il giovane ricercatore Simone Zacchini in questo interessante volume arricchito da
una bella e intelligente prefazione di Giorgio Penzo.
“L’importanza della musica composta da Friedrich Nietzsche –scrive
Zacchini– è stata spesso soffocata dietro l’ombra invadente di Richard
Wagner, oppure disgregata sotto fredde considerazioni storico-musicologiche.
Tuttavia né i rapporti Nietzsche-Wagner esauriscono la straordinaria ricchezza e sensibilità di uno spirito intimamente musicale quale è stato Nietzsche, né
le fragili pagine pianistiche e liederistiche possono sopportare i ferri acuti dell’analisi musicale”.
Dunque, è opportuno studiare la musica di Nietzsche, ma andando oltre
essa, per scoprire un paesaggio umano ricco e variegato, un territorio complesso e suggestivo, capace di gettare lampi di una luce inusitata e nuova
all’interno dell’universo nietzscheano: “Al di là della musica –sottolinea a questo proposito Zacchini– si trova il luogo dell’umano, dei troppo umano intrecciarsi di nostalgie, debolezze, attimi felici ed eroiche ribellioni”.
Diviso in tre capitoli ben equilibrati, sostenuto da una valida impalcatura
bibliografica, il lavoro di Zacchini si presenta come un contributo originale alla
comprensione del pensiero di Nietzsche, di un Nietzsche che attraverso i suoi
pezzi e i suoi abbozzi per pianoforte, coro, voce, violino lancia messaggi di
notevole significato e di grande suggestione.
Maurizio Schoepflin
AA. VV., Las conversaciones de la víspera. El Noventayocho en la encrucijada voluntad/abulía, a c. di J. M. Martín Morán e G. Mazzocchi, Lucca, Baroni,
2000, pp. 295.
Il volume che ci viene presentato da J. M. Martín Morán e G. Mazzocchi
costituisce la raccolta degli Atti del Congresso Internazionale tenutosi a
Vercelli dal 16 al 17 maggio 1997 in occasione del centenario (1898-1998) di
quella che in Spagna –e non solo– è nota come la generazione del ’98. Un
Congresso svoltosi anticipatamente rispetto a quella che sarebbe dovuta
essere la scadenza naturale della commemorazione, con l’intento di tracciare
i solchi dei vari simposi e convegni che naturalmente si sarebbero tenuti nell’anno successivo (1998) (p. 8).
Vari gli interventi e di varia natura, ed altro non sarebbe potuto essere visto
l’argomento complesso del convegno; infatti ad un primo studio di J. M. Alegre
RECENSIONI
S. ZACCHINI, Al di là della musica. Friedrich Nietzsche nelle sue composizioni
musicali, Milano, Franco Angeli, 2000, pp. 108.
79
80
Peyrón, El siglo XIX ispanoamericano dove sono considerati gli aspetti storico-politici del secolo XIX con gli avvenimenti che portarono alla fine della
dominazione spagnola sull’Ispanoamerica con la sua indipendenza, ne segue
uno di natura più propriamente filosofico-letteraria. È l’intervento di Ciriaco
Morón Arroyo, che da anni ormai si distingue per le sue indagini di confine fra
filosofia e letteratura, dando esempio di vero ispanismo, se consideriamo
anche la concezione della filosofia che ha l’Autore sul quale ha tanto scritto:
Miguel de Unamuno; secondo Unamuno cioè la filosofia è sorella gemella di
materie come la letteratura e la poesia ed ancora, alla stregua di Croce, la filosofia è filologia. Questa sua linea di ricerca si esplicita una volta più nel suo
intervento: El mundo como abulia y representación, nel quale pone in evidenza l’influenza di filosofi come Schopenhauer e Nietzsche sugli uomini della
generazione del ’98. In particolare termini, meglio concetti, come quelli di abulia e volontà sono tipici degli autori europei che gli spagnoli mutuano ed anzi
fondono quando devono confrontarsi con il problema dell’essenza del alma de
España. In Unamuno per esempio la caratteristica della volontà sta a contraddistinguere, almeno in un primo momento, il popolo; l’abulia invece è il prodotto di una crepa fra la conoscenza ed il desiderio e che troviamo espressa
sia in Nicodemo el fariseo, sottolinea Morón Arroyo, sia nel Diario Intimo. La
volontà schopenhaueriana ricomparirà ne Del Sentimiento trágico de la vida
con la denominazione stavolta di Sentimento, ma sempre con la stessa caratteristica: quella di essere il nucleo centrale della persona, sia nella sua conoscenza, come dei suoi atti. Ma oltre alla volontà, in don Miguel troviamo anche
altri termini: noluntad, o affermazione della nada; la gana, il desiderio che o
non si traduce in azione, oppure diventa un atto irresponsabile (pp. 49-56).
Ma l’opera di Unamuno viene anche indagata da uno studio di N. von
Prellwitz (Unamuno entre cimas y simas, pp. 203-215) nel quale, prendendo in
considerazione opere come Rosarios de sonetos liricos, De Fuerteventura a
París, mostra alla stregua di Morón Arroyo, la presenza dei termini volontà ed
abulia nella sua produzione poetica. Termini che immancabilmente ritornano
anche nella produzione nivolesca, come evidenziato da J. M. Martín Morán nel
suo Niebla: cuestión de límites, dove partendo dal contrasto individualità/personalità, io/altro come incapacità di Augusto Pérez di riconoscere i propri limiti
e quindi di autodefinizione, l’Autore mostra come una tale confusione dia vita
ora ad un sentimento di abulia, ora di slancio della volontà (pp. 217-256).
Su Niebla ritorna M. di Gennaro (Unamuno, Svevo, Pirandello e la tragedia
dell’uomo contemporaneo, pp. 257-271) per evidenziare le affinità con opere di
autori italiani, dopo aver sottolineato le affinità storiche e socio-politiche di Italia
e Spagna, fra la fine dell’800 ed i primi del 900. Il primo parallelo è quello fra i
due personaggi di Niebla (=Augusto) e Senilità (= Emilio) di Svevo: entrambi
sono dei paseantes, il cui atto motorio non implica alcun imperativo della volontà, né porta verso alcuna meta, dando la chiara idea di un modello di vita estremamente statico, almeno fino a quando non compare per entrambi la figura di
una donna. È l’incontro con la donna amata che li conduce alla vera vita da una
parte; dall’altra li porta ad essere anche creatori perché –sottolinea M. di
Gennaro– iniziano ad immaginare due donne diverse da quelle che realmente
RECENSIONI
conoscono –come dire: dall’abulia alla volontà– e dalle quali in realtà non sono
amati, ma sfruttati per trarne un vantaggio. Ma per entrambi i personaggi riconoscere tale realtà avrebbe significato tornare nella senilità o nella niebla, ossia
nella non-esistenza: per questo preferiscono ricrearle; una ricreazione nella
quale la parola svolge un ruolo di primo piano. Il tema invece dell’incertezza sulla
propria essenza, della spersonalizzazione dell’io a causa dei diversi giudizi ai
quali possiamo essere sottoposti dagli altri, il tema della ricercata indipendenza
da parte dei personaggi rispetto all’autore, è ciò che –secondo l’Autrice– accomuna Niebla di Unamuno a Sei personaggi in cerca d’autore di Pirandello; ma
noi ci permetteremmo di aggiungere –specie in riferimento al primo genere di
tematiche– anche ¿Como se hace una novela? ed Uno nessuno e centomila:
tutte tematiche che esprimono comunque una condizione tipicamente epocale.
Ancora un parallelo fra una autore italiano ed Unamuno è quello che prende in considerazione E. M. Montagnoli (La volontà della Ginestra, pp. 273285), questa volta per trattare l’influenza esercitata da Leopardi, cui tante volte
allude o richiama nella sua opera, facendo un maggiore riferimento a La
Ginestra, oltre ad esserne stato il traduttore. Un’influenza che si riconosce
soprattutto nel contrasto ragione/sentimento tipicamente leopardiano, romantico più in generale, e topico di Unamuno.
Ultimo, non certo in ordine d’importanza, intervento su don Miguel, è quello
di G. Mazzocchi che sposta la sua attenzione sulla produzione teatrale: El hermano Juan tra voluntas e noluntas (pp. 287-295), dove don Juan non è certo la
figura del seduttore, e ciò lo si vede anche per l’avere esso dei ricordi, un passato che il seduttore non ha, perché immerso sempre nel presente, ma assume
una tensione distruttiva nei confronti delle opere altrui che descrivono dei matrimoni felici; inoltre Unamuno vuole colpire con la sua opera anche i seduttori che
negano la possibilità procreativa, depauperando l’amore dell’elemento più profondo, e la concezione romantica di un amore assoluto chiuso in se stesso. Ma
Mazzocchi evidenzia che così come per la restante sua opera, anche il teatro ed
in particolare per El hermano Juan, si può parlare di un’autobiografia di don
Miguel, perché nel testo teatrale oltre a chiari riferimenti alla sua autobiografia:
Recuerdos de niñez y de mocedad, si possono distinguere tre elementi tipici di
tutta la sua opera; dalla considerazione della donna come madre, al dominio sui
personaggi fittizi, le loro vite e le loro decisioni, alla considerazione della fratellanza degli uomini nella morte che costituisce insieme l’unica donna che si può
amare, ed in conseguenza anche la tentazione più grossa per don Miguel: quella del desiderio che la noluntas abbia la meglio sulla voluntas.
Ma Morón Arroyo indaga anche il significato che assumono voluntad ed abulia in Ganivet, al quale appartiene il termine abulia e nel quale designa un grave
problema della volontà con dei chiari sintomi tutti intellettuali. Pur essendo essa
studiata scientificamente da psicologi positivisti, non è stata percepita fin la sua
ultima essenza perché metafisica: l’incapacità di desiderare, o la mancanza di
senso critico – come la definisce Ganivet – e che si traduce nell’incapacità di
associare rappresentazioni; ecco perché coltivare l’intelligenza viene a significare: coltivare la volontà. Un termine questo che troviamo anche –come sottolinea
Morón Arroyo– in Azorín, che anzi titola una sua novella: La voluntad, dove si
81
82
possono individuare tre parti tematiche in cui la stessa è suddivisa e nelle quali
la volontà ora si misura con l’ambiente esterno e quindi con la natura, la storia, la
conoscenza, la fede; ora si contrappone all’intelligenza; ora si scopre la doppia
identità dell’uomo come volontà e come riflessione e nel quale prevale quest’ultima identità per la doppia influenza in Azorín di Schopenhauer e di Nietzsche.
Un’influenza che comunque non si ferma agli uomini del ’98, giacché Morón
Arroyo la individua anche nella novella di R. Carreras, Doña Abulia (1904), nella
quale sono visibili tematiche comuni alla generazione del ’98 (pp. 56-70).
Rientrano invece più nell’ambito della storia letteraria, gli interventi di J.
Carlos Mainer e G. Gullón che da punti diversi svolgono un approccio alla differenza fra modernismo e Novantotto fatta dalla letteratura. Una distinzione
che in realtà Mainer (pp. 93-106) giudica oziosa, anche in considerazione dell’ultima critica sull’argomento, e che impedisce di comprendere la fine del
secolo spagnolo come una delle manifestazioni del decadentismo che dominava la scena culturale europea. Allo stesso modo Gullón (pp. 75-92) evidenzia come la storia della letteratura ufficiale abbia sempre visto nel modernismo
l’espressione del lato oscuro dell’identità, cui faceva fronte invece la chiarezza, la volontà, la forza propulsiva delle idee degli uomini del 98.
Una seconda parte del convegno è tutta dedicata a delineare dei paralleli
fra gli uomini della generazione del 98 ed altri autori europei. È questo il caso
di R. Pondero che in Il primo Azorín e Montagne, traccia paralleli interessanti
fra Azorín e Montagne, particolarmente espliciti nella trilogia romanzesca azoriniana: La voluntad, Antonio Azorín, Las confesiones de un pequeño filósofo
(1902-04), dove si possono rintracciare tematiche come: la limitatezza dell’uomo alle prese con la ragione e con gli ingannevoli sensi, la frammentazione del reale, l’ossessione della caducità, la ricerca del proprio ruolo d’intellettuale fra azione e contemplazione, il rapporto complesso e mai risolto con gli
altri uomini… (pp. 119-134).
Quattro sono invece gli studi dedicati alla poetica del 98 con particolare riferimento a quella di Antonio Machado, del quale S. Hutchinson (Reflexiones
sobre el sentimento y el lenguaje en la poética de Antonio Machado, pp. 135144) pone soprattutto in evidenza la formulazione di una poetica che si spinse
oltre la sua stessa opera, per diventare una serie di meditazioni teoriche sul linguaggio e le sue relazioni con il fatto letterario; M. Alcalá Galán (La antirretoricidad de la poesía como ideal estético […], pp. 145-155) che sottolinea lo sforzo
che Machado compie attraverso la sua poetica e la sua idea del linguaggio per
riuscire a comunicare in tutto il suo significato la realtà soggettiva. G. Caravaggi
(Un recuerdo infantil machadiano, pp. 191-201) offre un’analisi testuale di poesie machadiane, mentre un’altra analisi di poetiche viene compiuta da F. L.
Serrano (Poéticas alrededor de 1898 […], pp. 157-190) con riferimento particolare a quelle che hanno segnato la rottura estetica della fine del secolo.
Non avevamo dubbi che un convegno organizzato da un ispanista come il
prof. G. Mazzocchi potesse essere così interessante e completo nella trattazione di un argomento grande e complesso com’è quello della generacón del ’98.
In un’epoca culturale –tutta italiana– in cui dell’ispanismo si tende a fare
una materia esclusivamente letteraria –meglio forse stilistica, perché non c’è
RECENSIONI
letteratura che non esprima un pensiero, una concezione della vita e del
mondo e quindi una filosofia– gli Atti del congresso di Vercelli hanno il merito
di saper coniugare lo studio dello stile letterario alla riflessione sul pensiero,
sulla concezione che l’opera esprime e quindi sulla filosofia dell’Autore. Ciò si
rende tanto più necessario per gli autori spagnoli sempre impegnati –come
quelli della generación del ’98– in un tipo di produzione nella quale compare il
tema della morte, della nada, della voluntad/noluntad. In assenza di una riflessione su tali concetti si rischierebbe di ridurre l’opera ad un semplice schematismo stilistico senza carpirne i reali contenuti; sarebbe come leggere le poesie di Leopardi senza capire il pessimismo insito in esse, senza dire ciò che lo
stesso Unamuno pensava del rapporto filosofia/poesia.
Solo a partire da queste considerazioni si può capire come in Spagna esista –ormai da anni– l’Asociación de Hispanismo filosófico, nella cui rivista si
possono trovare articoli dedicati per esempio ad Oreste Macrì il cui “sforzo
dinanzi agli autori non era mai quello di giudicare, ma quello di capire”.
Carmine Luigi Ferraro
I. A. BIANCHI, Etica husserliana. Studio sui manoscritti inediti degli anni 19201934, Milano, Franco Angeli, 1999, pp. 289.
A giudicare dalla pur ampia messe di analisi relative alla problematica etica
e alla “riabilitata” filosofia pratica, l’impostazione fenomenologica husserliana
sembra essere considerata assolutamente secondaria e comunque incapace di
portare un proprio originale contributo. D’altra parte, all’interno di quello che è
oramai un evidente rinnovato interesse per la fenomenologia trascendentale, la
problematica etica sembra rimanere sullo sfondo, benché dopo la pubblicazione
del volume XXVIII della Husserliana, (Vorlesungen über Ethik und Wertlehre
[1908-1914]), curato da Ullrich Melle, sia stato messo a disposizione degli studiosi un ampio e significativo materiale che per molti versi sembra richiedere un
certo cambiamento di paradigma nella interpretazione tradizionale della fenomenologia di Husserl. Ci troviamo così di fronte a una duplice sottovalutazione,
una di carattere squisitamente teoretico e l’altra di carattere storiografico, ma in
una direzione di senso che tende comunque ad assumere una chiara valenza
interpretativa nei confronti della fenomenologia trascendentale nel suo complesso, soprattutto se si pensa che ancora oggi ci si attarda spesso in discussioni intorno ad un mitico teoreticismo e logicismo di Husserl, incapace di affrontare, sulla base della sua impostazione filosofica, i problemi concreti, di riuscire
a giungere alla chiarificazione delle questioni poste dalla vita, dalla storia e dunque ai problemi che più ci interessano e ci inquietano in quanto uomini che debbono agire, prendere decisioni di carattere sia personale, etico, e, in senso più
ampio, in quanto membri di una comunità intersoggettiva, di carattere politico.
Proprio per queste ragioni è tanto più significativa e degna di nota l’apparizione di un testo che si intende appunto opporre a quello che viene definito “un
declino quanto mai ingeneroso” dell’etica fenomenologica. Nel suo Etica hus-
83
84
serliana. Studio sui manoscritti inediti degli anni 1920-1934, brillantemente
prefatto da uno studioso del calibro di Franco Bosio, Irene Angela Bianchi
riesce ad abbinare magistralmente un raffinato interesse storiografico e filologico, teso a ricostruire l’elaborazione e lo sviluppo della problematica etica nel
pensiero del fondatore della fenomenologia, con una peculiare sensibilità teoretica che le permette di passare continuamente dal piano strettamente storiografico-ricostruttivo a quello del confronto con lo stato attuale della ricerca.
Dal punto di vista storiografico il lavoro della Bianchi si segnala per la ricchezza dei riferimenti e del materiale utilizzato. L’autrice non si limita, infatti, a
prendere in considerazione il materiale pur ampio che è disponibile attraverso
la pubblicazione delle lezioni sull’etica prima rammentate e attraverso gli studi
critici, peraltro significativi, dedicati alla questione dell’etica nella fenomenologia husserliana, ma prende in considerazione il materiale inedito disponibile
presso l’Archivio-Husserl di Lovanio, analizzando in particolare i manoscritti
che vanno dal 1920 al 1934, anche se l’autrice non disdegna di prendere in
considerazione anche manoscritti precedenti. In effetti, benché il sottotitolo
reciti Studio sui manoscritti inediti degli anni 1920-1934, il lavoro ricostruisce
lo sviluppo del problema tenendo conto dell’intera produzione husserliana, ed
è proprio a partire da tale ricostruzione che il discorso si allarga per coinvolgere in un confronto critico autori fondamentali della storia della filosofia, in
particolare Hume, Kant, Fichte, Hegel, Brentano e Scheler, così come autori a
noi contemporanei come Gadamer. L’opera di Husserl, la specificità della sua
proposta teoretica assume così un senso più acuto, risaltando attraverso un
confronto critico che la rende più preziosa e filosoficamente apprezzabile.
La ripresa della tematica fenomenologica da parte della Bianchi intende infatti esplicitamente caratterizzarsi non semplicemente come ricostruttiva e storiografica, ma come una risposta ad una esigenza di affrontare la problematica
etica sul terreno della fondazione e della giustificazione, poiché –nota la
Bianchi– “è solo rivendicando l’esigenza del valore che possiamo contrastare
una società che è sempre più ingabbiata nei termini del bisogno, dell’efficacia e
dell’utilità ad ogni costo” (p. 19). Questa ripresa della tematica del valore deve
tuttavia a suo parere avvenire senza ricadere in quel soggettivismo razionalistico, costruttivistico e universalistico che ha caratterizzato la modernità e che si è
oramai consunto. Il fine che esplicitamente guida il lavoro della Bianchi consiste
infatti –come l’autrice scrive senza giri di parole– nell’avviare “un ripensamento
di una possibile gerarchia dei valori permettendo così all’individuo di costituirsi
in quanto persona autoresponsabile” (p. 20). È in questo contesto e all’interno di
questo progetto che le analisi husserliane vengono riprese e che il pensiero di
Husserl viene non solo ricostruito, ma interrogato ed attualizzato, evitando di
cadere in quella scolastica fenomenologica che ripetendo un certo gergo finisce
per impedire che il discorso fenomenologico possa inserirsi in un più ampio
dibattito culturale. È nel pensiero di Husserl che vengono cercate le risorse per
rispondere a quelle impostazioni che tenderebbero a ridurre la norma morale ad
epifenomeni analizzabili psicologicamente e sociologicamente, poiché la fenomenologia pone l’accento sulla sintesi a priori nella genesi della norma morale.
Ma si tratta di una sintesi a priori e di un a priori che intendono rompere con
RECENSIONI
l’impostazione kantiana, proprio perché la nozione di apriori viene ripreso nel
senso dell’apriori materiale. In questo senso, è l’insegnamento di Brentano che
–secondo la Bianchi– Husserl sviluppa, e ricollegandosi a Hume è l’importanza costitutiva e trascendentale del sentimento che viene rivalutata, senza per
questo giungere ad un’etica fondata solo sul sentimento, poiché altrimenti si
avrebbe soltanto una relatività fluttuante anziché una effettiva oggettività originaria della legge morale (p. 66). Il ruolo dei sentimenti non consiste nel determinare la correttezza dell’agire morale. Si tratta semplicemente di notare che
“concetti come virtù e dovere verrebbero compromessi nella loro essenza se
facessimo sparire dal cuore dell’uomo ogni sensibilità e sentimento” (p. 81).
Su questa base, dopo avere nel Primo capitolo abbozzato i caratteri generali della problematica e avere nel Secondo messo in luce la centralità dei sentimenti, nel Terzo Capitolo viene affrontata un’altra questione decisiva per la problematica etica: il problema di una fenomenologia della volontà. Attraverso analisi sottili e differenziate, il cui centro ci sembra risiedere nella determinazione
nuova che nella fenomenologia viene operata delle nozioni classiche di spontaneità e recettività, viene messa in luce una volontà che deve affermarsi moralmente rispetto agli impulsi, alle tendenze e agli stimoli, e che “la libertà nella
scelta della prospettiva fonda la libertà della persona” (p. 119), cosicché la tematica del valore si salda con quella della persona in quanto soggetto della libertà.
Ma questo tema si salda a sua volta con quello relativo al problema del valore, della loro gerarchia e della loro irriducibilità ad un utilitarismo associativistico,
quindi ad un “egoismo allargato” (p. 147) all’interno del quale viene perso di vista
l’autentico riferimento comunitario che sta particolarmente a cuore a Husserl
all’interno della lettura che la Bianchi offre della sua opera. Ma la Bianchi è soprattutto verso lo sviluppo ulteriore che intende concentrare la sua intenzione, e cioè
sul passaggio dalla fase statica della fenomenologia a quella genetica, perché vi
è –secondo la Bianchi– uno sviluppo interno al pensiero husserliano che suggerisce un’interpretazione soltanto provvisoria e tattica della stessa tematica del
valore, una tematica che deve subire una riconsiderazione allorché ci si rende
conto che l’universalità della norma incontra in campo etico delle difficoltà che
non emergevano dal punto di vista logico, cosicché la problematica etica dovrà
dirigersi verso una teoria della persona e dell’intersoggettività. In questa direzione la Bianchi analizza la struttura di un soggetto etico, di un soggetto in cui la psiche e il corpo non sono separate, ma formano un tutt’uno, cosicché la questione
del soggetto etico implica una discussione e una analisi della corporeità, una problematizzazione del senso dell’“io posso” e della funzione, trascendentale e costitutiva, dell’istinto. Una tematica che restava ai margini delle impostazioni trascendentali classiche e che in Husserl assume invece un valore decisivo. La
Bianchi la collega giustamente con la nozione di “vita”, cercando, attraverso queste due nozioni, di giungere a “una dimensione etica in difesa della vita sin dallo
stato più originario dove la coscienza è, fin dall’inizio, in quanto ‘affezione originaria’, seppure non ancora consapevole e attiva, vita, pura vita” (p. 185).
In questa direzione Husserl incontra la filosofia di Fichte, e a questo incontro la Bianchi tende a dare un peso decisivo, dato che, a partire dalla meditazione husserliana sulla filosofia di Fichte, emergerebbe un mutamento impor-
85
tante dell’impostazione di Husserl, ed in particolare un’accentuazione del tema
della spontaneità rispetto alla passività e alla ricettività. Si tratta di un tema
assai delicato, ed a seconda dall’interpretazione che di questa questione si dà
emerge un’interpretazione complessiva della fenomenologia husserliana,
soprattutto rispetto alla questione dell’idealismo fenomenologico-trascendentale. La Bianchi tende certamente a dare un peso considerevole alla questione della spontaneità, cosicché “la volontà è la volontà verso l’assoluto dominio della ragione, verso l’assoluta determinazione razionale del sé e la formazione del mondo” (p. 267). Emergono qui temi centrali, come quello di sacrificio, che la Bianchi prende giustamente in considerazione e che pongono la
tematica etica di fronte alla questione dell’indecidibile e che collegano l’etica
husserliana ad una effettiva prospettiva filosofica piu ampia in cui –secondo la
Bianchi– assume una posizione centrale la questione teologica.
È dunque un Husserl per molti versi “inedito” che la Bianchi ci consegna,
un Husserl che si interroga sulle questioni della concretezza e spinge la fenomenologia trascendentale verso quei problemi limite che certamente rappresentano per essa un estremo pericolo, ma nello stesso una risorsa ed una
possibilità per continuare a pensare con Husserl dopo Husserl, che è forse
proprio ciò che l’autrice ha voluto fare con il suo lavoro rigoroso e puntuale.
Vincenzo Costa
86
M. DE UNAMUNO, Del sentimento tragico della vita, Casale Monferrato, ed.
Piemme, 20002, pp. 309.
Con una nuova edizione italiana de Del Sentimento trágico de la vida
(1913) del Rettore di Salamanca, Miguel de Unamuno, dotata rispetto all’edizione del 1989 (ed. SE) di un’introduzione all’autore oltre che all’opera, si conferma il grande interesse che da sempre l’intellettuale come il lettore italiani
mostrano nei confronti di quest’uomo, ormai sin dagli inizi del Novecento.
F. Savater, autore di una Presentazione al testo, da subito descrive quelle che
sono le caratteristiche della produzione di don Miguel attraverso la quale è arrivato alla gloria; una produzione che spazia dal saggio filosofico alla poesia, al
teatro, alle novelle e che in Unamuno si rimandano mutualmente. Per questo
motivo Savater contesta la critica quando essa divide la produzione dei vari autori in generi, arrivando a dimezzarli e poi a distruggerli. In contrapposizione a ciò
pone in evidenza come Unamuno “è stato come persona e come personaggio
uno scrittore totale, uno scrittore interamente dedito a fare il saggista, il poeta, il
romanziere, il drammaturgo, il politico, il mistico, l’eretico” (p. 6). È questa una
totalità alla quale arriva –come ci mostra A. Savignano, autore invece
dell’Introduzione– dopo un’infanzia nella quale è educato alla pratica ed osservanza della religione cattolica ed una gioventù completamente trascorsa nello
studio e nel vivere un clima in cui si respira una cultura razionalistica e positivistica. Tutto ciò lo porterà, accortosi del potere dissolvente della ragione (pp. 110131) specie nei confronti delle tematiche religiose, alla crisi religiosa del 1897;
RECENSIONI
quella crisi che determinerà tutta l’opera futura di don Miguel e quindi anche il
Sentimento trágico, dove compare in tutta la sua forza la concezione unamuniana e della filosofia che è poesia (= poiesis) ossia creazione, e della fede che è
fiducia, creare ciò che non vediamo: anch’essa quindi creazione e non semplice
assuefazione ad una teologia dogmatica frutto di mera razionalità (pp. 19-27). È
da qui che il supremo soggetto ed oggetto della sua filosofia viene ad essere el
hombre de carne y hueso “quello che nasce, soffre e muore –soprattutto muore, quello che mangia e beve, gioca e dorme, pensa e ama; l’uomo che si vede e
che si ascolta, il fratello, il vero fratello” (pp. 47-61, in part. p. 47). Per la sua caratteristica antidogmatica, potremmo pensare ad Unamuno come ad un autore
moderno, ma Savater preferisce denominarlo post-moderno per il suo culto nei
confronti del narcisismo trascendentale, visto come un’attenzione particolare nei
confronti dei problemi corporali e psichici dell’individuo e nell’ambito del quale si
possono distinguere due inquietudini: l’ansia d’immortalità e quella di un conflitto
polemico, entrambe fondate sulla volontà dell’autoaffermazione (pp. 7-9). Uscito
infatti da quella crisi religiosa del ’97 ciò che pervade l’animo di don Miguel è l’ansia d’immortalità per la quale egli non vuole morire e non vuole desiderarlo, ma
anzi vuole espandere il suo io fino a comprendere tutto, a comprendere Dio, ad
essere lui stesso Dio (pp. 77-92 e p. 39), come si vedrà anche nella sua novella
Niebla (1914). Unamuno pur desiderando Dio, non vuole tuttavia annullarsi in Lui,
ma salvaguardare il principium individuationis; quindi all’apocatastasi preferirà l’anacefaleusi come ricapitolazione di tutti in Cristo (pp. 172-194 e pp. 219-253).
Savater quindi sottolinea come in realtà di Unamuno non si possa certamente dire che sia cristiano, giacché il cristiano accetta la morte ed anzi la
concepisce come un mezzo per essere guarito dalle proprie imperfezioni,
insufficienze ed essere quindi redento; il cristianesimo non è affatto tragico,
perché davanti alla morte offre una possibilità di salvezza alla volontà di credere, mentre don Miguel preferisce restare nell’incertezza dell’immortalità e,
tuttavia, una incertezza voluta perché arricchisce anche culturalmente. Ma se
sotto questo aspetto don Miguel, secondo Savater, è anticristiano ed antireligioso, non lo è invece per il suo animus disputandi che costituirebbe invece il
suo aspetto religioso e cristiano per la sua esigenza di lotta contro l’evidente,
contro ciò che già ci viene offerto come compiuto e per il quale propugna uno
sforzo vitale e morale a favore dell’insostituibilità dell’individuo (pp. 12-14).
A proposito della religione di Unamuno, Savignano cura con maggior puntualità l’aspetto delle influenze esercitate dalle letture dei protestanti liberali,
soprattutto di Harnack e Ritschl e che fanno ormai da anni parlare di don Miguel
come di un ritschliano-cattolico; anzi proprio in relazione alla problematica della
morte e dell’immortalità, Savignano rileva l’esistenza di un doppio io in
Unamuno: quello scettico che gli proviene dal periodo razionalistico; quello mistico che gli proviene dalla sua formazione religiosa e dal suo profondo vitalismo
(pp. 28-37). È questa poi una dualità che conduce l’uomo –secondo Unamuno–
nel fondo dell’abisso (pp. 132-152), là dove le due tendenze s’incontrano dando
vita ad un’esistenza terribilmente seria perché scaturisce da una lotta continua,
caratterizzata da una perenne opposizione. È da qui che nasce –come sottolinea Savignano– la dialettica di Unamuno; una dialettica che non arriva mai a
87
88
sintesi e tende piuttosto a mantenere distinti i contrari rispetto ai quali propone
kierkegaardianamente il salto, più idoneo per un’esistenza che dev’essere caratterizzata dalla guerra (pp. 37-38). Una guerra per l’immortalità che da una parte
prevede la battaglia per rendermi insostituibile contro una morte che tende ad
eguagliare, mentre dall’altra –evidenzia Savater– prevede la battaglia per conformare l’altro a me, una volontà d’imposizione all’altro tale da esigere una fusione con l’altro fino a diventare un solo ed unico io.
Ciò sta a fondamento di un’etica che non è valutazione razionale, non è l’etica laidamente umanista che m’impone di riconoscere nell’altro il suo diritto a
realizzare il suo io in maniera infinita, così com’è per me, ma è un’etica profondamente religiosa; una religione che torna –secondo Savater– sotto forma
di ragion pratica (p. 15).
L’etica di Unamuno quindi “assume –afferma Savignano– connotati esistenziali, senza sottacere ascendenze fichtiane. L’irresistibile ansia d’immortalità simboleggiata da don Chisciotte, in lotta disperata contro il destino e la
morte, sono alla base della morale eroica” (p. 41). Una morale che prevede: il
sentimento tragico come chiamata all’azione; l’amore-compassione di
Schopenhauer, ma interpretato in senso personalista e secondo il cattolicesimo popolare, giacché la compassione è per un verso finitezza ma anche aspirazione al trascendimento (pp. 153-194); un imperativo d’eternità “agisci in
modo da meritare l’eternità a giudizio tuo e quello degli altri, in modo da renderti insostituibile, da non meritare la morte” (p. 256).
È questo un imperativo che impone la ricerca della felicità, oltre che del
dovere; una felicità che si può ritrovare nell’espletamento del proprio officium
quando esso consente di realizzare tutte le potenzialità dell’individuo (pp. 261262). Savignano rileva a questo proposito l’influenza che su Unamuno esercita: il protestantesimo liberale e Ritschl in particolare, il liberalismo ed il socialismo politico sui generis che sfociano in una politica tragica; come pure evidenzia che l’emblema del sentimento tragico è costituito dal don Chisciotte
che tuttavia in quest’opera, rispetto alla Vida de don Quijote y Sancho (1905),
subisce un’evoluzione interpretativa perché diventa un’esemplare vitalista, la
cui fede si basa sull’incertezza (pp. 143-144 e pp. 41-43).
Ma anche in quest’opera ritorna la veemente lotta di don Miguel contro l’europeizzazione –come sottolinea Savignano-, contro il progresso, la scienza, il
Kulturkampf in generale, assumendo rispetto a ciò una posizione d’agonismo,
vicino all’umanesimo cui pure rimprovera l’opzione per un’economia immanente anziché trascendente (p. 43).
Ed infatti Unamuno chiude l’opera esclamando: “ E che Dio non ti dia pace,
bensì gloria!” (p. 309).
Carmine Luigi Ferraro
G. RAMOINO MELILLI, Gilbert Ryle: itinerari concettuali, Pisa, ETS, 1997, pp. 284.
Questa raccolta di saggi di Grazia Ramoino Melilli viene ad aggiungersi opportunamente ad un’altra precedente monografia di introduzione alla filosofia di Ryle
RECENSIONI
(Filosofia e analisi in Gilbert Ryle, Pisa, ETS, 1983). Il libro contiene cinque saggi,
dedicati a temi centrali della filosofia ryleana, di cui quattro già pubblicati, mentre il
quinto, di circa 70 pagine, appare qui per la prima volta. Il volume include anche
un saggio originale di Ryle Can Virtue Be Taught? (insieme con la traduzione e un
breve commento) edito nel 1977 e ristampato qui per la prima volta.
Il primo capitolo traccia l’evoluzione dei rapporti non facili di Ryle con la
fenomenologia, dalla giovanile e generale attrazione verso la husserliana “active and original school of thought”, al suo definitivo disincanto, trasformatosi
negli ultimi anni in una crescente opposizione polemica. Lo scopo di Ramoino
Melilli è non tanto storico o esegetico, quanto piuttosto metafilosofico, in quanto mette in luce certi aspetti fondamentali della concezione ryleana del compito proprio della filosofia e del metodo filosofico, come prese forma nel contesto
della progressiva meditazione sui meriti e i difetti del movimento fenomenologico. La lettura di queste pagine è interessante e soddisfacente. Un tema emergente è l’ambivalenza di Ryle verso la fenomenologia almeno nei suoi primi
scritti. Infatti commentando la Review ryleana del ’29 di Sein und Zeit di
Heidegger, l’autrice evidenzia, da un lato, la cauta accettazione da parte di Ryle
della fenomenologia vista come un metodo di analisi a priori, descrittivo e privo
di presupposti –una sorta di ermeneutica che, nelle parole di Ryle: “reveals and
interprets what we must have already known ‘in our bones all the time’ “ (p. 18)–
e dall’altro lato, il suo simultaneo rifiuto della fenomenologia come corpo di dottrine ritenute pericolosamente inclini ad un idealismo soggettivo e ad un solipsismo, approdante infine ad una forma di platonismo di essenze intuite.
Ramoino Melilli mette in dubbio la validità di questa distinzione tra “contenuti
dottrinali e metodi di analisi” in quanto minaccia la reale unità della fenomenologia e vede nell’insistenza di Ryle su questo punto l’espressione del suo “spirito asistematico” (pp. 21-22). Senza dubbio ha ragione, anche se ci si può
domandare se l’ambivalenza ryleana non possa anche essere spiegata come
una naturale espressione del suo realismo oxfordiano (“bred in the bones”), rilevato dalla stessa autrice in pagine precedenti. Il “sano realismo” di Ryle, ad
ogni modo, spiegherebbe non solo la sua crescente ostilità verso i “lofty claims”
della fenomenologia ma anche la sua successiva rivalutazione della vera novità del metodo fenomenologico, che venne a percepire come non differente in
sostanza dai metodi tradizionali dell’analisi del linguaggio ordinario così legata
al common sense. Ci si può anche domandare, alla luce delle interpretazioni
“realiste” di Husserl più recenti (cf. per esempio, D. Føllesdal), se l’ostilità di
Ryle verso le “dottrine” della fenomenologia non possa essere stata il risultato
sfortunato del suo aver mal-interpretato Husserl in chiave eccessivamente soggettiva-idealista (un fraintendimento non inconsueto: cfr. A. Gurwitsch).
Il capitolo 2, Il problema dell’immaginazione ci offre un eccellente esempio
dello sforzo dell’autrice di arrivare a “leggere Ryle andando oltre Ryle”, con lo
sguardo volto a scoprire come si possa giungere ad una spiegazione più soddisfacente della materia in esame, in questo caso, la natura dell’immaginazione.
Le origini dell’interesse ryleano verso la famiglia di concetti che cadono sotto
l’umbrella-title di ‘immaginazione’ sono rintracciabili nei suoi primi saggi Are
There Propositions? (1930) e Imaginary Objects (1933), emblematici di quel
89
90
medesimo “zelo occamizzante” che lo guidò nella battaglia contro l’oggettificazione delle proposizioni e, in seguito, contro “il fantasma nella macchina” e contro le immagini quali “copie mentali”. Non tenterò di esporre l’attenta ricostruzione analitica di questi primi saggi di Ryle che, va ricordato, culminano nella tesi
che le asserzioni non asserenti fatti o che sembrano riferirsi a oggetti immaginari, vanno interpretate come “quasi-statements-of-facts” miranti a dirci a cosa
quei fatti somiglierebbero se quelle asserzioni fossero vere, oppure come asserzioni contenenti “quasi-(or pseudo) designations”, la cui intellegibilità dipende
dalla nostra comprensione di che cosa i simboli designerebbero se designassero effettivamente qualcosa. È opportuno notare a questo punto la comprensibile perplessità dell’autrice circa questo appello ai “quasi-simboli”, che la porta a
chiedersi se essa ci dia una chiarificazione genuina o una mera “parafrasi” e
riproposizione del problema originario, nella misura in cui “non serve ad individuare, quel che più importa, la differenza specifica tra un atto di mero opinare,
intuire, immaginare X come Y, e l’atto di conoscere che X è Y” (p. 34). Questa è
proprio la domanda fenomenologica che, come Ramoino Melilli mette in luce,
Ryle stesso poneva nel suo saggio del 1933 a conclusione della sua analisi logica: “What is the nature of the act of imagining, the occurrence of which is vouched for by adjective ‘imaginery’ in the proposition ‘Mr. Pickwick is an imaginery
being ?’”. È proprio tale domanda che Ryle perde di vista nello stesso istante in
cui la pone, perché mentre non nega completamente l’esistenza delle immagini
mentali, in effetti le assimila ad un insieme di “look-predicati” che sarebbero
descrittivi dell’oggetto immaginato se esso esistesse; e nel costruire tutto l’immaginare come un immaginare che, l’atto di immaginare risulta simile ad un atto
di “internal story-telling”. Non meraviglia che l’autrice sia portata a dubitare che
le giovanili analisi ryleane, pur ammettendo le immagini mentali quali veicoli di
un certo tipo di attività creativa, riescano effettivamente a catturare la loro funzione specifica e la natura stessa dell’immaginazione.
È ben noto il ripudio da parte di Ryle delle immagini mentali nel capitolo 8 di
The Concept of Mind, e la spiegazione che Ramoino Melilli ne dà nel seguito del
secondo capitolo del suo libro si sviluppa nel contesto familiare dell’attacco
ryleano al dogma cartesiano, in questo caso il dogma per cui l’immaginare consisterebbe nell’esercizio di una facoltà speciale di contemplazione interiore di
simulacra interiori in un teatro interiore. L’autrice esamina criticamente alcune
delle confusioni concettuali che Ryle attribuisce al fenomenalismo e al rappresentazionismo soggiacente al dogma, come pure le linee principali della sua sottile e attenta “geografia logica” della famiglia di concetti connessi all’immaginazione, e infine la spiegazione in positivo (essenzialmente behaviouristica) consistente nel collegare l’immaginare a varie forme di “pretending” e “make-believing”. Ciò che rende particolarmente valida la discussione di Ramoino Melilli sta
nel suo allargare lo sguardo al panorama storico e alla problematica filosofica
sul cui sfondo va compresa e valutata la riflessione sia critica che costruttiva di
Ryle sull’immaginazione. Ella ci ricorda (pp. 48 e sgg.) che molti aspetti centrali
della critica di Ryle all’immaginismo tradizionale si potevano scoprire (sebbene
in una forma diversa) nei lavori fenomenologici di Husserl e Sartre –un fatto che
non solo illustra alcune affinità importanti di metodo e contenuto tra l’analisi feno-
RECENSIONI
menologica e l’analisi linguistica, ma che anche mostra come le critiche di Ryle
“non danno di per sé alcuna indicazione su quale nuova strada si debba imboccare per una spiegazione positiva dei fenomeni in questione” (p. 49). Non c’è da
stupirsi che Ryle stesso in seguito, come Ramoino Melilli ci ricorda riferendosi
alle riflessioni retrospettive di Ryle nel colloquio sulla filosofia analitica tenutosi
a Royaumont nel 1962, abbia ammesso: “[…] dopo aver smascherato le interpretazioni false ed insidiose, ero obbligato a tentare di dare un’esposizione positiva corretta, ma in questa ricerca concettuale mi persi”. I fenomeni in questione,
insiste Ramoino Melilli, dovrebbero essere investigati dalla prospettiva più
ampia costituita dal problema generale della intenzionalità della coscienza, solo
così diventerà evidente che l’immaginare visivo e uditivo è un atto molto simile
a quello reale, perlomeno nel suo essere un atto intenzionale object-directed,
che pur non implicando l’esistenza di alcunché di visto o di udito, nondimeno
comporta il darsi di un’esperienza fenomenica di “vivacità quasi-sensoriale”.
Allora siamo in grado di capire che quei filosofi che postularono le immagini
mentali non erano meramente presi da smania ontologizzante, ma cercavano di
affrontare, sia pure in maniera spesso mal posta, un problema che non si sarebbe, una volta riformulato, “dissolto come nebbia al sole” (p. 29).
Data la pervasività nell’opera di Ryle della nozione generale di categorymistake è opportuno che questo volume includa anche un saggio (cap.3) dedicato alla discussione delle riflessioni ryleane sul tema delle categorie –tema che
Ryle ha sempre connesso strettamente con le proprie ricerche sui metodi dell’analisi filosofica e sulle fonti degli errori filosofici. Ramoino Melilli focalizza l’attenzione sul paper del 1938 Categories –l’unica trattazione sistematica del soggetto– tenendo anche conto sia di The Concept of Mind che di Dilemmas, dove
sono discussi e diagnosticati vari tipi di errori categoriali e concettuali. L’autrice
svolge un lavoro magistrale nell’esibire le difficoltà teoretiche incontrate da Ryle
nella ricerca dei criteri espliciti di uguaglianza e differenze tra categorie, e nel
districare i molteplici fili della rete di concetti spiegati dall’analisi ryleana.
Ryle nei suoi ultimi anni, ci ricorda l’autrice, giunse ad ammettere e deplorare la “perfunctoriness” con cui aveva trattato in The Concept of Mind la “Mind
qua pensive”, cosicché la preoccupazione di superare i limiti delle spiegazioni
del ’49 circa le forme di pensiero di livello superiore (pur persistendo nel suo
rifiuto di intepretare il thinking come una attività interna, fantomatica, che precederebbe il comportamento) divenne a suo stesso dire il “long term problem”
della sua vita. È proprio questo problema che Ramoino Melilli tratta nel quarto
capitolo –una ristampa della sua introduzione alla edizione italiana da lei curata di On Thinking (1979) (Pensare pensieri, Armando, Roma 1990). Il capitolo
ha il titolo suggestivo Verso una fenomenologia del pensiero: infatti la tesi dell’autrice è che pur avendo Ryle arricchito le sue analisi precedenti illuminando
il carattere polimorfo del pensare, esemplificato in ogni forma di “toilings” e
“idlings”, come pure proponendone una descrizione avverbiale (in quanto il
pensare consiste nel fare qualcosa con attenzione, intenzione, controllo, e via
dicendo), egli nondimeno non raggiunge il suo obbiettivo in pieno poiché la sua
analisi implica un appello a concetti intenzionali che presuppongono la stessa
nozione da spiegare; analisi che infine andrebbe vista come il punto di parten-
91
92
za di una ricerca complementare presumibilmente fenomenologica.
Poiché il concetto ryleano di disposizione comportamentale svolge un ruolo
centrale nella sua interpretazione del mentale e del connesso rifiuto del dogma
dualista cartesiano, il quinto e ultimo capitolo intitolato Discussioni critiche sul
modello disposizionale risulta di conseguenza il pezzo centrale di questa raccolta, ed è anche, come già detto, il più lungo e di nuova pubblicazione. Lo
scopo specifico dell’autrice è di passare in rassegna e valutare parte della
vasta letteratura critica fiorita sul The Concept of Mind e sul Modello disposizionale (MD), mentre il suo punto di vista personale in proposito era stato già
espresso nella monografia del 1983. La strategia della Ramoino Melilli nel trattare le obiezioni standard contro il MD –come la “tautologicità” e la “circolarità”–
è quella di limitarne al minimo i danni, proponendo una lettura di Ryle più fedele e simpatetica. Infatti, mentre sarebbe tautologico (o quasi?) spiegare causalmente la rottura del vetro se colpito, citando la sua fragilità, –dato che secondo il MD “x è fragile” significa proprio “x si romperà se colpito”– l’autrice ci ricorda che per Ryle la funzione dei concetti disposizionali è “prevalentemente predittiva” (p.145) piuttosto che causale-esplicativa; lo scopo delle attribuzioni disposizionali per Ryle è quello di fornire descrizioni “classificatorie-generalizzanti” che, una volta spacchettate, illustrano i modelli di comportamento tipici (e nel
caso delle disposizioni mentali o “many-track”, i modelli sono complessi e multiformi) che ci possiamo aspettare da un individuo particolare sotto varie condizioni. Quanto all’obiezione di circolarità (rivolta al fatto che le descrizioni del
comportamento associate a una disposizione psicologica sono a loro volta
saturate dal riferimento a condizioni psicologiche), la risposta dell’autrice ci
sembra ancora una volta del tutto appropriata: l’obiezione vale solo se interpretiamo erroneamente Ryle come se fosse un riduzionista mirante a fornire
traduzioni fisicaliste di asserzioni psicologiche; ma naturalmente sarebbe un
errore, data l’insistenza ryleana sul carattere “open textured” delle disposizioni
psicologiche e sulla natura “olistica” del mentale (pp.146-47). Inoltre il behaviourismo logico sui generis di Ryle, a differenza di altre forme riduzionistiche
di comportamentismo, si fonda su una ontologia irriducibile delle persone, non
certamente delle connessioni tra eventi fisici o del tipo stimolo-risposta.
Una sezione del quinto capitolo discute l’influenza del MD ryleano sull’acceso dibattito della filosofia analitica riguardante la possibilità di estendere in modi
appropriati il modello di spiegazione nomologico il c.d. “covering law model” prevalente nelle scienze naturali, anche alle scienze umane. La discussione di
Ramoino Melilli è, come al solito, illuminante e ben documentata: dovendo semplificare per motivi di brevità, i risultati dell’autrice sono sintetizzabili dicendo che,
mentre Hempel ha interpretato il MD come se fosse in fin dei conti compatibile
con il suo famoso modello nomologico, le posizioni tra i sostenitori del modello
concorrente, quello storico del Verstehen, variano in modi significativi: alcuni
come A. Donagan e J. Watkins hanno visto nel MD ryleano una sostanziale difesa del modello del “comprendere”, mentre altri come Dray e Winch, lo ritengono
al contrario “costituzionalmente inadatto” a fondare la nostra comprensione dell’azione razionale. Ramoino Melilli, pur inclinando verso l’approccio più eclettico
di filosofi quali P. Gardiner, ne trae la morale che la grande varietà di interpreta-
Ausonio Marras
A. CAPITINI, Scritti filosofici e religiosi, a cura di M. Martini, Perugia, Fondazione
Centro studi A. Capitini, 19982.
“Il soggetto capitiniano –chiarisce Mario Martini nella sua Introduzione alla
RECENSIONI
zioni fiorita intorno agli spunti di ricerca offerti dal MD è comunque prova della
sua intrinseca ricchezza, complessità e apertura.
Il resto del capitolo passa in rassegna i luoghi principali della letteratura critica che dopo il ’49 ha discusso il problema del rapporto tra le disposizioni e le loro
“basi” e spiega l’impatto che la soluzione “realista” ha avuto nello sviluppo delle
varie tendenze materialiste della filosofia della mente recente, dal “central state
materialism” di D. Armstrong al “computazionalismo” di J. Fodor. L’autrice, pur
concordando con la tesi prevalente secondo cui l’analisi concettuale di Ryle sulle
disposizioni mentali non è riuscita a spazzar via un’ontologia degli stati interni
quali basi materiali e causali delle disposizioni, e quindi ha fallito nella difesa del
behaviourismo logico, mette in rilievo giustamente l’importanza storica del lavoro
di Ryle quale punto di riferimento costante nello sviluppo degli approcci contrastanti nella filosofia contemporanea della mente. Una tale concessione sull’importanza storica dell’opera di Ryle potrebbe far pensare ad un giudizio implicitamente negativo sulla sua importanza teoretica: questa impressione sarebbe
infondata, perché, come l’autrice sottolinea, il MD (a dispetto della stessa opinione di Ryle in merito) non va visto come incompatibile con, ma piuttosto come
complementare a, una spiegazione realista delle disposizioni nei termini delle loro
basi. Infatti, pensarla diversamente significherebbe dimenticare la lezione dei
primi capitoli del suo libro, in cui enfatizza lo scopo descrittivo-fenomenologico
delle analisi concettuali di Ryle –uno scopo che chiaramente non entra necessariamente in conflitto con altri scopi ontologici e causali-esplicativi. “L’umanesimo
anti-riduzionista incentrato sul concetto di persona” (p.183, n. 40) di Ryle, su cui
l’autrice nuovamente insiste, è non solo la chiave principale di lettura –una volta
che si sia compreso, a nostro parere, la sua compatibilità con il causalismo scientifico– ma anche la chiave per “leggere Ryle andando oltre Ryle”.
Per concludere, una parola sull’Appendice. Il saggio originale Can Virtue Be
taught? scritto da Ryle intorno al 1965-66, fu inviato all’autrice da Ryle nel 1969
e poi pubblicato con traduzione italiana e commento in “Studi Filosofici e
Pedagogici” (1,1977); la sua ripubblicazione adesso servirà a rendere più accessibile questa piccola parte del corpus ryleano, aumentando l’interesse di questa
raccolta di saggi anche per un pubblico di lettori di lingua inglese. E, circa i suoi
meriti intrinseci, resta da aggiungere che questo saggio, oltre a fornire un esempio vivo e di prima mano –grazie ad una illuminante discussione della famosa
domanda socratica– del valore ma anche dei limiti della classica metodologia
ryleana di risolvere i puzzles filosofici disegnando la geografia logica dei concetti
(in questo caso la rete intricata dei concetti della conoscenza e della prassi
morale), chiude ottimamente, insieme ai commenti dell’autrice, questo bel libro.
93
94
bella raccolta di saggi del Capitini filosofo e “persuaso religioso”– disposto
all’ascolto, all’appello dell’altro, si pone non come soggetto logico ma dialogico, e pone questa modalità come propria di tutta la realtà”(p. XI). Il volume
offre al lettore una panoramica assai ampia su quelli che sono i principi chiave della filosofia di Aldo Capitini, autore che finalmente oggi pare ottenere la
meritata attenzione: il valore del tu, vero elemento degno di trascendenza, la
nonviolenza, e con essa la noncollaborazione e la nonmenzogna, ma anche
l’idea della realtà di tutti, quella della compresenza dei morti e dei viventi.
Il primo dei saggi proposti, Elementi di un’esperienza religiosa che è del
1937, è un testo “non di dottrina e saggezza libresca”, come diceva l’amico
Walter Binni, bensì di formazione di tutta una generazione che ne assorbì “il
valore fondamentale di educazione etico-politica” (p. 68). Presentando il suo
scritto lo stesso Autore lancia un invito: “Aprite a caso, mentre leggete questa
introduzione, il libro e troverete che in ogni periodo c’è la volontà di liberare, di
dare iniziativa alla sincerità, all’affetto, al pensiero che svolge nel suo travaglio
continuo la verità. […]. Era questa la mia esperienza che sorgeva dal concreto; e il mio libro era per tutti, proprio per tutti, appunto perché era dell’intimo
mio […]” (p. 6).
Di dieci anni dopo è il Saggio sul soggetto della storia, quasi testimonianza della originalità capitiniana nei confronti delle tesi crociane sulla storia e
dichiarazione dei diritti di un individuo concreto in sostituzione del soggetto
universale di matrice hegeliana. Vi troviamo, tra l’altro, un’affascinante definizione del valore come ciò che “ottiene il suo carattere di infinito dalla presenza dell’Uno-Tutti, presenza attiva, infinita; dunque il valore è in rapporto con
un’infinità soggettiva”(p.243).
La compresenza dei morti e dei viventi (Premio Viareggio nel ’67), poi, è
opera di grande respiro incentrata sulla tematica della condivisione che dell’esistenza mettono in atto, in crescendo, i vivi e i morti, gli uni vivendo attivamente e gli altri rimanendo presenti come modelli di incarnazione di valori. Nel
soffrire il vuoto lasciato dai morti, gli individui si impegnano nella vita con il
creare l’energia con cui rinnovano la vita stessa: l’eterno, allora, è nella gioia
vitale della cooperazione tra il più e il meno forte, è nell’“aurorale” fare insieme che lega gli uomini, gli animali e i vegetali, gli esseri tutti, esaltandone la
comune appartenenza a questo mondo. La chiusura verso la compresenza è
il peccato più grave e scellerato che l’uomo possa commettere (cfr. p. 281), e
perciò la più grande verità a nostra portata è quella della necessità di integrare l’amore sessuale con l’amore relazionale teso al “tu-tutti” (cfr. pp. 274-275).
E l’“apertura massima” si ha soltanto con la persuasione –termine che Capitini
mutua dal Michelstaedter–, ovvero con quella condizione per cui l’uomo,
offrendo la propria attenzione all’altro, oltrepassa i limiti di individuo e si scopre sostenuto da una forza d’animo esemplare che libera il presente di tutti.
Così l’aggiunta, libero atto della “tensione ad aggiungere alla varia esplicazione della vita atti che non sembrerebbero risultare dalle situazioni, come quelli
che hanno caratteri di vitalità, di scienza, di morale, ma che si decide di eseguire perché intimamente connessi con la compresenza” (p. 299). Ecco allora
che l’aprirsi alla compresenza è aggiunta: infatti, dice Capitini, se “si dovesse
Giuseppe Moscati
RECENSIONI
premiare ognuno che operi per la vita, ogni essere prenderebbe tranquillamente il premio. Ma se si volesse premiare ognuno che aiuta la produzione di
valori, l’infermo, l’inerte, il morto, avrebbero diritto al premio? Comunemente si
pensa di no, ed è una chiusura” (p. 347). E questo in virtù della convinzione
capitiniana di fondo, secondo la quale –ed è una “verità” di grandiosa umanità– lo stesso “aver coscienza della propria vita è già essere qualche cosa in
più, almeno come inquietudine e apertura” (ivi). Lo stesso atto del conoscere
è tratto sociale perché il “vero soggetto” ha in sé come atto distintivo la intersoggettività: anzi, Capitini –attraverso Giulio Preti– si richiama esplicitamente
a Feuerbach là dove, supposta la necessità di integrare ogni idealismo con la
“vita sensibile”, recupera “l’uomo come coscienza sensibile”.
Ma tante sono le pagine intense che egli ha dedicato all’antropologia del De
Martino come ai classici del pensiero filosofico (Kant, Hegel, Croce…), fermo
restando che “le sue ragioni –ha scritto Martini– sono più di ordine morale che
non dalla parte della razionalità teoretica o dimostrativa” (p.IX). E così pure
assai interessante è l’Appendice, ricca di un testo, quello di Religione aperta
(1955), dalla storia travagliata, anch’esso vittima della censura ecclesiastica (l’iscrizione all’Indice avvenne ad opera di Pio XII). Pagine di coraggiosa presa di
posizione e di seria riflessione sul proprio modo di intendere le questioni fondamentali dell’esistenza, Religione aperta testimonia dell’allontanamento del
Nostro dal chiuso cattolicesimo e del suo approdo ad una dimensione religiosa
tutta piena dell’amore universale e dell’attenzione a chi vive ai margini, nata da
un rigore morale, da un ripensamento dei classici e da una disposizione alle
“libere aggiunte” che contraddistinguono tutta una vita. “Qualsiasi posizione
religiosa –leggiamo nella Nota del curatore– che non fa sua questa tensione
all’apertura, si istituzionalizza, si “monarchizza”, finendo quindi col porre alla
propria base chiusure fondamentaliste”(p. 463). L’invito fondamentale di
Capitini rimane allora quello di muovere sempre dal tu e mai dall’io; una delle
“illuminazioni” più affascinanti è quella del passo in cui Capitini trae le sue conclusioni sul significato della morte: “Ho capito che la morte è un avvenimento e
una lezione all’io che voglia la sua continuazione particolare, indifferentemente
dalla sorte degli altri” (p. 483). La morte, una lezione per l’io solipsista.
E poi l’amore: “supremo conforto e unico fiore”, esso è ciò che ci dà una
certa “rivalsa sulla morte” e come questa “soggioga e fa ammutolire” (p. 489).
Esemplare, quindi, lo stesso modo in cui viene trattato l’argomento della vecchiaia, quasi una sorta di socialismo dell’animo: “bisogna essere migliori della
vita con i vecchi. […]). E noi dobbiamo colmare là dove la vita toglie, compensando come possiamo, con la presenza serena, l’attenzione, la devozione, la
pazienza, anzi la festevolezza, come a fugare l’amarezza e la dolente protesta”
(p. 494). Lo stesso profondo senso dell’umano, forte di una mirabile religiosità
laica, aveva portato il filosofo perugino a considerare l’individuo come luogo
vitale del valore e l’umanità della coralità del valore stesso, il tu–tutti: “nel tu
rivolto a lui io vedo altro, una sua partecipazione al dolore, ai sentimenti, alle
idee, alla bellezza, all’aspettazione di una realtà migliore” (p. 347).
95
A. ALES BELLO, Edith Stein. La passione per la verità, Padova, Edizioni
Messaggero, 1998, pagg. 139.
96
Questo libro rappresenta il primo profilo completo, unitario e sistematico,
dell’opera filosofica, che colpisce per la singolare personalità da cui sorge. Al
termine della lettura, infatti, ci si sente legati da stringente necessità a riconoscere fino a che punto in questo caso “non è possibile separare il contributo
intellettuale dalla vicenda esistenziale e spirituale che l’accompagna”
(Prefazione, p. 5). Di questa figura ci viene offerto un quadro policromo: l’ambiente familiare, gli studi, le amicizie intellettuali ed il dialogo con gli eventi dei
tempi sempre piu cupi, fino alla catastrofe –che ispirò a Husserl, suo maestro,
quella grande sinfonia tragica che è La Crisi delle scienze europee.
Il percorso di vita e di pensiero di E. Stein ha una sua cifra, assolutamente singolare e sorprendente: ella è, come persona e come intellettuale, creatura delle
unioni e delle lacerazioni, delle fedeltà sostanziali e delle scelte decisive.
Ebraismo e cristianesimo, agostinismo e fenomenologia, concezione tomistica e
soggettivismo moderno: di questi poli ella cerca con passione il filo di una congiunzione possibile, e, nella sua lucidità intellettuale, ripercorre le divergenze.
Fino alla polarità più comprensiva, ove si dispiega la distanza massima: scienza
–rigorosa, nel senso husserliano– e mistica. Nella reclusa solitudine del Carmelo
di Colonia, la fanciulla ebrea, la brillante studiosa, se in segreto dischiude le porte
del mistico castello dell’anima (Seelenburg), compone la grande opera teoretica,
le milletrecentosessanta pagine in cui si consolida un pensiero, ricco dell’esperienza scientifica della psicologia e sociologia del Novecento, affinato nell’esercizio dell’analisi fenomenologica, che non cede d’un punto sul piano della metodica rigorosa, tuttavia incontrando l’altro del sapere, l’ulteriorità che richiede la figura dell’essere. “Nel 1936 –scrive Angela A. Bello, che coglie ed offre di ogni dato
la risonanza assiologica –il manoscritto di milletrecentosessanta pagine era già
pronto e fu intitolato Essere finito ed Essere eterno. Tentativo di un’ascesa al
senso dell’essere” (p. 25), e noi non soltanto leggiamo il deliberato confronto con
Heidegger, come Ales Bello lo sintetizza: “Heidegger […] si chiude nella necessaria ed essenziale finitezza dell’essere di ogni ente”, mentre la Stein compie una
“ricerca dall’essere umano a Dio e poi di nuovo in particolare all’anima umana”
(p. 26); ma siamo colpiti dalla carica simbolica che c’investe nella coincidenza
cronologica: nel 1936 concludeva il suo cammino di pensiero scavando al fondo
dello spirito smarrito dell’Europa le radici della sua dissoluzione, ed evocava il
telos della ragione contro il prevalere di un “oscuro destino”.
I momenti che, tra l’inizio e la fine, presentano una significativa corrispondenza, nel contenuto e nel metodo, sono due. Innanzi tutto vi è il tema antropologico, che si affaccia con lo studio su L’empatia: “Non è un caso –scrive
Ales Bello– che E. Stein nel momento di scegliere la sua tesi di laurea si orienti verso la trattazione di questo tema”(p. 44). In questo campo, infatti, ella prosegue da un lato approfondendo le ricerche di Husserl attraverso il “lavoro di
revisione da lei condotto del secondo volume delle Idee” (p.31), ma anche
confrontandosi con Scheler, Tonnies ed altri a proposito di società e comunità, massa e stato. D’altra parte, il suo metodo, come sottolinea Ales Bello, è
Bianca Maria D’Ippolito
M. VIANELLO, E. CARAMAZZA, Donne e metamorfosi della politica, Roma, Editori
Riuniti, 1998, p.p. 175
La tematica della presenza e della specificità femminile, della differenza ses-
RECENSIONI
orientato “ad una lettura della realtà che la coglie nella sua totalità, ma la totalità non è un cerchio che chiude tutto, individuando un punto di forza teorico
unitario, che potrebbe essere la storia, l’economia, la ragione, l’inconscio, ma
è una totalità che si delinea per espansione in una duplice direzione di approfondimento e progressivo sondaggio dalla parte […] al tutto che essa rivela in
se stessa e a cui rimanda per poter essere compresa”(pp. 42-43).
L’antropologia di E. Stein ha alla sua base un concetto originale, rimasto estraneo alla fenomenologia husserliana: il concetto di forza vitale, che ha la funzione
d’interpretare sia il rapporto corpo-anima sia quello tra individuo e relazione, nelle
diverse forme e modalità, che sono: società, comunità, Stato; e massa, popolo.
La forza vitale è un elemento mobile, che attraversa gli strati ‘meccanici’ e ‘psichici’ per giungere fino al centro della persona, lo spirito. Nella sua ricostruzione
fedele all’esattezza fenomenologica, che ripercorre gli strati genealogici, Ales
Bello è sempre attenta al significato etico che le sorregge. Nel tema della forza
vitale si conserva la fenomenologica rivalutazione della corporeità come dimensione a pieno titolo soggettiva, e nello stesso tempo si disegnano le articolazioni
che connettono, dinamicamente, l’individuo agli altri in forme concrete e stabili: “la
forza vitale appartiene ai singoli che contribuiscono a formare la comunità, ma,
una volta oggettivata, essa può servire da stimolo al singolo” (p.47).
L’antropologia è d’altra parte il centro vivo del confronto più intenso e drammatico che la Stein affronta, nel momento della svolta cruciale dalla fenomenologia alla metafisica. Si tratta dello studio su S. Tommaso e Husserl, che Ales
Bello così commenta: “In tutto l’articolo è riscontrabile un duplice atteggiamento: desiderio di stabilire un accordo, ma anche di sottolineare la distinzione, che
indica uno sforzo teoretico comprensibile sulla base del nuovo indirizzo che la
sua speculazione stava assumendo. Il confronto fra le due posizioni è stabilito
in relazione ad alcuni temi di fondo: il significato della filosofia, la ragione e la
fede, il teocentrismo e l’egocentrismo, l’ontologia e la metafisica, il valore dell’intuizione, quindi sotto il duplice aspetto metafisico e gnoseologico”(p.60). Il
razionalismo di Tommaso, che “crede nella possibilità di una soperta razionale
delle cose” è il punto di maggior vicinanza tra i due filosofi – ciò che li disgiunge è la ‘modernità stessa’, quel “punto di partenza indubitabile e contemporaneamente critico” (p.62), così lontano dallo spirito della filosofia medievale.
L’esperienza di vita di Edith Stein fu segnata da un sistematico, sempre piu
feroce rifiuto, che le fu inflitto in molteplici forme. Prima con la negazione della
libera docenza, poi con la privazione del suo posto d’insegnante; della vita
stessa, infine, con la deportazione e morte ad Auschwitz. La forza del suo spirito non fu mai spezzata, e la sua voce parla ancora della speranza di unione,
di ciò che fu così tragicamente diviso.
97
98
suale, ha investito con intensità sempre più crescente, numerosi comparti delle
scienze umane: dalla storia alla filosofia, dalle scienze sociali a quelle politiche.
Oggi si parla maggiormente di “differenza sessuale”, superata la fase dell’antagonismo e della competizione che ha caratterizzato gli anni della rivendicazione
femminista. Questo nuovo orientamento ha di fatto mutato la modalità di pensare le stesse scienze umane, la struttura epistemica e disciplinare di diversi campi
del sapere che sono stati sottoposti a nuova lettura e a una diversa interpretazione in base anche e soprattutto ad una presenza femminile sempre più protagonista della produzione culturale, legittimata dalla società. Gli autori di questo
testo vogliono mettere in luce proprio questo processo evolutivo, la conquista
appunto di nuovi spazi sociali, culturali ma anche più semplicemente “fisici”. Il
grande sforzo compiuto nei secoli dalle donne, secondo gli autori di questo libro,
non è stato solo rappresentato dall’acquisizione del “diritto di parola” di uno “spazio d’ascolto” ma anche del più semplice ma vitale accesso ad uno “spazio fisico” e socialmente legittimato. Uno spazio che vada oltre i ruoli da secoli accreditati alla presenza femminile, compiti e ruoli già determinati e saldati da secoli
nel tessuto storico e sociale ma di uno “spazio scelto”, vivo e partecipato, luogo
di decisioni, relazioni ed azioni compiute in prima persona. Questo è l’oggetto di
riflessione affrontato dagli autori di questo libro che, partendo dalla convinzione
che la politica sia appunto uno “spazio di partecipazione alla vita pubblica” (questo almeno anche nella concezione della polis greca), si interrogano sui motivi
sociali, culturali, storici della emarginazione delle donne da questo spazio divenuto progressivamente appannaggio maschile.
Ciò ha comunque implicato molteplici conseguenze proprio nella vita della
società e nella sua crescita civile. L’ipotesi degli autori di questo libro è che le
donne siano state intenzionalmente escluse da uno spazio di scelta e di decisione proprio per l’incapacità degli uomini di condividere spazio e potere in
maniera complementare. Il mancato apporto che dalle donne sarebbe potuto
venire alla vita pubblica e la distorsione con cui essa è stata organizzata dagli
uomini, ha prodotto un tipo di storia caratterizzato largamente dalla violenza.
A questo riguardo gli autori di questo libro hanno voluto mettere in risalto ad
inizio del testo un’affermazione di Gandhi: “Se la non violenza è la legge del
nostro essere, il futuro appartiene alle donne” così come nell’analisi del costume e della tradizione di gran parte dei popoli ed in ogni tempo, si può constatare un unico filo conduttore costante: il culto dell’eroe e della violenza come
positiva connotazione intrinseca maschile. Così allo stesso modo anche per
l’uso ed il significato attribuito allo spazio: per i maschi lo spazio è sempre in
funzione delle cose, ovvero dei rapporti di potere relativamente alle cose; per
le donne lo spazio non è strumentale ma è sempre rivolto verso se stesse, la
propria interiorità e quella altrui, verso il mondo degli affetti e quindi dello “spazio interiore”. Spazio pubblico e potere per gli uomini, spazio interiore per le
donne. Per gli autori è necessario capovolgere nell’uomo proprio la visione
dello spazio, portarlo a guardare verso il dentro, abituarlo al valore del dettaglio concreto anche legato al quotidiano.
È questo il solo modo per condividere veramente lo spazio e realizzare un’effettiva parità secondo la logica della complementarietà, del “fare le stesse cose,
M. Camilla Briganti
G. CONTI ODORISIO, Una famiglia nella storia, Napoli, Edizioni Scientifiche
Italiane, 2000.
Scriveva Hannah Arendt che è vano cercare un senso nella politica o un
significato nella storia quando tutto ciò che è comportamento quotidiano sia
stato scartato come irrilevante.
Ginevra Conti Odorisio in Una famiglia nella storia, seguendo netta questa
indicazione arendtiana, e attingendo a un grande archivio privato fatto di diari,
lettere, quotidiani conti e bilanci economici e di vita dei componenti della sua
famiglia dal 1840 al 1980, ci consegna non solo una storia, una storia di una
famiglia (che sia proprio la sua ha persino un’importanza relativa), ma una storia pulsante tra biografia, politica e affresco d’ambiente, che non solo ha tutto
il gusto di un romanzo, ma, proprio perché rimane sulla soglia delle discipline
tradizionali, apre le porte a un modo nuovo e più fecondo di fare storia. Sicché
anche i contenuti vengono spesso a cambiare di segno o, almeno, ad illuminarsi di senso nuovo. E se nessun senso nuovo può illuminare la vita aspra
RECENSIONI
ma in modo diverso” che è alla base appunto dell’uguaglianza nella diversità.
Nella seconda parte di questo libro gli autori si soffermano a notare come le
donne siano estranee alle discipline delle scienze sociali, non esistono quasi
donne (almeno fino al Novecento) che abbiano contribuito in modo considerevole alla storia di queste discipline e ciò perché la produzione culturale è sempre stata appannaggio maschile. Di qui la difficoltà che le donne sperimentano
nell’esprimere se stesse. Semplicemente, per questi autori, non esistono schemi adatti a loro. Il “come” e il “che cosa” dire costituiscono già un problema,
anche solo per il fatto di non possedere nemmeno gli strumenti linguistici autonomi, di essere sempre oggetto di un “pensiero pregiudiziale” che ostacola la
libera espressione. L’esperienza femminile non è formulabile, non dispone di
metodi di analisi, né di teorie (almeno socialmente e culturalmente accettate).
Ecco il motivo della assenza delle donne, oggi intenzionale, dalle “scienze” già costruite dagli esperti e la decisione maturata sul piano intellettuale da
parte di molti gruppi femministi di iniziare a partire da sé (basti pensare in
Italia all’esperienza del gruppo di filosofe di “Diotima” a Verona).
Anche la stessa psicologia ha sempre dimostrato di non riuscire a pensare alla donna partendo dalla donna ma di farlo sempre in relazione alla identità maschile (basti pensare alla teoria freudiana della gelosia femminile per il
pene e quindi della figura della donna concepita come mancanza).
In conclusione dunque, gli autori di questo libro, hanno voluto dimostrare
come, l’esclusione e l’emarginazione femminile è da ricercare nel profondo delle
strutture psichiche e sociali e quindi nello spazio mentale ed in quello fisico.
La soluzione proposta è di espandere lo spazio della vita pubblica e quindi della democrazia e della partecipazione sociale anche alle donne aprendo
le porte ad una società che gli autori definiscono, “la società post maschilista”.
99
100
dell’Italia meridionale, che rimane sempre tale e faticosa per i suoi abitanti, tuttavia di senso nuovo la Storia, in questa asprezza che non è aridità, si illumina nella ricostruzione della vita di una famiglia di grandi proprietari terrieri del
sud, l’origine della cui fortuna risaliva agli anni lontani della soppressione della
feudalità e il seguente acquisto dei più importanti feudi della regione.
La terra e la proprietà sono le vere protagoniste di questo insolito volume,
dove il rapporto con esse non è mai statico e notarile, fatto di accaparramento e possesso, ma descritto e vissuto con sobrietà essenziale e persino ironica, come in uno dei commenti finali dell’autrice che, ricordando il suo rapporto, da giovane, con la proprietà, conclude con lo stile asciutto di un’abile scrittrice, che sa quello che dice. “Per me la proprietà non era un furto, ma una
sventura. Ogni anno le ulive avevano il verme, il prezzo del grano scendeva,
e quando era la stagione della vendemmia o pioveva troppo o non abbastanza. Il risultato era sempre lo stesso: in ogni caso o la quantità o la qualità del
vino ne risentiva. Solo chi ha vissuto, come me, le carenze dell’agricoltura biologica, può comprendere i benefici di quella chimica”(p. 137).
Ginevra Conti Odorisio è professore ordinario di Storia delle dottrine politiche a
Roma, ma in questo testo, volutamente, non utilizza nessuna parola tratta dal tradizionale lessico della politica o della sociologia politica: la famiglia non è definita
borghese, aristocratica, agraria. Né Emanuele dei Conti di San Marco Argentano,
suo padre e personaggio principale del volume, intorno al quale si snodano vicende che lo vedono sempre protagonista per scelta, vicende grandi come la grande
guerra, la guerra d’Africa e una Napoli sotto le bombe degli alleati, viene mai definito con una connotazione politica o culturale precisa. Lui che, elegante latinista,
traduceva brani dei Promessi sposi in latino, nutrito dei libri della biblioteca di famiglia, dove figuravano classici del sei-settecento, allevato nel gusto e nel senso della
storia in un ambiente familiare dove il prozio, don Camillo, gli ricordava con la stessa naturalezza con cui avrebbe commentato la morte di un conoscente: “Lulù, ricordati, oggi è morto Teodoro Mommsen”, è visto come un personaggio quasi ordinario, proprio perché capace, come tutti, di abitare la contraddizione. Dotato sì di grande forza di carattere, ma “né ricco, né povero”, decorato con una medaglia al valor
militare nel 1918, e multato dopo qualche mese per indisciplina. Con una medaglia
e una multa si conclude infatti la prima guerra del giovane meridionale che “divorava” Papini e che aveva fondato, studente di ingegneria a Torino, il Gruppo Giovanile
Nazionalista nel ’13 . Non si tratta solo di dati culturali sociali o caratteriali. Da un
lato, filosoficamente, capiamo che, come diceva Renouvier, la coesistenza dei contrari nello stesso soggetto è un assioma che si impone a un pensiero veramente
profondo. Dall’altro, storicamente, capiamo anche che l’idea di patria e nazione evitavano alla cultura meridionale il provincialismo e il campanilismo del sud e significavano integrazione in un nuovo ambiente, e anzi, apertura culturale all’Europa.
Un’apertura, già di fatto, vissuta dalla nonna Ginevra, che volle con fermezza e costanza la laurea del figlio in ingegneria a Torino, una donna del sud
che suonava al pianoforte Mozart, Mendelssohn e Schumann, e aveva studiato il francese, in un’apertura culturale che era di casa, visto che lo zio, il
Cavaliere, era stato amico personale di Alessandro Dumas, al quale egli aveva
persino fatto ottenere la cittadinanza di San Marco.
RECENSIONI
Tra radicamento e apertura all’Europa, apprendiamo che il giovane Conti
collabora a un periodico diretto da Curzio Malaparte, ma, finito il periodo movimentista del fascismo, disgustato profondamente dal provincialismo dei luoghi
e dalla “meschinità della vita politica”, va a Parigi dove passa intere giornate
alla Bibliothèque St. Geneviève, segue corsi di economia, i discorsi di Léon
Blum, conosce Daniel Halévy, è amico di Curzio Malaparte, sposa Renée.
Tra cose belle e altre di pessimo gusto, in tutta la loro contraddizione, si
offrono alla vista della giovane moglie francese, la Calabria e la grande vecchia
casa sconnessa e impolverata con galleria, biblioteca, salone, camera da letto,
solottino blu e stanza rossa, i grandi quadri degli antenati appesi alle pareti
della sala e i trattati di giurisprudenza, medicina, teologia nei mobili con le vetrine. La contraddizione continua nella dispensa che, di giorno, si riempie di
omaggi e regalie e, di sera, resta puntualmente vuota di ogni cosa. Gli oggetti
ricevuti in regalo venivano sistematicamente riregalati, offerti, dati, in un valzer
senza fine che faceva apparire e sparire vivande e provviste. Scopriamo così
la società meridionale con la sua elaborata e complessa economia del dono.
Nel doppio senso di struttura e capacità di risparmio; persino sul dono.
Tra integrità e imparzialità, “virtù oltremodo scomode” (p. 48), aggiunge con
la consueta ironia l’autrice, il capitano Conti parte per la guerra d’Africa dove
tiene, in francese, un diario da inviare alla moglie in sostituzione delle lettere.
Così veniva evitata la censura, ma soprattutto veniva evitato che il pensiero
fosse modificato, perché esposto a letture inquisitorie.
È un diario che rappresenta un documento storico di straordinario interesse sulla guerra africana vissuta da un soldato italiano impegnato nella guerra
coloniale.
Anche qui il rapporto con la terra conquistata è fondamentale. Si trasforma
in scoperta di un territorio che diventa quasi un “prolungamento di sé”. È lo
stesso modo di vivere la conquista coloniale come veniva vissuto il rapporto
con la proprietà privata, rapporto che si dispone sullo stesso ordine di quei
concetti espressi qualche anno dopo da Simone Weil a Londra, quando la giovane francese definiva la proprietà privata “un bisogno vitale dell’anima”.
L’anima, scriveva la Weil, è isolata, perduta se non è circondata da oggetti che
siano per essa “come un prolungamento delle membra del corpo”. Per Conti
padre, come per la Weil, la proprietà della terra era ben diversa dal capitale;
essa rappresentava solo la certezza che ciò che veniva usato per il lavoro, per
il piacere o per le necessità della vita non era estraneo, ossia non apparteneva ad altri. E assolutamente non estranea doveva apparire a questo energico
uomo del sud la terra sulla quale il piede affondava ogni giorno la sua orma.
Inserita nella grande Storia, non solo per la ricostruzione fatta nel volume,
ma perché ogni nostra storia lo è, quella di Emanuele Conti lo era un po’ di più.
Dal Sud era passato al Nord, dagli studi di ingegneria era passato alla politica, agli studi di storia e di economia alla guerra, alla Francia, all’Africa, alla
seconda guerra. Ma, “sempre volontario, sempre di complemento. La sua gli
sembrava un’intera vita di complemento”, commenta la figlia, e continua: “era
stato incapace di quella ‘lunga pazienza’ di cui parlava Buffon, necessaria per
tutte quelle cose che richiedono costanza e tenacia” (p.139).
101
Una ‘lunga pazienza’ che, invece, dimostra di possedere l’autrice, non solo
per questa ricostruzione tra storia e memoria, dove finalmente la storia vive perché la memoria le dà corpo e membra, ma soprattutto perché anche in questo
lavoro, lei sa di non essere ‘volontaria’ o ‘di complemento’, avendo assunto su di
sé la necessità della vita, e, soprattutto, quella intelligente ironia che le ha permesso un fare storia, oltre ogni disciplina, compresa quella paterna che, per anni,
le aveva vietato di parlare per non dire sciocchezze. Ora sa che “il mondo era più
tollerante di quanto potessi immaginare e che, anzi, anche di fronte a palesi
sciocchezze non accadeva nulla” (p.141). Come suo padre, che aveva abitato la
proprietà con atteggiamento completamente diverso dall’avidità esclusivista borghese, abita il sapere disciplinato con la stessa differenza che è frutto della consapevolezza di chi è in grado di percepire, anche con coscienza ironica, la pluralità e anche la contraddizione con cui la vita e la storia sempre si esprimono.
Marisa Forcina
F. TOCCAFONDI, L’essere e i suoi significati, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 264.
102
Un’espressione enunciativa di questo tipo, L’essere e i suoi significati, presa
alla lettera, risulterebbe magari solenne e maliosa, ma, in definitiva, sarebbe
oscura e persino ossimorica se vi fossero pre-giudizi neopositivistici a guidare i
nostri intenti critici. Sono note, infatti, le tonitruanti pagine di Carnap del 1932 (Il
superamento della metafisica attraverso l’analisi logica del linguaggio), nelle
quali l’intera tradizione (pseudo)semantica della metafisica (occidentale) è sottoposta a radicale e stringente critica al lume del principio-assioma di verificazione. “Le cosiddette proposizioni della metafisica –scrive Carnap– sono prive di
senso”; non, dunque, contraddittorie, ma semplicemente insensate in quanto
mero semeion. La riduzione al protocollo conferisce –secondo tale prospettiva–
significato al morfema ed al successivo costrutto proposizionale. L’isomorfismo
tra la struttura logica del linguaggio e l’evento suscettibile di significazione compie la definitiva deliberazione di ostracismo della metafisica dall’area di un linguaggio sostenuto da una sintassi logica rigorosa, così l’oggetto di questa millenaria disciplina, l’essere, si dimostra “una circostanza inopportuna”, un termine incapace di generare alcun gesto semantico e di veicolare alcun significato,
fatta salva la voce verbale “essere”, intesa al modo di semplice predicato d’esistenza rispetto ad un soggetto in generale. Ne consegue che associare il termine essere a quello di significato, al di fuori del solco dei tradizionali vagolamenti metafisici, equivarrebbe esattamente all’accostamento di costruzioni semantiche non in grado di interagire, visto che dell’essere, a rigore, non sarebbe predicabile alcunché se non il suo non esserci linguistico. Empirismo e trascendentalismo, in tale prospettiva, volgono a coalescersi muovendo dall’identità
definita ed immiscibile della rispettiva fisionomia gnoseologica. Ed anche dinanzi alle circesche seduzioni volte a solcare il cielo dell’intelligibile puro, superando i kantiani confini del fenomeno, la nozione di essere non sarebbe identificabile con nulla in grado di elaborare la reciprocità di Sinn e Bedeutung.
RECENSIONI
Con la scure iconoclasta della critica antimetafisica dell’esperienza teoretica circolista giunge comunque a confrontarsi l’intera valutazione successiva
della tematica dell’essere, all’altezza di quella suddivisione epocale per cui la
correlatività costitutiva di logica ed ontologia, sancita da Aristotele e variamente viva nella cultura occidentale fino all’idealismo classico tedesco e giù
sino a Husserl, volge a decretarsi con sanzione di inesorabilità.
La presa di posizione logico-linguistica dei circolisti non interferisce, tuttavia, con le significazioni storicamente determinate assunte dal termine “essere” attraverso gli autori che lo hanno meditato, e così, offertasi la possibilità di
parlarne, ci si imbatte in una serie di de-finizioni del concetto stesso di essere, in una “plurivocità dei significati del termine” (p. 23), come scrive l’autrice
del libro che si sta analizzando. La costitutiva polisemia del concetto ne configura anche la complessità in quanto funzione morfo-sintattica, collocata sul
crinale linguistico del proprio ruolo di sostantivo e di quello di voce verbale,
divisa tra il costituirsi come una funzione connotativa e l’intendersi al modo di
una decretazione d’esistenza. In quest’ultima prospettiva l’esistenza sub specie aeternitatis, elevata su un solenne piano assiologico, fonda la tradizione
metafisica dell’infinità del principio primo.
La trattazione storico-critica di Fiorenza Toccafondi, però, non trae le mosse
dai sistemi classici dell’essere (Parmenide, Eraclito, Platone, Aristotele), ma
avvia la propria ricerca dalla proposta kantiana di una critica della ragione in
virtù del riconoscimento delle sue forme a priori. Dopo aver circoscritto, nei
densi passaggi dedicati alla deduzione trascendentale delle categorie, sino al
limite dello schematismo e del sistema dei principi (Grundsätze), l’area prettamente fenomenica d’applicazione della sintesi trascendentale di materia e
forma, Kant pone il quesito dell’esistenza del “Prototypon transcendentale”
all’egida delle idee della Ragione. L’essere, preso in sé, è, in fondo, idea esso
stesso in senso dialettico. La differenza tra le due modalità d’intendere il termine essere era chiara al logico Kant, studioso e commentatore attento
dell’Auszug del Meier, e, in relazione a ciò, del tutto collocabile nel solco della
tradizione formale leibniziano-wolffiana. Esulando pure, in questo contesto,
dalla trattazione del contributo euristico offerto alla storia dello sviluppo della
disciplina logica dall’inesausta ricerca critica kantiana (si pensi soprattutto ai §§
9-11 della Critica della ragion pura), e prescindendo dall’indicazione dei termini del problematicissimo rapporto tra il portato classico della tradizione formale
con il progetto d’instauratio magna di una nuova logica trascendentale, è possibile riconoscere alla posizione di Kant il merito del riconoscimento della detta
distinzione tra carattere predicativo ed esistenziale dell’essere, quantunque
essa risalga già al Parmenide di Platone e corra lungo l’intero arco temporale
degli evi medio e moderno. Ma è nel complesso intreccio della deduzione trascendentale dei concetti puri che si fonda la plausibilità stessa dell’esperienza
sulle forme a priori del soggetto trascendentale, governate, nella loro protensione sintetica, dalla determinazione trascendentale cacuminale dell’Io penso;
ed è a partire da questi assunti che diventa perspicua l’identificazione del concetto classico della consuetudine ontologica occidentale, vale a dire l’essere,
con quell’“ideale trascendentale della Ragione” che si volge a pensare (ma non
103
104
a conoscere) l’“omnitudo realitatis”. Sono altresì assai note le pagine kantiane
dedicate alla confutazione delle prove d’esistenza dell’Essere supremo addotte dalla teologia razionale, nelle quali si dimostra la capziosità, tipica del razionalismo metafisico moderno, del salto metabatico dall’asseverazione di un predicato logico d’esistenza, in quanto determinazione linguistica del concetto del
soggetto, alla statuizione di un predicato realmente determinabile (prova ontologica). L’idea della Ragione diventa insuscettibile di sintesi, incapace di connettere materia e forma in una risultanza trascendentale retta dal concetto ed
espressa nel giudizio (secondo la configurazione delle classi): l’essere si configura, così, come un mero pensiero o, al limite, come un elato ideale regolativo.
La trattazione di Toccafondi muove, dunque, dalla trattazione dell’elaborazione kantiana della Seinsfrage per seguire, di seguito, gli sviluppi del trascendentalismo idealistico. Nell’alveo del trascendentale, anzi, con più netta impronta, a guisa di “compimento metafisico della Critica” (p. 41), vengono collocate
dall’autrice le opere di Fichte e Schelling; la prima a partire dal Versuch (1792)
e dalla prima Wissenschaftlehre (1794) a predicazione della funzionalità autotetica dell’Io, la seconda intesa alla determinazione –tra Spinoza, Leibniz e
Kant– di una concezione del fondamento come principio relazionale sorretto
dalla stretta identità di Sé con sé in quanto unità adiafora di Natura e Spirito.
Il cosiddetto dualismo kantiano tra essere fenomenico ed essere noumenico passa, poi, attraverso l’olismo speculativo hegeliano che, coordinando logica e metafisica, conduce l’essere nella pienezza del Sapere assoluto (cap. III).
Il volume presenta, di seguito e piuttosto cursoriamente, varie esperienze
dell’essere tipiche di talune stagioni filosofiche postidealistiche, tratteggiandone i caratteri in relazione alle opere di Herbart e di Rosmini, di Lotze come di
Feuerbach, di Trendelenburg sino al nichilismo di Nietzsche (cap. IV).
L’avvento del mentalismo, tipico della temperie retta dalla nascita della psicologia descrittiva moderna, conduce a cogliere il problema della rappresentazione in funzione dello statuto d’esistenza degli enti mentali, al confine di delimitazione tra logica, linguaggio e descrizione algoritmica della fenomenologia
delle funzioni mentali superiori (cap. V).
Con lo spiritualismo, d’intesa con la reviviscenza dell’idealismo e della
riflessione assieme teologica e neoscolastica, si risolleva il fascino dell’essere, alquanto obnubilato dall’operazionismo positivistico, e si tramuta nel punto
ultimativo di convergenza dell’acciottolato sentiero che reca alla fondazione
dell’identità spirituale del singolo (cap. VI).
L’ultimo capitolo del libro è dedicato al troncone semantico della riflessione
filosofica del Novecento, a partire da quella parabola circolista che, muovendo
dall’intensa meditazione di un certo numero di autori emblematici –tra i quali
Wittgenstein e Mach– identifica essere e significato, o, meglio, fa del significato
l’unica chiave di lettura dell’essere (cap. VII). La formalizzazione della logica, l’elaborazione di un paradigma logico strettamente legato alle procedure analiticoalgoritmiche della matematica orientano l’asse dell’indagine critica verso un’analitica rigorosa del linguaggio ordinario e del linguaggio strutturato, dal momento
che, comunque, non c’è pensiero al di fuori di una struttura sintattica che è linguaggio volto ad esprimerne i termini. La “svolta linguistica” (Dummett) sancita
RECENSIONI
dall’impostazione dell’opera di Frege, per certi versi realizzazione e suggello del
“sogno” leibniziano di un Calculus ratiocinator, la segmentazione tipologica dei
predicati proposta da Russell e condotta fra le macerie del primo logicismo, il pensiero di Wittgenstein come “terapia” per guarire dai problemi della filosofia intesi
come prodotti secondari di un malinteso linguaggio, il verificazionismo circolista e
la stratificazione di Quine orientata ad offrire ariosità e duttilità alla rigida impostazione tipologica russelliana ritagliano i confini di una consuetudine di indagine
linguistica, molto spesso screziata da angustianti riduzionismi, ma, specie ad
opera dell’ultima generazione di teorici di area anglosassone, soggetta a svolte
sistematizzanti di apertura (Dummett) tese ad affrontare con nuovi strumenti logico-linguistici persino talune tematiche classiche della tradizione ontologica. “La
filosofia ha attraversato […] una fase distruttiva”, ha scritto Dummett, mentre ora,
con lentezza, elabora teorie del significato capaci di poter prevedere un alto
grado di traducibilità teoretica: si pensi, oltre a Dummett, ai vari Hilary Putnam,
Kripke, Davidson, Quine. Del resto, superata l’asfittica ed esclusiva dicotomia tra
linguaggi ordinari e linguaggi di struttura, la stessa logica modale come semantica dei mondi possibili (Kripke), oltre ad impostare una teoria estensionalista del
significato, supera lo scoglio vincolante delle descrizioni definite assise sulla teoria fregeana del Sinn ed introduce un concetto del tutto metafisico di essenza
come hypokeimenon in quanto qualitas ineribile all’oggetto e stigma del suo riconoscimento nel senso di principium individuationis del suo statuto ontico in ciascuno dei mondi dell’esperienza in cui può apparire, senza che la verità di quest’inerenza abbia comunque a manifestarsi tautoteticamente, al modo di un giudizio analitico, data la reciproca condizionalità di significato e contesto.
Le variegazioni di tale orizzonte bene esprimono la vitalità del troncone analitico e configurano tracciati d’indagine volti a dar definizione ed offrire luce alla
base logica della metafisica (Dummett), dimostrando la strutturale linguisticità
(semanticità) della tanto aborrita riflessione ontologica dagli strali rivolti alla quale
si era partiti. Il tema dell’essere, dunque, è oggi quanto mai dibattuto, si carica di
nuova vitalità speculativa ed il significato storico complessivo di una simile presenza nella cultura filosofica occidentale questo testo si orienta a descrivere.
Il libro di Toccafondi offre, in verità, solo un primissimo quadro d’insieme dell’aporetica in questione al punto da manifestare, per certi versi ed in relazione a
taluni punti di snodo della tematica dell’essere, un carattere troppo cursorio ed
un approccio alimentato da un senso forse eccessivo della sinossi. E ciò non
perché non sia plausibile l’intento di offrire un quadro d’insieme di un problema
classico della filosofia in un numero ragionevolmente contenuto di pagine (quantunque sia sempre valida la massima dell’abate Terrasson, tanto amata da Kant,
secondo la quale “molti libri sarebbero molto più brevi se non fossero così
brevi”), ma per l’ampiezza dell’arco temporale assunto– da Kant alla filosofia
analitica contemporanea –che rischia di accorpare con troppa disinvoltura forme
storiche di “esperienze dell’essere” (Heidegger) distinte e perciò dotate di una
spiccata autonomia semantica, sebbene rette da linee di analogia magari persino ingenti. Una volta stabilito che la veste semasiologica di un concetto come
quello di essere risulta ampia e variegata, ne discende che il carattere storicamente determinato di ciascuna delle sue accezioni si concentra nell’opera delle
105
106
grandi figure che ne hanno teorizzato le fattezze concettuali. In tal modo risulta
di certo giustificato il criterio d’indagine di tipo, assieme, diacronico ed aporetico
adottato da Toccafondi, ma la trascuratezza di certi sfondi, esito inevitabile di
una trattazione cursoria e di superficie da un punto di vista storico-critico, non
consente, spesso, di rendere misura della complessità degli intrecci speculativi
che trovano un punto di insessione alle spalle delle varie concezioni dell’essere.
Tende, così, ad imporsi il tema della chiarezza, declinato sul registro dell’asse
sintagmatico delle varie tecniche di ricerca (Abbagnano), storicamente determinate, volte a pensare l’essere: il dettato del testo risulta fluido ma non chiaro in
quanto privo delle giuste distinzioni e, perciò, insuscettibile, nelle espressioni
delle sue ricostruzioni, della compositezza non univocamente esprimibile di
certe concezioni del problema. Si ricordi, al proposito, quel che ribadiva Kant
nell’Antropologia: “La coscienza delle proprie rappresentazioni, quando basta
per differenziare un oggetto da altri, si chiama chiarezza”. C’è chi ha scritto, inoltre, che la chiarezza è la cortesia del filosofo (Ortega y Gasset); se è chiaro ciò
i cui confini sono illuminati da una luce che squarcia le brume delle nubi consentendo, kantianamente, di “trovare con il pensiero l’oriente”, non c’è il rischio,
nella miriade di riduzionismi e di mediazioni linguistiche protese ad appianare le
angolosità e le polivalenze di ciò che per sua natura è complesso, di investirsi
della stucchevolezza di un’eccessiva cortesia, altrettanto insopportabile quanto
la boria e la solennità dello spirito vaticinante? Caso emblematico, a conferma
di quanto si va sostenendo, è quello kantiano che, di certo, rappresenta per molti
versi un punto di flesso nella storia del pensiero occidentale e che autorevolmente sintetizza in sé i due tronconi semantici che la tradizione aveva elaborato intorno al tema dell’essere (predicato-esistenza), ma che sfugge al rigore di
un’interpretazione esaustiva del legame con la tradizione logico-metafisica classica rispetto alla proposta fenomenistica della filosofia trascendentale. Tanto più,
inoltre, se è alle pagine della Dialettica trascendentale che Kant affida le sue più
dirette riflessioni sull’essere, costruendo le proprie controargomentazioni in
strettissimo legame con un retaggio teorico agglutinatosi intorno al nucleo della
tematica dell’essere nel corso di millenni.
Il testo di Toccafondi, in verità, evita enfasi di epocalità dinanzi alla giustificazione dell’avvio dell’intera trattazione con l’opera di Kant; ma è proprio la
leggerezza del tessuto argomentativo in sede di teoria della storiografia, che
dà adito ad interpretazioni intorno alle motivazioni intrinseche dell’identità dell’avvio dell’indagine, a lasciare assai perplessi. L’opera kantiana, inoltre, offre,
a chi intenda studiare il tema dell’essere e dei suoi significati, una serie di rinvii interni coglibili sul versante analitico in sede di categorie della “modalità” e,
nelle elate sfere della “dottrina trascendentale del Giudizio”, nel contesto fenomenologico di conduzione degli eventi del mondo naturale ai loro
Anfangsgründe. Per non parlare, poi, dell’ontologia teleologica dei giudizi
riflettenti della terza Critica o, ancor prima, del mondo noumenico dell’essere
che trova una via pratica di manifestazione. Troppo composito il quadro –in ciò
quasi scoraggiante– per riduzioni così, in fondo, liquidatorie.
Altro punto da rilevare intorno all’impostazione del testo di Toccafondi è la
proclività alle solite stereotipie interpretative invalse in anni in cui il dominio di
RECENSIONI
certi schemi storiografici era cogente ed una massa imponente di inediti, pazientemente raccolti dalla Commissione dell’Ausgabe, ignota. Proprio il composito
rapporto di Kant con la tradizione metafisica rappresenta un ineludibile momento di confronto interpretativo allorché ci si avvia alla discussione della pretesa
idealistica di allogarsi nel solco del trascendentale. Se, infatti, è non solo sulla
Critica della ragion pura che va posta attenzione per chiarire i significati della
metafisica (e della relativa concezione dell’essere), ma anche sui Fortschritte,
sull’analitica dello Übergang dell’opera postuma e sulle varie Vorlesungen ai
suoi problemi dedicate (il XVIII volume dei Kant’s gesammelte Schriften è interamente dedicato alle lezioni sulla prospettiva ontologica), sottoporre ad indagine le sole posizioni della prima Critica sull’“ideale trascendentale” non rende, se
non in parte, l’arduità del problema. E, ancora, lascia impregiudicato l’impervio
tema del rapporto del criticismo rispetto alla filosofia dell’Io assoluto. La linea di
continuità, pur presentata attraverso la presunta neutralità della mera sequenza
storica, che lega le due posizioni speculative è assai discutibile; lo aveva sommamente colto Hegel, quantunque su un versante stratigraficamente assiologico-speculativo, nell’elencazione delle “posizioni del pensiero rispetto all’oggettività”. Continuità e frattura, dunque, dell’idealismo rispetto al criticismo, nel solco
di una problematicità storiografica ed ermeneutica avviluppata nella difficoltà di
dover intendere le motivazioni che porteranno il primo Fichte a significarsi come
il culmine della rivoluzione trascendentale (motivazioni incoglibili in assenza dei
significati kantiani dell’essere delle altre due Critiche), e Kant a replicare asseverando l’autonomia della propria prospettiva nella Dichiarazione sulla Dottrina
della Scienza del 1799, tra le mille complessità di un pensiero, quello kantiano,
per vocazione realista in gnoseologia e pur votato all’incipiente temperie di tensioni fondazionali tipica dell’età dei grandi sistemi speculativi. Proprio perché
non è solo quella descritta la concezione kantiana dell’essere rimane un ostinato cono d’ombra nei capitoli dedicati a Fichte, Schelling, Hegel (II e III). Si parlava di stereotipie, inoltre, data l’enorme complessità del problema e delle interpretazioni intorno alle modalità di successione delle due dette posizioni di pensiero. E nella descrizione della concezione idealistica dell’essere non poco rilievo avrebbe il giudizio del proprio rapporto con il criticismo, a meno del voler
intendere i singoli autori in questione come titolari di un capitolo in una storia di
un problema, come se il pensiero si esprimesse in nome di cortesi inviti redazionali elaborati in funzione di esigenze editoriali. Il giudizio cui si allude si stanzia in quanto inteso senza alcun intento teoretico-fondativo, ma nell’ordine di
una chiarificazione svolta sul piano storiografico. Ritorna, pertanto, il Leitmotiv
dell’eccesso di sinteticità come alimento principale del presente testo di
Toccafondi. Se ciò è vero, per discutere di questo libro occorre esprimersi intorno a questioni di teoria della storiografia, anche in tal circostanza esprimendo
qualche rilievo e qualche perplessità. Il volume si articola in capitoli, come detto;
ma, descritte le posizioni dei protagonisti principali della filosofia idealistica, lo
studio compone i suoi momenti accostando autori e correnti secondo criteri tutti,
in fondo, da giustificarsi. Come è noto, uno dei massimi storici italiani del
Novecento, Nicola Abbagnano, aveva elaborato, in Possibilità e libertà, la nozione di orizzonte categoriale come “condizione della comprensibilità” di ogni pro-
107
108
cedimento razionale, al fine di segnalare storico-criticamente le analogie tra le
differenze per profondarsi negli intimi afflati di un’epoca cui personalità pur diverse risultano –sul piano filosofico e poi storico– partecipare; sotto tale profilo, per
esempio, secondo Abbagnano, Otto e Novecento potevano fronteggiarsi al lume
del sostegno dei concetti di necessità e di possibilità. Orientamenti metodologici di tal tipo possono rappresentare ipotesi di accomunamento di istanze diverse, ma il criterio di coerizione adottato da Toccafondi (segnatamente per i capp.
IV e VII) sarebbe potuto divenire oggetto di giudizio se almeno fosse stato
lumeggiato in qualche modo. Non sempre l’illusoria asetticità dell’elencazione
storica riesce a lasciare senza pensieri: storiografia è sempre e comunque adozione di una visuale interpretativa che privilegia di certo il dato, ma che connette sempre il testo con la testa, l’illustrazione testuale con una prospettiva interpretativa. Così è il linguaggio a condizionare, in diverse misure, la pretesa dello
storico di descrivere il fatto wie ist gewesen, come avrebbe detto von Ranke. In
questo senso, in ambito di teoria della storiografia, andava definito il significato
del concetto di analogia che ha guidato gli accostamenti critici, perché è in esso
che va a rintracciarsi lo spessore ed il tenore ermeneutico della trattazione.
Il volume di Toccafondi si colloca nella collana La filosofia contemporanea
dell’editore Il Mulino ed è preceduto da un attento saggio introduttivo di S. Poggi.
Quest’ultimo, dopo aver analizzato le ragioni della tradizione storiografica italiana, si orienta a sottolineare la necessità della ricognizione storica per cogliere “le
questioni […] che oggi […] si presentano come le più rilevanti e caratterizzanti”
(p. 10). In tale ottica si collocherebbe il testo di Toccafondi, per “fornire al lettore
i materiali con cui possa rendersi conto delle questioni al centro della filosofia dei
nostri giorni attraverso la ricostruzione di quello che, di queste ultime, non è
molto di più che il passato prossimo” (p. 21). Il presente e gli altri volumi della
collana intesi, dunque, come “voci” di una specie di “grande dizionario storico di
filosofia”; voci strutturate nelle varie de-finizioni ed aventi valore puramente informativo se, come s’è visto, risultano essere materiate da un insanabile –e forse
obbligato– riduzionismo. Fermarsi allo stadio informazionale non significa fare
ricerca storica, ma solo diluire la complessità storica e critica delle aporetiche
per offrire lo status questionis o per redigere i mai troppo esecrati quadri generali dei problemi. In più con un’ambizione dichiarata da parte di Poggi che almeno questo libro della collana non realizza. I volumi della serie, s’era detto, sono
intesi a ricostruire la storia di un concetto, nella fattispecie dell’essere, senza
addurre soluzioni, limitandosi “a chiarire le ragioni per cui i problemi si sono posti
e illustrare i modi in cui essi sono stati formulati” (ibid.). Chiarire le ragioni significa illimpidire i percorsi storici ed interpretarne le stazioni semantiche di senso.
D’altra parte rappresentano un’opzione ermeneutica –più o meno voluta e/o
nascosta– lo stesso avvio dell’indagine con l’opera di Kant o gli allogamenti
entro l’orizzonte categoriale adottato (si pensi alla questione storiografica dei criteri relativi agli accostamenti di autori nei vari capitoli del volume). Se le dette
“ragioni”, poi, discendono da una piena perlustrazione del quadro storico, la riduzione dei significati va intesa –sia detto non senza una punta d’impertinenza–
come una “necessità editoriale” o come un orientamento ermeneutico essa stessa? In quel termine (ragioni) c’è tutto il tormento dello storico che dà voce al
RECENSIONI
documento, che si libera da pretese fondative eppure interpreta. Di questo testo
si può predicare, al limite, una certa utilità pratica intesa come duttilità di consultazione immediata, ma sempre come prima vindemiatio e come resa dei cartigli preparatori per una rigorosa lettura e meditazione dei testi. Il libro, inoltre,
riorienta l’attenzione critica sull’eterno problema dello statuto epistemologico
dell’informazione filosofica rispetto all’indagine storica ed alla ricerca critica e
soprattutto richiama la questione dei moduli linguistici come modalità d’espressione dei massimi problemi della filosofia. Pertanto è sul terreno della teoria
della storiografia che si gioca il giudizio sul tipo di contributo profuso da
Toccafondi. Per essere crociani sino in fondo, inoltre, è utile sottolineare che è
la richiesta problematica di un tempo a guidare verso la perlustrazione storica di
certi temi; configura questione interrogarsi sul significato che può assumere
oggi, nell’era della chiusura entro un orizzonte globale, la domanda sul senso
dell’essere nel tentativo di comprendere il contenuto di senso che si nasconde
dietro la postulazione della domanda metafisica stessa. Temi, questi, che lo studio di Toccafondi non indaga ma cui pur rinvia, senza tuttavia sottrarci al sospetto –e al timore– che un’eccessiva mentalità manualistica, in nome del criterio
della contestualizzazione storica, trasformi la storia di un concetto in quella “galleria di opinioni” fratte e contraddittorie tra loro che faceva inorridire Hegel.
Sandro Ciurlia
P. RUMINELLI, Tra finito e infinito, Genova, ed. Compagnia Dei Librai, 1998, pp. 83.
Il concetto di finito e infinito (uso il singolare, perché le due nozioni sono
correlative: l’una si regge sull’altra) è uno dei concetti classici della filosofia,
uno dei concetti “universali”, nel senso che abbracciano la universalità, la totalità dell’essere (e la filosofia è appunto la disciplina della totalità: è questo lo
“spazio” della filosofia).
E fra i concetti della totalità quello di “finito-infinito” è il più immediato, per il
fatto che ha una sua espressione elementare nel mondo della spazialità e quindi della sensibilità. Ma esso non è l’unico, evidentemente; e a ben vedere, non
è neppure il primo e fondamentale. Quest’ultimo è invece costituito dal concetto di essere: concetto che tutti usiamo, ma sul quale raramente ci soffermiamo
(ad eccezione dei filosofi, e più precisamente dei filosofi dell’essere).
Veramente la filosofia è stata ed è, in gran parte, un discorso sul concetto
–o idea– di essere; concetto, o idea, che è passibile di un progressivo approfondimento illimitato. Di questo approfondimento mi limito qui a indicare quello fondamentale: cioè la universalità. Il concetto di essere è universale in tutta
l’estensione del concetto di universalità: abbraccia la totalità degli esseri, la
totalità degli enti, si predica di tutti gli enti e del “tutto” di ogni ente, è il concetto “trascendentale” (nel senso classico della parola).
La professoressa Ruminelli ha costruito il suo discorso filosofıco sul concetto di “finito e infinito”; altri lo hanno costruito e lo costruiscono sul concetto di
essere (che, d’altra parte, è implicito nello stesso concetto di “finito e infinito”,
109
110
come è implicito in ogni altro concetto: esso è veramente la luce di tutto il sapere intellettivo: è esso che costituisce il salto di qualità tra la conoscenza sensitiva, che abbiamo in comune con i semplici animali, e la conoscenza intellettiva).
Un altro concetto “universale” –nel senso cui ho accennato– è quello di
contingente e necessario, dove il “contingente” corrisponde “materialmente” al
“finito”, e il “necessario” corrisponde all’“infinito”, ma da una prospettiva diversa: quella appunto della “necessità” dell’essere, (nel senso che noi arriviamo
a concepire il “necessario” sulla base della constatazione del “contingente”).
Altro concetto analogo è quello di causato e incausato.
Il discorso della Ruminelli si inserisce dunque nel cuore del problema filosofico, il problema della totalità, il problema, in altra versione, del senso, cioè
del significato del tutto, dell’essere.
Ora, il discorso sulla totalità può essere fatto –come è stato fatto nella filosofia classica– attraverso l’analisi del concetto di essere, costruendo, in tal
modo, la disciplina filosofica per antonomasia nella sua versione classica, che
viene detta ontologia, cioè appunto il discorso sull’essere. Ma nella filosofia
contemporanea esso è soprattutto un discorso antropologico, cioè un discorso che ha come centro e oggetto l’uomo, più che l’essere nella sua universalità, in quanto l’uomo è quello che costituisce –o si ritiene costituisca– il senso
ultimo del mondo dell’esperienza e della realtà, dell’essere, così che illuminare il significato dell’uomo in quanto tale è illuminare il significato della totalità.
Filosofia come discorso antropologico che ha avuto già nell’antichità una sua
premessa nella riflessione di Socrate (v. il “conosci te stesso”), e un suo sicuro e decisivo avvio nella filosofia di Agostino, che è appunto, la filosofia della
interiorità, cioè dell’uomo in quello che egli ha di più specifico e essenziale (v.
lo “in te ipsum redi, in te habitat veritas”).
Orbene, il discorso della Ruminelli si inserisce in questa versione “antropologica” della riflessione filosofica. Che è tra il finito e l’infinito, secondo il titolo
del libro qui in esame, è proprio essenzialmente l’uomo. È l’uomo che è situato nel confine del finito e dell’infinito, e partecipa quindi dell’uno e dell’altro. E
qui mi inserisco, per un istante, in quel discorso richiamando l’idea dell’essere:
proprio in forza di questa l’uomo si apre alla totalità, all’infinito, nello stesso
tempo che si riconosce come finito (dico, tra parentesi, che l’uomo ha esperienza “materiale” della propria finitezza, al di qua della nozione esplicita di “infinito”; ma l’esperienza “formale” della propria finitezza c’è soltanto quando l’uomo giunge alla nozione di “infinito”, altrimenti non saprebbe neppure di essere
finito; i due concetti sono essenzialmente connessi e interdipendenti fra loro).
Vorrei rilevare un secondo aspetto generico, accanto a quello antropologico, che caratterizza il libro, cioè il discorso in certo senso prevalentemente
“fenomenologico”, anche se non solo. Si tratta cioè di un discorso “descrittivo”,
descrittivo dei problemi, delle discussioni relative alle tesi e delle soluzioni dei
medesimi, pur presentando un suo sicuro e solido orientamento. Anche per
questo motivo –io ritengo– la sua lettura, pur affrontando temi assai complessi e diffıcili, risulta accessibile e comprensibile ad ogni lettore di discreta cultura. Devo precisare che il discorso filosofico di per sé non è comunemente e
tradizionalmente “fenomenologico”, poiché nella sua versione classica ha una
RECENSIONI
natura “dimostrativa”, che presenta le sue espressioni più esplicite, ad esempio, nelle Summae dei filosofi medioevali –come la Summa theologica di San
Tommaso, dove il discorso è tutto costituito di precisi e rigorosi sillogismi. Altro
esempio classico di questo tipo di discorso è il capolavoro di Spinoza, la
Ethica ordine geometrico demonstrata.
Il semplice “narrare”, “descrivere”, non sarebbe, da solo, un dimostrare; ma
se la descrizione è fatta con un certo criterio, con un procedimento ordinato,
con la messa in evidenza delle motivazioni che hanno portato a certe tesi
–come avviene nel libro della Ruminelli–, il discorso finisce per assumere
anche un carattere dimostrativo e, se non sempre dimostrativo, certamente
persuasivo, oltre che stimolante per un approfondimento dei problemi.
Un’altra dimensione del discorso della Ruminelli è il suo librarsi tra il teoretico
e il morale, conformemente alla natura stessa del problema e della tesi di fondo
trattata: cioè l’esistenza umana “tra finito e infinito”. In effetti, l’esistenza umana,
la riflessione sull’esistenza umana, conosce la stretta dimensione teoretica dei
problemi (cioè quella propria dell’“intelletto”), ma conosce anche, e forse più
ancora, la dimensione “morale”, cioè quella che interessa la volontà, la libertà.
Ora i problemi toccati dall’autrice sono anche i problemi teoretici, ma sono spesso, e forse più ancora, i problemi morali. Ciò risulta, fra l’altro, dalla messa in
primo piano dell’idea del bene, a cui è affidata da Ruminelli la risposta, in fondo,
al problema dell’esistenza. E l’idea del bene è un’idea che è in rapporto anche
con l’intelletto, ma soprattutto è in rapporto con la volontà, con la libertà.
Proprio sulla base dell’idea del bene, posta così al centro della riflessione
di Ruminelli, è dato comprendere un altro aspetto del suo discorso: cioè una
certa forma di esigenzialismo. Questo ha una sua lunga tradizione nel campo
filosofico, incominciando da Platone, secondo il quale le cose belle, la bellezza sensibile e poi quella morale ecc., spingono l’animo a riconoscere l’esistenza della Bellezza assoluta. Ma l’esperienza forse più importante storicamente e anche teoreticamente è lo inquietum cor di Agostino: “inquietum est
cor nostrum donec requiescat in Te”: qui l’inquietudine del cuore crea l’“esigenza” del riconoscimento di Dio e del godimento di Dio. Altra espressione
classica dell’esigenzialismo è quella di Kant, secondo il quale la morale “esige”
di riconoscere l’esistenza di Dio quale garante dell’unione di virtù e felicità.
Esistono dunque varie forme di esigenzialismo –si potrebbe accennare
anche a quella di M. Blondel e di altri–. Qualche cosa del discorso esigenzialistico si può trovare nel volume della Ruminelli. A titolo esemplificativo cito
un’espressione di Benedetto Croce, che mi pare, in un certo senso, indicativa
dello spirito che anima l’intero libro: “Tutto ci assicura che, nella sua totale
estensione e nel suo finale risultato, la realtà è bene” (pag. 75).
Questa medesima citazione sull’esito positivo della realtà “nella sua totale
estensione” mi introduce ad un altro aspetto generale del discorso di Ruminelli
e cioè lo spirito di armonia. E ciò in un duplice senso, o duplice livello: anzitutto quello inferiore, di una certa confluenza, per alcuni aspetti, di tesi provenienti talvolta da concezioni piuttosto disparate, e ciò secondo un criterio non
di puro eclettismo, ma di un ritrovamento di aspetti, di verità condivisibili anche
in filosofie non condivise nelle loro istanze di fondo (come può essere, ad
111
112
esempio, la filosofia di Nietzsche, o di Sartre e di altri); secondariamente –e a
un livello più profondo– il senso di armonia è individuabile nella visione,
appunto, armonica della realtà e dell’esistenza.
Ciò non significa che non sia presente, nella riflessione di Ruminelli il problema del male: tutt’altro. Questo è uno dei problemi più avvertiti nel libro. Il
senso armonico e in definitiva ottimistico dell’esistenza non è espressione di
una visione meno attenta e consapevole degli aspetti negativi della medesima, ma è il risultato di un superamento di quegli aspetti, in nome di ragioni ben
fondate, che pur nella consapevolezza delle opposte ragioni del male, aprono
uno spiraglio sicuro per la definitiva vittoria del bene –secondo l’espressione
di Croce appena sopra riportata–.
L’accenno alle “ragioni” a proposito del problema del male mi offre il passaggio a un terzo punto di questa mia presentazione, e cioè il tipo, o per
meglio dire, ai tipi di ragioni su cui è costruito il discorso di Ruminelli. Si tratta
di ragioni di vario genere. Genericamente sono ragioni teoretiche –anche se
in versione, talvolta, fenomenologica, descrittiva, cioè descrittiva delle tesi dei
vari pensatori, come ho detto più sopra–. Ma si tratta anche di ragioni di ordine morale, in forza della centralità, come pure ho rilevato, dell’idea di bene. Si
tratta ancora di ragioni di ordine religioso: e ciò non tanto per un discorso di
fede religiosa –almeno direttamente–, quanto piuttosto, mi pare, per la valenza teoretico-morale, che spesso è dato trovare nella religione, e più propriamente, secondo la concezione di Ruminelli, nel religioso, conformemente alla
meditazione di un filosofo che è stato il maestro –come di tanti altri– della
nostra scrittrice: voglio dire Alberto Caracciolo. “L’aspirazione all’infinito”
–tema che costituisce la sostanza di tutto l’impianto del libro– trova la soluzione, come scrive Ruminelli, con forte accento caraccioliano nel “riconoscimento dell’Alterità infinita”, quale “sorgente e fine di ogni finito che in essa si radica” (pag. 20).
C’è ancora un altro tipo di “ragione” nel discorso della Ruminelli, cioè le ragioni artistiche, conformemente, d’altra parte, alla formazione culturale della medesima, cresciuta appunto in un ambiente familiare dominato dal senso e valore
dell’arte arricchito ulteriormente dagli studi letterari, punto di appoggio e argomento, per vari anni, della sua stessa professione di insegnante. Le ragioni, e
con esse i riferimenti, sono dunque molteplici, e spaziano su tutta la storia della
filosofia, che viene ripresa e interpretata dall’idea di fondo dell’autrice, I’idea
appunto, dell’uomo come partecipe del finito e dell’infinito. A questa tesi concorrono anche, come dicevo, ragioni morali, religiose, artistiche. In certo senso, il
libro di Ruminelli è uno specchio, una testimonianza, in fondo, della personalità
dell’autrice; e per questo, anche per questo, è un libro vivo ed efficace.
Infine, un accenno ad alcuni temi fra quelli principali in cui si dispiega, nel
libro, I’argomento dell’uomo, partecipante del finito e dell’infinito.
Anzitutto il tema della coscienza, che in un discorso sull’uomo è necessariamente in primo piano. La filosofia concepita come antropologia –secondo
quanto detto più sopra– è in gran parte e fondamentalmente un’analisi della
coscienza. Lo è stata per Agostino, l’iniziatore della filosofia della coscienza,
lo è stata per Cartesio, l’iniziatore della filosofia moderna, che è in gran parte
RECENSIONI
un’antropologia. E per la Ruminelli –e non solo per lei– è proprio nella coscienza che è dato trovare quella aspirazione all’infinito che costituisce la sostanza
di tutto il suo discorso.
Accanto a quello della coscienza un altro tema di fondo è il tema che con
sempre maggiore forza è emerso ed emerge nella filosofia contemporanea: il
tema della libertà. Tema che ha avuto e ha in Italia, in questi ultimi tempi, un’interpretazione radicale, ad opera soprattutto del filosofo Luigi Pareyson, il cui
pensiero è ripreso e continuato, almeno in parte, da diversi suoi discepoli.
Pur senza l’adesione alla tesi di Pareyson –tesi a cui accennerò tra poco a
proposito del problema del male–, la Ruminelli professa anch’essa –mi pare–
una tesi che, almeno implicitamente, concepisce la libertà come la nota fondamentale dell’essere: intendo la libertà nel significato per me radicale, ontologico, che è quello della libertà come creatività, come donatività di essere.
Qui vado oltre, credo, la lettera del testo di Ruminelli; ma penso mi sia lecito
anche introdurre qualche cosa di personale nel mio discorso, creando, in tal
modo, un “dialogo” teoretico con l’autrice, secondo quello che costituisce, in
fondo, uno dei fini dell’attività filosofica, e non solo.
Precisamente, il mio “intervento” nel discorso di Ruminelli si concretizza in
questo: ciò che leggo a pag. 60, che “proprietà [di Dio] è creare”, io lo interpreto –richiamando una mia tesi fondamentale, su cui mi sono soffermato in
molti miei scritti–, come espressione del concetto di Dio come Libertà, Libertà
assoluta, e, come tale, “Creatività”, in quanto la libertà, o più precisamente la
libertà che io chiamo “matura” cioè l’amore (e qui il discorso si fa ancora più
complesso, e non c’è modo, per ora, di delucidarlo maggiormente), è essenzialmente “creatività” (la creatività a livello fisiologico dell’amore umano e
creaturale è appunto, io ritengo, una traduzione della creatività propria dell’amore come tale, che nell’Amore assoluto –nella Libertà assoluta– ha il suo
principio).
Un altro tema, infine, tra i più avvertiti e sentiti nel libro di Ruminelli, è quello del male, che giustamente l’autrice connette con quello della libertà. Anche
qui mi inserisco nel discorso della Ruminelli per rilevare che il male non sta
alla radice dell’essere –come vorrebbero certe dottrine, le dottrine del pessimismo metafisico– ma sta alla radice della possibilità dell’essere, o, per meglio
dire, il male non è l’essere radicale, ma è una possibilità radicale. Non dico
possibilità radicale per l’Assoluto, ma possibilità radicale per le creature, in
quanto la libertà iniziale va concepita come “possibilità” di “realizzare” se stesso attraverso la “donazione” di se stesso, cioè attraverso la “creatività” in atto.
La libertà iniziale non è un “dato” –non sarebbe più libertà–, ma è appunto una
“possibilità”. Se fosse un dato noi non saremmo “padroni” di noi stessi. È precisamente la possibilità di “donare”, di “donarsi”; ma appunto perché possibilità di “donare” è anche possibilità del suo opposto: possibilità di “opprimere”,
invece di donare. Da qui appunto la estensione del male, del male morale.
Nella misura, invece in cui la libertà attua la propria vocazione”, quella appunto di essere “creatività”, essa diventa amore.
E con questo mi piace terminare il mio discorso, che qui è diventato “personale”, ma che è sulla linea, credo, di quello dell’autrice Ruminelli. Discorso
113
di Ruminelli che, pur originale e fortemente personale presenta anche una
sorprendente affınità con quello di un filosofo recentemente scomparso, tra i
più noti e fecondi in questa seconda metà del secolo: voglio dire Jean
Guitton, segno, anche questa affinità, della “attualità” –non effimera, perché
fondata sul vero perenne– della riflessione di Ruminelli. Ecco il brano di
Guitton che sembrerebbe estratto, direi, da una pagina del libro della nostra
autrice: “In ogni istante della vita c’è un po’ di finito e un po’ di infinito; il finito è ciò che tu credi di sentire, l’infinito è ciò che è all’interno e che tu senti
senza sentirlo, che tu pensi senza pensarlo, che tu vuoi senza volerlo”. E lo
scrittore Rodolfo Doni, che ha citato questo brano in un suo articolo su
Guitton, commenta così, in uno spirito che direi essenzialmente e profondamente agostiniano: “C’è insomma in noi una facoltà che è come l’occhio del
nostro occhio, essa unisce, mediante i concetti la nostra realtà intima con la
realtà intima che si cela nelle cose. Tale realtà noi chiamiamo l’Essere. E dunque l’Essere è ciò cui tende la nostra intuizione. Esso è il cuore delle cose al
quale tende il nostro cuore”.
Santino Cavaciuti
AA.VV., Vite di utopia, a c. di V. Fortunati e P. Spinozzi, Ravenna, Longo editore, 2000, pp. 336.
114
I saggi contenuti in questo volume sono ricavati dal testo delle relazioni
tenute al Convegno Internazionale di Gargnano sul Garda, organizzato dal
Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Utopia dell’Università di Bologna (911 giugno 1997). L’intento dichiarato è il rapporto “tra il testo utopico e il contesto storico-politico in cui lo scrittore opera”, che implica anche il rapporto tra
testo utopico e biografia; una impresa non facile, soprattutto se si è decisi a
non eludere gli apporti del poststrutturalismo, e cioè la decostruzione della
struttura teleologico-lineare della storia, cui invece l’utopia si affida, tenendo
conto, poi, che in quel quadro tutti i riferimenti diventano precari e la narrazione resta perennemente ipotetica.
Alla luce di questo New historicism, come nota Vita Fortunati nel suo saggio introduttivo, risulta davvero interessante operare il discrimine tra l’autentica passione della verità e gli artifici che tentano di comporla nel testo, ossia
quanto di “romanzesco” e di “soggettivo” entra nella descrizione della possibile o presunta verità. Una strategia, evidenziata da Carmelina Imbroscio,
potrebbe essere quella dell’“oggetto transizionale” cioè la messa in risalto del
ruolo che assumono certi elementi come via d’accesso alla finzione, ma anche
come via d’uscita per il “narratore-viaggiatore”.
Si libera subito il campo da pregiudizi stereotipi circa l’integralismo e il perfezionismo degli autori utopici, tenendo conto, dice Vita Fortunati, che anche
nei biografi sussistono tendenze al soggettivismo; e, a riprova di ciò, riporta
emblematicamente, come esempio, le varie biografie di William Morris, spesso tra loro contrastanti.
RECENSIONI
Se ci si ferma ai “meri percorsi biografici”, avverte Paolo Pissavino, che
propone la figura di Ludovico Zuccolo, la ricerca si psicologizza e non penetra
la profondità di pensiero dell’autore.
La melancholy che viene attribuita a Robert Burton o l’autoterapia attribuita più volte a Starobinski o l’ossessione del Panopticon di Jeremy Bentham,
sono semplici categorie di un genere letterario, chiarisce ancora Vita Fortunati.
E tuttavia Luigi Punzo ritiene che l’utopia, sia pure considerata nell’ambito
strettamente letterario-filosofico, si pone in un’ambiguità di segno positivo e
determina nel lettore una tensione progettuale o, comunque, produce uno stimolo all’interpretazione del presente, in quanto “segno positivo di una specifica realtà ritenuta negativa, un equivalente speculare ordinato”, in cui, più che
l’utopista, emerge il messaggio utopico, come avviene in Campanella, in
Andrea e in Bacone, e non solo. C’è poi il valore umanizzante dell’utopia, il suo
attestarsi come ucronia, cioè come ponte di equilibrio tra passato e futuro
(Mercier, Retif de la Bretonne).
L’ucronia può propendere più per il passato che per il futuro o viceversa, dice
Alberto Berretta Anguissola; ma è presumibile anche, letterariamente parlando,
che nell’utopia si nasconda un desiderio di rigenerazione, che nella psicoanalisi
corrisponde al riattraversamento dell’utero materno, mediatrici le figure parentali.
Quanto all’“irrompere” dell’autore nel testo, si può essere d’accordo con
Caterina Marrone e con Jean-Michel Racault, i quali sottolineano però che
occorre tener presente che l’utopista avverte più d’ogni altro il peso delle contraddizioni della società del suo tempo, come è evidente in More, più volte citato, e ancor più in Oscar Wilde, che finisce per modellare l’utopia in esperienza individualistico-estetica, come rileva Giovanna Silvani analizzando aspetti
dell’utopia letteraria nella fase del decadentismo.
Nel genere utopico la distinzione tra autore ideale e autore concreto non
sussiste; sussiste invece abbastanza netta la distinzione tra lettore ideale e
lettore concreto, per il tramite del messaggio, che è romanzesco per taluni,
filosofico per altri. Così come rilevante è il risalto che Enrico Nuzzo attribuisce
al sociomorfismo e all’urbanomorfismo di Platone, cioè la tendenza di un autore a rappresentarsi più nella socio-politicità che nella psico-unità, da cui emergono poi anche variegate forme di rapporti e analogie: unità-pluralità, cittàcosmo, teoresi-prassi, ecc. Si suppone anche una ricomposizione delle parti
(individuo-città, acropoli-agorà) in cerca di una soluzione del dualismo.
Miguel Martinez Lòpez pone un quesito emblematico circa il rapporto che
si stabilisce tra l’autore e i suoi biografi: c’è un More quale egli stesso pensa
di essere, un More quale altri pensano che sia e un More quale realmente è.
D’altronde, se la prospettiva resta segnatamente speculare, ci s’impiglia in una
versione, per così dire, intimista dell’utopia, per cui l’utopia sarebbe solo un
evento letterario, che non si confronta mai con la storia. E se lo fa, lo intende,
in genere, come il “già realizzato”. In tal modo, osserva Cosimo Quarta, non
solo si esclude la categoria del “non ancora” (fondamentale per il pensiero utopico) ma si finisce anche col togliere senso alla storia stessa, che altro non è
se non “temporalità dotata di senso”, visto che “il tempo diventa storia solo se
ha un senso”. L’utopia, quindi, lungi dall’essere un “esercizio mentale sui pos-
115
116
sibili laterali” della storia, ne è invece il “suo primo motore”, la sua “causa efficiente”. E ciò, rileva Quarta, si vede chiaramente proprio nell’Utopia di More,
dove è possibile scorgere (non solo nel primo, ma anche nel secondo libro)
una lunga serie di analogie tra utopia e storia: Utopia è l’Inghilterra, Amauroto
è Londra, e le stesse istituzioni di Utopia sono un chiaro riferimento (per analogia od opposizione) ai costumi e alle istituzioni inglesi.
Resta poi sempre la possibilità di considerare il progetto utopico come
mera espressione di un’epoca determinata come Les hermaphrodites attribuita ad Artus, calato nel periodo compreso tra la strage della notte di S.
Bartolomeo, l’editto di Nantes e la pace di Vervins. Lo sbocco della fiction è il
superamento della metafisica e dunque la conversione totale all’agnosticismo,
azzeramento delle differenze sessuali; mentre, ad esempio, gli Antangilani di
Emeric Crucé si limitano a sdogmatizzare le religioni per conseguire la pace
perpetua. Una sorta di “modica theologia” groziana, dice Maurizio Cambi, o
forse anche un’ontologizzazione delle Lettere sulla tolleranza di Locke. Il tema
di fondo è la scissione del rapporto natura-Dio, una sorta di anticipazione del
deismo illuministico. Un tema su cui torna Raimond Trousson, portato però
fino alla sue propaggini teoretiche, cioè fino all’anarchismo di Foigny, all’eliocrazia di Vairas e al materialismo di Tyssot. Da segnalare poi, in questa sezione, i contributi di Mariangela Tempera (su Tabacco e utopia), di Paolo
Passavino (su Zuccolo) e di Giovanna Silvani (sull’utopia anarchica).
Quanto al topos, al luogo, nell’utopia letteraria (che costituisce la terza
parte del volume) lo si prefigura come antitetico e antipodico. Ad esempio è
antitetico Into their labors di John Berger se, come Daniela Corona riconosce,
l’imagination finisce per assumere una “funzione eversiva” quando riesce a far
assumere al lettore (il lettore postmoderno) la “capacità di mettersi nei panni
altrui”. È antipodica New Zeland di Samuel Butler, antipodica all’Italia, per proporre, secondo Maria Luisa Bignami, un profondo revisionismo in fatto di religione. Completano questa parte i bei saggi di Paola Spinozzi (su W. Morris) e
Francesca Orestano (su L. Frank Baum)
Sulla imagination come “finzione” Adriana Corrado propone un rovesciamento. In gioco non sarebbe più l’immaginazione dell’autore (si discute di
Mary Vollstonecraft, compagna di William Godwin), quanto la proiezione ideologica che ne fa il lettore, o se si vuole, lo storico, al quale si rende necessaria una ricostruzione del pensiero e della biografia dell’autore. Se l’ideologia è
questa, emerge una straordinaria figura di Mary, una sorpresa per il biografo
e lo storico. Così di Charlotte Perkins, nell’intervento di Oriana Palusci, così di
Alice A. Chown, riportata da Rosella Mamoli Zorzi. Da segnalare poi, in questa quarta sezione, anche i saggi di Alessa Johns e Hans Ulrich Seeber.
Interessante anche cogliere lo stacco tra utopia e distopia nell’autobiografia, come suggerisce Beatrice Battaglia, cioè l’autobiografia chiaramente propositiva e progettuale e l’autobiografia che invece si attiene a ciò che è, o
meglio a ciò che ha la forza di essere; ad esempio il filone esistenzialistico di
stampo welleisiano e quello sovversivo fantastico di Morris. Si trova che le distopie sono per lo più allegoriche, metafore continuate, fiction e comunque un
punto di vista soggettivo di cui bisogna pur sempre stabilire i limiti. In questa
RECENSIONI
parte del volume, dedicata alle “mentalità utopiche”, compaiono anche gli stimolanti saggi di Erika Gottlieb, Maurizio Ascari e Annete Gomis.
Nell’ultima parte del volume, troviamo alcune esemplificazioni del rapporto
individuo-società nell’utopia. Così, per Haisa Pessina Longo, la metonimia
sembra essere il sostrato diagnostico di Andrej Platonov, nel quale assume il
senso di una “gestualità verbale”, per dare senso e vita a tutto quello che si
dice o si narra. Potrebbe essere questa la versione autobiografica esente dai
limiti consueti. In questa parte si trova anche il recupero di alcune figure eminenti. Così, nel saggio di Renato Risaliti quella di N.P. Ogarev e i caratteri della
Obscina o comune agricola russa; oppure quella di E.A. Johnson e i caratteri
dell’utopia nella comunità di colore in America, di cui parla Maria Giulia Fabi;
quella di D.H. Lawrence per quel suo rapporto garden-jungle equivalente a
utopia-distopia, come propone Stefania Michelucci.
La varietà e la complessità delle linee di ricerca qui proposte offrono un
notevole stimolo agli studiosi dell’utopia, e non solo a loro; tentare lo sconfinamento del proprio assetto di ricerca e vedere nella varietà delle proposte la
vera ricchezza dell’utopia.
Mario Schiattone
P. COLONNELLO, Percorsi di confine. Analisi dell’esistenza e filosofia della libertà, Casoria, Luc. editore, 1999, pp. 124.
Nell’introduzione lo stesso A. si preoccupa di mostrare come l’incrocio di
differenti itinerari all’interno di comuni orizzonti sia reso possibile dalla peculiare lettura dei pensatori, così diversi fra loro, qui presi in esame: Nietzsche,
Dostoevskij, Croce, Arendt. Fra i fondamentali crocevia degli itinerari filosofici
qui presi in esame è sottolineato quello costituito dalla destinazione etica cui
è indirizzato il filosofare, soprattutto se la problematica etica è considerata
intrinsecamente connessa con il tema della religiosità e con la questione del
tempo. Per l’A., l’opera di Dostoevskij, nel tentativo di descrivere e dar ragione di alcuni fondamentali dilemmi esistenziali, si avvicina “alla soglia dell’interrogare metafisico” (p.15). Il pensiero di Hanna Arendt è esaminato a partire
dai temi della menzogna e del perdono. L’A. mostra come nel pensiero della
Arendt restino centrali “il problema del tempo e quello del superamento della
scissione, due questioni in qualche modo tra loro connesse che oggi sono fondamento ripercorso della riflessione ermeneutica” (p. 51). Originale è la prospettiva da cui è considerato Croce, quella della religiosità e del phatos del
vivere. Sono illustrati i veri aspetti della “religiosità” di Croce, tra cui la concezione della moralità “come ‘religione’” (p. 61). Croce è esaminato anche nella
prospettiva della “individualità” e “universalità”, in rapporto al tema della “crisi”
della civiltà.
Nelle due appendici sono esaminati diversi aspetti del pensiero esistenziale e il tema del tempo come “circolo” e del meriggio di Zarathustra, in Nietzsche.
Albino Babolin
117
AA.VV. «Αρχη‘», a c. di S. Ciurlia Sentieri della Ragione: analitica filosofica al
crepuscolo della modernità, II, 1999.
118
In un’età come la nostra, caratterizzata dal dominio incontrastato della tecnica lungo un orizzonte ormai planetario che tende a riplasmare le concezioni
classiche di ragione, di spazio e di tempo, cui ha creduto l’Occidente, qual
ruolo può ancora recitare l’analisi filosofica e, soprattutto, qual senso può rivestire l’investigazione dei canoni di razionalità che sovraintendono alla concettualizzazione del nostro tempo? Cos’è cultura, oggi? Ed ancora, esiste (o può
darsi) una struttura del sapere? Problemi, questi, presenti ad alimentare il
variegato dibattito della riflessione filosofica contemporanea tra l’esaurirsi dei
contenuti di senso di trascorse concezioni della ragione e la faticosa elaborazione di nuovi paradigmi concettuali a rincorsa di un tempo irto di continui
mutamenti socio-culturali.
Questi temi, questi quesiti, queste aree problematiche rappresentano il filo
rosso che lega i contributi che animano il secondo numero della Rivista di filosofia «Αρχη‘», dal significativo titolo Sentieri della Ragione: analitica filosofica
e cultura al crepuscolo della modernità, affidato alla cura di Sandro Ciurlia. Il
“crepuscolo” del moderno, cui si allude nel titolo monografico, rinvia alla determinazione del venir meno del modello di razionalità della modernità a favore di
aree di significati in merito ad un concetto di ragione caratterizzato dalla conquista del senso della molteplicità delle espressioni del giudizio come acquisto
ineludibile del nostro tempo. Secondo la valutazione del curatore, come un
«ripensamento a più voci» (p.13) della cosiddetta crisi della modernità va intesa la sequenza dei contributi raccolti nel volume, strutturato secondo una precisa scansione che, ai Saggi, fa seguire una sezione costituita da rapide annotazioni critiche (Forum: le vie del pensare) e da contenuti informativi di segnalazione critica dei tratti del complesso quadro delle posizioni del dibattito filosofico contemporaneo (Effemeridi filosofiche). Il tutto preceduto da un denso saggio introduttivo di Ciurlia che ai sentieri della Ragione tracciati da «emblematiche esperienze razionali del moderno», (p.21), avvia. Non senza la provocazione dell’ossimorico, figura retorica protagonista principale delle ambivalenze
senza sintesi della fine della modernità, che è possibile cogliere sin dal titolo La
possibilità del necessario. Epicedi in memoria della modernità. A rigore, infatti,
possibilità e necessità rappresentano termini reciprocamente esclusivi, ma essi
pur convivono nel quadro pluriesteso e variegato del pensiero moderno. In tal
senso è intento dell’autore sottolineare quanto siano complesse le riduzioni d’identità cui è soggetta la ragione moderna, come se della sua pulsante varietà
potesse predicarsi un’unica anima. Secondo la prospettiva proposta, infatti, la
modernità rappresenta «un’entità nominale distinguibile per aree di significati
ed individuabile a muovere dal punto di vista assunto» (p.9). La presa di posizione assunta dall’autore è radicale: il termine “ragione moderna” viene proposto solo come uno tra i modelli possibili di ragione, e l’argomentazione condotta al riguardo testimonia un deciso alleggerimento dall’alea ontologica che giunge ad avvolgere di sé un concetto non oltremodo significativo, eppure così
enfatizzato come quello di razionalità moderna. In questo complesso quadro la
RECENSIONI
filosofia viene ritenuta «il luogo del domandare, senza alcun intento trionfalistico, ma nella precisa consapevolezza di un ruolo ancora del tutto recitabile di
sorvegliamento critico e, soprattutto, linguistico»(p.16) . La vivacità e la concentrata densità del saggio introduttivo non distraggono, tuttavia, da una breve
e doverosa, data la ricchezza e l’interesse degli argomenti indagati nel volume,
illustrazione dei vari saggi, raccolti nella prima sezione di Αρχη’.
Apre, il lungo e circostanziato contributo di Sandro Ciurlia (Itinerari dell’unità: l’aporetica della Deduzione trascendentale delle categorie nella Critica della
ragion pura di Kant) volto all’analisi concernente la successione di passaggi
argomentativi della Deduzione trascendentale kantiana, fulcro dell’intera prima
Critica, proprio nel mezzo di quello snodo all’altezza del quale Kant tenta di elaborare una logica trascendentale come logica delle forme a priori del soggetto
conoscente muovendo dal «filo conduttore» della tradizione logica classica,
quella formale dei giudizi. Il punto di vista interpretativo proposto dall’autore
dello studio vede l’analisi deduzionale «naturalmente intesa» a snodarsi sino
all’altezza dei suoi più vivi esiti, i principi dell’intelletto puro fondativi di una
metafisica della natura, resi trascendentalmente operativi da una Dottrina
Trascendentale del Giudizio, ostesa d’intesa con l’ipotesi schematistica. Il tutto
non senza la puntualizzazione, da parte di Ciurlia, di taluni rilievi al testo kantiano, tutti gravitanti intorno alla prodigiosa complessità del rapporto che Kant
instaura tra le due dette forme logiche, in costante interlocuzione critica con le
più autorevoli pagine della letteratura secondaria elaborata al riguardo.
Dello stesso Ciurlia va altresì segnalato un saggio dedicato al pensiero giovanile di Schelling (Schelling fra Ragione teologica e sistema dell’Assoluto) che getta
luce sugli ambienti stiftiani per acclarare le modalità attraverso cui Schelling giunse, negli anni che concludono la sua prima stagione di sviluppo speculativo con le
tre opere del 1795 (Uber die Moglichkeit einer Form der Philosophie uberhaupt;
Vom Ich als Princip der Philosophie oder uber das Unbedingte im menschlichen
Wissen; Philosophische Briefe uber Dogmaticismus und Kriticismus) alla ricezione dei contenuti fortemente teologizzati dei vari dualismi kantiani ed alla filosofia
della Ichkeit di Fichte. E questi due autori orienteranno Schelling alla concezione
dell’Assoluto come unità di Spirito e Natura, non prima che le Lettere filosofiche sul
dogmatismo e criticismo –su cui a lungo si sofferma il saggio– celebrino la propria
complessità in quanto centro di confluenza di un serrato confronto teoretico ingaggiato dal giovane filosofo con il pensiero di Kant, Fichte, Spinoza e Leibniz.
Va segnalato, a seguire, l’interessante contributo di Giuseppe De Lorenzis
e Marcello Petrelli (Luigi Martinotti. Condensazione di sistema), i quali hanno
messo in luce la presenza inquietante nel panorama intellettuale italiano di un
personaggio della cultura filosofico-letteraria degli anni venti come Luigi
Martinotti, figura intensa e poco nota al grande pubblico sino adesso, che
suscitò l’attenzione di Benedetto Croce, che ebbe a definirlo un «indagatore
del mistero dell’universo». Gli autori conducono per mano il lettore, fornendogli due piani di lettura e riflessione: quello dell’analisi afferente la sua
opera, e quello strettamente biografico, presentando documenti relativi alla
sua tormentata biografia che attendono ancora una sistemazione archivistico-storica più attenta. La seconda parte del saggio, costituita da una sorta di
119
120
antologia composta da brani tratti dall’opera del Martinotti, vuol anche essere un incitamento editoriale, rivolto al coraggio di qualche volenteroso amante della cultura disposto a riproporre l’opera di questo complesso autore, mai
più ristampato dagli anni venti o addirittura del tutto trascurato dalla critica.
Spiegano i co-autori: «Levato Luigi Martinotti dal suo silenzio lo abbiamo
seguito per degli anni non con spirito erudito nè col proposito di collocarlo in
un quadro già predisposto della cultura italiana. Non lo fece Croce e non ci
pare che avremmo dovuto farlo noi. Ma con quel desiderio di conoscenza che
di fronte a Martinotti significa partecipazione mentale e morale. […] Come
filosofo vogliamo presentarlo e sottoporlo quale nuova materia per indagare
il vero» (p.136).
Paolo Pastori (Le metafore della tradizione. Finzione letteraria di un immaginario viaggio verso la Magna Grecia alla ricerca di qualcosa di altrimenti indicibile), si è impegnato a riflettere sulla categoria teoretico-storiografica di tradizione, nonché sulle metafore che ne caratterizzano l’espressione.
Muovendo dai risultati conseguiti nei suoi noti studi precedenti intorno al tradizionalismo settecentesco, soprattutto di area francese (Bonald, De Maistre), la
briosa prosa polemica di questo saggio epistolare si volge a sollevare dalla
condanna all’ossimoricità la nozione di statica dinamicità della tradizione, da
intendersi come fluente sistema di valutazioni che non pietrifica le pulsioni o le
aspirazioni di un tempo o di un’epoca.
Antonio Quarta (Scienza ed etica nella crisi della modernità. Note e discussioni) compie un’attenta analisi del ruolo della scienza e dell’etica al tramonto di una modernità bersagliata dagli “imperativi categorici” del mercato e
della globalizzazione. Quarta, intrecciando il pensiero di E. Morin con le diagnosi intorno alla modernità di Rorty, porta la sua analisi alla trattazione del
concetto di phronesis, al centro del recente dibattito ermeneutico.
Ubaldo Sanzo (Radioattività e struttura della materia) analizza la vicenda
scientifica che ha condotto alla scoperta della radioattività, che vide come protagonisti Rontgen, Becquerel, e poi, i coniugi Curie, i quali identificarono,
com’è noto, in un primo momento, nei minerali di uranio un elemento con spiccatissime caratteristiche radioattive, tanto da farlo diventare il prototipo delle
sostanze che presentano il Radium. Sempre ai coniugi Curie, è da attribuirsi
la scoperta della radioattività, anzi la sua produzione che avvenne nel 1934,
quando bombardarono nuclei di alluminio con particelle α, producendo fosforo. Fa da sfondo alla ricostruzione storica del celebre evento scientifico una
notevole attenzione proiettata verso le vicende accademiche di politica culturale che condizionarono a lungo la visibilità della scoperta, a testimonianza di
quanto la scienza sia un’attività umana collocata nel vortice delle passioni
della vita che fanno il mondo e la storia.
Andrea Gabbianelli e Francesco Torre (L’arcipelago delle alterità nell’era
della globalizzazione) alimentano la loro ricerca sulla controversa prospettiva
della globalizzazione, attraverso un percorso di analisi delle complesse condizioni socio-economiche ed etico-giuridiche in cui si colloca.
L’ultima sezione della rivista –Effemeridi filosofiche– contiene una serie di
riflessioni critiche e di recensioni di testi intorno ai temi trattati nel volume, non-
Stefano Donno
AA.VV., Morale, diritto e politica: loro differenze e rapporti, in “Progresso del
Mezzogiorno”, n. 1-2, Napoli, Loffredo, 1999, pp. 297.
Sono stati pubblicati gli atti del Convegno nazionale tenuto a Napoli il 20-21
ottobre 1998. Da uno sguardo d’insieme di tutta l’opera e da tutte le singole
relazioni su tematiche teologiche, morali, giuridiche, politiche, ecologiche, economiche, ecc., emerge con chiarezza l’argomento fondamentale e dominante:
il valore, la difesa e lo sviluppo della persona umana in tutte le sue dimensioni.
Finora tutte le strade percorse dai movimenti politici in questi due ultimi
secoli, come anche quelle percorse dalle ideologie filosofiche, sociali, giuridiche, sono crollate perché non hanno avuto come punto di riferimento la persona dell’uomo. Così è avvenuto per i due movimenti antagonisti, il liberalismo
economico e il collettivismo di Stato: crollati “l’uno per l’autocritica e le riforme
sociali introdotte dai governi democratici dei paesi occidentali, l’altro, il collettivismo, per autoeliminazione operata dalla rivoluzione pacifica in URSS dal
1989 in poi. Sulle macerie dell’uno e dell’altro sistema è venuta sviluppandosi, nei paesi occidentali, “la terza via”, che potremmo denominare “democrazia sociale” o “stato sociale di diritto”, che ha una delle principali e più valide
matrici nel pensiero sociale cristiano” (p. 291).
Si tratta di una terza via che ha le sue radici nel personalismo cristiano,
RECENSIONI
ché un breve contributo a firma di Sandro Ciurlia (Oblomov da antieroe ad
eroe negativo. Prolegomeni ad un’estetica dell’inedia), sulla figura di Oblomov,
maschera tragi-comica dello spirito russo ed emblema di un’esistenza solo in
apparenza del tutto dedita all’inedia, di cui Oblomov costruisce faticosamente
un’estetica rendendo il lento intreccio della sua esistenza, come dice l’autore,
«un’eroica meditatio mortis».
Complessivamente, a nostro avviso, l’obiettivo principale nell’intento del
curatore del volume, di solcare, attraverso anche la coordinazione attenta dei
pregevoli e variegati contributi ospitati, problematicamente ed emblematicamente quelle aree del moderno soprattutto nell’ottica della spazialità polisemica delle irreduttibili tecniche e delle avventurose trame della ragione moderna,
viene in fondo raggiunto, proprio alla luce della consapevolezza che ogni valutazione storico-critica rimane comunque una determinazione suscettibile di
ulteriore analisi.
Sarebbe piaciuto, inoltre, dato il carattere monografico di questo numero di
Αρχη‘, poter osservare un qualche riferimento alle tematiche della crisi della
modernità per come essa è andata sviluppandosi nella storia dell’arte moderna e post-moderna, quantunque vada, ad ogni modo, ravvisato che una
Rivista si costituisce, per definizione, di voci critiche affidate a singoli studiosi
che evocano a sé l’area della propria specializzazione.
Pertanto alcun intento sistematizzante anima una tale valutazione, ma solo
la persuasione dell’irriducibile complessità dei problemi.
121
122
parte da queste radici e viene continuamente illuminato da queste radici quando si parla di uomo –persona o si fanno progetti scientifici, sociali, economici,
politici. Si legge nella relazione di A. G. Manno su Il centro politico direttrice del
moto della storia: “La terza via, in linea di principio e come suo ideale, si fonda
sul valore della persona umana, e sul concetto di “Stato” quale strumento della
società per la difesa e lo sviluppo della persona umana in tutte le sue dimensioni, nella collaborazione e integrazione interpersonale. Uno dei cardini dello
“Stato sociale di diritto” è costituito appunto dalla concezione dell’uomo –contrariamente all’uomo per natura egoistico e solitario di Hobbes e di Spinoza–
come “essere sociale”, cioè fatto per vivere in società, e solo in società capace di difendere e sviluppare le sue facoltà” (pp. 291-292).
È grazie ad uno stato sociale di diritto, che ha come fondamento giuridico
la centralità della persona, che vengono salvati i due fattori imprescindibili di
una società giusta, e cioè: “i diritti umani, diretti alla garanzia e allo sviluppo
della persona (Stato di diritto), e, nello stesso tempo, la difesa degli individui e
delle classi più deboli dallo sfruttamento e ingiustizie delle classi più forti,
garantendo loro un livello di vita dignitoso e civile; ove occorre anche con l’intervento dello Stato, affinché questo sia espressione della intera società e
assicuri il bene comune” (Ib.).
Su questa difesa degli individui, o meglio delle persone, e delle classi più
deboli dallo sfruttamento dei poteri forti, e cioè sulla centralità della persona,
si sono incentrate altre relazioni come: Diritto, morale e politica nel pensiero di
J. Maritain (M. Indellicato); Il primato dell’etica in Lèvinas: la persona e lo stato
(F. Marcolungo); Morale. diritto e politica nella dinamica della storia (T.
D’onofrio); Diritto e morale nella condizione postmoderna (G. Brescia); Libertà,
democrazia, decisionismo all’alba del Duemila (V. Addundo); Etica della persona, diritto e tribunale politico nel pensiero di Antonio Rosmini (P. Addante).
Questa attenzione alla persona come punto essenziale del cammino
umano va sempre tenuta alta, perché le insidie del male, a livello ideologico,
scientifico, politico, sono sempre pronte ad eclissare i valori della persona
umana e ad aggredire la famiglia. Lo stesso Croce ha posto profeticamente in
guardia gli uomini sulla minaccia perenne dell’Anticristo che è in noi, fin dal
1946, scrivendo: “Il vero Anticristo sta nel disconoscimento, nella negazione,
nell’oltraggio, nella irrisione dei valori stessi, dichiarati parole vuote, fandonie
o, peggio ancora, inganni ipocriti per nascondere e far passare più agevolmente agli occhi abbagliati dei creduli e degli stolti l’unica realtà, che è la
brama e cupidigia personale, indirizzata tutta al piacere e al comodo. Questo
è veramente l’anticristo opposto al Cristo”. Croce aveva visto questo capovolgimento dei valori, così come oggi si sta verificando nella comunità scientifica,
negli avvenimenti politici, nello scorrere della vita quotidiana, fatta di materialismo, di indifferenza, di stanchezza morale, civile e religiosa e tessuta soltanto di superficialità. Come salvare la persona da queste insidie? Con un impegno morale, dice Croce; con uno sguardo meditativo sulle apocalissi quotidiane, dice l’Orwell del 1984; con il primato della carità, dice l’apostolo Paolo e lo
dicono la Chiesa, i cristiani, gli uomini di buona volontà. “Se non hai la carità
nulla ti giova”, dice il messaggio cristiano di ieri e di oggi, messaggio proposto
Pietro Addante
RECENSIONI
anche in versioni laiche da chi si impegna nella salvezza dell’uomo.
Tutto ciò vuol dire “che tutti gli atti che non sono frutto di charitas o di
“volontà buona” (provvedimenti economici, materialismo, falso solidarismo e
falso pacifismo, assistenzialismo improduttivo o eccesso di legislazione sociale sulla legge “giusta” perché “certa” e “imparziale”, inganni sofistici e via
dicendo), lo sono, invece di potere o di interessi di parte, dunque di rapporti di
forza e di schiacciamento delle coscienze individuali, quali sono le prerogative storiche del “totalitarismo”, del “partito unico” e –appunto– dell’anticristo
che è in noi (p. 186).
La persona deve essere ritenuta, come afferma Rosmini, “apice” e “centro”
della società: “L’uomo, quando nasce, dice il Roveretano nella Filosofia del diritto, ha la proprietà o sia il possesso giuridico di se stesso. Tutte adunque le attività, facoltà, potenze, forze e beni che ha da natura, sono altrettanti diritti connaturali: non gli possono esser tolti né guastati da chicchessia. La suprema fra
le potenze è la persona, apice e centro, onde escono tutte le altre, e tutti i diritti, siccome raggi al centro. Le altre costituiscono la natura umana”. La persona
è quindi “la stella che deve illuminare l’universo degli uomini” (p. 57).
Altre relazioni, con riferimento indiretto o diretto allo studio e alla difesa della
centralità della persona, sono: Democrazia e dittature nel secolo XX: loro
cause; Antidemocrazia della Costituzione fascista, nazionalsocialista, comunista e loro responsabilità (ambedue di R. Belvederi); Moralità e amoralità della
politica in B. Croce (A. Nave); Diritto, politica. morale in B. Croce: il primato dell’etica (E. Paolozzi) Precisazioni per quattro concetti: politica, economia, economia politica, politica economica (M. Lombardi); Due casi moderni in cui la
morale ha fatto politica fondando nuove leggi: Gandhi e gli scienziati contro le
armi nucleari (A. Drago); Identità e differenza nell’età della globalizzazione (U.
Regina); Il centro politico, linea direttrice del moto della storia (A. G Manno).
Una cultura che si presenti come “nuova” non può trascurare il rapporto
essenziale che esiste tra morale, diritto e politica, con il fondamentale riferimento alla persona. “La nuova cultura” –scrive Manno– quale da più parti si
annunzia e si prospetta, intende fare “leva” sull’uomo come persona dal valore incommensurabile […] La nuova cultura punta sul valore dell’uomo, sul suo
essere persona, ente spirituale, e perciò dotato di “diritti inalienabili”, e obbligato ai corrispettivi doveri. Per esprimere sinteticamente, ma molto significativamente questa dottrina, è necessario riprendere il pensiero di Rosmini […] il
quale ebbe a definire “la persona umana la portatrice di tutti i diritti” (p. 6).
Questa è “la linea maestra della storia futura”, del progresso e delle civiltà
cui tutti i popoli sono chiamati.
123
Angelo Semeraro, Tommaso Fiore provveditore agli studi
La ricostruzione educativa in Puglia (1943-1947)
Un aspetto inedito dell’impegno del grande meridionalista: la sua attività nell’amministrazione periferica della Pubblica istruzione, in una fase di transizione marcata e di ricostruzione, morale e culturale prima che politica ed economica.
pp. 168, Lire 28.000
Egidio Zacheo, Politica e istituzione nella transizione
L’Italia in Europa
L’ingegneria istituzionale non può ispirarsi a modelli astratti, ma le riforme devono essere il risultato di una storia nazionale particolare ed insopprimibile. Con questo presupposto, Zacheo analizza la questione del cambiamento politico e istituzionale in Italia in
pp. 160, Lire 28.000
rapporto ad altre specificità europee.
Edizioni Quasar
Piero Manni
CODICI
124
Collana internazionale di narrativa diretta da Piero Sanavio
La collana risponde, con prospetive di qualità, all’oppressione diffusa dalla fiction globalizzata, senza progetto e senza stile, che distrugge il gusto della scoperta e cancella
storia e memoria.
Volumi pubblicati
Mario Lunetta, Montefolle, pp. 280, L. 25.000
“Fra le pagine più luminose e più trepidamente commosse di questa stagione letteraria”
Giorgio Barberi Squarotti, “La stampa”
Mario Quattrucci, A Roma, novembre, pp. 232, L. 25.000
“Un delitto, un intrigo, un giallo appassionante che è anche una riflessione sulla storia italiana dei nostri anni”.
Massimo Barletta, “Stream”
Fausto Coen, L’amore inconcluso di Margherita C., pp. 132, L. 20.000
“Uno stile malinconico, ma sempre ironico e lieve, e in fondo ottimista”
Arminio Savioli
Piero Sanavio, La felicità della vita, pp. 402, L. 25.000
“C’è un’originalità di invenzione e una forza creativa che non abbisognano di stimoli per
Andrea Zanzotto
manifestarsi”
PUBBLICAZIONI RICEVUTE DA “ SEGNI E COMPRENSIONE ”
(oltre quelle recensite nella rivista)
Volumi:
A.ALES BELLO, Edith Stein. Patrona d’Europa, Casale Monferrato, Piemme, 2000, pp.156;
A.AMATO, Il dramma della scienza, Foggia, Centrografico Francescano, 2000, pp.436;
V.AMPOLO E G.ZAPPATORE (a c. di), Musica droga & transe, pres. di P.Fumarola, Tivoli, Sensibili alle
foglie, 1999, pp.204;
K.O.APEL E E.DUSSEL, Etica della comunicazione ed etica della liberazione, a c. di A.Savignano,
Napoli, Editoriale Scientifica, 1999, pp.XXXII, 380;
G.BELGIOIOSO, La variata immagine di Descartes. Gli itinerari della metafisica tra Parigi e Napoli
(1690-1733), Lecce, Milella, 1999, pp.250;
F.BREZZI, Ricoeur. Interpretare la fede, Padova, Messaggero, 1999, pp.316;
A.BRUNO, Un’etica per la finitezza, Lecce, Milella, 2000, pp.202;
E.CALDIERI, J.-P. Sartre, gli uomini, gli artisti. Il problema estetico nell’ontologia esistenzialista,
Milano, Angeli, 1999, pp.112;
V.CAMERINO, Il divismo a Hollywood. Primordi e dintorni, Manduria, Barbieri, 2000, pp.160;
I.CANTONI, La filosofia “geroglifica”di Athanasius Kircher, Preprint, Dipartimento di Filosofia
dell’Università di Bologna, 2000, pp.72;
S.CAVACIUTI, Etica e libertà, Massarosa, Del Bucchia, 2000, pp. 146;
A.CORSANO, Ugo Grozio. L’umanista il teologo il giurista, a c. di C.Longo, Galatina, Congedo,
1999, pp.XIV, 200;
A.CORSANO, Umanesimo e religione in G.B.Vico e Giambattista Vico, a c. di F .P. Raimondi,
Galatina, Congedo, 1999, pp.XIV, 300;
R.CRISTIN, Fenomeno storia. Fenomenologia e storicità in Husserl e Dilthey, Napoli, Guida, 1999,
pp.160;
T.DELL’ERA, Augusto Del Noce filosofo della politica, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2000, pp.420,
A.DELOGU, La filosofia in Sardegna (1750-1915). Etica politica diritto, Cagliari, Condaghes, 1999,
pp.X, 440;
A.DENTONE E M.BRACCO (a c. di), Dialogo silenzio empatia, Foggia, Bastoni, 2000, pp.230;
A.DE SIMONE, Senso e razionalità. Max Weber e il nostro tempo, Urbino, QuattroVenti, 1999,
pp.628;
E. DI STEFANO, L’altro sapere. Bello, arte, indagine in Leon Battista Alberti, Palermo, Centro
Internazionale di Estetica, 2000, pp.188;
G.FARINA E P.TAMASSIA (a c. di), Immaginari di Sartre. Conversazioni con Michel Sicard, Roma,
Edizioni Associate, 1999, pp.160;
D.FELICE, Oppressione e libertà. Filosofia e anatomia del dispotismo nel pensiero di Montesquieu,
Pisa, ETS, 2000, pp.262;
C.L.FERRARO, Miguel de Unamuno (1864-1936), Nardò, Besa, 2000, pp.82;
G.FIGAL, Socrate, Bologna, Il Mulino, 2000, pp.140;
G.FILORAMO, Religione e modernità: il caso del fondamentalsimo, Preprint, Dipartimento di
Filosofia dell’Università di Bologna, 2000, pp.22;
F.FIORENTINO, Fondamenti di epistemologia e di metodologia filosofica classico-medievale, NapoliBari, Editrice Domenicana Italiana, 2000, pp.286;
G.FORGES DAVANZATI, Salario, produttività del lavoro e conflitto sociale, Lecce, Milella, 1999,
pp.256;
R.FREGA, Forme del pensiero attivo. Etica e costruzione concettuale nel pensiero di Gilles
Deleuze, Preprint, Dipartimento di Filosofia dell’Università di Bologna, 2000, pp.78;
P.GAMBAZZI, L’occhio e il suo inconscio, Milano, Cortina, 1999, pp.300;
G.GIMMA, Sylva rerum notabilum, a c. di M.Occhinegro e G.Belgioioso, Lecce, Milella, 1999,
pp.300;
D. Liuzzi, (a c. di), Intorno agli “Astronomica” di Manilio, Galatina, Congedo, 1999, pp.140;
S.KIERKEGAARD, Dalle carte di uno ancora in vita, a c. di D.Borso, Brescia, Morcelliana, 1999, pp.136;
125
126
G.LAMPIS, Maschere e dèmoni, voll.2, Roma, Mythos, 1999, pp.128;
L.LIPPOLIS, Rispetto dei diritti e pace giusta, Milano, Giuffrè, 2000, pp.256;
S.MANCINI, La sfera infinita. Identità e differenza nel pensiero di G.Bruno, Milano, Mimesis, 2000,
pp.314;
S.MARRA, Chiesa e Stato in Italia, dal dissidio alla collaborazione, Castrignano dei GreciCollepasso, Amaltea-Slogan, 1999, pp.128;
A.MARTANO, Pier Luigi Micheli medico umanista, Milano, Motta, 2000, pp.90;
W.MCBRIDE, Philosophical reflections on the changes in Eastern Europe, Lanham-Oxford,
Rowman & Littlefield, 1999, pp.140;
M.MELETTI BERTOLINI, La conversione all’autenticità. Saggio sulla morale di J.-P.Sartre, Milano,
Angeli, 2000, pp.188;
L.MESSINESE, Heidegger e la filosofia dell’epoca moderna , Roma, Pontificia Università
Lateranense-Mursia, 2000, pp.248;
M.MONTINARI, Cosa ha veramente detto Nietzsche, a c. di G.Campioni, Milano, Adelphi, 1999,
pp.228;
G.NICOLACI, Metafisica e metafora. Interpretazioni aristoteliche, Palermo, L’Epos, 1999, pp.196;
L.PAOLETTI, Uomo e tempo. Saggio di antropologia filosofica, Roma, Armando, 1999, pp.206;
G.PAPULI (a c. di), Antonio Corsano e la storiografia filosofica del Novecento, Galatina, Congedo,
1999, pp.156;
B.PIERRI, Gran Bretagna 1945. Le elezioni generali e la politicizzazione della stampa, ManduriaRoma-Bari, Lacaita, 2000, pp.150;
M.B.PONTI, Gorges Bataille e l’estetica del male, “Aesthetica Preprint. Supplementa”, n.3, dicembre 1999, pp.330;
S.PADULA, Carattere e compiti della filosofia, Lecce, Milella, 1999, pp.156;
S.PINTORE, Camineras de abba. Sentieri d’acqua. Poesie, Sassari, Kairos, 1999, pp.84;
I.PITTIGLIO, Franz Marc. Intuire l’invisibile, Firenze, Atheneum, 2000, pp.190;
M.PROTO, La comunicazione politica tra mercato e ideologia, Roma-Bari-Manduria, Lacaita, 1999,
pp.210;
A.QUARTA e P.PELLEGRINO, (a c. di), Humanitas. Studi in memoria di Antonio Verri, voll. 2,
Galatina, Congedo, 1999, pp.460, 510;
G.ROCCI, La maschera e l’abisso. Una lettura junghiana di Nietzsche, Roma, Bulzoni, 1999,
pp.308;
V.SAINATI, Idealismo e Neohegelismo, Pisa, ETS, 1999, pp.138;
M.SÁNCHEZ SORONDO (a c. di), La vita, Roma, Pontificia Università Lateranense-Mursia, 1998,
pp.XXVIII, 314;
U.SANZO, Poincaré e i filosofi, Lecce, Milella, 2000, pp.120;
H.SEIDL, Storia della filosofia e verità, Roma, Pontificia Università Lateranense-Mursia, 1999,
pp.240;
G.VOLPE, L’esperienza come metodo: la discussione popperiana del problema della base empirica della scienza, Preprint, Dipartimento di Filosofia dell’Università di Bologna, 2000, pp.20;
E.ZACHEO, Politica e istituzioni nella transizione. L’Italia in Europa, Lecce, Manni, 2000, pp.160;
Periodici
Acta Philosophica, f.II, v.8, 1999; f.I, v.9, 2000;
Aesthetica Preprint, n.57, dicembre 1999: FR.CH.OETINGER, Pensieri sul sentire e sul conoscere;
n.58, aprile 2000: AA.VV., Ripensare l’Estetica. Un progetto nazionale di ricerca;
Antologia Vieusseux, n.s., a.V, n.14, maggio-agosto 1999; n.15, settembre-dicembre 1999;
Aquinas, a.XLII, f.1 e f.2, 1999; f.3, 1999; a.XLIII, n.1, 2000;
Arké, n.2, 1999 ;
Cahiers du Centre Intedisciplinaire des Sciences du Langage, Université de Touoluse-Le Miral,
n.13. 1998; n.14, 1999;
Cuadernos del Pensamiento Latinoamericano, n.7, 1999;
Dianoia, a.IV, novembre 1999;
Estudios Mindonienses, n.15, 1999;
Hermeneutica, n.s., 1999: L’Occidente e il cristianesimo; 2000: Filosofie della religione;
Idee, v.42, 1999;
Il Contributo, n.s. n.2 (XX), maggio-agosto; n.3 (XX) settembre-dicembre 1999;
Itinerari, n.3, 1999; n.1, 2000;
L’immaginale, a.XV, n.27, ottobre 1999; a.XVI, n.28, aprile 2000;
L’immaginazione, n.160, settembre; n.161, ottobre; n.162, novembre; n.163, dicembre 1999;
n.164; gennaio; n.165, febbraio; n.166, marzo; n.168, maggio; n.169, giugno-luglio; n.170, agosto-settembre 2000;
L’incantiere, a.XII, n.50, settembre, n.51 dicembre 1999;
Notes et documents, Inst. Internat. J.Maritain, n.s., n.54/55, janvier-août ; n.56 septembre-décembre 1999;
Oikos. Per una ecologia delle idee, n.7, 1999;
Paradigmi, n.s., a.XVII, n.50, maggio-agosto 1999: Nuove prospettive di ricerca sul pensiero
medievale; n.51, settembre-dicembre 1999: Libertà e determinismo; a.XVIII, n.52, gennaio-aprile
2000: I filosofi tra pace e guerra;
Psicologia dell’educazione e della formazione, v.1, n.3, 1999;
Quaderni, Fondo Moravia, n.2, 1999;
Recherches husserliennes, v.12, 1999; v.13, 2000 ;
Rinascita della scuola, n. 4-5, 1999; n.1; n.2; n.3-4, 2000;
Rivista di filosofia, vol.XC, n.3, 1999; vol.XCI, n.1; n.2, 2000;
Symbolon, a.III, n.5-6;
Studi storici e religiosi, a.VIII, n.2, luglio-dicembre 1999;
Uomini e idee, n.6, 1999: Dell’essere o non essere Persona; n.7, 2000: Eutanasia: opinioni a confronto;
Via. Voices in Italian Americana, v.11, n.1, spring 2000;
127
Stampato presso ‘AGM - Lecce
nel dicembre 2000
per conto di Piero Manni s.r.l.
128
129
SAGGI
130
YOSSL RAKOVER, COME UN NUOVO GIOBBE
Yossl Rakover è un combattente ebreo del ghetto di Varsavia. Durante le
ultime ore della Resistenza, poco prima di morire, il 28 aprile 1943, si rivolge
a Dio chiamandolo in causa di fronte al trionfo dell’orrore e del male e alla sofferenza del popolo ebreo. Fissa queste sue ultime parole in pochi fogli, che
scrive con la faccia al suolo, mentre intorno a lui giacciono morti i suoi undici
compagni ed un bambino di cinque anni. Questi fogli sono, a ragione, il suo
testamento spirituale.
Trovato in una delle rovine del ghetto di Varsavia, tra cumuli di pietre carbonizzate ed ossa umane, sigillato accuratamente in una piccola bottiglia,
questo documento nel settembre del 1946 appare nella rivista di Buenos Aires
“El diario israelita” col titolo Yossl Rakover si rivolge a Dio, come l’ultimo messaggio scritto da un combattente del ghetto di Varsavia mentre il cerchio della
morte si stringeva intorno a lui. D’allora comincia a circolare per il mondo:
Israele, Germania, Francia, Stati Uniti, facendo, così, conoscere la storia della
rivolta ebraica di Varsavia e la tragedia che con essa si consumò.
Nel gennaio del 1955 il documento ritrovato viene diffuso da Radio Berlino
Libera nella traduzione tedesca a cura di David Kohan e Anna Maria Joki. Due
mesi dopo viene pubblicato nella “Terre retrouvèe”, periodico sionista di Parigi.
Due anni dopo appare a Gerusalemme –per la prima volta in ebraico come
“testamento”– sulle pagine dello”Ani-Ma’amin”. Nel 1963 Emmanuel Lévinas
dà alle stampe in Francia quel testo. A metà degli anni Settanta esce in Israele
un libro dal quale si apprende che Yossl Rakover è diventato la bibbia del
Gush Emunim, il movimento dei coloni più radicali nelle cui riunioni il testo
viene letto e riletto. In america finisce nei libri di preghiera sia degli ortodossi
sia dei riformati. Qualche anno fa il discorso di Yossl Rakover a Dio è stato
ripubblicato in America. Nell’autunno del 1994 è uscito in tedesco. Nel giugno
del 1997 è uscito in italiano1.
Yossl Rakover scrive queste righe mentre le case del ghetto di Varsavia
sono in fiamme, tranne la sua, che comunque non durerà molto, dato il violento cannoneggiamento tedesco, al tramonto, e dice che non gli dispiace non
poter mai più vedere il sole, perché i concetti e i sentimenti in lui, in tutti quelli ai quali è toccata la medesima sorte, sono cambiati: la vita una disgrazia, la
morte una liberazione, il giorno terrore, la notte sollievo. La notte, infatti, impediva ai tedeschi di trovare i fuggiaschi, il giorno, invece, li consegnava ad essi.”
Milioni di persone –scrive– nel vasto mondo, innamorate del giorno, del sole e
della luce, non sanno affatto, non hanno alcuna idea di quanta oscurità ci
abbia portato il sole. Si è trasformato in uno strumento nelle mani degli scel-
SAGGI
di Pietro Birtolo
131
132
lerati, che se ne sono serviti come di un riflettore per scoprire le tracce dei fuggiaschi. Quando mi rifugiai nei boschi con mia moglie e i miei figli –erano in
tutto sei–, la notte ci nascondeva nel suo grembo: il giorno ci consegnava ai
nostri persecutori”2. Dice che mai dimenticherà quel giorno di tempesta di
fuoco tedesco su migliaia di profughi in cammino da Grodino a Varsavia in cui
morirono la moglie con il piccino di sette mesi tra le braccia e due figli, David,
di quattro anni, e Yehdah, di sei. Gli altri suoi tre figli morirono nel giro di un
anno nel ghetto di Varsavia: Rohele, una ragazzina di dieci anni, ammazzata
dai nazisti perché sorpresa al di là del muro del ghetto mentre cercava dei
pezzi di pane nei bidoni dell’immondizia, Yankev, un ragazzino di tredici anni,
morto di tubercolosi il sabato successivo al giorno del suo compleanno, il giorno del suo Bar mitzvah, cerimonia durante la quale il ragazzo viene chiamato
per la prima volta a leggere pubblicamente la Torah nella sinagoga, diventando, così, membro effettivo della comunità, con tutti i doveri religiosi che ciò
comporta, e Have, di quindici anni, uccisa in un rastrellamento di bambini
cominciato all’alba dell’ultimo Rush hashanah (capodanno ebraico, che viene
celebrato i primi due giorni del mese di tishri settembre-ottobre) e conclusosi
al calar del sole.
Yossl Rakover ha perso la moglie, i figli, i compagni, con i quali ha combattuto per nove giorni contro il nemico; non ha più munizioni, dai piani superiori della postazione, una delle ultime del ghetto, non possono mandargli
alcun aiuto, perché le scale sono state distrutte dalle cannonate e l’edificio è
sul punto di crollare. “Ora –scrive– è giunto il mio momento, e come Giobbe
posso dire di me, e non sono il solo a poterlo dire, che torno nudo alla terra,
nudo come nel giorno della mia nascita”3. E soggiunge: “Intanto però sono
ancora vivo, e al mio Dio, prima di morire, voglio parlare come un vivo, come
un semplice uomo, che vive e ha avuto il grande ma disgraziato onore di essere ebreo”4.
Si dichiara fiero di essere ebreo, perché essere ebreo “è un’arte […]. Non
è un’arte essere inglese, americano o francese. È forse più facile e più comodo essere uno di loro, ma certo non è più onorevole.
Sì, è un onore essere ebreo!”5 “Si nasce ebrei così come si nasce artisti.
Non ci si può liberare dall’essere ebrei. È stata una qualità divina insita in noi
ad aver fatto di noi un popolo eletto. Chi non lo comprende, non capirà mai il
significato più alto del nostro martirologio. ‘Non vi è cosa più intatta di un cuore
spezzato’ ha detto una volta un grande rabbino. E non vi è un popolo più eletto di uno sempre colpito. Anche se non credessi che un Dio ci abbia destinati
a diventare popolo eletto, crederei che ci abbiano resi eletti le nostre sciagure”6.
Dichiara di avere quarantatrè anni, di aver vissuto con onestà e amato Dio
con tutto il cuore. Dichiara inoltre che la sua fede in Dio non è cambiata minimamente, ma che è cambiato invece il suo rapporto con Lui, dopo aver visto
e subìto tante atrocità. Prima, quando viveva nel benessere e nella prosperità, dice che egli aveva con Dio il rapporto che si ha con un benefattore e che
cioè nei suoi confronti era sempre debitore, ora, invece, dopo tante disgrazie,
è Dio ad essere in debito con lui e di avere, perciò, il diritto di esigere ciò che
gli spetta. “Concedimi, Dio, prima di morire, ora che in me non vi è traccia di
SAGGI
paura e la mia condizione è di assoluta calma interiore e sicurezza, di
chiederTi ragione, per l’ultima volta nella vita”7. Non Gli chiede, come Giobbe,
di indicargli il peccato causa di così tremendi castighi, perché è convinto che
non si tratti più di un castigo per i peccati commessi, ma dell’occultamento del
volto divino: –scrive– ha nascosto il suo volto al mondo e in questo modo ha
consegnato gli uomini ai loro istinti selvaggi”8 e “quando la furia degli istinti
domina il mondo, chi rappresenta la santità e la purezza deve essere la prima
vittima”9.
Ammesso che non si tratti più di un castigo per i peccati commessi, quindi
di colpa e punizione, ma che Dio abbia nascosto il suo volto, abbandonando
gli uomini ai loro istinti selvaggi, ecco la domanda che gli brucia dentro come
un fuoco divorante: “Che cosa ancora, sì, che cosa ancora deve accadere perché Tu mostri nuovamente il Tuo volto al mondo?”10 E ancora: “Dove si trovano i confini della tua pazienza?”11 Confessa di crede in Lui più che mai, di
sapere che Egli è il suo Dio, poiché non può essere il Dio degli assassini, di
non poterlo lodare per le azioni che tollera, ma di benedirlo e lodarlo per la sua
stessa esistenza, per la sua terribile maestà, di riconoscerlo così grande e di
avvertire la propria piccolezza.
Intanto il cerchio della morte intorno a lui si stringe: dai piani superiori della
postazione gli spari si fanno sempre più isolati, segno che i difensori son quasi
tutti morti. Il sole è ormai al tramonto e ringrazia Dio che non dovrà rivederlo
mai più. Tra un’ora al massimo sarà con la sua famiglia e con milioni di altri
uccisi del suo popolo “in quel mondo migliore in cui non vi sono più dubbi e
Dio è l’unico pietoso sovrano”12.
Vicino alla sua mano destra giace morto un bambino con un sorriso, “quel
riso calmo, ma eloquente e sottile, così tipico delle persone molto sagge quando parlano di sapienza con chi non sa nulla ma crede di sapere tutto”13. Il bambino “sa già tutto, tutto gli è ormai chiaro, sa persino per quale ragione è nato
dovendo poi morire così presto, e perché è morto a soli cinque anni dalla
nascita. Ma se anche lo ignora, sa perlomeno che la questione è del tutto irrilevante e priva di significato dinanzi allo splendore con cui si manifesta la gloria divina, in quel mondo migliore dove ora si trova, forse tra le braccia dei suoi
genitori assassinati ai quali ha fatto ritorno”14. Fra qualche ora lo saprà anche
Yossl Rakover, sul cui volto, se non sarà sfigurato dal fuoco, forse vi aleggerà
lo stesso sorriso, dopo la sua morte. Fra poco, tutto sarà chiaro anche a lui.
Muore tranquillo, credente, colmo d’amore per Dio: “l’ho amato, –confessa– e ho continuato ad amarlo anche quando mi ha umiliato oltre ogni dire,
quando mi ha torturato a morte, quando mi ha esposto alla vergogna e allo
scherno”15. Confessa inoltre che nonostante Dio abbia fatto di tutto perché non
avesse più fiducia in Lui, perché non credesse più in Lui, muore così come è
vissuto, “pervaso di un’incrollabile fede in […] Lui”16. Gli chiede comunque di
“non tendere troppo la corda, perché, non sia mai, potrebbe spezzarsi”17, di
perdonare, dal momento che li ha sottoposti ad una prova così ardua, così
insostenibilmente ardua, quelli che si sono allontanati da Lui, quelli che hanno
bestemmiato il Suo nome, quelli che sono diventati indifferenti verso di Lui e
quelli che sono andati a servire altri dèi: “Tu li hai percossi a tal punto che non
133
134
credono più che tu sia il loro padre, che ci sia comunque un padre per loro”18.
All’inizio del suo discorso a Dio Yossl Rakover è esigente, Gli chiede ragione, vuole sapere, chiama in causa il suo silenzio di fronte alla sofferenza del
giusto: “esiste al mondo una colpa che meriti un castigo come quello che ci è
stato inflitto? […]. “Esiste al mondo una punizione che possa fare espiare il crimine commesso contro di noi? […]. Dove si trovano i confini della tua pazienza?”19 Alla fine muore tranquillo, credente, colmo d’amore per Dio.
Non si tratta di una ribellione a Dio, ma dello sfogo di un immenso dolore
e del diritto di sapere. “Ti voglio dire in modo chiaro e aperto –dichiara Yossl
Rakover a Dio– che ora più che in qualsiasi tratto precedente del nostro infinito cammino di tormenti, noi torturati, disonorati, soffocati, noi sepolti vivi e
bruciati vivi, noi oltraggiati, scherniti, derisi, noi massacrati a milioni, abbiamo
il diritto di sapere”20. È il diritto che ogni uomo reclama, l’ordinario diritto della
verità.
Anche Giobbe, la cui pazienza nella sofferenza era già proverbiale sin dagli
inizi dell’èra cristiana, come è attestato nella Lettera di San Giacomo21, reclama lo stesso diritto e non esita a porsi di fronte a Dio in terminini di radicalità:
”Dico a Dio: non mi condannare! Fammi sapere perché mi contrasti!”22 Qui la
suprema probità intellettuale e spirituale di Giobbe. Egli vuol capire perché Dio
lo fa soffrire. Si sfoga con Dio e Gli chiede ragione del suo agire. La sincera
ricerca della verità lo spinge a porsi di fronte a Dio in termini di radicalità.
Di qui la protesta: “Quanti sono i miei delitti e i miei peccati? La mia colpa
e il mio peccato fammeli conoscere”23. Ai suoi amici Elifaz, Baldad e Sophar
che, avendo saputo della sciagura che si era abbattuta su di lui, erano venuti
a visitarlo per consolarlo dice: “Tacete! Via da me! Parlerò io: e avvenga su me
qualunque cosa!”24. “I vostri argomenti sono prove di cenere, difese d’argilla
sono le vostre difese”25. “Nelle vostre rimane solo la perfidia”26. La protesta è
ulteriormente radicalizzata dalla sua riflessione sulla brevità e fugacità della
vita umana: “L’uomo nato di donna, è breve di giorni, ma sazio d’affanno: qual
fiore egli spunta e avvizzisce e fugge come un’ombra, né mai si ferma. […].
L’uomo muore: tutto è finito: spirato che sia, dov’è più?”27 Qui Giobbe osa: è
contro questo uomo che Dio infierisce? Questo suo osare suscita la netta condanna dei suoi amici teologi e il verdetto di Elifaz: “Tu distruggi la religione e
abolisci la preghiera innanzi a Dio”28.
Gli amici cercano di convincerlo che se è stato colpito da Dio certamente è
peccatore, perché, secondo la sapienza antica, di cui essi si ritengono depositari, premio e castigo nella vita terrena si coniugano con rettitudine e iniquità; perciò, chi fa il bene ha il bene, chi fa il male ha il male, il giusto avrà sempre ragione, mentre il malvagio sarà punito e perirà. Per avvalorare questa
teoria –Dio infligge il male solo ai cattivi– non esitano ad accusare Giobbe di
peccati da lui mai commessi: “Non è forse grande la tua malvagità, –gli dice
Elifaz– e non sono senza fine i tuoi delitti? Senza motivo hai angariato i tuoi
fratelli, e hai spogliato delle vesti gli ignudi, non hai dato da bere all’assetato
e all’affamato tu negato il pane. La terra l’ha voluta il prepotente, e il favorito
l’ha potuta abitare. Le vedove hai rimandato a mani vuote, e le braccia degli
orfani tu hai spezzato. Perciò dei lacci sono a te d’intorno, e ti sorprende
SAGGI
improvviso il terrore”29. Sophar l’accusa di peccati interni a lui sconosciuti ma
non a Dio: “Tu dici: ‘Sincera è la mia condotta, puro sono io agli occhi miei’”.
Invece, oh! se Dio parlasse, e aprisse le sue labbra (a ragionar) teco, e rivelasse a te i segreti della sapienza, –come ne sono molteplici i consigli!– conosceresti allora che Dio oblia parte del tuo diritto […]”30.
Ad essi Giobbe si oppone fermamente dimostrando ostinatamente la sua
innocenza”31. Nel capitolo 31 dimostra la sua innocenza: “Un patto avevo stretto coi miei occhi, di non fissare vergine alcuna. E quale porzione mi destina
Dio dall’alto, e quale eredità l’Onnipotente dall’eccelso? Non forse la rovina
riserbata al disonesto, e la sventura al disonesto, e la sventura per chi commette il peccato? Non vede Egli forse la mia condotta, e tutti i passi miei non
conta? Se camminai con falsità e dietro alla frode corse il mio piede: mi pesi
Dio con bilance di giustizia, e conoscerà la mia integrità! Se si sviò il mio passo
e dietro agli occhi miei andò il mio cuore e alle mie palme si attaccò una macchia di infamia, semini io, mangi pure un altro, e le mie piantagioni vadano
divelte! Se il mio cuore fu sedotto da una donna, e alla porta del mio vicino
stetti a spiare: macini per un altro la mia moglie, e sopra lei si curvino altri!
Poiché e ben questa un’infamia, un delitto da condannarsi dai giudici, è un
fuoco che divora fino alla distruzione e che tutto il mio raccolto avrebbe consumato! Se disprezzai il diritto del mio servo e della mia ancella, nelle loro controversie con me: che cosa potrei fare quando sorgesse Dio, e giudicasse, che
cosa gli risponderei? Chi fece me nel seno materno, non fece forse (anche)
lui, e non ci formò dentro all’utero uno stesso Creatore? Fui forse insensibile
al desiderio del meschino, e gli occhi della vedova lasciai languire? Mangiai
forse da solo il mio boccone e non ne feci parte all’orfanello? Poiché Dio, fin
dalla mia giovinezza, mi educò qual padre, e fin dal seno materno mi guidò.
Se vidi un disgraziato senza ceste, e un mendico senza che coprirsi, forse non
mi benedirono i suoi fianchi e della lana delle mie pecore non si scaldò? Se
contro un innocente alzai la mano, vedendo presso la porta chi m’avrebbe aiutato, si stacchi la mia spalla dalla nuca e il mio braccio dall’omero si spezzi.
Poiché temevo il giudizio di Dio, e alla sua maestà non avrei potuto reggere”32. E ancora: Se riposi nell’oro la mia fiducia e all’oro fine dissi: ‘Tu sei la mia
speranza!’ se mi rallegrai perché grandi erano i miei beni, e molto aveva accumulato la mia mano, se contemplai il sole che fulgeva la luna splendente che
avanzava, e fu sedotto in segreto il mio cuore, e mandai baci con la mano alla
bocca: anche questo sarebbe stato un misfatto capitale poiché avrei rinnegato Dio che sta in alto!
Mi rallegrai forse della sventura di chi m’odiava e godei perché un malanno l’incolse? e (piuttosto) non permisi che la mia bocca peccasse chiedendo
la sua morte con imprecazioni? La gente della mia tenda non ha forse detto:
‘Chi della mia mensa non si è sfamato?’ Fuori non pernottò il forestiero e le
mie porte al viandante si aprivano. Non ho occultato, come un vile, il mio delitto, nascondendo nel mio petto la mia iniquità, poiché temevo la gran folla e lo
sprezzo delle famiglie mi spaventava: ammutolirei e non uscirei dalla porta. Se
contro di me gridò il mio terreno e insieme piansero i miei solchi, se il suo prodotto mangiai senza pagare e l’anima dei suoi padroni feci sospirare, invece
135
136
di grano spuntino le spine, e invece d’orzo nascano le erbacce! Ecco il mio tau!
L’Onnipotente mi risponda”33. Ed ecco il grido di fiducia nella propria innocenza: “Oh! S’io avessi chi mi ascoltasse! Il libello che scrivesse il mio avversario
sulla mia spalla io l’alzerei, e me lo cingerei come una corona! Del numero dei
miei passi io gli darei conto e (fiero) qual principe a lui mi avvicinerei!”34.
Ai suoi amici teologi Giobbe si oppone inoltre facendo rilevare che non è
vero che la rettitudine porti sempre salute e prosperità e che, anzi, spesso, i
buoni sono tribolati, mentre i malvagi trionfano e prosperano”. Perché mai gli
empi vivono, invecchiano, son pur forti in vigore? La loro stirpe prospera attorno a loro e i loro rampolli sono sotto i loro occhi: le loro case sono in pace,
senza timori, né la verga di Dio li raggiunge. Il loro toro è sempre fecondo, la
loro vacca figlia e non abortisce. Lascian liberi, come gregge, i loro ragazzi, e
i loro fanciulli saltellano festosi. Cantano al suono del timpano e della cetra, e
si divertono al suono del flauto. Trascorrono felici i loro giorni […]. Non è forse
la fortuna nelle loro mani?”35. Giobbe respinge la teoria meccanica, diffusa
presso gli ebrei, prima del tempo, in cui fu composto il libro di Giobbe, secondo la quale chi fa il male ha il male, chi fa il bene ha il bene (beni materiali,
fecondità, discendenza numerosa, vittoria contro i nemici). Giobbe dimostra
che Dio tribola anche l’innocente: “Egli lascia perire l’innocente e il reo.
Quando la sferza sua dà morte repentinamente, della disperazione degli innocenti ei si beffa […]. E i miei dì passarono più veloci di un corriere, fuggirono
via, non videro la felicità, trascorsero oltre quasi vascelletti di canna, come l’aquila che piomba sulla preda”36.
Insoddisfatto dei suoi amici, Giobbe chiede a Dio di discutere direttamente
con Lui di tutto questo. “Allora il Signore rispose a Giobbe di mezzo alla tempesta e disse: ‘Chi è costui che ottenebra il (mio) consiglio con parole prive di
cognizione? Cingi qual prode i tuoi lembi ed io t’interrogherò e tu m’istruirai!
Ov’eri tu, quando mettevo base alla terra? Parla, se possiedi tanta intelligenza. Chi fissò le sue dimensioni, che tu sappia, e chi distese sovr’essa la
corda? […]. E (chi) rinchiuse con porte il mare, quando erompendo dall’utero
uscì? […]. Hai tu contemplato l’ampiezza della terra? Parla, se conosci tutto
questo!”37 “Sai tu forse il tempo del figliar delle camozze e le doglie del parto
delle cerve tu osservi? Conti tu i mesi della loro gravidanza e sai il tempo che
esse partoriscono? […]. Chi ha dato libertà all’onagro, e i legami dell’asino selvatico chi li sciolse, cui Io assegnai il deserto per abitazione e qual sua dimora una terra salmastra? […]. Consentirà forse il bufalo di servirti, o pernottare
alla tua greppia? […]. Dai tu forse al cavallo vigorìa, adorni forse il suo collo di
criniera?”38. Di fronte alla sapienza creatrice di Dio Giobbe riconosce la propria
impotenza: “Ecco, meschino son io: che cosa potrei a Te replicare? Mi pongo
la mano sulla bocca! Una volta ho parlato, ma non ricomincerò, due volte, ma
non continuerò!”39 Dio parla ancora: “Ecco, l’ippopotamo, che io ho creato al
pari di te: di erba, come un bove, egli si ciba, eppure, ecco, qual forza ha nei
suoi lombi, qual potenza nei muscoli del suo ventre! Drizza la sua coda come
un cedro, i tendini delle sue cosce son ben intrecciati, le sue ossa son tubi di
bronzo, le sue costole son come spranghe di ferro […]. Chi potrà avvicinarlo
nelle sue occhiaie, forargli le narici coi giavellotti?”40. E soggunge: “Puoi tu
SAGGI
prendere con l’amo il coccodrillo e con funi legarne la lingua? Metterai forse
un giunco nelle sue nari e con un uncino bucherai la sua mascella? […]. Forse
crivellerai con dardi la sua pelle e con fiocina la sua testa?”41 Giobbe riconosce la propria impotenza innanzi alla forza bruta di questi due animali. Di fronte alla creazione, all’ordinamento dell’universo e al dominio che solo Dio ha
sugli elementi e sopra di esseri viventi i più indomiti per l’uomo, Giobbe riconosce che Dio può tutto ed è al di sopra di ogni comprensione umana, e ritratta le sue parole: “e come potrebbe aver ragione l’uomo di fronte a Dio?42
“Perciò ho parlato, senza discernimento, di cose troppo mirabili per me, senza
che le capissi […]. Per udito avevo saputo di te, ma ora l’occhio mio ti ha visto,
perciò io mi ritratto, e faccio penitenza in polvere e in cenere”43.
Giobbe riafferma la fede in Dio, nella cui sapienza il problema della sofferenza dell’innocente trova certamente una spiegazione, che tuttavia per l’uomo rimane imperscrutibile.
L’atteggiamento laico e profano, la protesta, che è sincera ricerca della
verità (Dio giusto e buono) che non contrasta con la realtà (la tragica esperienza di vita, la sciagura abbattutasi su di lui), si fa religioso. La ragione laica,
indagatrice, accetta il mistero, in cui e da cui il problema del male è avvolto, si
fa fede: Dio è grande e al di sopra di ogni comprensione umana e governa il
mondo secondo disegni imperscrutabili dall’uomo, compreso il dolore umano.
Dio elogia Giobbe, perché rivendica i diritti della verità anche al suo cospetto. Giobbe vuol capire, non può accettare la soluzione prospettatagli dagli
amici-teologi” La probità intellettuale perseguita fino in fondo, al costo di soccombervi: ecco la virtù di Giobbe, quel che ne fa un vertice insuperabile dello
spirito umano, e che lo rende accetto a Dio; non già la pazienza nè la rassegnazione suggeritegli dagli amici teologi”44. “Il Signore ebbe riguardo a
Giobbe”45, mentre condanna e punisce i suoi amici teologi: “la mia ira –dice a
Elifaz– si è accesa contro di te e contro i tuoi amici, perché non avete detto di
me la verità come il mio servo Giobbe”46.
Gli amici teologi sono puniti, perché mentono, sia pure in favore di Dio per
giustificarne l’operato, ma la menzogna è sempre un male e Dio non l’approva. Non rinunciano alle proprie idee, chiudono gli occhi alla realtà, si mantengono costantemente nel loro pensiero, intransigenti non sopportano contraddizioni e, davanti alle proteste di innocenza di Giobbe, riaffermano con vigore
il principio: chi è colpito da disgrazia è peccatore. Depositari della sapienza
antica, in virtù di questa certezza e solidità, difendono una verità che contrasta con la realtà, la tragica esperienza di vita di Giobbe, la verità della situazione nella quale è stato gettato.
“Di fronte ai discorsi degli amici, saturi di certezze, e della solidità di chi ritiene di possedere la verità collaudata dall’esperienza storica, Giobbe è preso tra
due fuochi: da un lato, la sapienza di cui egli stesso è considerato maestro e
che ha costantemente professato, dall’altro l’imperiosa esigenza di non tradire
la verità della situazione nella quale è stato gettato”47. Alla fine compie la scelta, che è follia per la sapienza dei padri, attraverso i suoi amici, di seguire la
verità e così taglia completamente i legami con la sapienza antica. Non la può
più accettare, perché non può soffocare la voce potente della coscienza, che lo
137
138
dichiara innocente. Dio, infatti, lo riconosce tale e gli raddoppia la passata prosperità, mentre condanna e punisce i suoi amici teologi, perché difendono il
comodo involucro di una verità che è ideologia religiosa. “Prendete dunque
–dice Dio ad essi– sette vitelli e sette montoni e andate dal mio servo Giobbe
ed offritegli in olocausto per voi; e il mio servo Giobbe farà orazione per voi:
così io, per riguardo a lui, non vi farò scontar la pena della vostra stoltezza, per
non aver detto di me la verità come il mio servo Giobbe”48. E Dio “ristabilì
Giobbe nello stato di prima per avere egli fatta orazione per i suoi, aumentando anzi del doppio tutto quello che Giobbe possedeva prima”49. È da sottolineare questo esercizio di carità di Giobbe: egli prega per quelli che lo avevano
definito il distruttore della religione e l’avevano fatto oggetto d’ironia e di disprezzo. Dio li salva proprio grazie all’intercessione, alle orazioni di Giobbe.
Dopo questo doveroso riferimento a Giobbe, ritorniamo al testo di Yossel
Rakover. Anch’egli come Giobbe, vuol capire perché Dio tribola l’innocente.
Emmanuel Lévinas rileva che il pensiero che emerge da quel testo è proprio questo: “Che cosa significa questa sofferenza degli innocenti?” 50.
Rileva altresì che “esso testimonia un atteggiamento intellettuale molto più
illuminante di certe letture d’intellettuali, e dei concetti attinti, per esempio, dai
testi di Simone Weil, ultimo grido della terminologia religiosa, come tutti sanno
a Parigi”51, “rivela una scienza ebraica, pudicamente dissimulata ma sicura, e
rispecchia un’esperienza di vita spirituale profonda e autentica” 52.
Oltre al tema della sofferenza, Lévinas osserva che in quel testo è ben
messo in rilievo l’occultamento del volto di Dio ed è ben sottolineato l’amore
per la Torah. La sofferenza –scrive– “rivela un Dio che, rinunciando ad ogni
manifestazione pietosa, fa appello alla piena maturità dell’uomo totalmente
responsabile”53. La responsabilità dell’uomo è il leit motiv della filosofia lévinasiana. “La responsabilità –afferma Lévinas– è un’individuazione, un principio
di individuazione. Riguardo al famoso problema: «l’uomo è individuato per
mezzo della materia o per mezzo della forma?», io sostengo l’individuazione
per mezzo della responsabilità per altri”54. In questa responsabilità per altri
sono l’eletto. L’elezione non è affatto un privilegio: “è piuttosto la caratteristica
fondamentale della persona umana, in quanto moralmente responsabile”55.
Per quanto riguarda l’occultamento del volto di Dio, rileva che Dio che
nasconde il volto “viene dal di dentro. Un’intimità che coincide, per la conoscenza, con la fierezza di essere ebreo, di appartenere concretamente, semplicemente al popolo ebraico”56. Yossl Rakover, a proposito, scrive: “Ritengo
che essere ebreo significhi essere un combattente, uno che nuota senza tregua contro una sordida, malvagia corrente umana”57. L’intimità che Dio si conquista combattendo, attraverso una prova estrema: la sofferenza. Poiché
appartiene al popolo ebraico che soffre, il Dio lontano diventa il suo Dio: “Ora
so che sei il mio, poiché di certo non sei, no, non puoi essere il Dio di quanti,
con le loro azioni, hanno dato la prova più atroce di empietà in armi”58.
Sottolinea la differenza tra il suo Dio e il Dio venerato dai popoli d’Europa:
“benché il nostro Dio –scrive– sia il Dio della vendetta, e nella nostra legge
abbondino le minacce di morte per le più piccole colpe, tuttavia si racconta
nella Gemara che era sufficente che il Sinedrio, il più alto tribunale del nostro
SAGGI
popolo quando era libero nella sua terra, pronunciasse una sola condanna a
morte in settant’anni, perché si potesse gridare ai giudici: “Assassini!”. Il Dio
dei popoli invece, che viene chiamato Dio d’amore, ha condannato di amore
ogni essere creato a sua immagine; ma nel suo nome veniamo assassinati
senza pietà, giorno dopo giorno, da duemila anni”59. Dio che nasconde il volto,
dunque, è riconosciuto come presente e intimo. Secondo Lévinas, non siamo
di fronte a una costruzione metafisica, né a un salto mortale paradossale di
gusto kierkegaardiano. “Noi pensiamo –scrive– che qui si riveli, al contrario, la
fisionomia particolare dell’ebraismo: il rapporto tra Dio e l’uomo non è comunanza di sentimenti d’amore per un Dio incarnato, ma relazione tra spiriti:
intermediario un insegnamento, la Torah. È proprio una parola, non incarnata
da Dio, che garantisce la presenza di un Dio vivente in mezzo a noi”60.
“Dio si concreta non mediante l’incarnazione, ma mediante la Legge”61. La
fiducia di Dio “non può riposare che sull’evidenza interiore e sul valore di un
insegnamento. […]. Ma soprattutto, fiducia che non riposa sul trionfo di un’istituzione, evidenza interiore della morale contenuta nella Legge”62.
Yossl Rakover dice di amare Dio, ma di più la sua Legge: “continuerei a
osservarla –afferma– anche se perdessi la mia fiducia in lui”63. Dice anche di
“essere felice di appartenere al più infelice di tutti i popoli della terra, la cui
Legge rappresenta il grado più alto e più bello di tutti gli statuti e le morali”64.
Dichiara di amare di più la Legge, perché essa “rappresenta un modello di vita,
e quanto più moriamo in nome di quel modello di vita, tanto più esso diventa
immortale”65.
Questo suo amore per la Legge, per la Torah, termine ebraico con cui sono
chiamati i primi cinque libri della Bibbia, Il Pentateuco (Genesi, Esodo,
Levitico, Numeri, Deuteronomio), è ben sottolineato da Lévinas. “Amare la
Torah ancor più che Dio –scrive– è per l’appunto accedere a un Dio personale contro il quale ci si può rivoltare, per il quale, cioè, si può morire”66.
Yossl Rakover muore tranquillo con una incrollabile fede in Dio e nella sua
Legge. Il male non è motivo di allontanamento da Dio o di negazione della sua
esistenza.
Il male rientra nei disegni secondo i quali Dio governa il mondo, imperscrutabili dall’uomo. Dio stesso dice: “I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le
vostre vie non sono le mie vie”67. E San Paolo scrive: “O abisso insondabile
della sapienza e scienza di Dio! Quanto sono impenetrabili i suoi segreti e inesplorabili le sue vie!”68. E ancora: “O uomo, piuttosto chi sei tu che vuoi discutere con Dio? Il vaso d’argilla chiederà forse a chi l’ha formato: Perché mi hai
fatto così? Il vasaio non è forse padrone dell’argilla e non ha diritto a fare della
stessa massa un vaso di onore e un altro per usi vili?”69. Perciò, non ha senso
ribellarsi a Dio o peggio negarlo. Le ideologie atee strumentalizzano questo difficile e toccante problema del male per diffondere più agevolmente l’ateismo.
Yossl Rakover riafferma la fede in Dio, come Giobbe, Lo prega (esercizio
di carità) di non punire quelli che, non reggendo la prova, si sono allontanati
da Lui, come Giobbe che prega per i suoi amici teologi, in più spera che Dio
“presto mostrerà di nuovo il suo volto al mondo, e ne scuoterà le fondamente
con la sua voce onnipotente”70.
139
Yossl Rakover muore in pieno possesso della fede, della speranza e della
carità, le tre virtù cardinali proprie del cristiano.
140
1 Zvi Kolitz, Yossl Rakover si rivolge a Dio, Milano, Adelphi, 1997.
2 Ivi, p. 13.
3 Ivi, pp. 15-16.
4 Ivi, p. 22.
5 Ibid.
6 Ivi, p. 23.
7 Ivi, pp. 23-24.
8 Ivi., p. 17.
9 Ibid.
10 Ivi, p. 24.
11. Ibid.
12 Ivi, p. 27
13 Ivi, P; 21.
14 Ivi, pp. 21-22.
15 Ivi, p. 28.
16 Ivi, p. 29.
17 Ivi, p. 24.
18 Ivi, p. 25.
19 Ivi, p. 24.
20 Ibid.
21 “Fratelli, prendete a modello di sofferenza e di pazienza i profeti, che hanno parlato a nome del
Signore. Vedete, noi diciamo felici quei che hanno sofferto con pazienza. Voi avete sentito parlare della pazienza di Giobbe e conoscete la fine felice che gli concesse il Signore, perché egli è
pieno di misericordia e di compassione” (Lettera di S. Giacomo, 5, 10-11).
22 Giobbe.
23 Ivi, 13, 23.
24 Ivi, 13, 13.
25 ivi, 13, 12.
26 Ivi, 21, 34.
27 Ivi, 14, 1-2; 14, 10.
28 Ivi, 15, 4. Gli dice inoltre Elifaz: “Fosti tu il primo degli uomini ad esser generato, e prima dei
colli fosti tu partorito? Hai tu forse assistito al consiglio di Dio e accaparrata per te la sapienza?
Che cosa sai tu che noi non sappiamo, che cosa capisci tu che noi non comprendiamo? Anche il
canuto, anche il vecchio è fra noi, carico, più che tuo padre, di giorni. Son forse poca cosa per te
le consolazioni di dio, una parola benigna a te rivolta? Dove ti trasporta il tuo cuore, e come sono
stravolti i tuoi occhi, quando rivolgi contro dio la tua animosità, e fai uscire dalla tua bocca tali
parole! Che cosa è l’uomo perché sia puro, e perché sia giusto il generato di donna? Eco, nei suoi
santi ei non ha fiducia, e i cieli non sono puri agli occhi suoi: quanto più un, essere abominevole
e corrotto, l’uomo –che beve come acqua l’iniquità” (Op. cit., 15, 7-15).
29 Ivi, 22, 5-10.
30 Ivi, 11, 4-6.
31 Ivi, 27, 5.
32 Ivi, 31, 1-23.
33 Ivi, 31, 24-37.
34 Ivi, 31, 38-40.
35 Ivi, 21, 7-16.
SAGGI
36 Ivi, 9, 22-26.
37 Ivi, 38, 1-18.
38 Ivi, 39, 1-19.
39 Ivi, 40, 4-5.
40 Ivi, 40, 15-24.
41 Ivi, 40, 25-31.
42 Ivi, 9, 2. Qualora egli potesse contener con Lui, questi non gli potrebbe rispondere una volta
su mille! Sapiente di cuore e gagliardo di forza, –chi mai si ostinò contro Lui e rimase incolume?
Sposta egli i monti, n- alcun se n’avvede, e li sconvolge nell’ira sua. Scuote la terra dal suo luogo
e le sue colonne tramano. Dà un comando al sole –e non spunta,– e per le stelle ei pone un suggello.… Compie egli cose grandi, che non si comprendono, opere mirabili –che non si contano.
Ecco: egli pass davanti a me, non lo vedo, scorre oltre, né m’accorgo di lui. … Quand’anche avessi ragione, non saprei rispondergli, al giudice mio chiederei pietà” (Op. cit. 9, 3-15).
43 Ivi, 42, 3-6.
44 G. M. Pizzuti, Il Dio di Giobbe, in Id, L’eredità teo-logica del pensiero occidentale: Auschwitz,
Soveria Mannelli, Rubettino, 1997, p. 227.
45 Giobbe, 42, 9.
46 Ivi, 42, 7. L’itinerario di Giobbe è “segnato da un incessante, progressivo agonizare pro veritate che conduce, al prezzo di una angoscia che è quasi la morte, all’autenticità del rapportarsi a
Dio, là dove le parole che sono ritenute bestemmia dai teologi si rivelano essere l verità sconvolgente di Dio, e le parole che sono ritenute sacre dai sapienti sono oggetto di una condanna senz’appello da parte di Dio” (G. M. Pizzuti, Il Dio di Giobbe, cit., p; 227).
47 Ivi, p. 224.
48 Giobbe, 2, 8.
48 Ivi, 42, 10.
50 E. Levinas, Amare la Torah più di Dio, in Zvi Kolitz, Yossl Rakover si rivolge a Dio, cit., p. 86.
51 Ivi, pp. 85-86.
52 Ivi, p. 86.
53 Ivi, p. 88.
54 E. Levinas, Filosofia, giustizia e amore, in E. Levinas, Tra noi, Milano, Jaca Book, 1998, p. 143.
55 Ibid.
56 E. Levinas, Amare la Torah più di Dio, cit., p. 88.
57 Zvi Kolitz, Yossl Rakover si rivolge a Dio, cit., p. 22. “L’ebreo è un eroe, un martire, un santo”
(Ibid.).
58 Ivi, p. 25.
59 ivi, pp. 18-19.
60 E. Levinas, Amare la Torah più di Dio, cit. p; 89.
61 Ivi, p. 90.
62 Ivi, p. 89.
63 Zvi Kolitz, Yossl Rakover si rivolge a Dio, cit., p. 23.
64 Ivi, p. 22.
65 Ivi, p. 23.
66 E. Levinas, Amare la Torah più di Dio, cit., p. 91.
67 Isaia, 55, 8.
68 S. Paolo Apostolo, Lettera ai Romani, 11, 33.
69 Ivi, 9, 20-21.
70 Zvi Kolitz, Yossl Rakover si rivolge a Dio, cit., p. 29.
141
142
143
SAGGI
144
145
SAGGI
146
147
SAGGI
148
149
SAGGI
150
151
SAGGI
152
153
SAGGI
154
155
SAGGI
156
157
SAGGI
158
159
SAGGI
160
161
SAGGI
162
163
SAGGI
164
165
SAGGI
166
167
SAGGI
168
169
SAGGI
170
171
SAGGI
172
173
SAGGI
174
175
SAGGI
176
177
SAGGI
178
179
SAGGI
180
181
SAGGI
182
183
SAGGI
184
185
SAGGI
186
187
SAGGI
188
189
SAGGI
190
191
SAGGI
192
193
SAGGI
194
195
SAGGI
196
197
SAGGI
198
199
SAGGI
200
201
SAGGI
202
203
SAGGI
204
205
SAGGI
206
207
SAGGI
208
209
SAGGI
210
211
SAGGI
212
213
SAGGI
214
215
SAGGI
216
217
SAGGI
218
219
SAGGI
220
221
SAGGI
222
223
SAGGI
224
225
SAGGI
226
227
SAGGI
228
229
SAGGI
230
231
SAGGI
232
233
SAGGI
234
235
SAGGI
236
237
SAGGI
238
239
SAGGI
240
241
SAGGI
242
243
SAGGI
244
245
SAGGI
246
247
248
SAGGI
249
250
SAGGI
251
252
SAGGI
253
254
SAGGI
255
256
SAGGI
257
258
SAGGI
259
260
SAGGI
261
262
SAGGI
263
264
SAGGI
265
266
SAGGI
267
268
SAGGI
269
270
SAGGI
271
272
SAGGI
273
274
SAGGI
275
276
SAGGI
277
278
SAGGI
279
280
SAGGI
281
282
SAGGI
283
284
SAGGI
285
286
SAGGI
287
288
SAGGI
289
290
SAGGI
291
292
SAGGI
293
294
SAGGI
295
296
SAGGI
297
298
SAGGI
299
300
SAGGI
301
302
SAGGI
303
304
SAGGI
305
306
SAGGI
307
308
SAGGI
309
310
SAGGI
311
312
SAGGI
313
314
SAGGI
315
316
SAGGI
317
318
SAGGI
319
320
SAGGI
321
322
SAGGI
323
324
SAGGI
325
326
SAGGI
327
328
SAGGI
329
330
SAGGI
331
332
SAGGI
333
334
SAGGI
335
336
SAGGI
337
338
SAGGI
339
340
SAGGI
341
342
SAGGI
343
344
SAGGI