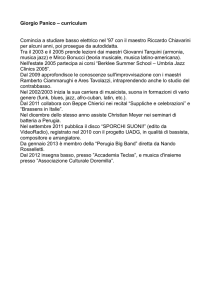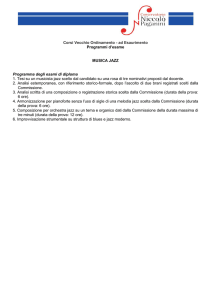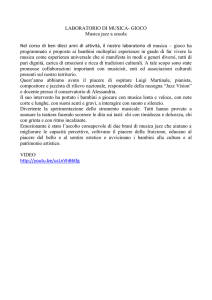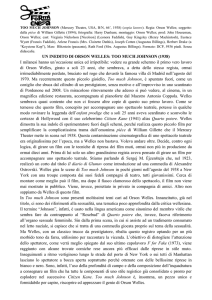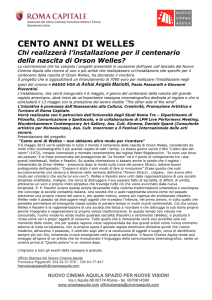AlbaNacinovich
lamusica
èmagia
la Voce
del popolo
spettacoli
www.edit.hr/lavoce
Anno 1 • n. 5
martedì, 24 novembre 2015
ANNIVERSARI
CINEMA
Celebriamo il grande
Jean Sibelius
L’influsso dell’opera
di Edgar Allan Poe
Ricorre quest’anno
il 150.esimo della nascita
del compositore finlandese
2
IL PERSONAGGIO
3
Il padre del racconto horror
ha ispirato numerosi adattamenti
cinematografici
RECENSIONE
Un ritratto del regista
Orson Welles
Il film «La teoria
del tutto»
Cent’anni fa nasceva uno
dei maggiori geni
della cinematografia americana
Una versione idealizzata
dello straordinario percorso
di vita di Stephen Hawking
6|7
8
2
martedì, 24 novembre 2015
ANNIVERSARI
spettacoli
a cura di Patrizia Venucci Merđo
|| Una vecchia
banconota
finlandese con il
volto di Sibelius
la Voce
del popolo
SI CELEBRANO
QUEST’ANNO I 150
ANNI DELLA NASCITA
DI JEAN SIBELIUS,
IL MASSIMO
COMPOSITORE
FINLANDESE
LO SPIRITO FINLANDESE
IN RAFFINATE MELODIE
I
n occasione dei centocinquant’anni
della nascita di Johan Julius Christian
Sibelius (Hämeenlinna, 8 dicembre
1865 - Jävenpää, 20 settembre 1957.)
il Teatro Nazionale Croato “Ivan de
Zajc” di Fiume ha reso omaggio a
questo compositore, massimo musico
finlandese e il più importante sinfonista
scandinavo, eseguendo in una serata
sinfonica il Concerto in re minore per
violino e orchestra e la sua Seconda
sinfonia. Una serata di successo, diretta
da Ville Matvejeff, con Marco Graziani
in veste di solista, che è stata l’imput per
indagare, a vantaggio dei nostri lettori, la
vasta produzione di Sibelius imperniata
principalmente sullo spirito e la cultura
del suo paese natio, riletti e trasfigurati
tuttavia attraverso il suo personale modo
di sentire e la propria immaginazione.
Figlio di svedesi - il padre era medico
- nacque nel Granducato di Finlandia,
all’epoca sotto il dominio russo e la sua
lingua madre fu il svedese. La sua famiglia
però decise consapevolmente di mandare
Jean in una scuola di lingua finlandese.
Si aggregò al movimento dei fennomani,
un’espressione del nazionalismo romantico
che sarebbe diventata una parte cruciale
della produzione artistica e delle idee
politiche di Sibelius. Abbandonati gli studi
di giurisprudenza, studiò musica a Berlino
e a Vienna. La sua opera, sebbene di non
facile collocazione stilistica, subì dapprima
l’influenza di Wagner, sebbene Ferruccio
Busoni e Čajkovskij abbiano segnato la
sua personalità musicale in maniera più
importante. Autore di poemi sinfonici
ispirati al poema nazionale “Kalevala”,
scrisse sette sinfonie, oltre cento Lieder per
voce e pianoforte, musiche di scena per
13 drammi, un’opera (Jungfrun i tornet),
musica da camera tra cui un quartetto
d’archi, musica per pianoforte, musica
corale e musica rituale massonica.
In questa sede ci limiteremo a passare in
rassegna alcune delle composizioni più
significative di Sibelius onde cercare di
approfondire le loro caratteristiche di base.
Le sette sinfonie
Nella lunghissima vita di Sibelius le
sette Sinfonie coprono un arco di tempo
di appena venticinque anni: eccetto la
Prima, esse nacquero tutte nel primo
quarto del secolo scorso, il Novecento.
Ciononostante si continua a considerarle
nel loro complesso rappresentative del
tardo Ottocento, nell’alveo delle scuole
nazionali, come il loro autore: una sorta di
Čajkovskij finnico.
Per quanto Sibelius appartenesse alla
generazione di Strauss, Mahler, Debussy
e Busoni (tutti nati a cavallo del 1865,
l’anno di nascita di Sibelius), risulta
storicamente arduo inquadrarlo a pieno
titolo in una delle tendenze della crisi o
del cambiamento da cui sarebbe nata la
musica moderna: nella cui genealogia si
stenta infatti a collocarlo. Se da un lato la
stessa definizione di lui come esponente
del nazionalismo romantico ottocentesco si
rivela inadeguata, non foss’altro per motivi
cronologici, dall’altro lato l’incidenza della
musica popolare finlandese in queste
opere, per quanto chiara, non giunse mai a
essere determinante nel senso in cui lo fu
per esempio per Bartók quella ungherese,
Society ed eseguito per la prima volta il
26 dicembre dello stesso anno sotto la
direzione di Walter Damrosch, “Tapiola”
è l’ultimo poema sinfonico scritto da
Jean Sibelius. Al pari di altri, si ispira
al “Kalevala”, il poema epico nazionale
finlandese caro al compositore; Tapio,
nella mitologia finnica, è il dio delle foreste
e Tapiola è la sua dimora, celata tra un
fitto e cupo intrico di alberi e vegetazione.
Il poema si basa sulla forma della
variazione, con una ripartizione in
introduzione, tema con sette variazioni
e coda; allo stesso tempo, tuttavia,
la composizione mostra una forma
quadripartita che porta a ritenere
l’esistenza di una correlazione con la strofa
di quattro versi apposta da Sibelius sulla
partitura: “Là si stendono ampiamente
le cupe foreste del Nord/, antichissime,
misteriose, meditando i loro sogni selvaggi:/
abita in esse il grande Dio delle Foreste/
e gli spiriti silvani tessono magici segreti
nell’oscurità”.
Il carattere descrittivo e programmatico
del poema sinfonico riesce particolarmente
congeniale al compositore finlandese,
giacché Sibelius si dimostra in quest’opera
come un sommo maestro della variazione;
tutti i temi e i motivi, per quanto possano
differire nei rispettivi caratteri, nascono
da un’unica cellula germinale. I moventi
leggendari e mitici vengono esaltati
da una fluida invenzione melodica e
da una smagliante e sempre cangiante
orchestrazione.
Il concerto per violino
|| La prima pagina del Concerto per violino
ossia quale spinta alla rifondazione del
linguaggio su basi strutturali avanzate:
essa rimase vagheggiamento ed evocazione
di atmosfere suggerite dall’anima della
natura, poeticamente trasfigurate da
un sottofondo inconscio, nostalgico o
programmaticamente affermativo, assai
personale.
Vecchi pregiudizi e associazioni automatiche
Con tutto ciò, viene il sospetto che Sibelius
sia ancora vittima di una visione d’insieme
ancorata a vecchi pregiudizi, ad associazioni
automatiche. Il percorso compiuto nelle
Sette Sinfonie non va tanto nel senso di
un’evoluzione rettilinea quanto di una
risposta sempre nuova a interrogativi
formali e linguistici radicati nel presente:
solo marginalmente cullati dall’eco di
nordiche magie crepuscolari e tutt’altro
che disimpegnati. Anche la tendenza a
una certa introspezione psicologicamente
inquieta, non esibita ma prettamente
moderna, si riflette sul piano compositivo
per addentrarsi in pieghe sottilmente
ambigue: di un’ambiguità latente e risolta
problematicamente. La caratteristica
proliferazione delle cellule tematiche
sviluppata fino a produrre, senza apparenti
cesure, l’organismo intero della costruzione
sinfonica (un modo di procedere tutt’altro
che tradizionale, schematico o epigonale),
l’identificazione completa del pensiero
sinfonico nell’idea formale che lo regge
(e che muta in modo rilevante da una
Sinfonia all’altra), la conseguente ricerca
di una espressione orchestrale che non sia
rivestimento esteriore ma incarnazione
|| Un ritratto giovanile di Sibelius
dell’idea e dello stato d’animo in timbri e
suoni assoluti: questi elementi configurano
una personalissima valorizzazione delle
risorse compositive, tutt’altro che riducibile,
se non in superficie, a intenti descrittivi,
nazionalistici o comunque programmatici.
«Finlandia»
Il celebre poema sinfonico “Finlandia”,
op.26 n.7, fu scritto per festeggiare
l’indipendenza del Granducato di Finlandia
dalla Russia, nel 1899. L’indipendenza
della Finlandia dalla Russia è stato un
tema molto sentito soprattutto alla fine del
XIX secolo, tanto che il poema sinfonico
Finlandia è stato usato molte volte come
simbolo di tale volontà di irredentismo.
Si compone di un unico movimento
suddiviso in diverse sezioni; quella iniziale
è particolarmente impetuosa e dai toni
cupi, ne segue una più ritmica e solenne,
mentre verso la fine compare una melodia
lenta in seguito divenuta molto famosa e
ribattezzata “Finlandia-hymni”. Per questa
melodia sono state scritte delle parole
per opera dello scrittore Veikko Antero
Koskenniemi nel 1941. Per la bellezza e la
popolarità acquisita da tale inno, nel 2001
il parlamento finlandese ha presentato
una mozione per trasformarlo in inno
nazionale (che attualmente è “Maamme”),
anche se la richiesta è stata poi respinta.
«Tapiola»
Un altro significativo brano sinfonico
nella produzione di Sibelius è il poema
sinfonico “Tapiola”. Composto nel 1926 su
commissione della New York Symphony
Uno dei grandi concerti per violino e
orchestra nella letteratura musicale è
rappresentato appunto dal Concerto
per violino e orchestra in re minore di
Sibelius. Egli lo compose fra il 1903
e il 1904, sforzandosi di sintetizzarvi
tutto quanto sapeva in fatto di tecnica
violinistica e costellando la partitura di
effetti mirabolanti. La sfida fu raccolta
dal giovane violinista boemo Victor
Novàcek, che tenne a battesimo il lavoro
sotto la direzione dell’autore a Helsinki l’8
febbraio 1904; ma vuoi per l’inesperienza
dell’interprete, vuoi per gli squilibri del
lavoro, l’accoglienza fu così fredda da
spingere Sibelius a ritirare la partitura e a
sottoporla a una drastica revisione.
Al massiccio sfoltimento delle insidie
tecniche riservate al solista, che peraltro
rimasero notevoli anche nella stesura
definitiva, si accompagnò lo sforzo di
snellire il primo tempo e di potenziare
la vena lirica e sentimentale, che nella
versione originaria era rimasta soverchiata
dall’esibizione di virtuosismo.
In questa nuova forma alleggerita e
addolcita il Concerto in re minore
poté finalmente ottenere il successo
sperato, anche grazie agli interpreti
che si incaricarono di presentarlo in
prima esecuzione a Berlino nel 1905, il
violinista Karl Halir e sul podio niente
meno che Richard Strauss. Da allora al
Concerto non sarebbero più mancati
il favore del pubblico e l’attenzione
dei maggiori violinisti, nonostante le
ricorrenti riserve sollevate in sede critica
sulla debolezza della sua struttura, sulla
sua eccessiva inclinazione sentimentale,
sull’anacronismo linguistico di una
partitura ostinatamente e un po’
nostalgicamente rivolta al passato.
Una partitura rivolta al passato
Il Concerto di Sibelius guarda dunque
soprattutto ai grandi modelli ottocenteschi,
a Mendelssohn, Brahms e Bruch per
l’accentuata inclinazione lirica, a Dvoràk
e a Čajkovskij per il carattere rapsodico
dell’invenzione e per il virtuosismo della
parte solistica. In questo senso si è soliti
inscriverlo nella fase giovanile della
carriera di Sibelius, quella dei Poemi
sinfonici e delle due prime Sinfonie, fase
ancora condizionata dal romanticismo
tedesco e anteriore alla svolta
classicheggiante inaugurata nel 1907 dalla
Terza Sinfonia.
Nonostante il riferimento alle tradizionali
strutture classiche (una forma-sonata con
due temi per l’Allegro iniziale, una forma
tripartita di canzone per il tenero Adagio
centrale, un rondò per l’Allegro finale), il
fascino del lavoro, fa notare Sergio Sablich
“va dunque ricercato principalmente nel
languore appassionato di un melodizzare
tipicamente nordico e negli effetti suggeriti
dalla elaboratissima scrittura violinistica,
specialmente quando vi sia impegnato
un interprete di grandi risorse tecniche,
in grado di sfruttarne tutti gli inviti
spettacolari”.
la Voce
del popolo
cinema
CINEMA
martedì, 24 novembre 2015
3
di Dragan Rubeša
LA STRAORDINARIA
OPERA DI EDGAR ALLAN
POE HA ISPIRATO
NUMEROSI ADATTAMENTI
CINEMATOGRAFICI
“D
urante un giorno triste, cupo,
senza suono, verso il finire
dell’anno, un giorno in cui le
nubi pendevano opprimentemente basse
nei cieli, io avevo attraversato da solo, a
cavallo, un tratto di regione singolarmente
desolato, finché ero venuto a trovarmi,
mentre già si addensavano le ombre della
sera, in prossimità della malinconica Casa
degli Usher.”
Questo incipit de “La caduta della casa
degli Usher” viene letto dalla voce
narrante di Stellan Skarsgård in una delle
scene più significative di Nymphomaniac
di Lars Von Trier. Ma il pazzo danese è
soltanto uno dei numerosi cineasti che
amano citare il grande Edgar Allan Poe.
Sembra che non ci sia un’opera di questo
scrittore, soprattutto di quelle più celebri,
che non abbia avuto un adattamento
cinematografico in qualsiasi variante.
Le leggende metropolitane narrano che
Sylvester Stallon giunse a suo tempo
all’idea di realizzare un film biografico
su Poe. Però, il suo colloquio con il
produttore Avi Lerner non portò all’esito
sperato. “Poe porta una pistola?”, gli
avrebbe chiesto il produttore. “Non, non
ha una pistola”, avrebbe risposto Stallone.
“Ma può lanciare un coltello?”, fa ancora
il produttore. “No, lui scrive poesie!” è la
risposta di Stallone. Il progetto non venne
mai realizzato.
|| The Raven
IL PADRE DELL’HORROR
CONTINUAADAFFASCINARE
Dall’ottica queer al film animato
«The Raven» di McTeigue
Il problema venne risolto da James
McTeigue nel film biografico The Raven
(Il corvo), girato a Budapest e Belgrado,
città che “impersonavano” Baltimore. Il
regista ha qui davvero ficcato una pistola
in mano al celebre scrittore (interpretato
da John Cusack).
La vita di Poe era troppo complessa, per
cui McTeigue non ha potuto illustrarla
in maniera radicale. Poe è stato ritratto
invece come un alcolizzato che adora il
suo procione.
In una delle scene introduttive del film,
Cusack offre un drink a chi completa un
verso dal suo “Corvo” (…Mai più!...),
nonostante il pubblico, al quale McTeigue
si rivolge, abituato ai blockbuster – e che
di regola evita le letture d’obbligo -, non
sarebbe capace di completare nemmeno
un verso, dove poi l’intera poesia.
Invece di immergersi nella coscienza
di Poe, presa dal buio e dal marciume,
l’autore introduce un “copycat” serial
killer (omicida seriale per imitazione)
ispirato dalle sue descrizioni di orribili
crimini e incita la mente geniale di Poe al
gioco, dandogli l’opportunità di salvare
l’amata Emily. “Se avessi saputo che le mie
opere avrebbero avuto un effetto simile,
mi sarei dedicato di più all’erotismo”, è
ironico Poe nel film di McTeigue. “La
gente aspetterà in fila per vedere quello che
vediamo noi”, dice l’assassino nel Corvo.
E davvero, i sette sequel della serie di
film Saw, di cui il quinto fa riferimento
a “Il pozzo e il pendolo”, conferma che il
maniaco aveva ragione.
I film dell’orrore
L’opus di Poe ha ispirato la corrente gotica
nel cinema, più che il torture porn. Ne è
la conferma l’ultimo film di Guillermo del
Toro (Crimson Peak) che si richiama a Poe,
|| The Raven di McTeigue
Hitchcock, Mario Bava, Conan Doyle e ai
vecchi horror della produzione Hammer.
Come il viso e il mantello di Vincent
Price ne La maschera della morte rossa di
Roger Corman, così anche del Toro ama
le tonalità rosse (l’abito della diabolica
Jessica Chastain, i pavimenti di Allerdale
Hall, i ritratti di inquietanti signore che
sembrano una via di mezzo tra gli zombie
della serie Walking Dead e le sculture di
Bernini), l’innocenza e il sangue. Ma la
vera minaccia nel film di del Toro non
sono i morti bensì i vivi.
Tuttavia, per goderci fino in fondo gli
adattamenti di Poe dovremmo ritornare
negli anni Cinquanta e Sessanta con il
geniale Roger Corman che all’epoca girò
ben otto film tratti dalle opere di Poe.
In questi mette spesso in evidenza i loro
aspetti decadenti e sessuali, aggiungendo
una nota umoristica anche laddove non
ce l’aspettiamo, come ad esempio nella
parodia Il corvo con l’indimenticabile trio
del quale facevano parte Vincent Price,
Boris Karloff e Peter Lorre nel ruolo di
illusionisti in conflitto, più l’allora giovane
Jack Nicholson nel ruolo del figlio di
Lorre.
|| The Mask of the Red death
“Il corvo” è stato letto anche nell’ottica
queer, grazie a David DeCoteau, il quale
ha adattato in un contesto simile pure
“Il pozzo e il pendolo”. Qui la suspense è
sacrificata sull’altare dell’omoerotismo e
vi si trova più carne che sangue.
Lou Reed ha dedicato a questa poesia
l’eccellente album concettuale “The Raven”
(2003). Karloff e Bela Lugosi diedero il
via ai loro scontri sadistici nel lontano
1934, quando Edgar G. Ulmer li ingaggiò
per l’adattamento del racconto “Il gatto
nero” di Poe, nonostante la sua fantasia
sovversiva si rifaccia alla tradizione
dell’espressionismo tedesco, in quanto
il regista lasciò la Germania per motivi
politici, insediandosi ad Hollywood.
L’opus letterario di Poe ha lasciato
traccia anche nel film animato, da Jan
Švankmajer (La caduta della casa degli
Usher) a Raul Garcia, il quale firma
l’omnibus Extraordinary Tales composto
da cinque brevi adattamenti animati
dei classici di Poe, ciascuno realizzato
con una tecnica d’animazione diversa e
nei quali le voci sono state prestate da
Christopher Lee (La caduta della casa degli
Usher), Bela Lugosi (Il cuore rivelatore),
Julian Sands (La verità sul caso di Mr.
Valdemar), Roger Corman (La maschera
della morte rossa) e Guillermo del Toro (Il
pozzo e il pendolo).
Poe incarnato in un corvo
Alcuni, come Lugosi e Corman, erano
venuti a contatto con l’opus di Poe già
prima. Ne Il cuore rivelatore è stata
utilizzata la registrazione di Lugosi,
risalente al 1940, in cui egli legge Poe.
La narrazione di Lee nella versione
animata de La caduta della casa degli
Usher è stato invece il suo ultimo ruolo
cinematografico.
Un sommario filo rosso che collega le
storie di Garcia è il colloquio tra una
statua di cimitero che simboleggia la
Morte e Poe, incarnato in un corvo.
Certo che Poe potrebbe richiedere i diritti
d’autore per tutto ciò che concerne il
genere horror, nonostante avesse dato
vita al giallo investigativo e al genere
thriller con il racconto “I delitti della Rue
Morgue”.
È interessante il fatto che la sua opera
“Le avventure di Arthur Gordon Pym”, la
quale gioca magistralmente sul confine tra
la realtà e l’immaginazione, sembra ideale
per un adattamento cinematografico,
anche se questo non è stato ancora
realizzato.
Mai dire mai.
4
lalaVoce
Voce
del popolo
del popolo
martedì, 24 novembre 2015
INTERVISTA
L’
di Ivana Precetti
|| Alba si è esibita con Leo al concerto di Renzo Arbore nell’Arena di Pola lo scorso settembre
ultima volta che l’abbiamo vista
esibirsi è stato al Jazz Time Festival
di Fiume ed è stata, come sempre,
un’esperienza magica. È così quando hai
davanti un talento vero, un’artista a 360
gradi che senza troppa difficoltà riesce a
emozionarti, coinvolgerti e trasportarti
in mondi lontani. Quando poi torni da
questi “viaggi”, per un po’ di tempo fai
fatica a ritornare alla realtà. Soltanto
l’arte, in questo caso la musica, ha il potere
di scombussolarti in questo modo, di
lasciarti stordito, di farti provare brividi
incredibili lungo tutto il corpo. Per un
attimo stenti a capire cosa stia accadendo
e ti lasci pervadere soltanto da queste
bellissime sensazioni. Alba Nacinovich,
connazionale figlia d’arte (il papà Bruno
e mamma Elvia sono entrambi attori del
Dramma Italiano di Fiume. Bruno è pure
musicista), è una di quelle rare persone
che, una volta sul palco, hanno il potere di
colpirti provocando in te un terremoto di
emozioni. Anche se giovanissima (è classe
1986), ha già un curriculum invidiabile,
costellato da esibizioni e concerti di
successo, collaborazioni importanti, premi
e ottime critiche. Dietro a tutto questo,
però, sta un grandissimo lavoro e una
forte tenacia, tipica soltanto per chi ama
profondamente ciò che fa. L’abbiamo
incontrata per un’intervista, reduci dalla sua
ottima esibizione con i Correspondances,un
quartetto molto particolare del quale fa
parte da circa un anno e mezzo e con il
quale ha cantato per la prima volta a Fiume,
appunto nell’ambito del Jazz Time Festival.
Correspondances
“Ci esibiamo per lo più in Italia – ha
esordito – e questa è stata la nostra prima
performance nella mia città. Un’esperienza
pazzesca. I Correspondances nascono da un
progetto di Francesco De Luisa, un amico
che ho conosciuto al Conservatorio Tartini di
Trieste, dove studiavamo entrambi, su poesie
di poeti stilisticamente, geograficamente e
per epoche diversi come Pascoli, Sanguineti,
Borges, Hemingway, Baudelaire (dal quale
abbiamo preso spunto per il nome del
gruppo), le cui poesie non vengono recitate
con accompagnamento musicale bensì
diventano canzoni vere e proprie, musica
nel vero senso della parola. Oltre a me in
qualità di cantante, del quartetto fanno
parte appunto Francesco che compone i
brani e suona il pianoforte, Simone Serafini
al contrabbasso e Alessandro Mansutti alla
batteria”. I Correspondances sono stati
ospiti di Alba al Festival “Trieste Loves Jazz”,
edizione 2014, nell’ambito del quale lei è
stata insignita del Premio “Franco Russo” che
sostiene i giovani musicisti che per talento
e impegno si stanno distinguendo nel jazz
regionale e nazionale. In questo talentuoso
quartetto, Alba ha modo di esprimersi anche
nella recitazione, un altro campo artistico in
cui si sente… a casa, poiché alcuni passi dei
brani vengono recitati.
Il duo Alba&Leo
Prima di unirsi a questo nuovo progetto
musicale, la nostra interlocutrice ne ha fatta
di gavetta. In tanti la conoscono come parte
del duo “Alba & Leo”. “È nato nel 2008, per
puro caso. All’epoca Leo (Škec, nda) ed io
suonavamo in un gruppo che si chiamava
Love Runners e che è ancora attivo, ma con
una nuova formazione. In un’occasione ci
era stato proposto di sostituire Lela e Joe
Kaplowitz a un festival, ma come duo. Da
quel giorno abbiamo continuato a esibirci
così, noi due da soli. L’idea che aveva Leo
era di trasferire su chitarra gli arrangiamenti
dei vari brani che gli piacevano e che
ascoltava in genere e che non appartengono
soltanto al jazz ma anche al rock e al pop,
sviluppando una tecnica tutta sua, che unisce
sia il fingerstyle che una maniera percussiva
di suonare lo strumento. È uno stile che
ci ha permesso sin dall’inizio di esibirci in
coppia, una forma che mi piace tantissimo
perché ti dà libertà e possibilità infinite. È
una formazione impegnativa perché si sente
ogni singola nota, ogni minimo sussurro e
questo a volte risulta rischioso. Il rischio,
però, è talmente piacevole e coinvolgente
che vale la pena viverlo. Da un lato è molto
intimistico ma può diventare molto potente,
anche perché a volte utilizziamo la tecnica del
live looping che consiste nella sovraincisione
dal vivo, nel senso che durante un’esibizione
si incidono più voci e più strati di suoni
allo scopo di ampliare le possibilità di
sperimentazione e improvvisazione”.
Il jazz, un approccio verso la musica
Una domanda che ci viene spontanea
di fare ad Alba è perché proprio il jazz?
“Per me il jazz non è una scelta di genere,
bensì di approccio verso la musica. Per
quanto riguarda il canto, come studio al
Conservatorio si può scegliere o il canto
lirico o il jazz. Oltre al Tartini, parte degli
studi li ho fatti a Oporto, in Portogallo,
nell’ambito del progetto Erasmus. Del
jazz mi piace la libertà e il modo di
giocare con i suoni. Ho avuto da sempre
il pallino dell’improvvisazione e della
composizione. Infatti, la composizione
nasce dall’improvvisazione, in questo senso
guidata. Perché proprio il jazz? Non lo so.
L’ho scoperto alle medie (Alba ha frequentato
l’ex Liceo di Fiume, nda), ascoltando un
album di Thelonious Monk, che mi ha
colpito in modo particolare. C’erano tutti
i presupposti perché il jazz diventasse
una parte di me. Devo dire, però, che non
mi sono mai definita una cantante jazz,
semplicemente perché non mi rappresenta
fino in fondo. E poi, apprezzo questo genere
così tanto che non voglio nemmeno definirmi
una jazzista. È un mondo particolare in
cui, ancora sempre, non ci si aspetta che
i cantanti abbiano la preparazione degli
strumentisti e questa è una cosa che non
riesco ad accettare. La voce non è vista a tutti
gli effetti come uno strumento e si crede che
pertanto i cantanti jazz possano in qualche
modo… passarla liscia. Secondo me, però, il
livello dei cantanti è oggi alla pari di quello
che gli strumentisti jazz hanno da decenni.
D’altra parte, in tanti si definiscono con
troppa facilità cantanti jazz, anche se magari
sono lontani anni luce dal genere. Non basta
eseguire canzoni del repertorio per diventare
un interprete jazz. Per fare un esempio, Frank
Sinatra era un cantante pazzesco, molto
rispettato nell’ambiente jazz, anche se il
genere non lo rappresentava a tutti gli effetti.
La cosa vale anche un po’ per me, perché mi
piace fare anche altre cose.
Diversi progetti musicali
Non amo venir etichettata come jazzista
appunto perché sono attiva anche nel duo
con Leo che mischia pop, jazz e rock. Negli
ultimi due anni mi dedico inoltre alla musica
elettronica e con il pianista Marco Germini,
un altro mio amico di studi, abbiamo formato
un duo che si chiama The Hunting Dogs.
Siamo appena tornati dal Karlovačko RockOff
Festival di Zagabria nell’ambito del quale
ci è stato conferito il premio come gruppo
più innovativo. Abbiamo partecipato anche
all’Arezzo Wave Festival, uno dei più grandi
festival per gruppi emergenti in Italia. Nei
The Hunting Dogs mi diletto a suonare le
tastiere, la chitarra e varie percussioni e anche
qui usiamo la tecnica della sovraincisione.
Con l’ausilio, poi, dei sintetizzatori modulari,
in due riusciamo a creare uno spazio sonoro
abbastanza potente e ricco con risonanze
fortemente elettroniche. I pezzi sono nostri,
alcuni dei quali sono racchiusi nel nostro
primo vinile Out To Hunt, uscito nel giugno
scorso. Nell’ambito di un concorso, uno dei
nostri brani è stato scelto come colonna sonora
per uno spot pubblicitario di Sky Italia”.
Collaborazioni importanti
Oltre a cantare, Alba lavora come
programmatore musicale a Radio Fiume e
insegna musica in scuole private a Codroipo
e Gorizia. Vanta, inoltre, collaborazioni con
nomi importanti del jazz come Elvis Stanić
e Zvjezdan Ružić, al cui ultimo album “The
Knightingale Cabaret” ha anche collaborato.
È presente pure, assieme a Leo, in quello del
noto chitarrista Damir Halilić Hal, uscito nei
la Voce
spettacoli
del popolo
martedì, 24 novembre 2015
«FACCIO MUSICA
PER SPERIMENTARE
E COMUNICARE
CON IL PUBBLICO»
5
A COLLOQUIO CON LA
GIOVANE CANTANTE
CONNAZIONALE
ALBA NACINOVICH,
UN’ARTISTA A 360 GRADI
festival a rischio di chiusura. In Croazia il
pubblico jazz è una piccola realtà e questo mi
rende triste”.
Dove viene invece festeggiato? “La mecca è
indubbiamente New York. Però ci sono Paesi,
come ad esempio la Polonia, in cui il genere
si sta sviluppando velocemente e in cui c’è
una grande concentrazione sia di musicisti
che di pubblico. Il jazz è un genere musicale
che quando fatto bene riesce a trasmetterti
un’energia incredibile e a conquistare anche
quelli che prima forse non lo capivano. Non
capisco quando qualcuno dice: ‘A me il jazz
non piace’. È come dire che non ti piace il
pop, ma in esso ci sono sia Severina che
Sting, tanto per rendere l’idea. Il jazz è un
genere immenso, un campo talmente vasto
in cui ognuno può trovare qualcosa di suo
gradimento. Ce n’è veramente per tutti”.
Figlia d’arte
giorni scorsi. Tra le altre collaborazioni, va
sottolineata quella con il violinista zagabrese
Marko First e nuovamente con Francesco
De Luisa con il quale forma il progetto jazz
“Questioning answers”.
Ma dove lo trova il tempo necessario?
“Ahimé, quello è un tasto dolente. Il tempo
è sempre un problema e sarebbe bello se la
giornata avesse qualche ora in più. Preferisco
avere progetti fissi, a differenza di quello a
cui ci spinge il mercato in cui i musicisti si
beccano a malapena per una prova prima
del concerto. I bei progetti, soprattutto
in Croazia, si estinguono dopo due o tre
appuntamenti e non riescono a mantenere
una crescita costante a discapito sia dei
musicisti che del pubblico. Tutte le mie
collaborazioni sono nate spontaneamente,
perché si sente a pelle con chi potresti farla.
Quindi, senza calcolare troppo, ti ritrovi sul
palco con il musicista con il quale hai un
certo feeling”.
«C’è sempre da imparare»
La voce è uno strumento che va curato.
Come si comporta Alba? “È uno studio
continuo e ogni progetto offre nuove sfide.
Certo che il timbro cambia nel tempo. Me
ne rendo conto riascoltando registrazioni
passate in cui usavo la voce in una maniera
che ora mi sembra improponibile, quasi
inascoltabile. Questo, però, è un buon segno.
Ogni tanto chiedo anche qualche consiglio
nelle scuole in cui insegno e mi confronto
con qualche cantante lirico, partecipo ai vari
workshop di canto. C’è sempre da imparare
e mi piace prendere spunto da qualsiasi
possibilità mi si offra. Un’ottima cosa sono
i concerti degli altri, per i quali purtroppo
trovo sempre poco tempo”.
Che musica ascolti? “Io dico sempre che la
mia Santa Trinità è rappresentata da Bach,
Thelonious Monk e Freddy Mercury, per i
quali ho un’adorazione assoluta. Freddy,
poi, come cantante è inarrivabile. Delle
pietre miliari mi piacciono ancora Björk, che
secondo me è un’artista che ha cambiato il
nostro tempo, e i Radiohead”.
Che artisti ammiri? “Troppi, non vorrei fare
un torto a qualcuno non nominandolo,
nominerò pertanto quelli scoperti di recente:
St. Vincent, Laura Mvula, Julian Lage. Non
posso poi dimenticare Amy Winehouse, una
benedizione durata troppo poco. Amy ad
esempio aveva uno spirito jazz.
Ammiro pure Cyrille Aimée, Fay Claassen,
Maria João che ho avuto il piacere di
conoscere e l’onore di fare una jam ad
Abbazia. Dei musicisti croati aspetto con
curiosità il nuovo disco dei Jinx che credo
siano particolarissimi, e dei nuovi mi
piacciono i Detour”.
Fiume messa male con il jazz
Come vedi la scena jazz a Fiume? “In città ci
sono tantissimi validi giovani musicisti che
purtroppo si sono dovuti trasferire a Zagabria
perché il capoluogo quarnerino col jazz è
messo veramente male. Un esempio lampante
ne è il Jazz Festival che rischia di scomparire
dopo 24 anni di illustre tradizione. Forse
perché si punta su altri generi, non lo so.
La cultura in generale sta combattendo
per sopravvivere. Anche a Zagabria ci sono
Quanto ti ha segnato il fatto di essere figlia
d’arte? “Tantissimo. I miei genitori sono stati
fondamentali. Mio papà, che oltre a essere
attore è anche musicista, mi ha trasmesso
entrambe le passioni. Come pure la mamma.
Per un cantante il teatro è parte sostanziale
di un’esibizione. I miei mi hanno insegnato
sin da piccola a cogliere le sfumature della
parola, della comunicazione e di trasferirle
in musica. Un consiglio fondamentale che
mio padre mi ha dato è stato quando avevo
cinque o sei anni, dopo avermi iscritta ai
Minicantanti con il mitico Zio Severino.
Ricordo che prima di salire sul palco per la
prima volta, mio papà mi ha detto: ‘Sorridi e
divertiti’. È una consiglio che seguo sempre,
anche adesso. È fondamentale soprattutto
di questi tempi in cui i giovani iniziano a
fare musica con grande entusiasmo e poi in
questo percorso vengono assaliti da mille
fobie e paranoie che quasi dimenticano il
piacere che la musica offre. Non è importante
avere una tecnica perfetta, un vibrato
pazzesco o che ne so cosa. L’obiettivo è
comunicare. A me interessa l’emozione che
un artista riesce a trasmetterti. È per questo
che andiamo ai concerti, no? Credo che
in questo mondo ci siamo un po’ impigriti
emotivamente e che siamo talmente abituati
agli effetti speciali, senza sostanza, che
dimentichiamo cosa sia l’arte vera. Oggi
è tutto sensazionalismo. Mia madre dice
sempre che è molto più semplice mettersi a
nudo fisicamente che emotivamente. Sono
d’accordo con lei”.
«...è come se uscissi da questo mondo»
Come si sente Alba sul palco? “Se sento che
il pubblico mi segue, è come se uscissi da
questo mondo. A volte sento i brividi lungo
la schiena quando mi collego alla platea. Il
bello della musica è che non devi neanche
saper parlare la lingua del cantante, non devi
sapere cosa canta di preciso per emozionarti.
Le emozioni che ci accomunano sono sempre
le stesse e l’arte in generale ha il potere di
trasformarle in una sostanza magica e quindi
trasferibile. Non importa se io, che ne so, sto
cantando di Giovanni mentre quello che mi
ascolta ama Stefania. Ci capiamo lo stesso.
Questa è la magia della musica. Quando
mi esibisco, entro in questa dimensione di
emozione liquida che prende forme diverse
e si trasferisce da persona a persona. È
estremamente intenso e io mi sento benedetta
per il fatto di poterlo sperimentare”.
Ma Alba sta già vivendo il suo sogno? “Già il
fatto di fare quello che amo mi sembra una
fortuna e io ho sempre nuovi obiettivi. Una
cosa di questo mondo che mi riesce difficile
fare è essere manager di me stessa. Non
sono tanto brava in questo. Dalle nostre parti
manca una figura professionale che si occupi
di questo aspetto ovvero di tutto quello
che sta intorno alla musica e promuoverla.
Io faccio musica per sperimentare, per
comunicare con il pubblico, per improvvisare.
Finora ho avuto veramente tante belle
soddisfazioni in quanto a premi, critiche,
concerti e collaborazioni. Sono concentrata
sulla musica d’autore e quindi vorrei poter
portare più spesso a un pubblico più vasto le
mie composizioni. La parte organizzativa è
quella che curo meno. Forse perché finora ho
vissuto nell’innocente pensiero che bastino
i risultati e che essi parlino da soli. Invece
non è così e purtroppo bisogna sempre
combattere. A volte ha più visibilità chi parla
senza risultati piuttosto che l’inverso”.
«Sfruttare le mille opportunità che la musica offre»
Cosa insegni ai tuoi studenti? “Di godere in
quello che fanno e di rispettare la tradizione
senza diventarne schiavo. Sapete come si
dice: togli a un musicista classico lo spartito e
smette di suonare e metti lo spartito davanti a
un musicista jazz e succede lo stesso. Secondo
me bisognerebbe unire i generi e sfruttare le
mille opportunità che la musica offre”.
L’ultima domanda è d’obbligo: quali sono
i tuoi prossimi piani? “Ho in programma
diverse date con Alba & Leo, con cui stiamo
registrando alcuni singoli che usciranno
l’anno prossimo per una major croata, e i The
Hunting Dogs, con i quali saremo a dicembre
in concerto a Fiume e in tutta l’Istria. L’anno
prossimo collaborerò con Glauco Venier, uno
dei grandi musicisti jazz in Italia, nominato
al Grammy, che è stato mio professore
e che mi ha invitata a unirmi a lui a un
progetto di poesie friulane. Avrò inoltre una
collaborazione con il Cantus Ensemble di
Zagabria. Non vedo l’ora”.
6
spettacoli
martedì, 24 novembre 2015
IL PERSONAGGIO
di Sandro Damiani
la Voce
del popolo
RICORRONO QUEST’ANNO IL CENTESIMO ANNIVERSARIO
M
otivazione per l’Oscar alla carriera:
“Per la superlativa capacità artistica
e la versatilità dimostrata nella
creazione di opere cinematografiche”.
Non c’è campo in cui non si abusi
del termine “genio” e la sua variante
“geniale”; più in generale, viviamo in
un’epoca di superlativi assoluti. A farne
maggiormente le spese, se così si può dire,
è il vasto e articolato mondo dell’arte.
E al suo interno, il cinema, nel quale
pare vi stazionino solo “mostri sacri”.
A farne le spese – essendo che di notte
tutte le vacche sono bigie – sono quei
pochi veri e, diciamo così, “provati” geni.
Uno di questi è George Orson Welles
(Kenosha, 6 maggio 1915 – Los Angeles,
10 ottobre 1985), il quale, “genio”, venne
proclamato a poco più che vent’anni, nel
1938, precisamente all’indomani della più
grande beffa inscenata ai danni di milioni
di radioascoltatori. Stiamo ovviamente
parlando della sua famosa trasmissione
radiofonica in presa diretta, del 30 ottobre
del ‘38, in cui fece credere che la Terra
stesse subendo un’invasione di alieni su
temibili astronavi.
Dirà, Welles, in seguito: “Per quello che
abbiamo fatto sarei dovuto finire in galera,
ma al contrario, sono finito a Hollywood“.
Infatti, affascinati dalla follia, pardon,
dalla “genialità” dell’idea e di come Welles
condusse tutta l’operazione, i capataz della
potente major hollywoodiana RKO gli
offrirono un contratto per la realizzazione
di tre pellicole.
Si badi bene che fino a quel momento,
Orson George Welles aveva girato un solo
film, l’anno prima, un mediometraggio
(Too Much Johnson), che francamente
non si sa chi abbia visto... Inciso: quella
che sembrava essere rimasta l’unica copia
della pellicola, di proprietà dell’Autore,
finì in cenere nel ‘70 nella villa madrilena
di Welles, che prese fuoco. Sembrava...
perché qualche anno fa ne è stata ritrovata
un’altra, a Pordenone (?) e rimessa a
nuovo dalla Cineteca del Friuli.
In precedenza, il giovane Orson aveva
girato un cortometraggio dal quale
traspare – scrivono i suoi esegeti - la sua
precoce intelligenza nel sapere coniugare a
amalgamare Espressionismo e Surrealismo,
Buñuel, von Stroheim e Murnau...
ORSO
UNUOMOF
Una personalità unica
Pazzerelloni, dunque, i produttori della
Radio-Keith Orpheum Pictures? Manco per
niente. Del giovane neoregista sapevano
tutto. E tutto diceva loro che ci si trovava
al cospetto di una personalità unica. Alle
spalle, infatti, aveva robuste esperienze
teatrali, negli USA e, precedentemente,
in Inghilterra; come attore, come regista,
come autore, con una preparazione
culturale, classica e moderna di
prim’ordine.
Orson Welles nasce ricco, da padre
industriale, ma non di quelli che inseguono
solo il danaro; anzi, costui aveva il
pallino dell’invenzione, mentre la madre
era un’artista dilettante, ex suffragetta
impegnata nel sociale (purtroppo per lui,
la perderà giovanissimo). Insomma, il
bimbo cresce in un ambiente che gli offre
interessanti e stimolanti opportunità,
sicché sin da piccolo calca le scene, studia
pianoforte e pittura. Sogna, ragazzo, di
fare il musicista, poi il pittore. Finisce per
diventare attore, ma non autodidatta:
studia. E, il passo successivo, regista.
Dicevamo dei primi passi alla RKO. Il
contratto che va a firmare, non solo è
favoloso sotto il profilo economico (avendo
sposato a vent’anni una benestante, questo
aspetto più di tanto non gli fa né caldo
né freddo), ma anche per la durata e il
numero di progetti, tre, per i quali gli viene
data carta bianca, quanto a tempi e mezzi
di realizzazione.
Il primo film in cantiere è l’adattamento
di “Cuore di tenebra” (Heart of
Darkness) di Joseph Conrad. Ma non
verrà mai realizzato: troppo complessa
la lavorazione, troppo ardite le novità
tecniche e di ripresa che Welles vuole
apportare. E troppo astrusa la materia per
il pubblico americano. Stessa fine farà il
secondo progetto, il poliziesco “Smiler with
a Knife”.
È trascorso un anno dalla firma in pompa
magna del rapporto RKO-Welles e ancora
non s’è visto nulla. Peggio: si sono avuti
due aborti. L’ambiente comincia a dubitare
della “genialità” del cineasta del Visconsin.
Che sia un bluff?
È la volta del terzo progetto.
|| Orson Welles all’epoca della trasmissione choc
Quarto potere
Il soggetto è originale, niente testo
drammatico o novella come base dell’opera.
È la storia di un ricco e potente capitalista,
proprietario anche di un quotidiano, sulla
cui vita un giornalista indaga dopo che,
morendo, il magnate – Charles Foster Kane
– si pronuncia in modo talmente strano
che immediatamente si pensa a un qualche
mistero legato alla sua esistenza.
Quarto potere – è il titolo italiano;
nell’originale è Citizen Kane.
“Vi si racconta la storia – scrive Welles dell’inchiesta fatta da un giornalista di nome
Thompson per scoprire il senso delle ultime
parole di Charles Foster Kane. Poiché il suo
parere è che le ultime parole di un uomo
devono spiegare la sua vita. Forse è vero. Lui
non capirà mai cosa Kane volesse dire, ma il
pubblico, invece, lo capisce. La sua inchiesta
lo porta da cinque persone che conoscevano
bene Kane, che lo amavano e lo odiavano. Gli
raccontano cinque storie diverse, ognuna delle
quali molto parziale, in modo che la verità
su Kane possa essere dedotta soltanto - come
d’altronde ogni verità su un individuo - dalla
somma di tutto quello che è stato detto su
di lui. Secondo alcuni Kane amava soltanto
sua madre, secondo altri amava solo il suo
giornale, solo la sua seconda moglie, solo sè
stesso. Forse amava tutte queste cose, forse non
ne amava nessuna. Il pubblico è l’unico giudice.
Kane era insieme egoista e disinteressato,
contemporaneamente un idealista e un
imbroglione, un uomo grandissimo e un uomo
mediocre. Tutto dipende da chi ne parla. Non
viene mai visto attraverso l’occhio obiettivo
di un autore. Lo scopo del film risiede, d’altra
parte, nel proporre un problema piuttosto che
risolverlo”.
Il film inizialmente non ottiene il successo
di pubblico sperato (che arriverà in
seguito), ma nell’ambiente il parere è ben
diverso, talché il Nostro viene ufficialmente
incoronato “genio”. Per François Truffaut,
che prima di divenire regista era un
apprezzatissimo critico cinematografico,
siamo in presenza del “film dei film“, l’opera
che influenzerà numerosi giovani cineasti.
Il «film dei film»
La mancata risposta positiva del grosso
pubblico non deriva tanto da supposte
difficoltà a capire la pellicola, benché le
novità (tecniche di ripresa, narrazione, piani
sequenza, flash back, citazioni, rimandi,
simbolismo, ecc.) non siano poche ma
semplicemente perché il magnate della
carta stampata Hearst, al quale in effetti
inizialmente Welles si ispirò, si riconosce nel
protagonista e avvia una campagna avversa
al film di tale portata da non invogliare la
gente ad andare a vederlo. Non solo, ma
riesce pure a condizionare i proprietari delle
sale e dei circuiti di distribuzione.
Ma, ripeto, la critica la pensa diversamente.
Come pure reputa straordinario l’attore
Welles. Questi dirà che il merito maggiore
andava al truccatore, che riuscì a “ritrarre”
Kane da ventenne a quasi ottantenne.
Ricorda Orson:
“Riuscivo appena a muovermi, per via del
corsetto e del cerone sul viso. Norman Mailer,
una volta, ha scritto che quando ero giovane
ero il più bell’uomo che mai si fosse visto.
Grazie tante! Era tutto merito del trucco di
Quarto potere“.
Dopo Citizen Kane, due anni dopo, nel
1942, arriva L’orgoglio degli Amberson (The
Magnificent Ambersons). Qui Welles non
recita, è solo “voce narrante”. È la saga di
una famiglia borghese americana. Regista e
produttori sperarono in una immediata forte
risposta del pubblico, che al contrario, non
arrivò. L’Autore ha sempre parlato di questo
film come migliore del primo, ma i suoi
ammiratori non sono mai stati d’accordo,
non trovandovi la compattezza del primo, nel
quale peraltro Orson era impegnato 24 ore
su 24. Qui, invece, in più occasioni egli lascia
il set; una volta per girare un documentario
in Brasile, commissionato nientemeno che
dal Governo, una seconda volta per recitare
in un’altra pellicola, su cui comunque riesce
a mettere le mani. Insomma, fa capolino
l’Orson Welles di prima di Quarto potere,
che sarà poi il Welles futuro, quello, cioè,
impegnato contemporaneamente su più
fronti: un vulcano di idee che non riesce a
non... eruttare a tambur battente.
Flop de «L’orgoglio degli Amberson»
L’esito poco soddisfacente della saga, il flop
del progetto successivo e l’avvicendamento
ai vertici della RKO, comportano il
licenziamento in tronco. Siamo in piena
guerra, il Paese, non a torto pensano i
produttori, ha bisogno di ben altre “storie”
rispetto a quelle che Welles può e vuole
raccontare, oltre tutto costosissime. E
così, Orson torna alla radiofonia, ma con
trasmissioni, pur se fatte con tutti i crismi
dell’approccio culturale, di mera propaganda
politica. E il suo lavoro è talmente apprezzato
che addirittura il presidente Roosevelt gli
chiederà di scrivergli dei discorsi politici.
spettacoli
la Voce
del popolo
martedì, 24 novembre 2015
7
DELLA NASCITA E IL TRENTESIMO DELLA MORTE DI UNO DEI GRANDI DELLA STORIA DEL CINEMA
|| Orson Welles, Rita Hayworth e Joseph Cotten
|| Oja Kodar e Orson Welles
|| Una scena di “Othello”
ONWELLES
FUORIDAGLISCHEMI
Sul fronte privato, Welles ha divorziato dalla
prima moglie nel 1939. E dopo una relazione
con la star Dolores Del Rio, sposa Rita
Hayworth, da cui avrà una figlia, Rebecca.
Nel ‘44 torna sullo schermo, attore. Alla
grande: per David O. Selznick, recita
accanto a Joan Fontaine. Segue una
pellicola meno impegnativa, in cui ha per
partner Marlene Dietrich, ed una accanto a
Claudette Colbert.
Finalmente, nel 1946 gli viene affidata una
regia in cui recita pure. È Lo straniero, con
Loretta Young ed Edward G. Robinson.
Quindi, torna al teatro. Vi investe del
proprio. Critici entusiasti, pubblico zero! Si
tratta dell’adattamento musicale di “Il giro
del mondo in ottanta giorni”. Flop e tasche
vuote. Torna a Hollywood, la Columbia gli
propone La signora di Shanghai: davanti alla
macchina da presa ci sono lui e sua moglie
Rita. Ma siccome il produttore non crede
nella pellicola, l’uscita viene rimandata.
Uscirà, neanche a farlo apposta, quando
Orson e la “scandalosa Gilda” stanno
divorziando... A lei piacque molto il film, più
in generale non smise mai di ritenere l’ex
marito un “genio”.
«Macbeth» sul grande schermo
A questo punto, Welles comincia ad avere
le tasche piene di un ambiente che crede a
corrente alternata alle sue capacità e medita
la fuga in Europa: “Hollywood – dice - è un
quartiere dorato adatto ai giocatori di golf, ai
giardinieri, a vari tipi di uomini mediocri ed
ai cinematografi soddisfatti. Io non sono nulla
di tutto ciò“.
Prima di andarsene, si toglie lo sfizio di
portare sul grande schermo “Macbeth”
(regista e interprete), nonostante i soldi
siano men che pochi. Il film viene girato
in un mese, in un unico teatro di posa, con
scenari abborracciati e i tecnici a fare da
comparse. A lui non dispiace. Comincia a
pensare ad un secondo Shakespeare, ma
da fare senza la palla al piede delle major
hollywoodiane. Pensa a “Otello” (era rimasto
colpito dall’interpretazione broadwayana
di Paul Robeson del ‘43). Per prima cosa,
bisogna fare soldi, sicché “si sda”, come
attore, in tre mediocri filmacci in costume;
americani, ma fatti in Europa: Cagliostro,
Il principe delle volpi e La rosa nera, in cui
primeggia la sua espressione tra l’ironico e il
divertito, sebbene interpreti ruoli, inquietanti
più sì che no... Siamo tra il 1947 e il 1950.
Pochi minuti in «Il terzo uomo»
Prima dell’ultimo, ha modo di farsi
ammirare in tutta la sua grandezza
attoriale nel ruolo del “luciferino” (così
lo definisce) Harry Lime in Il terzo uomo,
diretto da Carol Reed, sceneggiato da un
grande scrittore, Graham Greene. Welles
appare per pochi minuti, ma di questo
capolavoro ci si ricorda più di lui che non
di Alida Valli, Trevor Howard e Joseph
Cotten (suo compagno di strada in Quarto
potere), anche perché di lui, cioé di Harry
Lime, non si fa che parlare per tutta la
durata del film.
Ed eccoci all’Otello. Che esce nel 1952 dopo
una lunga e travagliata lavorazione, dovuta
anche ai suoi impegni nei succitati film.
Si tratta della prima regia europea, sin da
subito segnata da problemi finanziari, con il
fallimento del produttore italiano (la Scalera
Film). Ne troverà uno in Marocco, dove in
parte gira. Verrà ripagato con la Palma d’Oro
a Cannes. L’Italia gli piace: forse c’è troppa
improvvisazione, ma è sempre meglio della
logica dei “golfisti” di Hollywood. Sicché
non si tira indietro neppure di fronte a
offerte, come definirle? Buffe? Mi riferisco al
pirandelliano L’uomo, la bestia e la virtù, di
Steno, a fianco di Totò.
La BBC lo chiama per affidargli la regia
televisiva di “Re Lear”.
Siamo nel 1955 quando gira Rapporto
confidenziale, storia assai vicina a quella del
cittadino Kane. Alla critica piace, il pubblico
gradisce. L’anno dopo rieccolo a teatro, per
“Moby Dick“, a Londra. Orson è Ackab,
naturalmente. Ma non lo è successivamente
nel film di John Huston, dove riveste il ruolo
di Padre Mapple.
Ritorno a Hollywood
Riacquisita, in America, la fama degli inizi,
Orson Welles fa ritorno a Hollywood. Da
segnalare il ritratto del rude e volgare Will
Varner ne La lunga estate calda, in cui in
sostanza “ruba” la scena a Paul Newman e
Joanne Woodward.
L’anno dopo, nel 1958, gli viene affidata
la regia del primo film americano dopo
oltre dieci anni. Lo fa la Universal. Welles,
autore della sceneggiatura, si cuce addosso
un personaggio mostruoso, il poliziotto del
titolo L’infernale Quinlan.
“Quinlan – scrive il critico Joseph McBride
- è un personaggio degno di Shakespeare,
ed è la summa di molti ‘cattivi’ interpretati
|| Una scena di “Quarto potere”
da Welles: il dittatoriale Kane, il sarcastico
Rochester, l’amorale Macbeth, il brutale
Renchler“. Con Orson ci sono Charlton
Heston, rivelatosi attore-monumento grazie
al Mosé di tre anni prima, ma qui divenuto
piccino piccino al cospetto dell’uomomontagna Welles-Quinlan; e Janeth Leigh.
I tre anni americani a Orson Welles
sembrano trenta, ergo – ritorno in Europa.
Con tante idee, ma scarse possibilità di
trovare produttori... generosi. E allora,
rieccolo in film improbabili o quantomeno
lontani anni luce dal suo modo di intendere
vedere fare proporre cinema: David e
Golia, I tartari, Le meravigliose avventure di
Marco Polo. Ovviamente, gli riesce anche di
lavorare con registi di caratura, come Abel
Gance (Napoleone ad Austerlitz).
«Il Processo». Riprese anche nell’ex Jugoslavia
Inattesa, nel 1960 gli arriva l’offerta di
girare “Il Processo” da Kafka. Il produttore
è Alexander Salkind (noto nell’ambiente,
ma il mondo lo conoscerà appena negli anni
Ottanta, dopo i tre Superman). Welles si
mette al lavoro. Scrive la sceneggiatura.
Protagonista, Anthony Perkins già ammirato,
con paura, in Psycho; Jeanne Moreau, Romy
Schneider ed Elsa Martinelli. Si gira in Italia,
Francia, Jugoslavia. Per Orson, è il suo
migliore film. Ed eccoci alla realizzazione
del grande sogno: “Falstaff”, già diretto e
interpretato a teatro.
“Più studiavo la parte – scriverà Orson meno mi sembrava allegra. Questo problema
mi ha preoccupato per tutto il tempo delle
riprese... Non mi piacciono molto le scene
in cui sono soltanto divertente. Mi sembra
che Falstaff sia più un uomo di spirito che
un pagliaccio... È il personaggio cui credo di
più, è l’uomo più buono di tutto il dramma.
Le sue colpe sono colpe da poco, e lui se ne fa
beffe. È buono come il pane, come il vino. Per
questo ho trascurato un po’ il lato comico del
personaggio: ogni volta che l’ho interpretato
mi sono persuaso sempre di più del fatto che
rappresenta la bontà e la purezza“.
La sceneggiatura prende in considerazione
varie opere di Shakespeare: “Enrico IV“,
“Enrico V“, “Le allegre comari di Windsor“ e
“Riccardo II“. Con lui ci sono John Gielgud,
la Moreau, la Rutherford, la Vlady, Walter
Chiari, Alan Webb... In Europa piace, negli
USA no.
Girerà ancora alcuni film, metà dei quali
resteranno incompiuti, ma oramai il cinema
pare affascinarlo sempre meno. Ha capito
che, onori e premi a parte – non ve n’è
uno, di quelli che “contano” che non l’abbia
ricevuto – è un “incompreso”. Termine che
nella prassi cinematografica significa, nel
concreto, l’impossibilità di trovare produttori
disposti a mettersi a sua disposizione.
Perciò decide, pur continuando a lavorare,
a dedicare il tempo a sé e alla sua ultima
compagna, la performer e attrice jugoslava
Olga Palinkaš (in arte Oja Kodar), conosciuta
quando girava Il Processo. Non divorzia
dalla terza moglie, Paola Mori, sposata nel
1955, con cui ha una figlia, Beatrice, ma
si accompagna anche professionalmente
con Oja, donna intelligente e sensibile, la
quale oltre a recitare in alcuni suoi film,
quali The Other Side of the Wind, The Deep
e The Dreamers, collabora anche come
sceneggiatrice (determinante la sua duplice
presenza in F, come Falso).
Il Raffaello dei nostri giorni
Insieme, sullo schermo, li vedremo nel
Segreto di Nikola Tesla di Krsto Papić, nel
1980. Insieme, lontano dallo schermo,
invece, li si vedrà ogni estate a Primošten
in Dalmazia. A proposito di Jugoslavia,
come non ricordarlo nel ruolo del politico e
militare cetnico nel film di Veljko Bulajić, La
battaglia della Neretva.
Dell’attore e del regista Orson Welles
parlano i suoi film. E qualche milione di
pagine firmate da cineasti, critici e storici
del cinema di tutto il mondo. Dell’uomo,
che, chi lo ha conosciuto, non ha potuto non
amarlo e rimanerne affascinato, voglio qui
annotare alcune considerazioni.
Andy Warhol: “Orson Welles era veramente
grande. Non i suoi film. Lui”.
Carmelo Bene: “Lo ricordo soprattutto come
un attore eccezionale, sublime... Sono convinto
che Welles avesse in testa un meraviglioso
brusio, grazie anche al suo stupendo alcol,
e che fosse un genio, ma non mi va di
rinchiuderlo in una definizione: era troppo
avventuriero, troppo fuori dagli schemi,
troppo imprevedibile, perché noi oggi si possa
fare un’operazione del genere... A me Welles
ricorda Raffaello. Raffaello che cammina per
le strade di Roma nel Cinquecento e che a ogni
passo si deve fermare perché la gente gli bacia
le mani, le vesti”.
Marlene Dietrich: “Quando lo vedo e gli
parlo, mi sento come una pianta dopo che
l’hanno annaffiata”.
8
spettacoli
martedì, 24 novembre 2015
D
urante la visione del film
britannico La teoria del tutto (The
Theory of Everything, 2014)
di James Marsh, uno non riesce a far
diversamente che meravigliarsi della
Vita, lo straordinario fenomeno che
troppo spesso prendiamo per scontato.
A farci riflettere sull’esistenza umana
nel film non sono soltanto le vittorie e
le riflessioni scientifiche di una delle
più brillanti menti del nostro secolo, del
fisico e cosmologo Stephen Hawking,
ma piuttosto le sue sfortune personali,
consapevolmente trasformate in una
grande vittoria. Sono piuttosto rari gli
scienziati del calibro di Hawking, che
possono vantare un numero talmente
grande di premi, riconoscimenti e
onorificenze scientifiche.
Il film ci fa riflettere sulle magnifiche
capacità umane, un aspetto che la vita
del fisico rispecchia perfettamente. Lo
scienziato affetto da paralisi traccia uno
straordinario percorso sia personale che
scientifico, contribuendo al continuo
divenire in un mondo di persone
fisicamente abili che paradossalmente
vivono paralizzate nel presente della
propria esistenza, incapaci di rompere
il cerchio chiuso delle proprie illusioni,
della disperazione e dell’autodistruzione.
È l’aspetto che il film di Marsh presenta
con raffinatezza e sensibilità raccontando
la figura di Hawking. “Per quanto difficile
possa essere la vita, c’è sempre qualcosa che
è possibile fare. Guardate le stelle invece dei
vostri piedi“, sono le parole di Hawking.
Vivere nel presente
Le leggi della natura di cui facciamo parte
e che poco saggiamente trascuriamo
ci offrono immense possibilità di
espansione. L’Universo, invece, comprende
la natura stessa e le leggi scientifiche,
per cui se l’uomo non si adegua a queste
regole infrange le leggi dell’esistenza.
Al di sopra della conoscenza, della
consapevolezza e dei limiti sul piano
fisico ci sono dimensioni più potenti e se
camminiamo al loro fianco, rispettando
le leggi che tendono all’equilibrio,
all’ordine, abbiamo la possibilità di
espandere la nostra coscienza e vivere
nel presente, ovvero accettare la vita per
ciò che è: l’arte della realizzazione del
nostro Essere. È un discorso che riflette il
pensiero di Henry Miller, ma la figura di
Hawking suscita diverse domande.
“Viviamo in un mondo che ci disorienta con
la sua complessità. Vogliamo comprendere
ciò che vediamo attorno a noi e chiederci:
Qual è la natura dell’universo? Qual è il
nostro posto in esso? Da che cosa ha avuto
origine l’universo e da dove veniamo noi?
[...] quand’anche ci fosse una sola teoria
unificata possibile, essa sarebbe solo un
insieme di regole e di equazioni. Che cos’è
che infonde vita nelle equazioni e che
costruisce un universo che possa essere
descritto da esse?”, si chiede lo scienziato.
la Voce
del popolo
Anno 1 / n. 5 / martedì, 24 novembre 2015
IN PIÙ Supplementi è a cura di Errol Superina
[email protected]
SPETTACOLI
Edizione
Caporedattore responsabile f.f.
Roberto Palisca
Redattore esecutivo
Helena Labus Bačić
Impaginazione
Vanja Dubravčić
Collaboratori
Sandro Damiani, Ivana Precetti, Dragan Rubeša, Ana Varšava,
Patrizia Venucci Merđo
Foto
Željko Jerneić, Creative Commons e archivio
RECENSIONE
la Voce
del popolo
di Ana Varšava
VI PRESENTIAMO IL FILM «LA TEORIA DEL TUTTO»
DI JAMES MARSH CHE NARRA LA STRAORDINARIA VITA
DEL GRANDE SCIENZIATO INGLESE STEPHEN HAWKING
«GUARDATE
LESTELLEINVECE
DEIVOSTRIPIEDI»
Una dolce storia d’amore
Nonostante gli importanti quesiti che
si pone, La teoria del tutto è un film
incentrato principalmente sulla dolce
storia d’amore tra Stephen Hawking e la
sua prima moglie, Jane Hawking.
Siamo a Cambridge, nel 1963. Nella
prima scena, Stephen e Jane si
incontrano a una festa studentesca.
La fase iniziale della loro storia viene
raccontata brevemente con qualche
cenno al genio di Stephen. Il giovane,
all’epoca ventunenne, avrà un collasso, al
che gli verrà diagnosticata una malattia
degenerativa del motoneurone. Questa
provocherà un progressivo declino fisico
e l’atrofia muscolare al punto da non
consentirgli più di parlare e tramandare
oralmente i suoi brillanti pensieri. Gli
verranno pronosticati al massimo due
anni di vita, ma questa condizione non
impedirà a Stephen e Jane di superare
ogni ostacolo nella vita. Fortunatamente,
la prognosi dei medici si è rivelata
sbagliata, anzi, l’astrofisico ha festeggiato
lo scorso gennaio il suo 73.esimo
compleanno.
La dimensione umana
Il film non lo inquadra tanto in veste
di scienziato e illustre professore
universitario quanto si concentra sulla
sua dimensione umana di marito e
padre di tre figli avuti da Jane. Le scene
consistono spesso in sguardi di Stephen,
pieni di emozioni, che raccontano la
sua difficile condizione. Allo scopo
di comunicare, Stephen verrà aiutato
dal sintetizzatore vocale che genera
artificialmente ill suono di ciò che egli
scrive sul computer, un sistema che
successivamente verrà perfezionato
permettendogli di esprimersi più
velocemente.
Particolarmente ben elaborata è una
scena che riguarda direttamente la
sua condizione fisica. Mentre nelle
scene iniziali seguiamo Stephen ancora
inconsapevole della sua malattia, che
cammina e parla normalmente, egli è
ancora indeciso sull’argomento della tesi
di dottorato. Ma non appena gli viene
diagnosticata la malattia che gli prevede
soltanto due anni di vita, Stephen entra
nella stanza del professore con passo
deciso a riferirgli il tema della sua tesi: il
tempo, l’unica cosa che in quel momento
gli sfugge di mano.
Tra gli argomenti più rilevanti che
trattò in ambito scientifico sono la
cosiddetta “radiazione di Hawking“, la
termodinamica dei buchi neri, ovvero
la teoria secondo la quale i buchi
neri emanano radiazioni, e la teoria
cosmologica dell’universo senza confini
nello spaziotempo. Ha collaborato con
numerosi scienziati ed è un grande
promotore dell’idea che ci siano molti
mondi all’interno della meccanica
quantistica. Ipotizza, infatti, l’esistenza di
universi paralleli.
Versione idealizzata della vita di Hawking
Il suo bestseller “Dal big bang ai buchi
neri. Breve storia del tempo“, pubblicato
nel 1988, è stato venduto in più di 10
milioni di copie in tutto il mondo. È
pure il punto cruciale del film dal lato
personale: la fama che gli portò il libro
inasprì le tensioni nel matrimonio. Si
separò da Jane dopo trent’anni di vita
comune e sposò Elaine Mason, la sua
infermiera, ma i due divorziarono nel
2006. Jane e Stephen sono ancora oggi
buoni amici e collaboratori.
Il film è una versione romanticizzata
e idealizzata della vita di Stephen e
Jane, dal momento che il regista non si
sofferma più di tanto sulle sofferenze
dello scienziato. Ritengo che ci sia una
ragione per questo: l’ottimismo con cui
Hawking affronta la vita sembra davvero
un miracolo.
Le sue pubblicazioni sulle frecce del
tempo termodinamiche legate all’ipotesi
dell’universo senza confini pongono una
domanda chiave: “Che cosa accadrebbe
se l’universo cessasse di espandersi e
cominciasse a contrarsi?“.
Il gioco del tempo raggiunge l’apice nella
scena finale, in cui viene sintetizzata la
sua teoria secondo la quale nel caso in
cui l’universo smettesse di espandersi il
tempo inizierebbe a scorrere all’indietro
e noi avremmo la possibilità di vedere
il futuro al posto del passato. Il passato
lo vediamo soltanto perchè le frecce del
tempo si muovono in avanti.
Le frecce del tempo
Nell’ultima scena ci troviamo in
un bellissimo giardino. Stephen,
accompagnato da Jane, è stato appena
ricevuto dalla regina per essere insignito
del titolo di cavaliere dell’ordine
britannico (che ha, però, rifiutato).
Mentre osserva i figli correre spensierati,
il tempo comincia a scorrere all’idietro
fino alla scena iniziale, il momento in cui
Stephen scorge Jane alla lontana festa
studentesca. Invece noi, ora nel passato,
abbiamo effettivamente visto il futuro
e tutti i successi che questo futuro ha
portato a Stephen. L’ultima scena è una
splendida rappresentazione simbolica
della sua teoria sulle frecce del tempo e le
speculazioni sulle loro direzioni.
“Ospite: Professor Hawking, lei ha detto
di non credere in Dio... Ha una filosofia di
vita che la aiuta?
Stephen: È chiaro che noi siamo solo una
razza evoluta di primati su un pianeta
minore, che orbita intorno ad una stella
di medie dimensioni nell’estrema periferia
di una fra cento miliardi di galassie...
Ma... Fin dall’alba della civiltà, l’uomo
si è sempre sforzato di arrivare alla
comprensione dell’ordine che regola il
mondo. Dovrebbe esserci qualcosa di
molto speciale nelle condizioni ai confini
dell’universo. E cosa può essere più speciale
dell’assenza di confini? Non dovrebbero
esserci confini agli sforzi umani. Noi siamo
tutti diversi, per quanto brutta possa
sembrarci la vita, c’è sempre qualcosa che
uno può fare e con successo. Perché finché
c’è vita... c’è speranza!“
Il film ha ottenuto dieci nomination al
British Academy Film Awards, mentre
l’attore principale Eddie Redmayne
è stato insignito dell’Oscar per la sua
straordinaria interpretazione del noto
scienziato inglese.