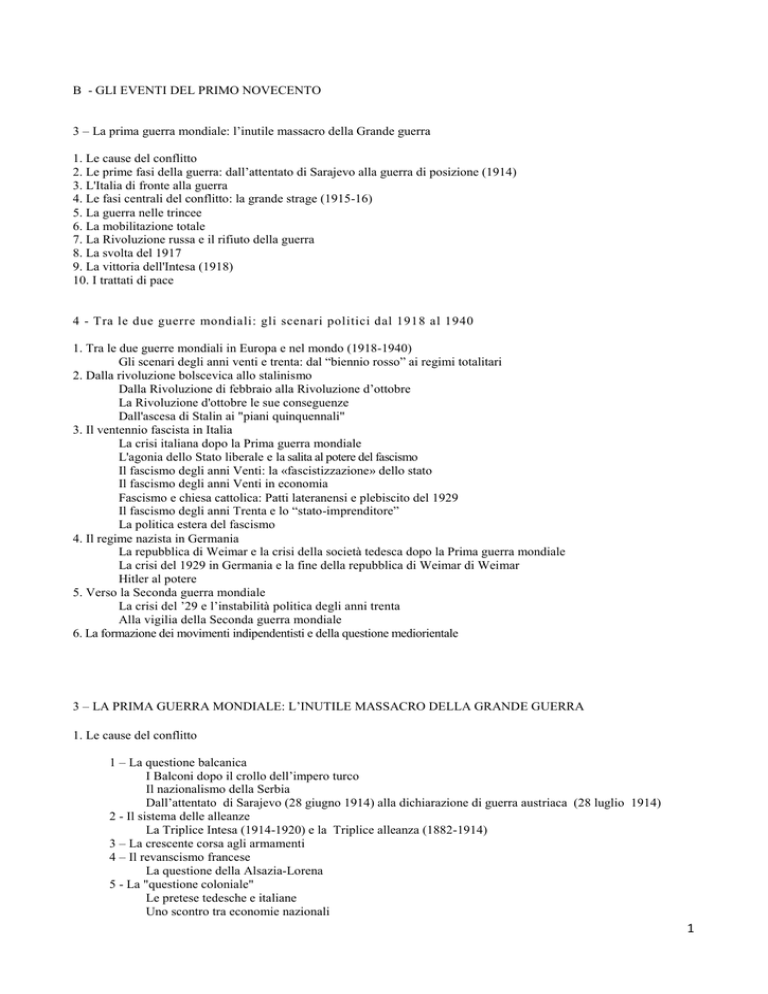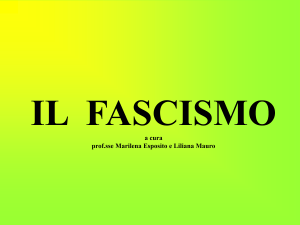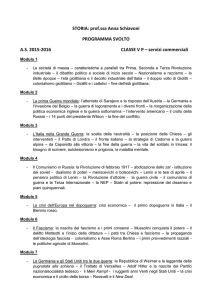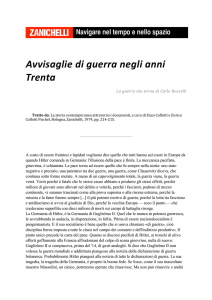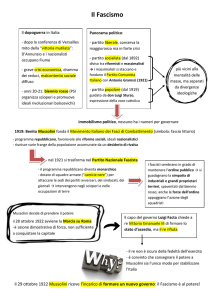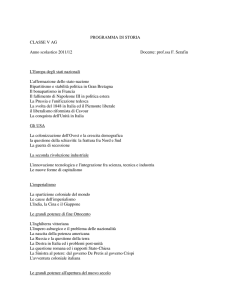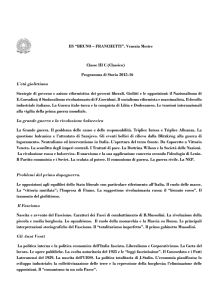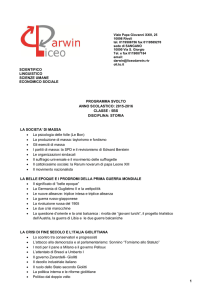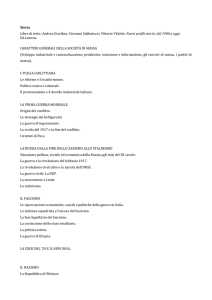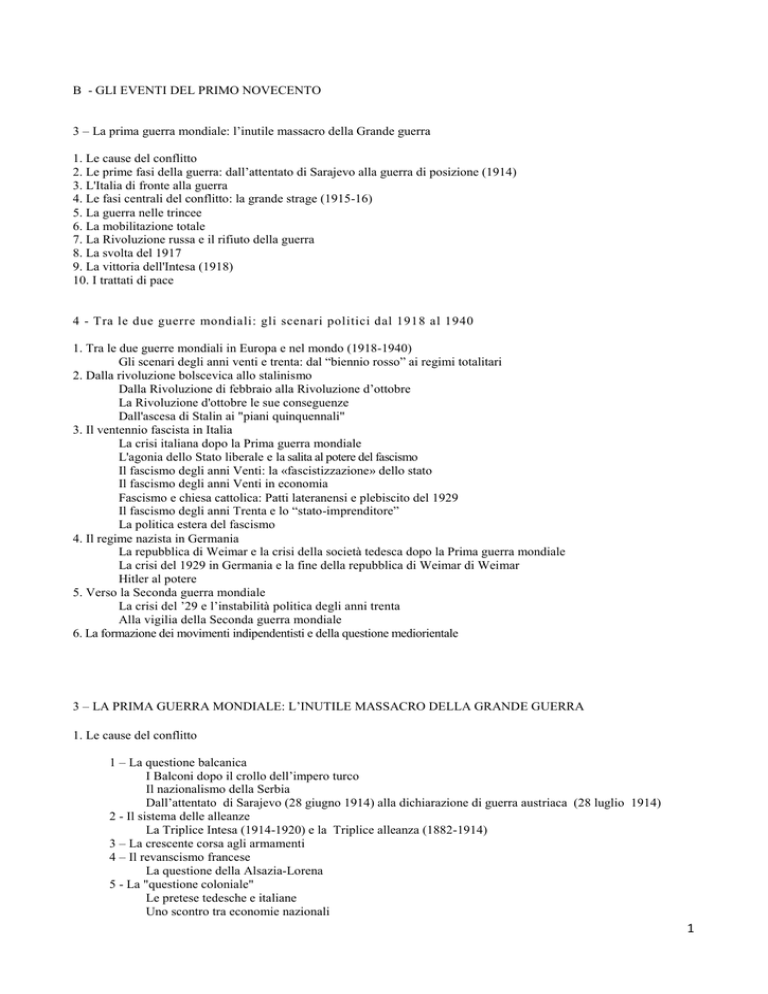
B - GLI EVENTI DEL PRIMO NOVECENTO
3 – La prima guerra mondiale: l’inutile massacro della Grande guerra
1. Le cause del conflitto
2. Le prime fasi della guerra: dall’attentato di Sarajevo alla guerra di posizione (1914)
3. L'Italia di fronte alla guerra
4. Le fasi centrali del conflitto: la grande strage (1915-16)
5. La guerra nelle trincee
6. La mobilitazione totale
7. La Rivoluzione russa e il rifiuto della guerra
8. La svolta del 1917
9. La vittoria dell'Intesa (1918)
10. I trattati di pace
4 - Tra le due guerre mondiali: gli scenari politici dal 1918 al 1940
1. Tra le due guerre mondiali in Europa e nel mondo (1918-1940)
Gli scenari degli anni venti e trenta: dal “biennio rosso” ai regimi totalitari
2. Dalla rivoluzione bolscevica allo stalinismo
Dalla Rivoluzione di febbraio alla Rivoluzione d’ottobre
La Rivoluzione d'ottobre le sue conseguenze
Dall'ascesa di Stalin ai "piani quinquennali"
3. Il ventennio fascista in Italia
La crisi italiana dopo la Prima guerra mondiale
L'agonia dello Stato liberale e la salita al potere del fascismo
Il fascismo degli anni Venti: la «fascistizzazione» dello stato
Il fascismo degli anni Venti in economia
Fascismo e chiesa cattolica: Patti lateranensi e plebiscito del 1929
Il fascismo degli anni Trenta e lo “stato-imprenditore”
La politica estera del fascismo
4. Il regime nazista in Germania
La repubblica di Weimar e la crisi della società tedesca dopo la Prima guerra mondiale
La crisi del 1929 in Germania e la fine della repubblica di Weimar di Weimar
Hitler al potere
5. Verso la Seconda guerra mondiale
La crisi del ’29 e l’instabilità politica degli anni trenta
Alla vigilia della Seconda guerra mondiale
6. La formazione dei movimenti indipendentisti e della questione mediorientale
3 – LA PRIMA GUERRA MONDIALE: L’INUTILE MASSACRO DELLA GRANDE GUERRA
1. Le cause del conflitto
1 – La questione balcanica
I Balconi dopo il crollo dell’impero turco
Il nazionalismo della Serbia
Dall’attentato di Sarajevo (28 giugno 1914) alla dichiarazione di guerra austriaca (28 luglio 1914)
2 - Il sistema delle alleanze
La Triplice Intesa (1914-1920) e la Triplice alleanza (1882-1914)
3 – La crescente corsa agli armamenti
4 – Il revanscismo francese
La questione della Alsazia-Lorena
5 - La "questione coloniale"
Le pretese tedesche e italiane
Uno scontro tra economie nazionali
1
6 - Ambizioni egemoniche in Europa
Irredentismo italiano, pangermanesimo tedesco, il panslavismo russo
7 - La guerra spinta come acceleratore dello sviluppo economico
8 - Un modo di controllare i conflitti sociali interni
2. Le prime fasi della guerra: dall’attentato di Sarajevo alla guerra di posizione (1914)
Dall’attentato di Sarajevo (28 giugno 1914) alla dichiarazione di guerra austriaca (28 luglio 1914) (vedi cap. 1)
II sistema delle alleanze militari e la mobilitazione russa
La dichiarazione di guerra della Germania alla Russia (2 agosto 1914) e alla Francia (3 agosto 1914)
L’iniziativa tedesca e l'invasione del Belgio (4 agosto 1914)
L’entrata in guerra della Gran Bretagna (4 agosto 1914)
La mondializzazione del conflitto
L'attacco tedesco e l’arresto dell’offensiva sul fiume Marna
La "guerra di posizione"
I1 fronte russo-tedesco e la fermata dei russi
Fronte orientale e fronte occidentale
3. L'Italia di fronte alla guerra
I neutralisti (liberali di Giolitti, i socialisti e i cattolici)
Gli interventisti (irredentisti, singole personalità socialiste, nazionalisti, liberali di destra)
Il Patto di Londra e le «radiose giornate»
Il voto favorevole della Camera e la dichiarazione di guerra all'Austria ( 24 maggio 1915)
4. Le fasi centrali del conflitto: la grande strage (1915-16)
La guerra di posizione
La tattica dello sfondamento e dell’usura
Il fronte alpino
Le battaglie dell’Isonzo (giugno-dicembre 1915)
Il fronte orientale
La ritirata dei russi dalla Polonia e la sconfitta della Serbia
Il coinvolgimento della società civile
Le "battaglie d'usura" di Verdun (inverno-estate 1916) e della Somme (dall’estate 1916)
Il fronte alpino
La “spedizione punitiva”
Le dimissioni di Salandra e il nuovo governo Boselli
La ripresa dell'offensiva sull'Isonzo (agosto 1916)
II blocco navale franco-inglese e la guerra sottomarina
II fronte mediorientale
Promesse d'indipendenza e guerriglia antiturca
Giovani turchi e minoranze etniche
Il genocidio degli armeni
5. La guerra nelle trincee
La trincea
La vita nelle trincee
L'assalto
Ufficiali e soldati
Renitenza e insubordinazione
6. La mobilitazione totale
La mobilitazione totale e l’accelerazione del processo di massificazione della società
La guerra come esperienza di massa
1 – Il legame scienza, tecnica, e industria
Il coinvolgimento dei paesi più industrializzate
L’efficienza delle armi (mitragliatrici, gas, sommergibili, aerei e carri armati)
La crescita del potenziale economico-industriale nazionale
2 -L'intervento dello Stato nell'economia
2
Lo stato da committente a regolatore del mercato del lavoro, del credito, del commercio
Le applicazioni del capitalismo organizzato alla guerra
Dal modello liberale e liberista all’economia organizzata
3 - L’intervento dello Stato nella società civile
Nuovi aspetti della vita civile regolati dallo Stato
Guerra totale e fronte interno
La militarizzazione della politica
4 - Nuovi soggetti sociali: le donne
7. La Rivoluzione russa e il rifiuto della guerra
La rivoluzione a Pietrogrado (febbraio del 1917)
Le protese contro la guerra
L’ideologizzazione della guerra
8. La svolta del 1917
L’uscita della Russia (vedi cap. 7)
L’entrata in guerra degli Stati Uniti
La ripresa della guerra sottomarina totale
La dichiarazione di guerra degli Stati Uniti (6 aprile del 1917)
I «quattordici punti» del presidente Wilson
L’uso ideologico dei «quattordici punti»
Le conseguenze del crollo del regime zarista
La disfatta di Caporetto (24 ottobre 1917 )
Il governo Orlando
L'armistizio di Brest-Litovsk (dicembre del 1917)
9. La vittoria dell'Intesa (1918)
La tattica della" sorpresa
Lo sfondamento del fronte alleato franco-inglese in Piccardia e nello Champagne (21 marzo 1918)
La seconda battaglia della Marna (18 luglio 1918)
Lo sfondamento franco-inglese a Amiens (8-11 agosto 1918)
La vittoria italiana a Vittorio Veneto (24 ottobre 1918)
I disastri causati della guerra
10. I trattati di pace
.
Dai «Quattordici punti» a limitare la Germania e il pericolo del socialismo
I trattati con la Germania
Riduzione esercito, smilitarizzazione Renania, pagamento danni di guerra mediante, restituzione
dell'Alsazia-Lorena alla Francia, diritto francese e belga a sfruttare per quindici anni il bacino carbonifero
della Saar, cessioni territori alla Danimarca e alla Polonia, Danzica città libera
I trattati con l'Austria
Divisione Austria e Ungheria
Cessione all’Italia del Trentino, dell'Alto Adige, di Trieste e dell'Istria ma non della Dalmazia
La creazione di nuovi Stati
Austria, Ungheria, Cecoslovacchia, Jugoslavia (Serbia, Croazia, Slovenia, Macedonia) , Finlandia,
Estonia, Lettonia e Lituania, Turchia (ridotta alla penisola anatolica)
I rapporti con la Russia rivoluzionaria
Gli stati Stati-cuscinetto
Il disfacimento degli ultimi Imperi (russo, austro-ungarico, Reich tedesco
La Società delle nazioni
L'esclusione iniziale dei paesi sconfitti e della Russia e la non adesione degli Stati Uniti
L’egemonia della Gran Bretagna e della Francia
3
4 -TRA LE DUE GUERRE MONDIALI: GLI SCENARI POLITICI DAL 1918 AL 1940
1. Tra le due guerre mondiali in Europa e nel mondo (1918-1940)
1. Gli scenari degli anni venti e trenta: dal “biennio rosso” ai regimi totalitari
Il “biennio rosso”: rivendicazioni sindacali e consigli operai
L’ondata di agitazioni (otto ore giornaliere, potere nella fabbrica e nello Stato)
La fr attur a tr a avan guar die (III Internazionale comunista) e il resto del movimento operaio
Anni venti: la stabilizzazione
La Repubblica di Weimar
La Costituzione di Weimar
La rivolta degli spartachisti e il colpo di stato a Monaco
Gli accordi di Locarno (1925),
L’elezione a presidente di Hindenburg
I regimi liberaldemocratici in Francia e Gran Bretagna
Francia: governi moderati di destra e di sinistra
Gran Bretagna: bipolarismo tra conservatori e laburisti
Anni trenta: l’avvento del totalitarismo
I precedenti: l’Italia e i paesi dell’Europa centro-orientale
I regimi autoritari di tipo tradizionale e il totalitarismo moderno
La dittatura di Primo de Rivera in Spagna
Il regime clericale-autoritario in Austria
La svolta bellicista degli anni trenta
2. Dalla rivoluzione bolscevica allo stalinismo
Dalla Rivoluzione di febbraio alla Rivoluzione d’ottobre
La Russia alla vigilia della rivoluzione
Pochi grandi centri industriali e un'agricoltura di tipo arretrato
Aperture e misure repressive
Il peggioramento delle condizioni di vita causato dalla guerra,
La Rivoluzione di febbraio (1917)
Scioperi e fraternizzazione delle truppe dell'esercito
Arresto e uccisione dello zar Nicola
Il primo governo repubblicano provvisorio
Il governo provvisorio (conservatori, liberali, esponenti della destra social rivoluzionaria e appoggio
di socialrivoluzionari e menscevichi)
Diverse e contrapposte aspettative (continuare la guerra e riforma agraria)
I soviet
Dalle fabbriche alle truppe al fronte
Il "doppio potere":
Il governo Kerenskij
L’apertura alle forze moderate dei menscevichi e dei socialisti rivoluzionari
Il Partito bolscevico di Lenin
Lenin e le Tesi di aprile (Tutto il potere ai soviet, pace subito, terra ai contadini)
Il tentativo di colpo di stato del generale Kornilov
Sommosse spontanee di operai e di soldati e messa fuori legge dei bolscevichi
Il tentativo colpo di stato del generale Kornilov e l’intervento del partito di Lenin
La Rivoluzione d'ottobre le sue conseguenze
La presa del palazzo d’inverno (ottobre 1917)
L’assalto al palazzo d'Inverno e la fuga di Kerenskij
L’appoggio del congresso dei soviet
4
Appello per una pace senza annessioni, la confisca e la ridistribuzione ai contadini delle terre, la
costituzione di un soviet dei commissari del popolo e la preparazione dell'Assemblea costituente
L’Assemblea costituente
La maggioranza dei socialrivoluzionari
Lo scioglimento dell'assemblea da parte del governo rivoluzionario dei soviet
La proclamata della Repubblica federale socialista russa
La pace di Brest-Litovsk
La rinunciare a estesi territori
L'opposizione dei socialrivoluzionari e le prime azioni terroristiche
La guerra civile e la dittatura rivoluzionaria
Le truppe inglesi, americani e giapponesi, le truppe fedeli al governo provvisorio di Kerenskij o al
precedente regime zarista (i "bianchi") o ai socialrivoluzionari nella regione del Don, gli anarchici in
Ucraina
Il rafforzamento della polizia politica, la messa fuori legge dei social rivoluzionari e degli altri partiti,
la restaurazione della pena di morte, arresti arbitrari ed esecuzioni sommarie di «nemici di classe»
La riorganizzò dell’esercito: l’Armata rossa di Trotzkij
Il fallito tentativo di esportare la rivoluzione con la guerra
L'offensiva sul territorio polacco
Il riconosceva delle repubbliche indipendenti della Polonia, della Finlandia e gli Stati "baltici"
(Estonia, Lettonia, Lituania).
La costituzione dell’Unione delle repubbliche socialiste sovietiche (Urss) (1922)
Il comunismo di guerra
La carenza di generi alimentari
Le drastiche misure di guerra (requisizioni, amassi),
Scioperi e ammutinamenti
La Nep
La Nuova politica economica e la liberalizzò il commercio
La malattia di Lenin
Dall'ascesa di Stalin ai "piani quinquennali"
L'isolamento internazionale dell'Urss
Il contrasto tra e le posizioni di Trotzkij e di Stalin
1 - Rivoluzione permanente (Trotzkij) o socialismo in un solo paese (Stalin)
La Terza Internazionale
II controllo decisivo del partito bolscevico e l’alleanza con Bucharin
2 - Industrializzazione rapida (Trotzkij) o prospettiva agricola (Stalin)
Il Partito bolscevico sotto la guida di Stalin
3 - La denuncia dell’'involuzione burocratica (Trotzkij, Zinov'ev, Kamenev)
Il fallimento della collettivizzazione delle terre
I nepmen
Il primo piano quinquennale e la collettivizzazione dei fondi
Fuga dei contadini, deportazioni di massa e morti di fame
Industrializzazione forzata e "piani quinquennali"
L’Urss tra i paesi più industrializzati
La militarizzazione della vita economica
Stalinismo e repressione
La religione del capo
Le purghe
3. Il ventennio fascista in Italia
La crisi italiana dopo la Prima guerra mondiale
La crisi sociale
La crisi istituzionale
Il governo Nitti e l'approvazione della nuova legge elettorale (introduzione del sistema
proporzionale)
La frammentazione delle forze politiche
La sfiducia nella democrazia e nella pace
La vittoria mutilata
5
La richiesta di Fiume e l’abbandono della Conferenza di pace
L’occupazione di Fiume da parte dei legionari di Gabriele D'Annunzio
Il Trattato di Rapallo (12 novembre 1920)
L’intervento dell’esercito contro i legionari (18 gennaio 1921)
La politica interna tra politica giolittiana e aspirazioni rivoluzionarie
Il risanamento del bilancio statale
Il fallimento del disegno politico giolittiano
1 – La perdita di potere da parte dello Stato
L'occupazione delle fabbriche
Lo scontro tra industriali metalmeccanici, Federazione italiana operai metallurgici e consigli di
fabbrica
La serrata e l’occupazione delle fabbriche come l'inizio di un moto rivoluzionario
Il prevalere della linea dei dirigenti della Cgl e dell'iniziativa mediatrice di Giolitti
L’accettazione delle richieste economiche della Fiom e il progetto per il controllo sindacale delle
fabbriche
La nascita del partito comunista
II Congresso del Comintern e le condizioni per l'ammissione dei partiti operai all'Internazionale
comunista
La minoranza di sinistra abbandona il Psi per fondare il Partito comunista d'Italia (gennaio 1921)
Il prevalere dei massimalisti nel Psi
L'agonia dello Stato liberale e la salita al potere del fascismo
Il declino dello stato liberale
La paralisi del sistema politico italiano
Le elezioni del maggio 1921 e le dimissioni di Giolitti
Dallo stato liberaldemocratico al regime fascista
Le fasi del passaggio dallo Stato liberale allo Stato fascista: 1 - perdita di potere, 2 - situazione di
stasi, 3 - presa del potere
La nascita del movimento fascista
La fondazione dei «fasci di combattimento» (23 marzo 1919)
Il programma politico eclettico e confuso, le eterogenee adesioni, lo stile politico aggressivo e
violento
L'incendio della sede dell'«Avanti!».
Il processo di mutazione: strutture paramilitari e lotta spietata contro il movimento socialista
Il fascismo agrario e lo squadrismo
I proprietari terrieri e il finanziamento dello squadrismo per abbattere il potere delle leghe contadine
La diffusione dello squadrismo
I motivi del successo dello squadrismo: neutralità della classe dirigente e degli apparati statali.
L’intento della classe dirigente: «costituzionalizzare» il fascismo assorbendolo nella maggioranza
liberale
Le elezioni del maggio 1921
I blocchi nazionali e l'ingresso alla Camera di 35 deputati fascisti
2 – La stasi istituzionale
Il governo Bonomi e il patto di pacificazione
Il patto di pacificazione tra socialisti e fascisti
Il congresso dei Fasci: lo scontro tra Mussolini e i fascisti intransigenti
La sconfessione del patto di pacificazione e la fondazione del il Partito nazionale fascista
Il governo Facta
La scarsa autorità politica e il dilagare della violenza squadrista
La strategia fascista: violenza armata e manovra politica
Lo sciopero generale legalitario
I fascisti come custodi dell'ordine
La marcia su Roma e la conquista dello Stato
Il pericolo del rigetto da parte delle forze moderate
Il progetto della marcia su Roma
Il rifiuto del re di firmare il decreto per la proclamazione dello stato d'assedio
Mussolini richiede e ottiene la presidenza del governo (fascisti e liberali giolittiani, liberali di destra,
democratici e popolari)
6
Il fascismo degli anni Venti: la «fascistizzazione» dello stato
3 – La conquista del potere
La costruzione dello Stato totalitario
La normalizzazione dei quadri minori del fascismo
Il controllo dei partiti
La fusione con i nazionalisti e il collaborazionismo del Partito popolare
Milizia volontaria per la sicurezza nazionale
Organizzazione armata del partito
Gran Consiglio del fascismo
Un nuovo organo dello Stato, direttamente controllato dal partito fascista e da Mussolini
La nuova legge elettorale e le elezioni del 1924
Il premio di maggioranza
Il "listone" (fascisti, molti esponenti della classe dirigente liberale)
La vittoria dei fascisti meno clamorosa del previsto
Il delitto Matteotti e l'Aventino
La denunciò in Parlamento le violenze e la scomparsa di Matteotti
L’Aventino dei parlamentari
Le responsabilità di Mussolini nel delitto
Il discorso del 3 gennaio 1925
Mussolini compreso che il re non sarebbe intervenuto si assume la piena paternità del delitto
Il controllo delle associazioni politiche "segrete"
Il ruolo istituzionale di Mussolini
L’edificazione del potere personale di Mussolini
Emanare norme giuridiche senza dover chiedere l'approvazione delle Camere
La smobilitazione dei centri di potere periferici
La sostituzione dei sindaci elettivi con i podestà e il rafforzamento dell'autorità dei prefetti
La restrizione delle libertà e il partito unico
La «costituzionalizzazione» del Gran Consiglio, la soppressione della libertà di stampa e lo
scioglimento de i partiti
L’apparato repressivo
I confino di polizia e il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, la pena di morte
La soppressione delle libertà sindacali
Confederazioni sindacali fasciste e corporazioni
Il Codice di diritto penale
Il fascismo degli anni Venti in economia
Il periodo liberista
Privatizzazioni, detassazione de i capitali esteri, abolizione del le imposte sui capitali delle banche e
delle industrie
La rivalutazione della lira
«Quota 90» e la difesa dei ceti medi a reddito fisso
Stato e gruppi industriali
La difesa degli interessi dei grandi gruppi industriali
Il «corporativismo
Il «Patto di palazzo Vidoni» e le «corporazioni nazionali» fasciste
La «Carta del Lavoro» (1927)
Fascismo e chiesa cattolica: Patti lateranensi e plebiscito del 1929
I Patti lateranensi
L’accordo diplomatico (piena sovranità al papato sulla città del Vaticano, il risarcimento
finanziario)
Il Concordato (piena libertà di culto, effetti civili del matrimonio religioso e insegnamento
obbligatorio della religione cattolica nelle scuola)
Il plebiscito del 24 marzo 1929
Il rapporto di convivenza fra fascismo e gerarchie della chiesa
I rapporti privilegiati Chiesa - Stato e il rafforzamento della presenza nella società della Chiesa
I limiti del fascismo italiano (concorrenza Chiesa nel controllo della società, presenza re, arretratezza
socio-economica) (vedi appunti)
Il fascismo degli anni Trenta e lo “stato-imprenditore”
La crisi del ‘29
7
La crisi delle grandi «banche miste»
La nuova strategia «dirigista»
La creazione di un istituto di credito pubblico (l'Imi)
La creazione dell'Iri (azionista di maggioranza delle banche in crisi e controllo di alcune fra le
maggiori imprese italiane)
Il capitalismo di stato in Italia
Stato-banchiere e Stato-imprenditore
La subordinazione dell'agricoltura all'industria,
I programmi di lavori pubblici
L’economia di guerra
La politica estera del fascismo
Anni venti: tra velleità revisionistiche e atteggiamento moderato
Il comportamento amichevole verso Francia e Inghilterra
La restituzione di Fiume e il riconoscimento della Jugoslavia
L’ostilità nei confronti della Germania e le mire egemoniche di Mussolini sull'Austria.
Anni trenta: la politica bellicista
Mussolini assunse personalmente il ministero degli Esteri
La conferenza di Stresa (aprile 1935) e la condanna del riarmo tedesco
L’aggressione all’Etiopia
Un'impresa coloniale come sfogo alla vocazione imperiale del fascismo, occasione di mobilitazione
popolare e per sfruttare la favorevole congiuntura diplomatica
Un esercito enorme e metodi atroci
La condanna della Società delle Nazioni e le «sanzioni»
La politica economica dell'«autarchia»
Produrre in Italia le merci in precedenza importate
Le illusioni di Mussolini
L’avvicinamento alla Germania: dall’asse Roma-Berlino al Patto d’acciaio
L’asse Roma-Berlino: un'alleanza subordinata
Il Patto d'acciaio
La svolta totalitaria
Un atteggiamento duro nei confronti della borghesia come atteggiamento mentale
Le modifiche istituzionali
La creazione del ministero per la Cultura popolare, della Gioventù italiana del littorio e la
sostituzione della Camera dei deputati con una nuova Camera dei fasci e delle corporazioni
Iniziative di carattere formale
La vergogna delle leggi razziali
4. Il regime nazista in Germania
La repubblica di Weimar e la crisi della società tedesca dopo la Prima guerra mondiale
Il dopoguerra e la repubblica di Weimar
Consigli degli operai e dei soldati e governo provvisorio (ala moderata del Spd )
Lo scontro socialdemocratici e Lega di Spartaco
L’Assemblea costituente e la Costituzione di Weimar
Il compromesso fra Spd ed esercito
I risultati sul piano sociale (giornata lavorativa di otto ore, assistenza ai disoccupati, divieto dei
licenziamenti arbitrari, suffragio universale maschile e femminile, ecc.) e il mancato
ridimensionamento dei precedenti poteri
Le conseguenze delle sanzioni internazionali e il rafforzamento delle forze di destra
La svolta conservatrice della repubblica
Il pagamento dei debiti di guerra
Stampa di carta-moneta e inflazione
Colpiti: lavoratori salariati, ceto medio; avvantaggiati proprietari di immobili e i grandi gruppi
industriali
La campagna propagandistica delle forze di destra
I corpi franchi e gli attentati terroristici, il putsch (rivolta) a Monaco in Baviera di Hitler (1923)
L’accordo con i vincitori sulle riparazioni (piano Dawes)
L’elezione del maresciallo Hindenburg a presidente della Repubblica
8
Il nuovo ceto medio, la riduzione degli operai professionalizzati e sindacalizzati e le difficoltà della
socialdemocrazia
La crisi del 1929 in Germania e la fine della repubblica di Weimar di Weimar
La crisi del ’29 e la salita al potere di Hitler: le fasi 1) la «crisi di efficienza» ; 2) la «crisi d’autorità» ; 3)
la «presa del potere»
1 - La «crisi di efficienza» del governo Brüning (1930-32)
La crisi del 1929 e l’aumento della disoccupazione
Brüning e la gestione extraparlamentare della crisi
L’elezioni del settembre 1930 e il fallimento di rafforzare il governo
2 - La «crisi d'autorità» dei governi di Franz von Papen e Kurt von Schleicher (1932-33)
La crisi economica e la radicalizzazione delle masse degli elettori
Il partito nazionalsocialista e l’ampliamento delle sue alleanze
La rielezione di Hindenburg
Le dimissioni di Brüning e il governo Franz von Papen
La richieste di nuove elezioni da parte di Hitler e l’ottenimento della maggioranza relativa ( luglio
1932)
La nomina a cancelliere di Hitler (30gennaio 1933)
3 - La «presa del potere» da parte di Hitler (1933)
Hitler al potere
La costruzione dello stato totalitario
Le violenze delle Sa e l’incendio al Reichstag
Le elezioni del 5 marzo 1933 (43,9% al Partito nazionalsocialista)
La messa fuori legge dei partiti ( luglio 1933)
«La notte dei lunghi coltelli»
L'eliminazione fisica della componente «socialista» del Partito nazionalsocialista: il massacro
delle Sa da parte di reparti delle Ss
Hitler si autonomina Fiihrer e cancelliere (Reichkanzler) (agosto 1934)
La persecuzione antisemita
Le leggi di Norimberga
La «notte dei cristalli»
La politica economica, sociale e militare del Terzo Reich
Lavori pubblici e integrazione dell'intervento dello stato con il sistema privato
Il riarmo della Germania e i creditori internazionali
5. Verso la Seconda guerra mondiale
La crisi del ’29 e l’instabilità politica degli anni trenta
Le conseguenze della crisi del ’29: l’instabilità politica tra fascismo e Fronti popolari
Il fascino seduttivo della violenza e i movimenti di estrema destra
La strategia del movimento operaio
I successi di Hitler e la svolta nella politica estera dell’URSS (adesione alla Società delle
nazioni , l'alleanza militare con la Francia)
Il capovolgimento della linea seguita dal Comintern e dei partiti comunisti europei: dalla
contrapposizione frontale nei confronti delle forze democratico-borghesi e delle socialdemocrazie alla collaborazione nella lotta al fascismo (i fronti popolari)
Il Fronte popolare in Francia
L’instabilità istituzionale dei primi anni trenta
Le elezioni del 1936 e la vittoria del Fronte popolare
Gli accordi di Palais Matignon (contratti collettivi di lavoro e dei diritti sindacali; maggiorazione dei
salari, introduzione dei delegati operai, quaranta ore settimanali, due settimane di ferie)
L’insofferenza dei ceti medi urbani
La divisione delle forze di sinistra
Lo "sciopero del capitale" (esportare i capitali all'estero per ridurre gli investimenti)
Il nuovo governo Daladier e la sconfessione degli accordi di Matignon. (1938)
La Guerra civile spagnola (1936-39)
L’esilio volontario del re e la proclamazione della repubblica (1931)
La fondazione della Falange e il ricorse ad azioni terroristiche (1933)
9
La vittoria elettorale del «Fronte popolare» (1936)
La ribellione dell'esercito di stanza in Marocco con a capo Francisco Franco
L’aiuto di Hitler e di Mussolini e l'equidistanza o il non intervento" delle potenze democratiche
Le Brigate Internazionali di volontari filo repubblicani e l’aiuto dell’Urss
L'unità delle destre e le divisioni del Fronte popolare
La caduta di Barcellona e Madrid (1939)
Alla vigilia della Seconda guerra mondiale
Il trabocchetto del Trattato di Versailles
Le rivendicazioni della Germania, dell'Italia e del Giappone
Le tensioni fra i vincitori della Prima guerra mondiale
I tentavi egemonici della Francia controbilanciati dall'Inghilterra spalleggiando le rivendicazioni della
Germania; l’ambiguità dell'Italia,
I limiti politici degli stati-nazione
Il prevalere del proprio interesse nazionale (stati europei) e l’imposizione del libero scambio (Usa)
Anni Trenta: i primi venti di guerra
L’aggressione giapponese alla Manciuria cinese (1932)
L’aggressione dell'Italia fascista all'Etiopia (1935)
L'asse Roma-Berlino (ottobre 1936).
Le prime iniziative hitleriane
1- La reintroduzione della coscrizione obbligatoria (1935)
2 – la rimilitarizzazione della Renania (1936)
3 – L’occupazione dell'Austria (1938)
La politica di appeasement
«Ammansire» Hitler accontentandolo nelle sue rivendicazioni più «ragionevoli» (Chamberlain)
Churchill: (l'unico modo per fermare Hitler opporsi)
4 - La questione dei sudeti
Le mire di Hitler: l'annessione della regione dei Sudeti e la distruzione dello Stato cecoslovacco
La Conferenza di Monaco
L’accettazione del progetto presentato dall'Italia che accoglieva quasi alla lettera le richieste
tedesche
5 - L’ultimatum alla Polonia
L’ ultimatum alla Polonia perché gli cedesse la città di Danzica (marzo 1939)
6 - Il Patto d'acciaio e il Patto Ribbentrop-Molotov
Il Patto d'acciaio con l'Italia ( 22 maggio 1939): la subordinazione italiana
Il patto Ribbentrop - Molotov
Un patto di non aggressione e la spartizione della Polonia
10