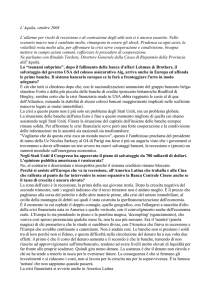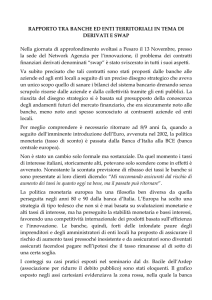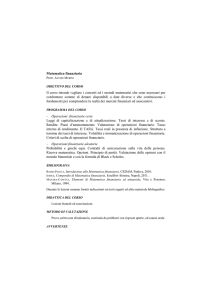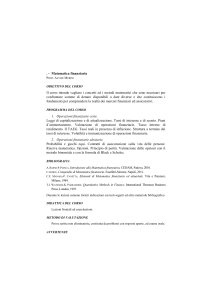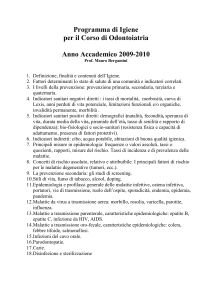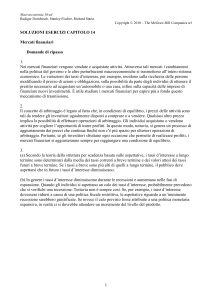PAUL KRUGMAN
IL
RITORNO
DELL’ECO
DELLA
DEPRESSI
E LA
CRISI
DEL 2008
Il premio Nobel per
l'Economia
ci spiega il «grande crac»
e come uscirne
nuova edizione aggiornata e
ampliata
Prima edizione: 1999
Prima edizione negli Elefanti
Saggi: aprile 2001
In questa collana
Nuova edizione aggiornata e
ampliata: gennaio 2009
Prima ristampa: febbraio 2009
Seconda ristampa: marzo 2009
Traduzione dall’inglese di
Nicolò Regazzoni (capitoli
1,2,3, 4, 5, 6, 10)
Roberto Merlini (capitoli 7,8,9
e aggiornamenti)
Titolo originale dell’opera:
The Return of Depression
Economics and the Crisis of
2008
© 2009, 1999 by Paul Krugman
ISBN 978-88-11-60093-0
© 1999, 2001, 2009, Garzanti
Libri s.p.a., Milano
Gruppo editoriale Mauri
Spagnol
Printed in Italy
garzantilibri.it
Dello stesso autore in edizione
Garzanti:
Il silenzio dell’economia
L’incanto del benessere
Geografia e commercio
internazionale
Economisti per caso Meno
tasse per tutti?
IL RITORNO
DELL’ECONOMIA
DELLA
DEPRESSIONE
E LA CRISI DEL
2008
Introduzione
La
maggior
parte
degli
economisti, se per caso hanno
avuto una propria opinione in
merito, considerano la Grande
Depressione degli anni Trenta
una tragedia di cui si poteva
tranquillamente fare a meno. Se
solo Herbert Hoover non avesse
tentato di portare il bilancio in
pareggio in un momento di
piena recessione; se solo la
Federal Reserve non avesse
difeso lo standard aureo a spese
dell’economia nazionale; se
solo fosse stato dato denaro
contante alle banche sull’orlo
del collasso, così da arginare il
panico che si diffuse tra gli
istituti di credito negli anni
1930-31; allora il crollo del
mercato azionario del 1929
avrebbe portato solo a una
recessione di poco conto, che
sarebbe
stata
presto
dimenticata.
E
poiché
economisti e politici hanno
imparato la lezione – oggi
nessun ministro del Tesoro
seguirebbe infatti il famoso
consiglio di Andrew Mellon di
«Disfarsi degli operai, disfarsi
delle azioni, disfarsi dei
contadini,
disfarsi
degli
investimenti
immobiliari…
espellere il marcio dal sistema»
– niente di simile alla Grande
Depressione potrà mai fare
ritorno.
E se non fosse vero?
Alla fine degli anni Novanta,
un gruppo di economie
asiatiche – economie che
producevano circa un quarto
dell’output
mondiale
e
contavano una popolazione
complessiva di oltre seicento
milioni di abitanti – ha vissuto
una
crisi
che
ricorda
sinistramente
la
Grande
Depressione. Oggi come ieri
quella crisi ha cominciato a dare
i primi segnali in un cielo
azzurro e sereno, quando la
maggior parte degli esperti
prevedeva che il boom sarebbe
comunque continuato, anche se
la
recessione
si
stava
avvicinando; oggi come ieri i
tradizionali
interventi
macroeconomici si sono rivelati
inefficaci,
forse
anche
controproducenti. Il fatto che
qualcosa di simile possa
accadere nel mondo moderno
dovrebbe far venire i brividi a
chiunque abbia un minimo di
senso della storia. A me li ha
fatti venire di sicuro. La prima
edizione di questo libro è stata
scritta in risposta alla crisi
asiatica degli anni Novanta.
Mentre alcuni la consideravano
un fenomeno esclusivamente
asiatico, io la consideravo un
fosco presagio per tutti noi, un
indicatore del fatto che i
problemi dell’economia della
depressione non sono venuti
meno nel mondo moderno. È
triste doverlo dire, ma avevo
ragione a preoccuparmi: mentre
questa nuova edizione va in
stampa, gran parte del mondo,
inclusi gli Stati Uniti, è alle prese
con una crisi finanziaria ed
economica che assomiglia alla
Grande Depressione ancora più
di quanto non le assomigliavano
le vicissitudini asiatiche degli
anni Novanta.
Il tipo di problema che ha
vissuto l’Asia un decennio fa, e
che stiamo vivendo tutti noi, è
proprio quello che pensavamo
di avere imparato a evitare. Nel
passato, durante i momenti di
difficoltà, i grandi paesi
industrializzati con governi forti
– come la Gran Bretagna negli
anni Venti – potevano non
essere sempre in grado di
rispondere a prolungati periodi
di stagnazione e deflazione; ma
negli anni a cavallo tra John
Keynes e Milton Friedman
eravamo convinti di essere
ormai sufficientemente pronti a
evitare che ciò succedesse di
nuovo. Tempo fa le nazioni più
piccole – come l’Austria nel
1931 – potevano anche restare
in balìa dei dissesti finanziari e
apparire incapaci di governare il
loro destino economico, ma
oggi ci si aspetta che esperti
banchieri
e
funzionari
governativi (per non parlare del
FMI) siano in grado di
intervenire rapidamente così da
contenere le crisi prima che si
diffondano. Un tempo i governi
– come quello degli Stati Uniti
durante gli anni 1930-31 –
potevano assistere impotenti al
collasso del sistema bancario
nazionale; ma nel mondo
moderno si presume che
l’assicurazione dei depositi e la
prontezza delle banche centrali
nel fornire denaro contante agli
istituti di credito in difficoltà
possano prevenire il sorgere di
queste situazioni. Nessuna
persona di buon senso pensava
che i problemi in economia
fossero
finiti;
eravamo
comunque sicuri che qualsiasi
problema avessimo mai potuto
incontrare in futuro sarebbe
stato abbastanza diverso da
quelli degli anni Venti e Trenta.
Ma un decennio fa avremmo
dovuto renderci conto che la
nostra fiducia era mal riposta. Il
Giappone si è trovato per quasi
tutti gli anni Novanta in una
trappola economica che Keynes
e
i suoi contemporanei
conoscevano benissimo. Le
economie asiatiche più piccole,
per contro, sono passate dal
boom alla calamità praticamente
da un giorno all’altro; e la storia
di questo tracollo sembra
ambientata nel clima finanziario
degli anni Trenta.
All’epoca la pensavo così:
era come se alcuni batteri che
avevano causato gravissime
pestilenze,
ma
che
si
consideravano
ormai
definitivamente sconfitti dalla
medicina moderna, fossero
riemersi in una forma resistente
agli antibiotici standard. Ecco
quello
che
scrivevo
nell’introduzione alla prima
edizione: «Per ora solo un
numero limitato di persone è
stato vittima di questo nuovo
malessere incurabile; ma anche
quelli che hanno avuto la
fortuna di non essere contagiati
sarebbero degli sciocchi se non
cercassero nuove cure, nuovi
accorgimenti
preventivi,
qualsiasi cosa occorra, per
evitare di diventare le prossime
vittime».
Be’, siamo stati veramente
degli sciocchi. E adesso
abbiamo in casa la peste.
Questa nuova edizione è
dedicata in gran parte alla crisi
asiatica degli anni Novanta, che
si è rivelata una sorta di prova
generale della crisi globale a cui
stiamo assistendo adesso. Ma
ho aggiunto parecchio nuovo
materiale, nel tentativo di
spiegare perché gli Stati Uniti si
sono ritrovati nella stessa
situazione in cui versava il
Giappone una decina di anni fa,
perché l’Islanda si è ritrovata
nella stessa situazione della
Thailandia, e perché i paesi
colpiti dalla crisi originaria degli
anni Novanta si sono ritrovati
ancora una volta sull’orlo
dell’abisso.
Questo libro
Permettetemi di dichiarare
subito che questo libro è, in
fondo, un trattato analitico. Non
si occupa tanto di quello che è
successo quanto del perché. La
cosa importante, credo, è capire
come questa catastrofe sia
potuta accadere, come possano
riprendersi i paesi colpiti e come
possiamo evitare che la
situazione
si
ripeta.
Di
conseguenza l’obiettivo ultimo
è, come insegnano nelle aule di
economia, sviluppare una teoria
su questo specifico argomento,
riuscire
a
capire
come
interpretare questa serie di
eventi.
Tuttavia ho tentato di non
renderla un’esposizione teorica.
Non ci sono né equazioni, né
diagrammi complicati, né (mi
auguro) parole incomprensibili.
In qualità di economista di una
certa fama sono assolutamente
in grado di scrivere cose che
nessuno può leggere. In realtà il
linguaggio incomprensibile – il
mio e quello degli altri – mi ha
aiutato
a
giungere
alle
conclusioni che vi presento qui
di seguito. In questo momento
il mondo ha bisogno di decidere
sulla base di informazioni
concrete; di conseguenza le idee
devono essere rese accessibili a
tutte le persone interessate, non
solo ai professori di economia.
Comunque le equazioni e i
diagrammi
caratteristici
dell’economia
formale
rappresentano, il più delle volte,
solo un’impalcatura utilizzata
per aiutare a mettere in piedi
una costruzione intellettuale.
Una volta che i lavori di
costruzione abbiano raggiunto
un certo livello, l’impalcatura
può essere tolta, lasciando così
solo parole comprensibili.
Inoltre, sebbene il principale
obiettivo del libro sia analitico,
vi sono contenute molte
descrizioni di eventi. In parte
perché seguire una storia
dall’inizio alla fine spesso
garantisce che la teoria di cui si
sta discutendo abbia senso. (Per
esempio,
la
visione
«fondamentalista» delle crisi
economiche – secondo la quale
le economie hanno soltanto la
punizione che si meritano –
deve fare i conti con la strana
coincidenza che un gran
numero di sistemi economici
apparentemente così diversi
siano crollati nel giro di pochi
mesi.) Ritengo inoltre che
riportare l’intera sequenza degli
eventi fornisca un quadro di
riferimento necessario a ogni
tentativo di spiegazione, e che la
maggior parte delle persone non
abbia passato gli ultimi 18 mesi
a seguire in maniera ossessiva le
varie fasi del dramma. Non tutti
ricordano cosa ha detto il primo
ministro Mohamad Mahathir a
Kuala Lumpur nell’agosto del
1997, e non tutti riescono a
mettere in relazione questa
dichiarazione con quanto ha
finito per fare Donald Tsang a
Hong Kong un anno dopo.
Bene, questo libro servirà a
rinfrescarvi la memoria.
Una
nota
sullo
stile
intellettuale: una tentazione che
prova spesso chi scrive di
economia, specie quando la
materia è così grave, è quella di
esprimersi
in
modo
eccessivamente paludato. Non
che gli eventi di cui ci
occupiamo qui non siano
importanti; in alcuni casi sono
questione di vita o di morte.
Troppo
spesso,
però,
i
cosiddetti esperti pensano che
essendo una materia molto
seria, vada affrontata in tono
solenne; che trattandosi di
grossi problemi, si debbano
trattare in stile ampolloso; che
non
siano
ammessi
né
l’informalità né un tocco di
umorismo. Tuttavia, come si
vedrà in seguito, per dare una
spiegazione a fenomeni nuovi e
insoliti bisogna essere pronti a
giocare con le idee. E uso la
parola «giocare» con cognizione
di causa: le persone austere,
senza una vena di stravaganza,
non sono quasi mai in grado di
avere buone intuizioni, in
economia
come
altrove.
Immaginiamo che io affermi: «il
Giappone sta soffrendo di una
profonda
incapacità
di
adattamento, perché il suo
modello di crescita governato
dallo stato porta a una rigidità
strutturale». Adesso pensateci
bene: non ho detto proprio
niente; al massimo sono riuscito
a comunicare una vaga
sensazione che i problemi sono
difficili e che non esistono
risposte
immediatamente
disponibili – una sensazione che
può
anche
risultare
completamente
sbagliata.
Immaginate invece che io mi
metta a spiegare i problemi del
Giappone con la divertente
storiella dei successi e degli
insuccessi di una cooperativa di
baby-sitter (a cui in realtà farò
spesso riferimento in questo
libro). Può darsi che il tutto
risulti infantile, forse la mia
leggerezza offenderà la vostra
sensibilità, ma la stravaganza ha
uno scopo preciso: fa pensare a
soluzioni originali, suggerendo
che in realtà può esserci un
modo sorprendentemente facile
di risolvere almeno una parte
dei problemi del Giappone.
Quindi non aspettatevi un libro
austero e solenne: trovare un
argomento più serio di questo è
difficile, ma la scrittura sarà
semplice come è doveroso che
sia.
E adesso iniziamo il nostro
viaggio, partendo dal mondo
come sembrava che fosse solo
pochi anni fa.
1. «IL PROBLEMA
PRINCIPALE È STATO
RISOLTO»
Nel 2003 Robert Lucas,
docente presso la University of
Chicago e vincitore nel 1995 del
premio Nobel per l’economia,
ha
tenuto
il
discorso
presidenziale
all’assemblea
annuale
dell'American
Economic Association. Dopo
aver
spiegato
che
la
macroeconomia era nata in
risposta
alla
Grande
Depressione, ha dichiarato che
era ora di fare un passo avanti in
questo campo: «Il problema
principale di prevenire la
depressione», ha osservato, «è
stato risolto, in tutte le sue
implicazioni pratiche».
Lucas non ha detto che il
ciclo economico, l’alternanza
irregolare di recessioni ed
espansioni che ci accompagna
da almeno un secolo e mezzo,
era finito. Ma ha detto che era
stato addomesticato, al punto
che i benefici di nuovi interventi
finalizzati
a
metterlo
ulteriormente sotto controllo si
potevano considerare marginali:
l’appiattimento delle irregolarità
che si riscontrano nel processo
di crescita, ha affermato,
avrebbe prodotto solo dei
benefici trascurabili a livello di
benessere nazionale. Era venuto
perciò
il
momento
di
concentrarsi su aspetti come la
crescita economica di lungo
termine.
Lucas non era l’unico a
sostenere che la prevenzione
della depressione fosse ormai
un problema risolto. Un anno
dopo Ben Bernanke, un ex
professore di Princeton che era
entrato a far parte del board
della Federal Reserve – e di lì a
poco ne sarebbe diventato il
presidente – ha tenuto un
discorso
straordinariamente
ottimista intitolato The Great
Moderation, in cui affermava,
proprio come Lucas, che la
moderna
politica
macroeconomica aveva risolto il
problema del ciclo economico –
o, per essere più precisi, l’aveva
ridotto a un banale fastidio.
A pochi anni di distanza,
mentre gran parte del mondo è
alle prese con una crisi
finanziaria ed economica che
ricorda sin troppo da vicino gli
anni
Trenta,
questi
pronunciamenti
ottimistici
appaiono quasi incredibili. La
cosa
più
singolare
di
quell’ottimismo era il fatto che
negli anni Novanta, problemi
economici molto simili ai
sintomi
della
Grande
Depressione erano emersi in
diversi paesi – incluso il
Giappone, la seconda economia
del mondo.
Ma nei primi anni di questo
decennio, i problemi tipici della
depressione
non
avevano
ancora colpito gli Stati Uniti,
mentre l’inflazione – il flagello
degli anni Settanta – appariva
finalmente sotto controllo. E
questa notizia relativamente
tranquillizzante si inquadrava in
un contesto politico che
incoraggiava l’ottimismo: il
mondo sembrava più favorevole
alle economie di mercato di
quanto non fosse stato da quasi
novant’anni.
Il trionfo del capitalismo
Questo è un libro di
economia, ma inevitabilmente
l’economia prende forma in un
contesto politico e non si può
comprendere il mondo così
come appariva in quell’estate
dorata
senza
considerare
l’evento politico fondamentale
degli anni Novanta: il collasso
del socialismo, considerato non
soltanto
come
ideologia
dominante, ma come ideale in
grado di far muovere la mente
degli uomini.
Il collasso ebbe inizio,
abbastanza stranamente, in
Cina. Fa ancora impressione
ricordare che nel 1978 Deng
Xiao-ping aveva spinto il suo
paese su quella che poi sarebbe
stata conosciuta come la via al
capitalismo, solo tre anni dopo
la vittoria dei comunisti in
Vietnam e solo due anni dopo la
sconfitta interna dei maoisti
radicali
che
volevano
ricominciare la Rivoluzione
culturale. Probabilmente Deng
non comprese del tutto quanto
lontano avrebbe portato la
strada
da
lui
indicata;
certamente il resto del mondo ci
mise un bel po’ per capire che
un miliardo di persone si era
tranquillamente lasciato alle
spalle il marxismo. Infatti, al più
tardi nei primi anni Novanta, la
trasformazione della Cina non
era assolutamente stata recepita
dall’opinione pubblica; nei
bestseller del tempo l’economia
mondiale era vista come
un’arena per un combattimento
«testa a testa» tra Europa,
America e Giappone – la Cina
veniva ritenuta al massimo un
attore di secondo piano,
eventualmente parte di un
gruppo di paesi emergenti sotto
l’egida dello yen.
Ciò nonostante tutti avevano
intuito che qualcosa era
cambiato – e che quel
«qualcosa» era la caduta
dell’Unione Sovietica.
Nessuno capisce veramente
che cosa sia accaduto al regime
sovietico. Col senno di poi noi
ora
consideriamo
quella
struttura come qualcosa il cui
sviluppo era stato a lungo
ostacolato, e che dunque era
destinata al fallimento. In realtà
quello sovietico era un regime
che aveva conservato il potere
passando attraverso una guerra
civile e una carestia, che
nonostante tutto era stato
capace di sconfiggere il
precedente
Nuovo
Ordine
tedesco, che era in grado di
mobilitare risorse scientifiche e
industriali per competere con la
superiorità nucleare degli Stati
Uniti. La ragione per cui
l’Unione Sovietica sia finita così
all’improvviso,
senza
esplosioni, ma con solo un
leggero
brontolio,
va
considerata uno dei grandi
misteri dell’economia politica.
Probabilmente
era
solo
questione di tempo – alcuni
dicono
che
il
fervore
rivoluzionario, al di là di quel
gran desiderio di uccidere i
nemici in nome di un bene
superiore, non può durare per
più di un paio di generazioni.
Oppure il regime potrebbe
essere stato progressivamente
indebolito dal fatto che il
capitalismo
si
rifiutava
ostinatamente di mostrarsi
vicino alla fine.
Io ho una mia personale
teoria in proposito, che tuttavia
non si basa su alcuna prova
specifica: secondo me, la
crescita
dell’Asia
ha
demoralizzato in maniera sottile
ma profonda il regime sovietico,
rendendo
ancora
meno
plausibile
la
pretesa
di
quest’ultimo di avere la storia
dalla sua parte. L’orribile guerra
dell’Afghanistan, destinata a
essere persa sin dall’inizio, ha
certamente facilitato questo
processo, assieme all’evidente
incapacità
dell’industria
sovietica di confrontarsi con la
crescita militare statunitense
all’epoca di Ronald Reagan. Ma
poco importa: qualunque sia
stata la ragione, nel 1989
l’impero sovietico si sfaldò
improvvisamente nell’Europa
dell’Est e nel 1991 la medesima
sorte toccò alla stessa Unione
Sovietica.
Gli
effetti
di
questo
sfaldamento furono avvertiti in
tutto il mondo, in modo
evidente e sottile. E le sue
conseguenze facilitarono il
successo politico e ideologico
del capitalismo.
Innanzitutto diverse centinaia
di milioni di persone che
vivevano sotto i regimi marxisti
divennero
improvvisamente
cittadini di stati disposti a
tentare la strada dell’economia
di mercato. Al contrario di
quanto la maggior parte delle
persone si aspettava, le
«economie di transizione»
dell’Europa
dell’Est
non
diventarono
rapidamente
protagoniste di primo piano
nell’economia mondiale, o meta
privilegiata per gli investimenti
stranieri. Caso mai accadde il
contrario, poiché la maggior
parte di questi paesi dovette fare
molta fatica per portare a
termine la transizione: la
Germania dell’Est, per esempio,
è diventata per la Germania
l’equivalente di quello che il
Mezzogiorno è per l’Italia: una
zona sempre depressa che
continua a essere fonte di
problemi sociali e fiscali. Solo
oggi, una decina d’anni dopo la
caduta del comunismo, alcuni
paesi – la Polonia, l’Estonia e la
Repubblica Ceca – possono
essere annoverati tra le storie di
successo. La stessa Russia non
è riuscita a effettuare una
convincente
transizione
all’economia di mercato; anzi,
dopo aver preso a prestito
ingenti quantitativi di denaro,
offrendo in realtà come garanzia
il suo decadente arsenale
nucleare, ha rischiato di
diventare fonte d’instabilità
finanziaria per il resto del
mondo.
Un’altra diretta conseguenza
del collasso del regime sovietico
fu che i governi che nel passato
si erano affidati alla sua
generosità
dovevano
ora
contare solo su se stessi. Poiché
alcuni di questi paesi erano stati
idealizzati e idolatrati dagli
avversari del capitalismo, la loro
improvvisa povertà – e la
conseguente percezione di
quanto in precedenza fossero
stati dipendenti – servì a
delegittimare
tutti
gli
atteggiamenti di questo tipo.
Cuba, per esempio, aveva fama
di essere una nazione eroica, da
sola e a pugni chiusi di fronte
agli Stati Uniti, e rappresentava
un allettante simbolo per i
rivoluzionari di tutta l’America
Latina – molto più allettante,
naturalmente, di quanto non
fossero i grigi burocrati di
Mosca. Lo stesso si può dire del
governo della Corea del Nord
che fino agli anni Novanta,
nonostante
tutto
il
suo
squallore, riusciva a emanare un
certo fascino tra i radicali – in
particolar modo tra gli studenti
della Corea del Sud. Non
appena la popolazione cominciò
a morire di fame perché non
riceveva più gli aiuti sovietici,
l’eccitazione scomparve.
Un altro effetto più o meno
diretto della caduta dell’impero
sovietico fu la scomparsa di
molti movimenti estremisti che,
sebbene
nelle
intenzioni
volessero rappresentare un più
nobile spirito rivoluzionario, in
realtà potevano operare solo
perché Mosca forniva le armi, i
campi di addestramento e i
soldi. Gli europei amano
sottolineare che i terroristi degli
anni Settanta e Ottanta –
Baader-Meinhof in Germania,
Brigate Rosse in Italia – si
ritenevano tutti veri marxisti e
non avevano nulla a che fare
con i vecchi comunisti corrotti
della Russia. Tuttavia oggi noi
sappiamo che questi movimenti
erano
profondamente
dipendenti dagli aiuti che
arrivavano dal blocco sovietico,
e che non appena gli aiuti
cessarono anche il terrorismo
svanì.
Il fallimento dell’Unione
Sovietica distrusse soprattutto il
sogno socialista. Per un secolo e
mezzo l’idea di socialismo –
«da ognuno secondo le proprie
possibilità, a ognuno secondo i
propri bisogni» – servì come
punto di riferimento intellettuale
per
coloro
che
non
apprezzavano il modo con cui
venivano trattati dal mercato. I
leader nazionalisti invocavano
gli ideali socialisti perché
ostacolavano gli investimenti
stranieri o non permettevano
l’indebitamento con l’estero; i
sindacati usavano la retorica del
socialismo per chiedere salari
più elevati; anche gli uomini
d’affari facevano riferimento a
vaghi princìpi socialisti per
chiedere dazi doganali o sussidi.
E i governi che, nonostante
tutto, avevano optato per un
mercato più o meno libero, lo
facevano con molta cautela,
quasi con un po’ di vergogna,
perché avevano sempre il
timore che un atteggiamento
troppo esplicito potesse essere
considerato alla stregua di una
politica
brutale,
inumana,
antisociale.
Ma con che faccia oggi ci si
può permettere di utilizzare le
espressioni
tipiche
del
socialismo? Faccio parte della
generazione dei «baby boomer»
e di conseguenza riesco a
ricordarmi di quando l’idea di
rivoluzione,
di
uomini
coraggiosi che portavano avanti
la storia, aveva ancora un certo
fascino. Ora questa parola è
come una barzelletta che non fa
più ridere nessuno: dopo tutte le
purghe e i gulag, la Russia è
arretrata e corrotta come non lo
è mai stata; dopo tutti i Grandi
balzi e le Rivoluzioni culturali,
la Cina ha deciso che far soldi è
la
cosa
più
importante.
Circolano ancora estremisti di
sinistra,
che
dichiarano
ostinatamente che il vero
socialismo non è ancora stato
messo in pratica; e ci sono
ancora moderati di sinistra che
affermano
con
maggiori
giustificazioni che si può
rifiutare il marxismo-leninismo
senza dover necessariamente
diventare discepoli di Milton
Friedman. Ma la verità è che il
nocciolo del socialismo non
rappresenta più un’opposizione
al capitalismo.
Per la prima volta dopo il
1917 viviamo dunque in un
mondo in cui i diritti alla
proprietà e al libero mercato
sono
considerati
princìpi
fondamentali, non più cinici
espedienti; dove gli aspetti
negativi
dell’economia
di
mercato
–
ineguaglianza,
disoccupazione, ingiustizia –
sono accettati come parte della
vita. Come accadeva durante
l’epoca vittoriana, il capitalismo
è garantito non solo dai suoi
successi – che, come vedremo
tra poco, sono molto concreti –
ma dal fatto che nessuno
dispone di alternative plausibili.
Questa situazione non durerà
per
sempre.
Di
sicuro
seguiranno altre ideologie, altri
sogni; prima o poi questi ultimi
prenderanno forma se la crisi
economica attuale persisterà e si
estenderà ulteriormente. Ma per
ora il capitalismo governa in
maniera incontrastata il mondo.
Il ciclo economico
addomesticato
I grandi nemici della stabilità
capitalistica sono sempre stati la
guerra e la depressione. La
guerra, inutile dirlo, è ancora
con noi. Ma le guerre che hanno
rischiato di mettere fine al
capitalismo negli anni intermedi
del XX secolo erano conflitti
giganteschi tra grandi potenze –
ed è difficile immaginare come
una guerra di quella portata
possa scoppiare nel prevedibile
futuro.
E che dire della depressione?
La Grande Depressione riuscì
quasi a distruggere sia il
capitalismo sia la democrazia e
portò più o meno direttamente
alla guerra. Tuttavia nel mondo
industrializzato a quest’ultima
seguì un lungo periodo di
elevata crescita, durante il quale
le recessioni furono brevi e non
particolarmente gravi. Fino agli
ultimi anni Sessanta gli Stati
Uniti erano andati avanti così a
lungo senza una recessione che
gli economisti avevano iniziato
a tenere conferenze dal titolo Il
ciclo economico è ormai un
concetto obsoleto?
Era troppo presto per porsi
questa domanda: gli anni
Settanta furono segnati dalla
«stagflazione»,
un
crollo
economico unito a inflazione; e,
come ho
già accennato
nell’introduzione, le due crisi
energetiche del 1973 e del 1979
furono seguite dalle peggiori
recessioni mai conosciute dopo
gli anni Trenta. All’inizio degli
anni Novanta ci si pose
nuovamente la domanda, e
come abbiamo visto, pochi anni
fa sia Robert Lucas sia Ben
Bernanke hanno dichiarato
pubblicamente che mentre
l’economia avrebbe continuato
a incontrare occasionali battute
d’arresto, l’era delle grandi
depressioni, e tanto più delle
depressioni
globali,
era
definitivamente alle nostre
spalle.
Come potete farvi un’idea su
queste affermazioni, se non
limitandovi a notare che di
recente l’economia non ha
avuto più grandi recessioni? In
realtà per rispondere a questa
domanda è necessario compiere
una digressione teorica e
chiederci innanzitutto che cosa
vuol dire ciclo economico. In
particolare, perché le economie
di mercato vivono momenti di
recessione?
Dite tutto quello che volete,
ma per favore non dite che la
risposta è ovvia – che le
recessioni succedono a causa di
X, dove X rappresenta il vostro
preconcetto. La verità è che, se
ci pensate bene – in particolar
modo se siete dell’idea che i
mercati abbiano l’obiettivo di
far incontrare domanda e offerta
– la recessione è una cosa
veramente
molto
insolita.
Durante un crollo economico,
in particolar modo uno di quelli
più gravi, sembra infatti che ci
sia troppa offerta e niente più
domanda. Ci sono lavoratori a
disposizione
ma
non
abbastanza posti di lavoro,
stabilimenti
perfettamente
funzionanti ma non abbastanza
ordini, negozi aperti ma non
abbastanza clienti. È piuttosto
facile osservare come ci possa
essere una carenza di domanda
su alcuni prodotti: se le
industrie producono grandi
quantità di bambole Barbie, ma
ci si rende conto che i
consumatori
preferiscono
invece le più moderne Bratz,
alcune
Barbie
resteranno
inevitabilmente invendute. Ma
come
è
possibile
che,
complessivamente, il livello
della domanda resti basso? Non
è forse necessario che la gente
spenda i propri soldi per
qualcosa?
La gente ha di solito
problemi
a
parlare
razionalmente delle recessioni
perché le è difficile capire quello
che accade durante un crollo,
perché non riesce a concepire il
tutto da un punto di vista
pratico. A questo proposito mi
diverte molto raccontare una
storia, sia per spiegare cosa
siano
effettivamente
le
recessioni sia per aiutarmi a
pensare in maniera creativa. (I
lettori dei miei precedenti libri
hanno già avuto modo di
leggerla.) È una storia vera,
anche se nel capitolo 3 ne
utilizzerò una versione un po’
rielaborata per chiarire le
difficoltà
che
attualmente
incontra il Giappone.
Questa storia era contenuta in
un articolo scritto da Joan e
Richard Sweeney, pubblicato
nel 1978 con il titolo La teoria
monetaria e la grande crisi
della cooperativa di baby-sitter
di Capitol Hill. Non fermatevi
al titolo: si tratta di una cosa
seria.
Durante gli anni Settanta la
famiglia Sweeney era socia,
pensate un po’, di una
cooperativa di baby-sitter:
un’associazione di giovani
coppie, in questo caso quasi
tutta gente impiegata presso il
Congresso degli Stati Uniti, che
volevano
aiutarsi
reciprocamente a fare da babysitter ai propri bambini. Questa
cooperativa era piuttosto grossa,
formata da circa 150 coppie: di
conseguenza
c’era
grande
abbondanza di potenziali babysitter e gestire l’organizzazione
– in particolar modo assicurarsi
che ogni coppia avesse fatto il
suo dovere – non era
assolutamente facile.
Come tante altre istituzioni
simili (e altri sistemi di
scambio), la cooperativa di
Capitol Hill aveva un problema
da risolvere: doveva emettere
dei certificati, i buoni che
dessero diritto al portatore a
un’ora di baby-sitter. Chi si
occupava di assistere i bambini
avrebbe ricevuto i buoni dai
genitori che lasciavano in
custodia i loro figli. Strutturato
in questo modo, il sistema era a
prova di furbo: assicurava
automaticamente che, con il
tempo, ogni coppia avrebbe
elargito tante ore di baby-sitter
quante ne aveva ricevute.
Ma non era così semplice. Si
scoprì che un sistema di questo
tipo necessitava la messa in
circolazione del giusto numero
di certificati. Le coppie che
avevano più serate consecutive
libere, e nessun piano per uscire
nell’immediato,
avrebbero
cercato di accumulare riserve
per il futuro; questo accumulo
sarebbe stato compensato dalla
diminuzione delle riserve delle
altre coppie, ma con il tempo
ogni
coppia
avrebbe
mediamente
desiderato
risparmiare abbastanza buoni
per poter uscire durante periodi
di intensa attività di baby-sitter.
L’emissione di buoni da parte
della cooperativa di Capitol Hill
era il risultato di un processo
complicato:
le
coppie
ricevevano i buoni ogni volta
che si prestavano a fare da
baby-sitter,
dovevano
consegnarli ogni volta che
lasciavano i propri figli, ma
dovevano pagare sotto forma di
buoni anche chi si occupava
della gestione. I dettagli non
sono importanti: il punto è che
arrivò il momento in cui ci
furono relativamente pochi
buoni in circolazione – troppo
pochi,
effettivamente,
per
soddisfare i bisogni della
cooperativa.
Il
risultato
fu
molto
particolare. Le coppie che si
resero conto che le proprie
riserve di buoni erano diventate
insufficienti cercarono a tutti i
costi di fare da baby-sitter e
diventarono riluttanti all’idea di
uscire la sera. Ma quando una
coppia decideva di uscire, dava
a un’altra l’opportunità di fare
da baby-sitter; di conseguenza
le opportunità di fare da babysitter si fecero rare, rendendo le
coppie ancora più riluttanti a
usare le loro riserve se non nelle
occasioni speciali, il che rese le
opportunità di fare da babysitter ancora più rare…
In breve, la cooperativa entrò
in un momento di recessione.
Va bene, prendiamoci un
momento di sosta. Come avete
reagito di fronte a questa storia?
Se siete confusi – questo
doveva essere un libro sulle crisi
economiche, non sulla cura dei
bambini – non avete afferrato la
morale della storia. L’unico
modo
per
rendere
comprensibile
un
sistema
complesso, che si tratti di
previsioni del tempo a livello
globale
o
dell’economia
mondiale, è quello di lavorare
con
dei
modelli
–
rappresentazioni semplificate
che ci si augura possano aiutare
a capirne il funzionamento.
Alcune volte si tratta di sistemi
di equazioni, oppure di
programmi di computer (come
le simulazioni che forniscono
quotidianamente le previsioni
del tempo); altre volte i sistemi
sono simili ai modelli di
aeroplani che i progettisti
sperimentano nelle gallerie del
vento, versioni in scala ridotta di
oggetti di più grandi dimensioni,
più facili da osservare e
studiare. La cooperativa di
baby-sitter di Capitol Hill era un
sistema economico in miniatura
– in realtà era una piccola
economia
in
grado
di
sperimentare un momento di
recessione. Ma quello che visse
fu una recessione reale, così
come la portanza generata dalle
ali di un modello di aeroplano è
una portanza a tutti gli effetti; e
così come il comportamento di
quel modello può dare ai
progettisti indicazioni utili
riguardo
al
futuro
comportamento di un jumbo
jet, gli alti e bassi di quella
cooperativa ci possono fornire
importanti lezioni riguardo ai
motivi per cui le economie di
dimensioni reali funzionano o
meno.
Se non siete più offesi che
confusi – in questa sede
dovevamo discutere argomenti
importanti e invece vi stanno
raccontando simpatiche storielle
sugli yuppies di Washington –
vergognatevi. Ricordatevi quel
che ho detto nell’introduzione:
la stravaganza, il desiderio di
giocare con le idee, non solo è
divertente
ma
è
pure
indispensabile, in tempi come i
nostri. Non fidatevi mai di un
progettista di aeroplani che si
rifiuta di giocare con i modellini,
e non date mai fiducia a un
esperto di economia che non
gioca con i suoi modelli
economici.
La storiella della cooperativa
di baby-sitter torna utile proprio
come
strumento
per
comprendere
i
problemi
assolutamente non stravaganti
dell’economia reale. I modelli
teorici che usano gli economisti,
la maggior parte dei quali sono
complessi concetti matematici,
sembrano spesso molto più
complicati di quest’ultimo, ma
di solito le loro conclusioni
possono essere riassunte in
semplici storielle, simili a quella
della cooperativa di Capitol Hill
(e, se non è possibile, allora è
segno che c’è qualcosa che non
funziona con il modello). Finirò
per tornare più volte sulla storia
delle baby-sitter, in diversi
momenti del libro. Per ora,
tuttavia,
limitiamoci
a
considerare due importanti
conseguenze di questa storia:
una riguardo a come le
recessioni possono nascere,
l’altra riguardo a come è
possibile gestirle.
Innanzitutto,
perché
la
cooperativa di baby-sitter ebbe
un momento di recessione? Il
motivo non era che i membri
della
cooperativa
stessero
facendo male il loro compito di
baby-sitter: forse lo stavano
facendo, o forse no, ma in ogni
caso non è questo il discorso. Il
motivo non era neanche che i
valori della cooperativa fossero
degenerati, che avesse preso
piede il nepotismo, o che non ci
si fosse adeguati a una
determinata
tecnologia.
Il
problema non aveva niente a
che fare con l’abilità della
cooperativa a produrre, ma
semplicemente con la mancanza
di «domanda effettiva»: si
spendeva troppo poco in beni
reali (le ore di baby-sitter)
perché la gente preferiva
accumulare contanti (i buoni
per le ore di baby-sitter). La
lezione per il mondo reale è che
la vulnerabilità nei confronti del
ciclo economico può avere
poco o nulla a che fare con i
fondamentali:
cose
brutte
possono capitare anche alle
buone economie.
In secondo luogo, come si
poteva risolvere il problema? I
coniugi Sweeney affermano
che, nel caso della cooperativa
di Capitol Hill, era piuttosto
difficile convincere il comitato
di gestione – formato in larga
misura da avvocati – che il
problema
era
fondamentalmente tecnico, e
che avevano una rapida
soluzione a portata di mano.
All’inizio i responsabili della
cooperativa considerarono il
problema come «strutturale»: fu
emanata una regola che
obbligava ogni coppia a uscire
almeno due volte al mese. Alla
fine, tuttavia, gli economisti
ebbero la meglio e fu deciso di
aumentare l’offerta di buoni. Il
risultato fu sorprendente: con
più ampie riserve di buoni le
coppie cominciarono ad avere
più voglia di uscire, e così
facendo
diedero
maggiori
opportunità ad altre coppie di
fare da baby-sitter, rendendo
queste ultime ancora più
desiderose di uscire, e così via.
Il PIL della cooperativa di babysitter, calcolato in termini di
bambini accuditi, aumentò. Il
motivo non fu che le coppie
disponevano di migliori babysitter o che la cooperativa fosse
passata attraverso un radicale
processo di riforma; il motivo
era semplicemente che si era
deciso di correggere una
situazione di scarsità di denaro
contante. Le recessioni, in altre
parole, possono essere sconfitte
semplicemente
stampando
nuova moneta – e talvolta (di
solito) possono essere curate
con estrema facilità.
E con questo ritorniamo al
ciclo economico nel mondo a
dimensioni reali.
L’economia di una piccola
nazione è, naturalmente, di gran
lunga più complessa di quella di
una cooperativa di baby-sitter.
Tra le altre cose, nel mondo
reale la gente spende il denaro
non solo per il suo piacere
attuale ma per investire sul
futuro (immaginate di chiedere
aiuto
ai
membri
della
cooperativa non per sorvegliare
i vostri figli, ma per costruire un
nuovo piccolo recinto per
bambini). Nel mondo reale c’è
anche il mercato dei capitali, nel
quale
le
persone
che
dispongono di contanti in
eccesso possono concedere
prestiti a quelli che ne hanno
bisogno. Ma la questione di
fondo è sempre la stessa: una
recessione è un evento che
normalmente
riguarda
un
insieme di persone che cercano
di accumulare contanti (o, detto
in maniera diversa, che cercano
di risparmiare più di quello che
investono), a cui normalmente
si può ovviare limitandosi a
emettere nuovi buoni.
Nel mondo moderno coloro
che emettono buoni sono le
banche centrali: la Federal
Reserve, la Banca centrale
europea, la Bank of Japan e così
via. Il loro compito è quello di
tenere in equilibrio l’economia,
aggiungendo
o
togliendo
contanti a seconda delle
necessità.
Ma se è veramente così facile
ovviare al problema, perché mai
ci sono collassi economici?
Perché le banche centrali non
stampano sempre abbastanza
moneta per mantenerci a un
livello di piena occupazione?
Prima della Seconda guerra
mondiale la risposta sembrava
essere abbastanza evidente:
questa politica si rivelava
inefficace perché chi doveva
applicarla
non
sapeva
esattamente che cosa stava
facendo. Oggi praticamente tutti
gli economisti, da Milton
Friedman fino alla sinistra,
concordano sul fatto che la
Grande Depressione fu causata
da un’improvvisa caduta della
domanda, e che la Federal
Reserve
avrebbe
dovuto
combattere il tracollo con grandi
iniezioni di liquidità. Ma
all’epoca questo non era
assolutamente il pensiero della
maggioranza. Al contrario,
molti importanti economisti
aderirono a una sorta di
fatalismo
moralistico,
che
considerava la depressione
come
una
conseguenza
inevitabile
dei
precedenti
eccessi
dell’economia,
e
addirittura come un processo
salutare: la ripresa, dichiarò
Joseph Shumpeter, «è salutare
solo se non la si cerca. Poiché
ogni ritorno dovuto a soli
interventi
artificiali
lascia
irrisolta una parte degli obiettivi
della depressione e aggiunge, a
un residuo non ancora digerito
di difficoltà, nuove difficoltà che
a loro volta devono essere
eliminate, minacciando così in
prospettiva l’economia con
un’altra [peggiore] crisi».
Questo fatalismo scomparve
dopo la guerra, e per alcuni anni
la maggior parte dei paesi si
diede da fare per controllare
attivamente il ciclo economico,
con un successo considerevole;
le recessioni diventarono più
tenui e normalmente c’era
abbondanza di lavoro. Alla fine
degli anni Sessanta molti
cominciarono a credere che il
ciclo economico non fosse più
un problema serio; anche
Richard Nixon promise di
utilizzare la politica del «fine
tuning».{1}
Non era altro che arroganza;
e il tragico difetto delle politiche
di pieno impiego divenne
evidente negli anni Settanta. Se
la
banca
centrale
è
eccessivamente
ottimista
riguardo al numero di posti di
lavoro che possono essere
creati, se mette in circolazione
troppa moneta, come risultato si
ha l’inflazione; e una volta che
l’inflazione si è profondamente
radicata nelle aspettative della
gente, può essere estirpata dal
sistema solo attraverso un
periodo
di
elevata
disoccupazione. Si aggiungano
alcuni shock esterni che
improvvisamente aumentano i
prezzi – come, per esempio, il
raddoppio del prezzo del
petrolio – ed ecco pronta la
ricetta per ottenere pericolosi
collassi economici, che possono
avvicinarsi alla depressione.
Ma alla fine degli anni
Ottanta l’inflazione era tornata a
livelli tollerabili, l’offerta di
petrolio era abbondante e le
banche centrali sembravano
aver capito come gestire
l’economia. In realtà gli
spiacevoli eventi che erano
accaduti in precedenza avevano
finito
per
rafforzare
la
sensazione
che
fossimo
finalmente riusciti a capirci
qualcosa. Nel 1987, per
esempio, il mercato azionario
statunitense collassò – con un
crollo durato un solo giorno,
che si rivelò terribile quanto il
primo giorno del crollo del ’29.
Ma la Federal Reserve rifornì di
contanti il sistema, l’economia
reale
non
fece
neanche
registrare una flessione e
l’indice Dow Jones riprese
presto quota. Alla fine degli
anni Ottanta le banche centrali,
preoccupate per un piccolo
aumento dell’inflazione, non
avvertirono per tempo i segnali
di una recessione nascente, e
mentre la combattevano ne
rimasero
vittime;
questa
recessione costò il posto a
George Bush ma, alla fine, la
solita medicina fece effetto e gli
Stati Uniti conobbero un altro
periodo di elevata crescita. Alla
fine degli anni Novanta
sembrava corretto dire che il
ciclo economico, se non
eliminato, era perlomeno sotto
controllo.
Gran parte del merito di
questi risultati fu dato alle
autorità monetarie: mai nel
corso della storia il governatore
di una banca centrale ha
ricevuto tanti onori come Alan
Greenspan.
Si aveva
la
sensazione che la struttura
dell’economia facesse sembrare
sempre più verosimile una
situazione
di
continua
prosperità.
La tecnologia come
elemento salvifico
In
senso
strettamente
tecnologico si potrebbe dire che
l’età moderna dell’informatica
iniziò quando Intel lanciò sul
mercato il microprocessore –
l’anima di un computer su un
singolo chip – nel 1971. Nei
primi anni Ottanta i prodotti che
utilizzavano questa tecnologia
per gli usi più conosciuti – fax,
videogiochi
e
personal
computer – cominciavano a
essere sempre più popolari. Ma
all’epoca non la si percepiva
ancora come una rivoluzione.
La maggior parte delle persone
dava
per
scontato
che
l’industria informatica avrebbe
continuato a essere dominata da
grandi
multinazionali
burocratizzate come IBM – o
che tutte le nuove tecnologie
avrebbero seguito il destino del
fax, del videoregistratore e dei
videogiochi:
inventati
da
americani intraprendenti, ma
trasformati in prodotti redditizi
solo da sconosciuti produttori
giapponesi.
Negli anni Novanta, tuttavia,
era ormai chiaro che l’industria
informatica
avrebbe
completamente cambiato la
struttura e le logiche della nostra
economia.
È ancora possibile restare
scettici riguardo ai benefici
economici
indotti
dalla
tecnologia informatica. Quello
che non si può negare è che le
nuove tecnologie abbiano avuto
un impatto più visibile sul
nostro modo di lavorare,
rispetto
a
qualunque
innovazione emersa negli ultimi
venti o trent’anni. Dopo tutto il
tipico uomo moderno oggi
lavora seduto in ufficio, e dal
1900 fino agli anni Ottanta
l’arredo e il modo di lavorare
tipici di un ufficio – macchine
da scrivere e archivi, appunti e
riunioni – sono cambiati molto
poco. (È vero, la macchina
fotocopiatrice ci ha permesso di
fare a meno della carta
carbone.) Successivamente, in
un periodo di tempo molto
breve, è cambiato tutto: pc
collegati in rete su ogni
scrivania, posta elettronica e
Internet, videoconferenze e telelavoro.
Tutto
ciò
ha
rappresentato
un
evidente
cambiamento qualitativo, e ha
dato
una
sensazione
di
progresso
che
i
soli
miglioramenti quantitativi non
potevano dare. E questo senso
di progresso ha aiutato a far
nascere una nuova sensazione
di ottimismo riguardo al
capitalismo.
I nuovi settori economici ci
hanno riportato indietro a quello
che potremmo chiamare il
«romanzo del capitalismo»:
l’immagine di un eroico
imprenditore che costruisce una
migliore trappola per topi e che,
così
facendo,
diventa
meritatamente ricco. A partire
dall’epoca di Henry Ford quella
figura
eroica
era
stata
progressivamente
mitizzata,
mentre l’economia diventava
sempre più dominata da grandi
multinazionali, gestite non da
romantici innovatori ma da
burocrati
che
avrebbero
benissimo
potuto
essere
funzionari dello stato. Nel 1968
John Kenneth Galbraith scrisse
che «con la nascita delle aziende
moderne, la creazione di
organizzazioni compatibili alle
moderne tecnologie e ai sistemi
di
pianificazione,
e
la
separazione tra la figura di chi
possiede il capitale e quella di
chi gestisce l’azienda, scompare
l’imprenditore, inteso come
persona
impegnata
nella
gestione di mature strutture
industriali». E chi avrebbe
potuto dirsi entusiasta di un
sistema
capitalistico
che
assomigliava più o meno a un
socialismo senza giustizia?
L’industria
informatica,
tuttavia,
diede
un
bello
scossone
alla
struttura
industriale. Così come era
accaduto nel XIXsecolo, la
storia economica tornò a essere
opera di individui speciali:
uomini (e solo di rado donne)
che ebbero una grande idea, la
approfondirono nel loro garage
o sul loro tavolo di cucina e si
arricchirono improvvisamente.
Le
riviste
di
economia
diventarono
finalmente
interessanti da leggere; e, dopo
un
secolo,
il
successo
economico tornò a essere una
cosa desiderabile.
Tutto ciò creò terreno fertile
per
le
idee
liberiste.
Quarant’anni fa i difensori del
libero mercato e delle virtù
dell’imprenditorialità
senza
vincoli avevano un problema di
immagine: quando dicevano
«impresa privata», la maggior
parte delle persone pensava alla
General
Motors;
quando
dicevano «manager» la maggior
parte delle persone pensava a
uomini con un vestito di flanella
grigia. Negli anni Novanta tornò
la vecchia idea che la ricchezza
fosse il prodotto della virtù, o
per lo meno della creatività.
Ma
ciò
che
alimentò
veramente
l’ottimismo
economico fu l’incredibile
diffusione della prosperità – non
solo nei paesi industrializzati
(dove, in realtà, i benefici non
erano così condivisi come ci si
sarebbe potuti augurare), ma
anche in quei paesi che non
molto tempo fa sarebbero stati
considerati senza speranza.
I frutti della
globalizzazione
La
definizione
«Terzo
Mondo»
era
stata
originariamente coniata per
esprimere un certo orgoglio:
Jawaharlal Nehru la utilizzò per
primo per descrivere i paesi che
avevano
difeso
la
loro
indipendenza, non alleandosi né
con l’Occidente né con
l’Unione Sovietica. Ma in breve
l’originaria intenzione politica
fu sopraffatta dalla realtà
economica: il «Terzo Mondo»
cominciò a voler dire arretrato,
povero, sottosviluppato. E
questo termine perse la
connotazione
di
legittima
ambizione, per acquistarne una
priva di speranza.
Questo cambiamento era
dovuto alla globalizzazione: il
trasferimento di tecnologia e di
capitale dai paesi con alto costo
del lavoro a quelli con
manodopera più a buon
mercato, e la conseguente
crescita di esportazioni ad alta
intensità di lavoro dal Terzo
Mondo.
È assai difficile ricordare a
cosa somigliava il mondo prima
della globalizzazione; quindi
proviamo
a
far
girare
all’Indietro
le
lancette
dell’orologio, fino al Terzo
Mondo di meno di una
generazione fa (è ancora così, in
molti paesi). A quel tempo,
sebbene la rapida crescita
economica di alcuni piccoli
paesi del vicino Oriente avesse
già
iniziato
ad
attirare
l’attenzione, paesi in via di
sviluppo come le Filippine,
l’Indonesia o il Bangladesh
restavano in gran parte quello
che erano
sempre stati:
esportatori di materie prime,
importatori di prodotti finiti.
Piccoli,
inefficienti
settori
produttivi rifornivano i mercati
interni, protetti da quote
d’importazione, ma questi
settori generavano pochi posti
di lavoro. Allo stesso tempo
l’aumento della popolazione
costrinse i poveri contadini a
coltivare territori sempre più
marginali, o a cercare in tutti i
modi di sopravvivere – per
esempio facendosi dare in
concessione una delle tante
montagne di rifiuti che si
trovano alla periferia di molte
città del Terzo Mondo.
In
mancanza
di altre
opportunità, a Giacarta o a
Manila era possibile assumere
operai per un tozzo di pane. Ma,
alla fine degli anni Settanta, la
disponibilità di lavoro a buon
mercato non bastava a rendere
competitivo un paese in via di
sviluppo sui mercati mondiali. I
vantaggi
dei
paesi
industrializzati – il know-how
tecnico
e
logistico,
le
dimensioni molto più vaste dei
mercati e la vicinanza ai
fornitori, la stabilità politica e i
sottili ma cruciali adattamenti
sociali necessari a operare in
un’economia
efficiente
–
sembravano
compensare
differenze pari anche a dieci o
venti volte il costo della mano
d’opera. Anche gli estremisti
sembravano aver perso ogni
speranza di poter capovolgere
questa situazione: negli anni
Settanta la richiesta di un
Nuovo Ordine Economico
Internazionale si concentrava
sul tentativo di aumentare il
prezzo delle materie prime,
piuttosto che di far entrare i
paesi del Terzo Mondo nel
moderno sistema industriale.
E poi, improvvisamente,
successe
qualcosa.
Un
misterioso insieme di eventi che
ancora non abbiamo ben
compreso – meno barriere
all’ingresso,
migliori
telecomunicazioni, tariffe aeree
più convenienti – ridussero gli
svantaggi per chi produceva nei
paesi in via di sviluppo. A pari
condizioni è ancora meglio
produrre
nei
paesi
industrializzati – sono numerosi
i casi di aziende che, dopo aver
spostato la produzione in
Messico o nel vicino Oriente,
hanno deciso di tornare sui loro
passi dopo aver toccato con
mano gli svantaggi del Terzo
Mondo – ma a quell’epoca in
alcuni settori il basso costo del
lavoro rappresentò per i paesi in
via di sviluppo un vantaggio
competitivo sufficiente per
poter entrare nei mercati
mondiali. E così i paesi che
prima
sopravvivevano
vendendo
juta
o
caffè,
cominciarono invece a produrre
magliette e scarpe di tela.
Gli operai impiegati nella
produzione di scarpe e magliette
vengono inevitabilmente pagati
molto poco e devono essere
disposti a sopportare condizioni
di lavoro terribili. Ho detto
«inevitabilmente» perché i loro
datori di lavoro non hanno
deciso di avviare un’attività
economica per prendersi cura
della propria salute (o di quella
dei propri operai); cercheranno
quindi di pagare il meno
possibile, e questo minimo
dipende dalle altre opportunità
che i lavoratori hanno a
disposizione. E in molti casi si
tratta ancora di paesi molto
poveri.
Tuttavia nei paesi dove i
nuovi settori dediti all’export
hanno trovato terreno fertile, c’è
stato
un
miglioramento
innegabile nella vita della gente
comune. In parte perché i nuovi
settori economici devono poter
offrire ai lavoratori uno
stipendio in qualche modo più
alto di quello reperibile altrove,
così
da
incentivare
il
cambiamento. Ancora più
importante, tuttavia, è che la
crescita dell’industria – e di
tutto l’indotto che ha creato
l’export – abbia avuto un effetto
benefico su tutta l’economia. La
spinta a occupare nuove terre
divenne meno intensa e di
conseguenza gli stipendi dei
contadini crebbero; si ridusse il
numero di disoccupati che nelle
grandi città erano sempre in
cerca di lavoro e, così facendo,
le industrie cominciarono a
disputarsi
l’un
l’altra
i
lavoratori, e gli stipendi
cominciarono a crescere anche
nelle città. Nei paesi dove
questo processo era durato
abbastanza a lungo – per
esempio nella Corea del Sud o a
Taiwan – gli stipendi hanno
raggiunto livelli da paesi
avanzati. (Nel 1975 lo stipendio
medio orario nella Corea del
Sud era solo il di quello degli
Stati Uniti; nel 2006 era salito al
62%.)
I benefici per la popolazione
dei
paesi
da
poco
industrializzati, causati dalla
crescita delle esportazioni,
erano evidenti. Un paese come
l’Indonesia è ancora così
povero che il progresso può
essere misurato con la quantità
di cibo che in media ogni
abitante può mangiare; tra il
1968 e il 1990 la razione di cibo
giornaliera pro capite aumentò
da 2000 a 2700 calorie e
l’aspettativa di vita passò dai 46
ai 63 anni. Si possono osservare
miglioramenti simili lungo tutta
la costa del Pacifico e anche in
stati come il Bangladesh. Questi
miglioramenti ebbero luogo
senza che nessun occidentale
avesse fatto niente per aiutare le
popolazioni
–
gli
aiuti
provenienti dall’estero, mai
troppi, negli anni Novanta si
ridussero praticamente a zero. I
miglioramenti
non
erano
neanche la conseguenza di
particolari politiche attuate dai
governi nazionali, che – come
presto ci saremmo resi conto –
erano corrotti e senza cuore.
Erano invece il risultato
indiretto e non intenzionale
della condotta di multinazionali
senz’anima e di imprenditori
locali senza scrupoli, il cui unico
scopo era quello di approfittare
delle interessanti opportunità
offerte dalla disponibilità di
lavoro a buon mercato. Non era
uno spettacolo particolarmente
edificante; ma poco importa
quanto fossero spregevoli le
motivazioni di coloro che vi
erano coinvolti: il risultato fu
quello di riuscire a tirare fuori
dalla povertà più miserabile
centinaia di milioni di persone e
a creare condizioni di vita che in
molti casi erano ancora orribili
ma, nonostante tutto, erano
assai migliori di prima.
Una volta di più il capitalismo
poteva, a ragione, vantarsi dei
risultati raggiunti. I socialisti
avevano a lungo promesso lo
sviluppo; una volta il Terzo
Mondo considerava i Piani
quinquennali di Stalin il solo
modo con cui una nazione
sottosviluppata poteva entrare
nel xx secolo. Anche dopo che
l’Unione Sovietica aveva perso
la sua fama progressista, molti
intellettuali credevano che solo
non entrando in competizione
con i sistemi economici più
avanzati le nazioni povere
potevano sperare di uscire dalle
loro trappole. Negli anni
Novanta, tuttavia, alcuni paesi
testimoniarono che un rapido
sviluppo dopo tutto era
possibile – e lo si poteva
ottenere non con l’orgoglioso
isolazionismo socialista, ma
integrandosi invece il più
possibile al capitalismo globale.
Gli scettici e i critici
Non tutti erano soddisfatti
dello
stato
dell’economia
mondiale dopo la caduta del
comunismo. Mentre gli Stati
Uniti vivevano un momento di
grande
ricchezza,
altre
economie
industrializzate
avevano qualche problema. Il
Giappone non si era ancora
ripreso dalla crisi che la sua
economia
aveva
vissuto
all'inizio degli anni Novanta e
l’Europa stava ancora soffrendo
della «Eurosclerosi», vale a dire
del continuo presentarsi di alti
tassi di disoccupazione –
specialmente tra i giovani –
anche durante i momenti di
ripresa economica.
Anche negli Stati Uniti non
tutti
condividevano
la
medesima
sensazione
di
prosperità. I benefici della
crescita erano ripartiti in modo
ineguale: la disuguaglianza sia
della ricchezza sia del reddito
aveva raggiunto livelli che non
si vedevano dall’epoca del
Grande Gatsby e le statistiche
ufficiali affermavano che per
molti lavoratori i salari reali
erano
diminuiti.
Anche
interpretando i numeri con un
minimo di logica era piuttosto
evidente che i progressi
dell’economia
americana
avevano lasciato almeno 20 o 30
milioni di persone nei gradini
più bassi della scala sociale,
dopo
averli
ricacciati
all’indietro.
Alcune persone si sentivano
offese da altre cose ancora. I
bassi salari e le misere
condizioni di lavoro in industrie
che esportavano dai paesi del
Terzo Mondo costituivano un
frequente pretesto per discorsi
d’ordine morale – dopo tutto,
secondo gli standard dei paesi
industrializzati, quei lavoratori
erano certamente dei poveracci,
e questi critici non si lasciavano
convincere dall’argomento che
un cattivo lavoro con un basso
stipendio era pur sempre meglio
di nessun lavoro. Le persone
più sensibili facevano inoltre
notare che vaste parti del
mondo non erano ancora state
toccate dai benefici della
globalizzazione: in particolare
l'Africa
era
ancora
un
continente contraddistinto da
livelli di povertà sempre
maggiori, da un malessere
diffuso e da guerre brutali.E,
come sempre, c’era chi vedeva
nero. Ma fin dagli anni Trenta
c’è sempre stata gente che
prediceva
una
nuova
depressione; gli osservatori più
razionali hanno imparato a non
prendere sul serio questi moniti.
Ecco perché gli inquietanti
sviluppi
determinatisi
in
America Latina nella prima
metà degli anni Novanta –
sviluppi
che
segnalavano
effettivamente,
adesso
lo
sappiamo, la possibilità del
ritorno a un’economia della
depressione – sono stati
generalmente ignorati.
2. UN
AVVERTIMENTO
IGNORATO:
LE CRISI
DELL’AMERICA
LATINA
Immaginate di fare un gioco
con le parole – una persona dice
un nome o una frase e l’altra
deve rispondere la prima cosa
che le viene in mente – con un
banchiere internazionale di
grande
esperienza,
un
esponente del mondo della
finanza o un economista. Fino a
poco tempo fa, e forse anche
adesso, di fronte alla parola
«crisi finanziaria» la risposta
sarebbe
sicuramente
stata
«America Latina».
Per molti anni i paesi
dell’America Latina hanno
quasi avuto l’esclusiva di crisi
valutarie, fallimenti bancari,
brevi periodi di iperinflazione, e
di tutti gli altri problemi
monetari di cui siamo a
conoscenza. Deboli governi
eletti democraticamente si
alternavano a dittature militari,
ed entrambi cercavano di
conquistare la fiducia della
gente con programmi populisti
che in realtà non potevano
permettersi. Nell’intento di
finanziare questi programmi
finivano per ricorrere a prestiti
concessi da disinvolti banchieri
esteri, che facevano entrare in
crisi la bilancia dei pagamenti,
oppure alla stampa di denaro
contante,
che
creava
iperinflazione. Oggi, quando gli
economisti parlano dei pericoli
del
«populismo
macroeconomico», dei diversi
modi con cui il denaro può fare
una
brutta
fine,
stanno
implicitamente ragionando in
«peso».
Alla fine degli anni Ottanta
sembrava che l’America Latina
avesse finalmente imparato la
lezione. In America Latina
pochi ammiravano la brutalità di
Augusto Pinochet, ma le
riforme economiche che aveva
lanciato in Cile si rivelarono
molto
efficaci e
furono
mantenute quando il Cile tornò
finalmente alla democrazia nel
1989. Il ritorno del Cile alle virtù
vittoriane – il denaro e il libero
mercato
–
cominciò
a
incuriosire sempre più gli
investitori, mentre il paese stava
accelerando il suo tasso di
crescita. Inoltre le vecchie
politiche
sembravano
finalmente arrivate a fine corsa:
la crisi finanziaria iniziata nel
1982 era andata avanti per gran
parte del decennio, ed era
sempre più chiaro che solo
qualche cambiamento radicale a
livello
politico
avrebbe
permesso alla regione di
ricominciare a muoversi.
E così l’America Latina
cominciò a darsi da fare. Le
aziende di proprietà dello stato
furono privatizzate, furono tolte
le restrizioni alle importazioni,
furono ripianati i deficit di
bilancio.
Il
controllo
dell’inflazione divenne un
obiettivo prioritario; in alcuni
casi, come vedremo, i paesi
adottarono drastiche misure per
ridare fiducia alle valute. Questi
sforzi
vennero
presto
ricompensati non solo da una
maggiore efficienza, ma anche
da una rinnovata fiducia da
parte degli investitori stranieri. I
paesi che avevano trascorso gli
anni Ottanta come paria –
almeno fino al 1990 chi vendeva
i buoni del tesoro di paesi
latino-americani a investitori più
propensi al rischio riceveva in
cambio, in media, solo 30
centesimi per ogni dollaro –
cominciarono
a
essere
apprezzati
dai
mercati
internazionali,
che
fecero
arrivare quantità di denaro tali
da far sembrare poca cosa
anche i debiti bancari che
avevano originato la crisi
finanziaria.
I
media
internazionali
iniziarono
a
parlare della «nuova» America
Latina, in particolare del
«miracolo messicano». Nel
settembre del 1994 il Rapporto
mondiale
sul
livello
di
competitività, preparato da
coloro che presiedevano le
famose conferenze di Davos,
ospitò uno speciale intervento
dell’eroe del momento, il
presidente del Messico, Carlos
Salinas.
Tre mesi dopo, il Messico
piombò in una delle peggiori
crisi finanziarie mai viste. La
cosiddetta «crisi tequila» causò
una delle più dure recessioni
che avessero mai colpito un
solo paese dagli anni Trenta; le
sue ripercussioni si diffusero in
tutta
l’America
Latina,
riuscendo quasi a far crollare il
sistema bancario in Argentina.
Ripensandoci a posteriori,
quella crisi avrebbe dovuto
essere considerata come un
presagio, un avvertimento che la
reputazione dei mercati può
cambiare da un momento
all’altro, che quello che oggi è il
benevolo atteggiamento della
stampa non può prevenire una
futura crisi di fiducia.
Ma
l'avvertimento
fu
ignorato. Per capire il perché
bisogna dare un’occhiata alla
cronaca della grande crisi
dell’America Latina.
Il Messico: dagli anni
Ottanta in poi
Nessuno
potrebbe
considerare poco sofisticato il
governo del Messico. La stretta
cerchia che attorniava il
presidente,
i
cosiddetti
Cientìficos, era costituita da
giovani uomini ben educati, che
desideravano che il Messico
diventasse
una
nazione
moderna e di conseguenza
credevano fosse necessaria una
maggiore integrazione con
l’economia
mondiale.
Gli
investitori stranieri erano i
benvenuti, i loro diritti di
proprietà venivano garantiti. E,
attratti
dalla
leadership
progressista,
questi
ultimi
arrivarono effettivamente in
gran numero, ed ebbero un
ruolo cruciale nel processo di
modernizzazione del paese.
Ok, vi ho preso in giro. Non
sto parlando di uno degli ultimi
governi
messicani.
Sto
descrivendo il regime di Porfirio
Diaz, che governò il Messico
dal 1876 al 1911, quando il suo
regime fu rovesciato da una
sommossa popolare. Il governo
che salì al potere dopo un
decennio di guerra civile era
populista,
nazionalista,
e
sospettoso degli investitori
stranieri in generale e di quelli
statunitensi in particolare. I
membri del Partito Istituzionale
Rivoluzionario (PRI), dal nome
così
attraente,
volevano
modernizzare il Messico, ma lo
volevano fare a modo loro: le
aziende erano gestite da società
nazionali e rifornivano il
mercato locale, tenute al riparo
da stranieri più efficienti grazie a
tariffe
e
a
massimali
d’importazione.
Il
denaro
straniero lo si poteva anche
accettare,
finché
non
comportava come conseguenza
la perdita del controllo; il
governo messicano fu ben felice
di permettere alle aziende di
prendere in prestito dalle
banche
statunitensi,
a
condizione che le azioni con
diritto di voto rimanessero nelle
mani dei messicani.
Questa politica economica si
è
probabilmente
rivelata
inefficiente; a eccezione dei
maquiladoras,
aziende
orientate all’esportazione, a cui
era permesso di operare solo in
una stretta zona di confine
vicino agli Stati Uniti, il Messico
non riuscì ad approfittare della
crescente globalizzazione. Una
volta avviata, la politica
messicana
si
radicò
profondamente nel sistema
politico e sociale del paese,
difeso da oligarchie industriali
(che
avevano
l’accesso
preferenziale ai crediti e ai
permessi all’importazione), da
politici (che ricevevano denaro
dagli oligarchi), e dai sindacati
(che
rappresentavano
«un’aristocrazia» di lavoratori
relativamente ben pagati in
alcune
industrie
protette).
Bisogna anche dire che fino agli
anni Settanta il Messico fu
attento
a
non
esporsi
eccessivamente da un punto di
vista finanziario; la crescita era
molto lenta, ma per lo meno
non c’erano crisi.
Negli ultimi anni Settanta,
tuttavia, la tradizionale cautela
fu messa da parte. L’economia
messicana entrò in una fase di
boom, che si nutriva delle
nuove scoperte petrolifere,
dell’elevato prezzo del petrolio
e di grandi prestiti ricevuti dalle
banche
straniere.
Mentre
l’economia si surriscaldava e la
liquidità continuava a crescere,
pochi scorgevano i segnali di
pericolo.
Rari
articoli
suggerivano la nascita di
problemi finanziari, ma era
opinione condivisa che il
Messico (e, in generale,
l’America
Latina)
stava
correndo pochi rischi. Questo
atteggiamento compiacente si
può quantificare: al più tardi nel
luglio 1982 gli interessi sui
buoni del tesoro messicani
erano leggermente inferiori a
quelli di altre istituzioni
presumibilmente
sicure,
indicando così che gli investitori
consideravano minimo il rischio
che il Messico non sarebbe
riuscito a rispettare le scadenze
dei pagamenti.
A metà del mese successivo,
tuttavia, una delegazione di
funzionari messicani volò a
Washington per informare il
segretario al Tesoro statunitense
che erano a corto di denaro e
che il Messico non poteva più
onorare i propri debiti. Nel giro
di pochi mesi la crisi si era
allargata
a
gran
parte
dell’America Latina e anche
oltre, mentre le banche avevano
smesso di concedere prestiti e
cominciavano a chiederne il
pagamento. Con enormi sforzi
– prestiti d’emergenza da parte
del governo degli Stati Uniti e di
agenzie internazionali come la
Bank
for
International
Settlements, la modifica dei
tempi di pagamento, e quello
che formalmente si chiamava
«prestito concertato» (in cui le
banche sono più o meno
obbligate a prestare ai paesi il
denaro di cui questi ultimi
hanno bisogno per pagare gli
interessi sui debiti) – la maggior
parte dei paesi cercò di evitare
che
l’inadempienza
fosse
completa. Il prezzo pagato per
aver evitato di un soffio la
catastrofe finanziaria, tuttavia,
fu una severa recessione,
seguita da una ripresa lenta e
spesso incerta. Nel 1986 il
reddito reale pro capite era del
10% inferiore a quello del 1981;
i salari reali, colpiti da un tasso
d’inflazione medio superiore al
70% negli ultimi 4 anni, erano
del 30% più bassi del loro livello
precedente alla crisi.
A questo punto entra in scena
una nuova generazione di
riformatori. Nel corso degli anni
Settanta in Messico una «nuova
classe» era diventata sempre più
influente all'interno del gruppo
dirigente e del governo.
Beneducati, spesso laureati ad
Harvard o al MITcon un ottimo
inglese
e
una
visione
internazionale dei problemi, si
sentivano abbastanza messicani
per riuscire a navigare nelle
acque politiche dei boss e dei
patronati
del
PRIma
sufficientemente americani per
credere che le cose dovevano
essere diverse da come erano.
La crisi economica lasciò la
vecchia guardia, i «dinosauri», a
corto di risposte; i tecnici che
potevano spiegare come le
riforme del libero mercato
avessero funzionato in Cile,
come la crescita focalizzata
all’esportazione
avesse
funzionato in Corea, come
l’obiettivo della stabilizzazione
dell’inflazione
fosse
stato
raggiunto in Israele, diventarono
gli uomini del momento. Alla
fine degli anni Ottanta molti
economisti
latino-americani
avevano
abbandonato
la
vecchia visione statalista degli
anni Cinquanta e Sessanta in
favore di quello che venne
chiamato
«Washington
Consensus»: la crescita si
poteva
raggiungere
più
facilmente con bilanci sani,
bassa inflazione, mercati non
regolamentati e libero scambio.
Nel 1985 il presidente Miguel
de la Madrid cominciò a mettere
in pratica la sua dottrina,
soprattutto
attraverso
una
radicale liberalizzazione del
commercio messicano: i dazi
furono eliminati e la tipologia di
importazioni che richiedeva
licenze
governative
fu
drasticamente
ridotta.
Il
governo cominciò a vendere
alcune delle aziende di sua
proprietà e rese meno severe le
regole che disciplinavano la
proprietà straniera. La decisione
forse più ammirevole di tutte fu
la designazione da parte di
Miguel de la Madrid del suo
successore. Non il solito capo
del PRIma un campione dei
nuovi riformatori: il ministro
della Programmazione e del
Bilancio Carlos Salinas de
Gortari, anche lui in possesso di
una laurea della Kennedy
School of Government di
Harvard, circondato da uno staff
di economisti di elevata
reputazione formati in gran
parte al MIT.
Non a caso ho usato
l’espressione «designare come
successore». Dal 1920 al 1990 il
sistema politico messicano fu
veramente unico. Sulla carta si
trattava di una democrazia
rappresentativa, ma solo da
poco questa definizione ha
cominciato a diventare realtà.
Nel 1988, l’anno in cui Salinas
fu eletto, la democrazia
messicana era in pratica una
versione gonfiata del vecchio
modo di fare politica a Chicago:
un sistema a partito unico nel
quale gli elettori erano oggetto
di politiche clientelari, e ogni
calo di voti era compensato da
un sistema di conteggio molto
creativo. Tuttavia l’aspetto più
straordinario di questo sistema
era che il presidente, sebbene
fosse diventato quasi un
monarca assoluto durante i suoi
sei anni di mandato, non poteva
ottenere un secondo mandato;
doveva lasciare il posto, con
tutte le ricchezze accumulate
durante questo periodo, e
lasciare le redini a un successore
designato che sarebbe stato
nominato dal PRI e che avrebbe
inevitabilmente vinto le elezioni.
Nel 1988 questo sistema,
come il Messico nel suo
complesso, era sotto tensione.
Salinas aveva di fronte per la
prima volta un vero antagonista
nelle
elezioni
generali:
Cuauhtémoc Càrdenas, figlio di
un famoso vecchio presidente,
che criticava il riformismo
liberistico di Salinas ed era
favorevole a un populismo di
stampo più tradizionale e
anticapitalistico. Si trattò di
elezioni dall’esito non scontato:
vinse Càrdenas. Ma i risultati
ufficiali furono diversi. Salinas
diventò presidente; in questo
caso, più di quanto non fosse
già avvenuto con i suoi
predecessori, doveva ottenere
dei risultati. Proprio per questo
si rivolse al suo team di esperti
economici
proveniente
da
Cambridge.
I successi dell’epoca di
Salinas si fondavano su due
importanti decisioni politiche.
Innanzitutto una deliberazione
sulla crisi finanziaria. All’inizio
del 1989, dopo aver archiviato
con
sicurezza
l’elezione
presidenziale, il governo degli
Stati
Uniti
volle
inaspettatamente riconoscere gli
aspetti più spiacevoli della
realtà. Ammise finalmente ciò
che tutti sapevano da tempo,
vale a dire che molte casse di
risparmio avevano giocato con
il denaro pubblico e che
dovevano
essere
chiuse.
Intanto, nel corso di un inatteso
discorso, il segretario al Tesoro
Nicholas Brady dichiarò inoltre
che il debito dell’America
Latina non poteva essere
completamente rimborsato e
che parte del debito sarebbe
stata congelata. Il cosiddetto
Piano
Brady
era
più
un’intenzione che un vero e
proprio piano – il discorso di
Brady era frutto di intrighi
burocratici, durante i quali i
funzionari governativi che
avrebbero avuto le competenze
tecniche per mettere assieme un
piano in grado di alleggerire il
debito furono tenuti da parte,
per paura che potessero
sollevare obiezioni. Tutto ciò
diede
ai
messicani,
estremamente
competenti,
l’opportunità
che
stavano
aspettando. Nel giro di pochi
mesi avevano escogitato un
progetto valido. Il Messico finì
per sostituire
una
parte
dell’ingente debito con «titoli
Brady» di valore nominale più
basso.
Complessivamente
la
diminuzione
del
debito
messicano
ottenuta
grazie
all’accordo Brady fu modesta,
ma rappresentò una svolta
psicologica. I messicani, che a
lungo erano stati considerati
poco
affidabili,
si
tranquillizzarono nel vedere che
i banchieri esteri gli erano venuti
un po’ incontro; il debito
divenne un tema di politica
interna. Allo stesso tempo gli
investitori stranieri, che avevano
esitato a depositare in Messico i
propri capitali per paura di non
riuscire più a riportarli a casa,
considerarono l’accordo come
la conclusione di un capitolo, e
si mostrarono disponibili a
versare
denaro
fresco.
Diminuirono i tassi d’interesse
che il Messico era stato
obbligato a pagare per evitare
che il denaro uscisse dal paese;
e poiché il governo non doveva
più pagare tassi di interesse sul
debito così elevati, in breve il
deficit di bilancio svanì. Un
anno dopo l’accordo Brady, la
situazione
finanziaria
del
Messico si era trasformata.
La soluzione del problema
del debito non era però l’unico
asso nella manica di Salinas.
Nel 1990 quest’ultimo sorprese
il mondo proponendo che il
Messico firmasse un trattato di
libero scambio con gli Stati
Uniti e il Canada (il Messico
aveva già negoziato un accordo
di libero scambio con ciascuno
dei due paesi). In termini
quantitativi il North American
Free Trade Agreement, o
avrebbe
avuto
meno
conseguenze di quanto si
poteva pensare: il mercato
statunitense era già aperto ai
prodotti
messicani
e
la
liberalizzazione del commercio
era cominciata quando de la
Madrid aveva dato una svolta al
Messico, anche se non radicale,
in direzione del libero scambio.
Ma, come le misure volte alla
riduzione del debito, il aveva
come obiettivo quello di
rappresentare un punto di svolta
psicologico. Facendo sì che la
decisione del Messico di aprirsi
ai prodotti stranieri e agli
investitori di altri paesi non
fosse solo un’iniziativa di
politica interna, ma parte di un
trattato internazionale, Salinas
sperava
di
rendere
il
cambiamento irreversibile – e di
convincere in tal senso i
mercati. Salinas sperava anche
di poter garantire che l’apertura
del Messico sarebbe stata
ricambiata, che gli Stati Uniti
avrebbero
effettivamente
assicurato al Messico l’accesso
perpetuo al proprio mercato.
George Bush accettò l’offerta
di Salinas. Come avrebbe
potuto rifiutare? Nel 1982,
quando
esplose
la
crisi
finanziaria, molta gente negli
Stati Uniti ebbe paura di un
processo di radicalizzazione
della politica messicana, nel
corso del quale le forze
antiamericane – forse addirittura
comuniste – avrebbero potuto
avere la meglio. Invece erano
miracolosamente giunte al
potere persone ben disposte nei
confronti degli Stati Uniti e del
libero mercato – gente che ci
assomigliava:
costoro
si
offrirono di abbattere tutte le
vecchie
barriere.
Lasciarli
cadere avrebbe rappresentato
uno schiaffo in faccia alle
riforme;
sarebbe
stato
praticamente come incentivare
l’insorgere dell’instabilità e
dell’ostilità nel nostro vicino.
A causa degli urgenti motivi
di politica estera, i diplomatici
americani
si
mostrarono
entusiasti riguardo al NAFTA.
Come vedremo, convincere il
Congresso si rivelò invece un
po’ più difficile. Ma nei primi
momenti d’entusiasmo tutto ciò
era ancora lontano.
Mentre in Messico le riforme
andavano avanti – le aziende di
stato venivano privatizzate, vi
erano sempre meno restrizioni
alle importazioni, venivano ben
accolti gli investitori stranieri –
l’entusiasmo nei confronti del
paese aumentò. Personalmente
mi ricordo di avere parlato a un
gruppo di dirigenti di una
multinazionale – che erano a
capo delle filiali dell’America
Latina – a Cancun nel marzo
del 1993. In quell’occasione
espressi alcune deboli riserve
sulla situazione messicana, e
dimostrai che il risultato delle
riforme era stato un po’
deludente. «Lei è la sola
persona in questa stanza che ha
qualcosa di negativo da dire
riguardo a questo paese», mi fu
detto in maniera educata.
Persone come quelle della
stanza in questione finirono per
investire i loro soldi proprio in
questo paese: nel 1993 più di 30
miliardi di dollari di capitale
estero furono investiti in
Messico.
L'Argentina rompe con il
passato
«Ricco come un argentino».
Questo era un modo di dire
comune in Europa prima che
scoppiasse la Prima guerra
mondiale, un’epoca in cui
l’Argentina era considerata dalla
gente, e dagli investitori, come
una
terra
dalle
mille
opportunità.
Al
pari
dell’Australia, del Canada e
degli Stati Uniti, l'Argentina era
una nazione ricca di risorse, una
delle destinazioni preferite sia
dagli emigrati europei sia dal
capitale europeo. Buenos Aires
era una graziosa città con
un’atmosfera europea, al centro
di una buona rete ferroviaria
costruita e finanziata dagli
inglesi,
che
facilitava
l’esportazione di grano e carne
delle pampas in tutto il mondo.
Unita
da
commercio
e
investimenti
all’economia
globale, dal telegrafo al mercato
mondiale
dei
capitali,
l’Argentina rappresentava un
solido tassello del sistema
internazionale di prima della
guerra.
È vero, anche l’Argentina
talvolta aveva avuto la tendenza
a stampare troppo denaro e a
trovarsi in difficoltà nell’onorare
il debito estero. Ma lo stesso
capitava allora agli Stati Uniti.
Pochi
avrebbero
potuto
immaginare che l’Argentina
sarebbe caduta così in basso.
Gli anni tra le due guerre
furono difficili per l’Argentina,
come per tutti i paesi esportatori
di materie prime. I prezzi dei
prodotti agricoli rimasero bassi
negli anni Venti e crollarono
negli anni Trenta. La situazione
peggiorò a causa dell’aumento
del debito avvenuto durante gli
anni
migliori.
In
effetti
l’Argentina era come un
agricoltore che chiedeva ingenti
prestiti quando i tempi erano
favorevoli, e poi si trovava
dolorosamente schiacciato tra
prezzi in caduta e inderogabili
pagamenti di debiti. Nonostante
tutto, durante la Depressione
l’Argentina non si comportò
così male come ci si sarebbe
potuti aspettare. Il suo governo
si rivelò meno indottrinato di
quelli dei paesi industrializzati,
determinati a difendere a tutti i
costi le loro politiche monetarie.
Grazie alla svalutazione del
peso, ai controlli sulla fuga dei
capitali e a una moratoria sul
pagamento
dei
debiti,
l’Argentina fu in realtà in grado
di vivere un momento di forte
ripresa dopo il 1932; in realtà
nel 1934 gli europei avevano
ripreso a emigrare in Argentina,
perché
avevano
migliori
prospettive di trovare un lavoro
di quante ne avessero a casa
propria.
Ma il successo delle politiche
eterodosse
durante
la
Depressione collaborò a creare
abitudini di governo che si
rivelarono
sempre
più
distruttive a mano a mano che il
tempo passava. I controlli sugli
scambi con l’estero costituirono
un insieme di regole così
complesse da diventare un
incubo, con il risultato che
finirono per scoraggiare le
imprese e per incoraggiare la
corruzione. Quelle che erano
temporanee limitazioni delle
importazioni divennero barriere
permanenti, dietro alle quali
sopravvivevano
industrie
incredibilmente inefficienti. Le
aziende privatizzate divennero
occasione per sperperare il
denaro pubblico e per dare
lavoro a centinaia di migliaia di
persone senza riuscire ad
assicurare neanche i servizi
fondamentali. Il deficit di
bilancio correva impazzito,
conducendo a brevi periodi di
inflazione ancora più distruttivi.
Negli anni Ottanta le cose
peggiorarono
ulteriormente.
Dopo la sconfitta subita nella
guerra delle Falkland del 1982, il
governo militare argentino
cadde e il governo laico di Raúl
Alfonsín prese il potere con la
promessa
di
rivitalizzare
l’economia. Ma
la
crisi
finanziaria colpì l’Argentina in
maniera altrettanto forte del
resto dell’America Latina, e il
tentativo di Alfonsín di
stabilizzare
i
prezzi
introducendo una nuova valuta,
l’austral, si rivelò un fallimento.
Nel 1989 il paese soffriva di una
vera iperinflazione, con i prezzi
che crescevano a un tasso
annuale del 3000%.
Vinse le elezioni del 1989
Carlos Menem, il peronista –
vale a dire il candidato del
partito fondato da Juan Perón,
le cui politiche nazionalistiche e
protezionistiche erano servite
più di tutto il resto a trasformare
l’Argentina in un paese del
Terzo Mondo. Menem, come si
scoprì successivamente, era
pronto
a
una
versione
economica di quello che era
stato il viaggio di Nixon in Cina.
Come ministro delle Finanze
nominò Domingo Cavallo, un
laureato ad Harvard (dello
stesso anno di Pedro Aspe,
ministro delle finanze del
Messico
nella
fase
di
maturazione della crisi). Cavallo
sviluppò un piano di riforma
persino più radicale di quello
del Messico.
Parte del piano riguardava
l’apertura dell’Argentina ai
mercati mondiali – in particolare
si voleva porre fine all’abitudine
distruttiva,
consolidata
da
tempo, di considerare le
esportazioni agricole del paese
come attività su cui imporre
tasse molto elevate, che
potessero
poi
servire
a
finanziare altro. Anche la
privatizzazione dell’immenso e
inefficiente settore statale del
paese procedeva a ritmi veloci.
(Al contrario del Messico,
l’Argentina privatizzò anche la
compagnia petrolifera statale.)
Considerato che la precedente
politica argentina era forse la
peggiore al mondo, queste
riforme
ebbero
importanti
conseguenze.
Ma il tocco distintivo di
Cavallo fu dato dalla riforma
monetaria. Con l’obiettivo di
mettere fine per sempre alla
tradizione inflattiva del paese,
Cavallo fece resuscitare un
sistema monetario che era stato
quasi dimenticato nel mondo
moderno: il currency board.
Il currency board era tipico
dei possedimenti coloniali
europei,
che
avevano
normalmente il permesso di
stampare la propria moneta; ma
quest’ultima doveva essere
strettamente ancorata al valore
della
moneta
del paese
colonizzatore; la solvibilità
veniva assicurata da una legge
secondo la quale l’emissione di
valuta nazionale doveva essere
completamente garantita da
valute forti. La gente aveva
dunque diritto a convertire la
valuta locale in sterline o in
franchi a tassi stabiliti per legge,
e la banca centrale era obbligata
a conservare una quantità di
denaro del paese colonizzatore
sufficiente a cambiare tutto il
denaro espresso in valuta locale.
Negli anni del dopoguerra,
con il declino degli imperi
coloniali e la nascita di un’attiva
gestione
dell’economia,
il
currency board cadde nel
dimenticatoio. È vero, nel 1983
Hong Kong, in un momento in
cui la propria valuta stava
subendo forti pressioni, istituì
un currency board che fissava il
dollaro di Hong Kong a 7,8 nei
confronti
del
dollaro
statunitense. Ma anche Hong
Kong era una specie di reliquia
coloniale,
sebbene
assai
dinamica, e questo precedente
non
colpì
particolarmente
l’attenzione.
Il bisogno di credibilità
dell’Argentina
era
tuttavia
disperato, e così Cavallo tornò
al passato. Il vecchio austral fu
sostituito da un nuovo peso, e
per quest’ultimo fu stabilito un
tasso di scambio fisso – un peso
per un dollaro – con ogni
dollaro in circolazione garantito
da un dollaro di riserve. Dopo
decenni in cui aveva abusato
della propria valuta, con una
legge l'Argentina aveva adesso
completamente rinunciato alla
possibilità di stampare nuova
moneta, a meno che qualcuno
volesse cambiare un dollaro per
un peso.
I risultati furono incredibili.
L’inflazione
si
ridusse
rapidamente a un tasso vicino
allo zero. Come il Messico,
l'Argentina negoziò un accordo
Brady e fu ricompensata dalla
ripresa di flussi di capitale dai
paesi esteri, sebbene non della
stessa portata. Si riprese anche
l’economia reale: dopo anni di
declino, il PIL aumentò di un
quarto in soli tre anni.
Il difficile anno del
Messico
Alla fine del 1993 c’erano
altre
nuvole
all’orizzonte
dell’America
Latina?
Gli
investitori
erano
euforici:
sembrava
che
il
nuovo
orientamento liberista avesse
trasformato il continente in una
terra piena di opportunità. Gli
uomini d’affari stranieri, come
quelli ai quali avevo parlato a
Cancun, erano tutti ugualmente
sconvolti: il mercato da poco
liberalizzato aveva creato nuove
e grandi opportunità. Solo
alcuni economisti nutrivano
perplessità e queste ultime
erano
relativamente
poco
importanti.
Una domanda che si
ponevano sia il Messico sia
l’Argentina era quale fosse la
giusta definizione del tasso di
cambio. Entrambi i paesi
avevano stabilizzato le loro
valute; entrambi avevano fatto
calare l’inflazione; ma in tutti e
due
i
casi
l’inflazione
sopravviveva alla stabilizzazione
del tasso di cambio. In
Argentina, per esempio, il peso
fu ancorato al dollaro nel 1991;
tuttavia nel corso dei due anni
successivi i prezzi aumentarono
del 50%, rispetto al 7% degli
Stati Uniti. Un processo simile,
anche
se
meno
severo,
coinvolse il Messico; in
entrambi i casi l’effetto fu
quello di rendere costosi i
prodotti nazionali sui mercati
mondiali, e gli economisti
iniziarono a pensare che le
valute
erano
state
sopravvalutate.
Una
questione
simile
riguardava
la
bilancia
commerciale (più precisamente
quella che si chiama bilancia dei
pagamenti, un indicatore che
comprende servizi, pagamenti
d’interessi e così via – tuttavia
utilizzerò i due termini in
maniera intercambiabile). Nei
primi
anni
Novanta
le
esportazioni
messicane
aumentarono
abbastanza
lentamente, in gran parte perché
la forza del peso rendeva i
prezzi non competitivi. Allo
stesso tempo aumentarono le
importazioni, stimolate sia
dall’eliminazione delle barriere
protezioniste, sia da una
significativa crescita del credito.
Di conseguenza ci fu un
notevole surplus di importazioni
sulle esportazioni: nel 1993 il
deficit del Messico aveva
raggiunto l’8% del PIL, un
livello con pochi altri precedenti
nella storia. Era un segnale di
difficoltà?
I funzionari messicani, e
molti altri al di fuori del paese,
risposero di no. La loro
spiegazione
prendeva
direttamente spunto dai testi di
economia. Per una semplice
legge contabile la bilancia dei
pagamenti
è
sempre
in
equilibrio: vale a dire che ogni
acquisto effettuato all’estero
deve essere compensato da una
corrispondente
vendita
di
valuta.
(Gli
studenti
di
economia sanno che esiste una
piccola eccezione a questa
affermazione, che riguarda i
trasferimenti unilaterali, ma non
importa.) Se un paese ha un
deficit di spese correnti –
compra più beni di quelli che
vende – deve avere una
corrispondente eccedenza di
flussi di capitale – vendere più
titoli di quelli che acquista. E
vale anche il contrario: un paese
che ha un’eccedenza di flussi di
capitale deve avere un deficit
sulle spese correnti. Ma ciò
significa che il successo
ottenuto
dal
Messico
nell’incentivare gli stranieri ad
acquistare titoli messicani aveva
come necessaria conseguenza il
deficit commerciale – il deficit,
in realtà, era semplicemente un
altro modo di dire che gli
stranieri pensavano che il
Messico fosse un posto ideale
dove investire. L’unico motivo
per cui ci si sarebbe dovuti
veramente
preoccupare,
dicevano gli ottimisti, sarebbe
stato se l’ingresso di capitali
fosse stato in qualche modo
stimolato artificialmente – se il
governo avesse attirato i capitali
dall’estero dando lui stesso
denaro in prestito (come era
successo nel 1982), o creando
deficit di bilancio che avessero
fatto diminuire i risparmi
interni. Il governo messicano,
tuttavia, aveva un bilancio in
equilibrio, e in realtà stava
accumulando sempre più titoli
stranieri (riserve in valuta
estera), piuttosto che passività.
Quindi perché preoccuparsi? Se
il settore privato voleva investire
in Messico, perché il governo
avrebbe dovuto fermarlo?
Tuttavia c’era un aspetto
preoccupante
nei
risultati
ottenuti dal Messico: una volta
fatte tutte le riforme e con tutto
il
capitale
che
arrivava
dall’estero, dov’era la crescita?
Tra il 1981 e il 1989
l’economia
messicana
era
cresciuta solo a un tasso
annuale dell’1,3%, ben al di
sotto della crescita demografica,
lasciando il reddito pro capite a
un livello molto inferiore a
quello del 1981. Dal 1990 al
1994, gli anni del «miracolo
messicano», le cose andarono
decisamente meglio: l’economia
si sviluppò del 2,8% annuo. Ma
tutto ciò era ancora ben al di
sotto della crescita demografica;
nel 1994 il Messico, secondo le
sue stesse statistiche, restava
sotto ai livelli del 1981. Dov’era
il miracolo – dove si erano
nascosti i risultati di tutte queste
riforme, degli investimenti
stranieri? Nel 1993 l’economista
del MIT Rudiger Dornbush, uno
studioso
di
lunga
data
dell’economia messicana (e che
era stato professore di molti
degli
economisti
che
governavano il Messico, incluso
Aspe), scrisse una caustica
analisi sulla situazione, intitolata
Messico:
stabilizzazione,
riforma e nessuna crescita.
I difensori dei risultati
messicani facevano notare che
da questi numeri non si riusciva
a percepire il vero progresso
dell’economia, in particolar
modo la trasformazione da una
struttura industriale inefficiente
e chiusa in sé stessa a una
altamente competitiva e dedita
all’export. Tuttavia non era
certo fonte di soddisfazione che
gli ingenti capitali provenienti
dall’estero
producessero
risultati così miseri. Cosa c’era
di sbagliato?
Dornbush e altri sostenevano
che il problema stava nel valore
del
peso:
una
valuta
eccessivamente forte metteva
fuori mercato i prodotti
messicani, impedendo così
all’economia di trarre vantaggio
dall’aumento della sua capacità
produttiva. Il Messico quindi
aveva
bisogno
di
una
svalutazione – una riduzione
«una tantum» del valore del
peso espresso in dollari, che
avrebbe permesso all’economia
di riprendersi. Dopo tutto, nel
1992 la Gran Bretagna era stata
obbligata dai mercati finanziari
(in particolare da George Soros
– vedi capitolo 6) a lasciare che
il
valore
della
sterlina
diminuisse, e il risultato fu
quello di trasformare la
recessione in ripresa. Il Messico,
dicevano alcuni, aveva bisogno
di una dose della stessa
medicina. (Simili proposte
erano state avanzate anche a
proposito dell’Argentina, la cui
economia era cresciuta molto
più in fretta di quella del
Messico, ma che aveva dovuto
far fronte a un tasso di
disoccupazione ostinatamente
elevato.)
I messicani rifiutarono questi
discorsi,
assicurando
gli
investitori che il loro piano
economico stava procedendo
secondo programma, che non
c’erano motivi per svalutare il
peso e che non avevano alcuna
intenzione di farlo.
Fu
particolarmente
importante mettere in piedi un
valido piano di difesa, perché il
North American Free Trade
Agreement
aveva bisogno
dell’approvazione
del
Congresso statunitense ed era
contrastato
dall’opposizione.
Ross Perot aveva messo in
guardia che gli Stati Uniti
avrebbero ascoltato un «gran
rumore
di
parassiti»
muovendosi verso sud; opinioni
più rispettabili vennero sorrette
da motivazioni più serie. Nel
1993 l’amministrazione Clinton,
che aveva ereditato il NAFTA
dai suoi predecessori, si lasciò
alle spalle tutti i precedenti
tentennamenti e, con gran
difficoltà, arrivò alla meta; si
trattava però di una decisione
presa con l’acqua alla gola –
appena in tempo.
Infatti, nel corso del 1994 in
Messico alcune cose importanti
iniziarono peggiorare. Il primo
dell’anno ci fu una rivolta di
agricoltori nel povero stato
rurale del Chiapas, un’area che
non era stata colpita dai
cambiamenti
economici
e
politici che si erano diffusi in
tutto il paese. La stabilità del
governo non fu messa in
discussione, ma l’incidente
ricordava che le vecchie cattive
abitudini della corruzione e
l’opprimente povertà rurale
interessavano ancora una parte
importante del Messico. Un
fatto ancora più grave fu
l’assassinio di Donaldo Colosio,
il successore di Salinas,
avvenuto a marzo. Colosio
rappresentava
una
rara
combinazione tra la figura di un
riformista e quella di un politico
dotato di grande carisma
popolare; era considerato da
tutti l’uomo in grado di
legittimare il nuovo modo di
gestire il paese; l’assassinio
privò il Messico di un leader di
cui si aveva molto bisogno e
suggerì che forze oscure (boss
politici corrotti? signori della
droga?) non volevano un vero
riformatore al governo. Il
candidato che ne prese il posto,
Ernesto
Zedillo,
era
un
economista che aveva studiato
negli Stati Uniti, una persona la
cui onestà e intelligenza non
venivano messe in discussione;
ma era un politico ingenuo che
si sarebbe fatto comandare dai
dinosauri? Alla fine, nel periodo
precedente le elezioni, il cercò
di ottenere consensi spendendo
somme notevoli; parte dei peso
stampati fu convertita in dollari,
prosciugando le riserve di valuta
estera.
Zedillo vinse le elezioni,
questa
volta
onestamente,
perché riuscì a convincere gli
elettori che il pensiero populista
di Càrdenas avrebbe provocato
una crisi finanziaria – come mi
ha
spiegato
un
amico
messicano, il convinse gli
elettori che, se non avessero
votato per Zedillo, «ciò che era
successo
prima,
sarebbe
successo
di
nuovo».
Nonostante tutto, purtroppo, la
crisi esplose.
La crisi tequila
Nel dicembre del 1994, di
fronte a una drastica riduzione
delle riserve di valuta estera, le
autorità messicane dovevano
decidere cosa fare. Potevano
coprire le perdite aumentando i
tassi d’interesse, rendendo di
conseguenza
attraente
ai
residenti messicani conservare
in peso il loro denaro e, magari,
riuscendo anche ad attirare
capitali stranieri. Ma questo
aumento dei tassi d’interesse
avrebbe danneggiato le aziende
e i consumatori e il Messico era,
dopo parecchi anni di crescita
assai scarsa, già sull’orlo di una
recessione.
In
alternativa
potevano svalutare il peso –
ridurre il suo valore nei
confronti
del
dollaro
–
augurandosi di poter ottenere gli
stessi
effetti
raggiunti
dall’Inghilterra diciassette mesi
prima.
In
realtà
una
svalutazione poteva rendere nel
migliore dei casi non solo più
competitive le esportazioni
messicane,
ma
anche
convincere
gli
investitori
stranieri che i titoli messicani
erano un buon investimento, e
di conseguenza che i tassi
d’interesse potevano diminuire.
Il Messico decise di svalutare.
Ma combinò un disastro.
Quello che ci si aspetta
succeda quando la valuta di un
paese viene svalutata è che gli
speculatori dicano «Ok, è finita»
e smettano di scommettere sulla
sua continua discesa.
Così successe per Inghilterra
e Svezia nel 1992. Il pericolo è
che gli speculatori interpretino
la prima svalutazione come un
primo avvertimento di qualcosa
che deve ancora venire, e che
comincino dunque a speculare
in maniera ancora più forte. Per
evitare che tutto ciò accada, un
governo deve normalmente
seguire alcune regole. Prima di
tutto, se si decide di svalutare, la
svalutazione
deve
essere
sufficientemente grande. In
secondo luogo, subito dopo
aver deciso la svalutazione è
necessario dare la sensazione
che tutto sia sotto controllo, che
ci si sta comportando da
persone
responsabili
che
capiscono
quanto
sia
importante
trattare
correttamente gli investitori, e
così
via.
Altrimenti
la
svalutazione rischia di congelare
i dubbi riguardo alla solidità
dell’economia, e scatena il
panico.
Il Messico contravvenne a
tutte le regole. La svalutazione
iniziale fu del 15%, solo la metà
di quello che economisti quali
Dornbush avevano suggerito. E
il comportamento dei funzionari
governativi fu tutto tranne che
rassicurante. Il nuovo ministro
delle Finanze, Jaime Serra
Puche, si mostrò arrogante e
indifferente ai giudizi dei
creditori esteri; si scoprì inoltre
che alcuni uomini d’affari
messicani erano stati consultati
in anticipo riguardo alla
svalutazione, e furono date loro
informazioni riservate che erano
state negate ai creditori
internazionali. Una massiccia
fuga di capitali era ormai
diventata inevitabile e il governo
messicano
dovette
presto
abbandonare i tassi di cambio
fissi.
Tuttavia Serra Puche fu
rapidamente sostituito e il
Messico cominciò a fare una
serie di mosse appropriate; si
sarebbe potuto pensare che
tutte le riforme fatte a partire dal
1985 erano comunque servite a
qualcosa. In realtà non fu così:
gli
investitori
stranieri
ricevettero uno shock – un
autentico shock – nello scoprire
che il Messico non era ciò che
poteva sembrare, e vollero
ritirare il loro denaro a tutti i
costi. In breve tempo il peso
valeva la metà di prima della
crisi.
Il problema più urgente era il
bilancio del governo. I governi
la cui credibilità finanziaria è
sospetta fanno fatica a vendere
titoli a lungo periodo, e
normalmente finiscono per
emettere un grande ammontare
di debito a breve termine che
deve essere rinnovato a
intervalli frequenti. Il Messico
non faceva eccezione; gli elevati
tassi d’interesse sul debito
rappresentarono
uno
dei
principali problemi fiscali degli
anni Ottanta. Come abbiamo
visto, uno dei maggiori benefici
apportati dall’Accordo Brady
del 1989 fu che, dando più
fiducia agli investitori, il
Messico poté rinnovare il suo
debito a breve termine a tassi
d’interesse molto più bassi.
Questi vantaggi si erano nel
frattempo persi; e non solo: in
marzo il Messico stava pagando
agli investitori un tasso di
interesse del 75%.
Ancora peggio, nello sforzo
di convincere i mercati che non
avrebbe svalutato, il Messico
aveva convertito miliardi di
debito a breve termine nei
cosiddetti tesobonos, che erano
indicizzati al dollaro; mentre il
peso crollava, la dimensione di
questi debiti collegati al dollaro
esplodeva. E se il problema dei
tesobonos
ricevette ampia
pubblicità, il tutto servì solo a
rafforzare la sensazione di
panico.
La crisi finanziaria del
governo si allargò presto anche
al settore privato. Nel 1995 il
PIL del Messico sarebbe caduto
del
7%,
la
produzione
industriale del 15%, ben peggio
di quanto accadde negli Stati
Uniti a partire dagli anni Trenta
– in realtà molto peggio del
primo crollo che seguì la crisi
finanziaria del 1982. Migliaia di
imprese fallirono; centinaia di
migliaia di lavoratori persero il
posto. Rimane importante
chiedersi perché la crisi
finanziaria ebbe un tale effetto
devastante sull’economia reale
– e perché il governo messicano
non poté far nulla (come invece
aveva fatto la cooperativa di
baby-sitter) per prevenire il
tracollo.
La cosa più impressionante
fu che la crisi non si limitò a
colpire il Messico. In realtà
l’«effetto tequila» si diffuse
praticamente in tutto il mondo,
e in particolare agli altri paesi
dell’America
Latina,
specialmente l’Argentina.
Si trattava di una brutta
sorpresa. Innanzitutto perché
l’Argentina e il Messico sono
agli
estremi
opposti
dell’America Latina, con pochi
scambi finanziari o commerciali
tra di loro. In secondo luogo
perché si riteneva che il
«currency
board»
dell’Argentina fosse in grado di
rendere
invulnerabile
la
credibilità del suo peso. Come
era potuta restare coinvolta nella
crisi messicana?
Forse l’Argentina fu attaccata
perché per gli investitori yankee
tutti i paesi dell’America Latina
si assomigliano. Ma una volta
cominciata la speculazione
contro il peso dell’Argentina,
diventò
evidente
che
il
«currency board» non era
riuscito a mantenere quel tipo di
isolamento che i suoi creatori si
erano augurati. È vero, ogni
peso in circolazione era
garantito da un dollaro di
riserve, così che da un punto di
vista tecnico il paese poteva
sempre difendere il valore del
peso. Ma che cosa sarebbe
successo quando la gente,
razionalmente o meno, avrebbe
iniziato a cambiare grandi
quantità di peso in dollari? La
risposta, come si scoprì
successivamente, fu che le
banche
del
paese
si
avvicinarono
rapidamente
all’orlo
del
collasso
e
minacciarono di trascinare con
loro il resto dell’economia.
Le cose andarono così:
immaginate che un funzionario
di un’azienda di credito di New
York, innervosito dalle notizie
che provengono dal Messico,
decida che è meglio ridurre
l’esposizione nei confronti dei
paesi dell’America Latina – e
che non vale la pena di spiegare
al suo boss che, come ha
ricordato una volta Ronald
Reagan, «sono tutti paesi
diversi». Di conseguenza dice a
un cliente argentino che la sua
linea di credito non verrà
rinnovata e che i crediti arretrati
devono essere rimborsati. Il
cliente ritira i pesos necessari
dalla banca locale, li converte in
dollari senza problemi, poiché la
banca centrale ha ampia
disponibilità di dollari. Ma la
banca argentina deve ora
rinnovare le sue riserve di cassa;
quindi chiede il rimborso di un
prestito a un uomo d’affari
argentino.
È qui che cominciano i
problemi. Per ripagare il debito
l’uomo d’affari deve avere
peso,
che
probabilmente
dovranno essere ritirati da un
conto presso qualche banca
argentina – quest’ultima dovrà
lei stessa chiedere il rimborso di
alcuni debiti, portando così ad
altri prelevamenti bancari e a
ulteriori riduzioni di crediti.
L’iniziale riduzione del credito
dall’estero, in altre parole, avrà
un
effetto
moltiplicatore
all’interno dell’Argentina: ogni
dollaro di riduzione di credito a
New York porta a diversi peso
di prestiti a Buenos Aires.
Alla pari delle linee di credito,
anche la situazione economica
comincia a diventare rischiosa
in Argentina. Le aziende hanno
difficoltà a rimborsare i loro
debiti sul breve periodo, e tutto
ciò diventa ancora più difficile
perché i clienti sono anch’essi
sotto pressione finanziaria. I
titolari di conti correnti
cominciano a chiedersi se le
banche possano veramente far
fronte alle richieste della
clientela e iniziano a premunirsi
ritirando dei soldi, frenando
così ancor di più il ricorso al
credito; ed eccoci all’inizio di
quel
circolo
vizioso
di
strozzatura creditizia e di corsa
agli sportelli che ha devastato
l’economia statunitense negli
anni 1930-31.
Oggi le nazioni moderne
possono
difendersi contro
situazioni di questo genere.
Innanzitutto i depositi sono
assicurati dal governo, quindi i
risparmiatori non hanno motivo
di preoccuparsi per la solvibilità
delle loro banche. In secondo
luogo la banca centrale è pronta
ad agire come «prestatore
dell’ultima
ora»,
inviando
contanti alle banche così che
queste ultime non sono
obbligate
a
svendere
disperatamente qualcosa per
soddisfare le esigenze dei
risparmiatori. In questo modo
l’Argentina avrebbe potuto
stroncare il processo sul
nascere.
Ma le cose non furono così
facili. I risparmiatori argentini
erano certi che i loro peso
fossero al sicuro, ma non erano
altrettanto sicuri che il peso
avrebbe conservato il suo valore
in dollari; quindi volevano
premunirsi acquistando dollari,
per ogni evenienza. E la banca
centrale non poteva agire come
prestatore
dell’ultima
ora
perché non le era permesso
stampare nuovi peso eccetto
che in cambio di dollari! Le
severe regole studiate per
proteggere il sistema da una
particolare tipologia di crisi di
fiducia
lo
lasciarono
profondamente vulnerabile a un
altro tipo di attacco.
All’inizio del 1995, quindi,
sia il Messico sia l’Argentina
passarono
rapidamente
dall’euforia al terrore: sembrava
ormai
evidente
che
gli
esperimenti
riformisti
in
entrambi i paesi avevano
portato a crolli disastrosi.
Il grande salvataggio
Ciò di cui aveva urgente
bisogno l’America Latina erano
dollari: dollari con i quali il
Messico
avrebbe
potuto
ripagare i tesobonos alla
scadenza, dollari che avrebbero
permesso
all'Argentina
di
stampare peso e di prestarli alle
proprie banche.
La soluzione della situazione
messicana era la più urgente e
difficile dal punto di vista
politico. Mentre la maggior
parte del denaro proveniva da
agenzie internazionali come il
Fondo
Monetario
Internazionale, l’Europa e il
Giappone consideravano il
salvataggio del Messico come
un tema di competenza degli
USA, e di conseguenza gli Stati
Uniti
avrebbero
dovuto
provvedere da soli a fornire il
denaro
necessario.
Sfortunatamente
c’erano
potenti forze politiche schierate
contro un salvataggio di questo
tipo. Chi si era opposto con
tutte le forze al NAFTA
considerava la crisi messicana
una vendetta e non era disposto
a vedere il denaro pubblico
utilizzato per salvare i messicani
e i banchieri che avevano
prestato loro il denaro. Allo
stesso tempo i conservatori
rifiutavano
l’idea
di far
intervenire i governi in aiuto del
Messico, in particolare erano
contrari al ruolo del Fondo
Monetario Internazionale, che
consideravano un passo in
avanti in direzione di un
governo mondiale. Divenne
subito chiaro che il Congresso
degli Stati Uniti non avrebbe
approvato lo stanziamento di
alcun fondo per il salvataggio
del Messico.
Fortunatamente si scoprì che
il
segretario
al
Tesoro
statunitense poteva utilizzare a
sua discrezione lo Exchange
Stabilization Fund (ESF), un
determinato ammontare di
denaro riservato a interventi
d’emergenza
sui
mercati
azionari stranieri. L’obiettivo
della
legge
che
aveva
predisposto questo fondo era
chiaramente
quello
di
stabilizzare il valore del dollaro;
ma il testo non diceva
esattamente così. Quindi, con
grande creatività, il Tesoro lo
utilizzò invece per stabilizzare il
peso. Tra l’ESF e altre fonti di
finanziamento, una linea di
credito di ben 50 miliardi di
dollari fu rapidamente messa a
disposizione del Messico; e
dopo
diversi
mesi
da
cardiopalma
la
situazione
finanziaria
cominciò
a
stabilizzarsi.
Il salvataggio dell’Argentina
fu invece attuato tramite la
Banca Mondiale, che stanziò 12
miliardi di dollari per sostenere
le banche del paese.
I salvataggi non evitarono a
Messico e Argentina una severa
recessione economica – di gran
lunga peggiore, in realtà, di
quanto accadde nel primo anno
della crisi finanziaria degli anni
Ottanta. Ma alla fine del 1995 gli
investitori cominciarono
a
tranquillizzarsi e ad avere
fiducia che, dopo tutto, quei
paesi non erano proprio
destinati al collasso. Calarono i
tassi d’interesse; la spesa
cominciò ad aumentare; e dopo
poco tempo il Messico e
l’Argentina si stavano entrambi
riprendendo. Per migliaia di
aziende e milioni di lavoratori la
crisi era stata devastante; ma
finì prima di quanto molti
avevano temuto o si erano
aspettati.
Trarre le conclusioni
sbagliate
Due anni dopo la fine della
«crisi tequila» sembrava che
tutto fosse rientrato nella
norma. Sia il Messico sia
l’Argentina stavano vivendo
una fase di ripresa economica, e
gli investitori che non si erano
lasciati prendere dal panico
ottennero ottimi risultati. Così
quello che poteva essere
considerato un avvertimento
divenne, al contrario, fonte di
soddisfazione. Mentre pochi
mettevano esplicitamente in
pratica le lezioni imparate dalle
crisi in America Latina, una
sintesi informale di saggezza
post-tequila avrebbe potuto
assomigliare a quanto segue.
Innanzitutto la «crisi tequila»
non
concerneva
il
funzionamento del mondo
intero: riguardava il Messico e
solo il Messico. La crisi era stata
causata da errori messicani –
soprattutto politici, che avevano
permesso
alla
valuta
di
sopravvalutarsi,
avevano
aumentato il credito invece di
limitarlo quando erano iniziate
le speculazioni nei confronti dei
peso, e avevano gestito
goffamente la svalutazione
finendo per innervosire gli
investitori. La portata del crollo
rappresentava
una
diretta
conseguenza della situazione
messicana, con un passato
ancora irrisolto infarcito di
populismo e antiamericanismo;
si sarebbe quasi potuto
concludere che il crollo era una
punizione
per
i
brogli
nell’elezione del 1988.
La lezione che si poteva
trarre, in breve, era che la
sconfitta del Messico aveva
scarsa rilevanza per il resto del
mondo. È vero, la crisi si era
diffusa nel resto dell’America
Latina;
ma
la
lotta
dell’Argentina contro il crollo
finanziario evitò in qualche
modo di attirare l’attenzione del
mondo intero, forse perché fu
seguita da una ripresa così
vigorosa. Di certo la «crisi
tequila» non si sarebbe ripetuta
in economie ben governate, che
non avevano una storia di
populismo macroeconomico –
paesi come le economiemiracolo dell’Asia.
L’altra lezione non riguardava
il Messico, ma Washington –
vale a dire il Fondo Monetario
Internazionale e il segretario al
Tesoro statunitense. La crisi
sembrava avere mostrato che
Washington aveva la situazione
sotto controllo: disponeva delle
risorse e delle competenze
necessarie per contenere crisi
finanziarie anche di questa
portata. Grandi aiuti furono
velocemente
messi
a
disposizione del Messico; e
riuscirono nel loro intento.
Invece del difficile periodo che
aveva caratterizzato l’inizio
degli anni Ottanta, la «crisi
tequila» si concluse in un anno
e mezzo. Sembrava che questo
tipo di problemi potesse essere
gestito meglio che in passato.
Quattordici anni dopo l’inizio
della «crisi tequila», mentre gran
parte del mondo, inclusi gli Stati
Uniti, vive una crisi finanziaria
che ricorda molto da vicino gli
eventi del 1994-1995, è chiaro
che avevamo tratto lezioni
sbagliate dall’America Latina.
Quello che ci saremmo
dovuti chiedere era ciò che
l’economista Guillermo Calvo,
della Banca Mondiale e
successivamente dell’Università
del Maryland, era solito
domandare nel corso dei
convegni:
«Perché
una
punizione così severa per un
crimine così piccolo?». Nel
periodo
immediatamente
successivo alla «crisi tequila»
era fin troppo facile ripensare
alle politiche seguite dal
Messico e trovarle piene di
errori; ma il problema era che al
momento sembravano piuttosto
buone e, anche dopo la crisi, era
difficile trovare passi falsi
abbastanza
importanti
da
giustificare
la
catastrofe
economica del 1995. Avremmo
dovuto
tenere
a
mente
l’interrogativo di Calvo – che
suggeriva
l’esistenza
di
meccanismi che trasformavano
errori di poco conto in disastri
economici di vaste proporzioni.
Avremmo dovuto prestare più
attenzione
ad
alcuni
commentatori, che affermavano
che in realtà non c’era stato
alcun errore grave, a eccezione
di quell’insieme di segnali poco
chiari che finirono per alterare le
percezioni del mercato nei
riguardi del Messico, e che
misero in moto un processo di
panico che si autoalimentava.
Di conseguenza avremmo
anche dovuto comprendere che
quello che era accaduto al
Messico poteva capitare altrove:
l’apparente
successo
di
un’economia,
lo
sguardo
ammirato dei mercati e dei
media nei confronti dei suoi
manager, non garantivano che
l’economia fosse immune da
improvvise crisi finanziarie.
Ripensandoci a posteriori,
risulta anche evidente che
abbiamo dato troppo credito a
«Washington»,
al
Fondo
Monetario Internazionale e al
segretario al Tesoro. Era vero
che avevano tutti agito in
maniera coraggiosa e decisa, e
che i risultati raggiunti lo
testimoniavano. Ma a un esame
ravvicinato non era possibile
prevedere che questi risultati
avrebbero
potuto
essere
raggiunti un’altra volta. Questo
perché la movimentazione del
denaro era stata resa possibile
grazie a una sorta di gioco di
prestigio legalizzato, in gran
parte giustificato dalla speciale
importanza che il Messico
assumeva agli occhi degli Stati
Uniti; in occasione di crisi
successive non sarebbe stato
possibile trovare il denaro così
velocemente o
facilmente.
Inoltre il salvataggio del
Messico fu facilitato dalla
cooperazione
del
governo
messicano: i collaboratori di
Zedillo non dovevano soffocare
il proprio orgoglio nazionalista
ed erano in completa sintonia
con Washington riguardo a
quello che era necessario fare.
Avere rapporti con paesi asiatici
abituati a negoziare da una
posizione di predominio, con
leader che vedevano le cose
solo a modo loro, sarebbe stato
molto diverso.
Soprattutto forse non siamo
riusciti a capire fino a che punto
il Messico e Washington furono
semplicemente fortunati. Il
salvataggio non fu il frutto di un
piano approfondito che puntava
alla radice dei problemi; si trattò
di un’iniezione di denaro
liquido a un governo colpito
dall'esterno, che fece la sua
parte
prendendo
decisioni
dolorose, più per mostrare la
volontà del governo di ridare
fiducia al mercato che per
affrontare i problemi economici.
Ci riuscirono, purtroppo solo
dopo che l’economia era stata
severamente colpita; tuttavia
non c’erano motivi validi per
prevedere che una strategia di
questo tipo avrebbe potuto
funzionare anche la prossima
volta.
Per cui, quando la crisi arrivò,
nessuno
era
pronto
né
all'emergere di una nuova
«tequila» in Asia pochi anni
dopo, né al fatto che un piano di
salvataggio
che
ricalcava
l’esperienza
messicana
si
rivelasse inefficace. Eravamo
ancora meno preparati alla crisi
globale che è scoppiata nel
2007. La cosa incredibile
riguardo
alla
nostra
inconsapevolezza era che la più
grande economia asiatica aveva
già seri problemi e stava
commettendo chiari errori nel
gestire la propria attività
economica.
3. LA TRAPPOLA DEL
GIAPPONE
C’è stato un periodo, non
molto tempo fa, in cui gli
Americani erano ossessionati
dal Giappone. Il successo
dell’industria giapponese fece
nascere sia ammirazione sia
paura; non era possibile entrare
nella libreria di un aeroporto
senza incappare in pile di libri
che esibivano in copertina un
sole calante o guerrieri samurai.
Alcuni
di
questi
titoli
promettevano di svelare i segreti
del management giapponese;
altri
profetizzavano
(o
chiedevano)
una
guerra
economica. Modelli da prendere
a esempio o demoni, i
giapponesi erano al centro
dell’attenzione.
Tutto ciò appartiene al
passato. Di tanto in tanto il
Giappone finisce ancora sulle
prime pagine dei giornali, specie
per le cattive notizie – un
tracollo del Nikkei o un
problema sul «carry trade»,
mediante il quale i fondi
speculativi si finanziano a basso
costo in Giappone e prestano
quei soldi altrove. Ma la
maggior parte di noi ha perso
interesse
per
l’argomento.
Dopotutto i giapponesi non
erano così forti, sembra aver
concluso la gente, quindi
possiamo
permetterci
di
ignorarli.
Questa
è
una
vera
sciocchezza. Ogni fallimento del
Giappone ha per noi lo stesso
valore di un suo successo.
Quello che è accaduto al
Giappone è sia una tragedia sia
un presagio. La seconda più
grande economia mondiale ha
ancora milioni di lavoratori con
un elevato livello d’istruzione e
tanta buona volontà, un
moderno mercato azionario, e
un impressionante know-how
tecnologico. Ha un governo
stabile, che non ha difficoltà nel
raccogliere le imposte; a
differenza dell’America Latina o
di economie asiatiche più
piccole, il Giappone è una
nazione creditrice, che non
dipende dagli alti e bassi degli
investitori
stranieri.
Le
caratteristiche
della
sua
economia, che produce in gran
parte per il mercato interno,
dovrebbero dare al Giappone –
come agli Stati Uniti – una
libertà d’azione negata ad altre
nazioni.
Il Giappone, tuttavia, ha
subito per gran parte degli anni
Novanta una fase di recessione,
alternando brevi e insufficienti
momenti di crescita economica
a
recessioni ancora
più
profonde. Una volta campione
di
crescita
nel
mondo
industrializzato, alla fine del
1998 il Giappone aveva un
reddito pro capite più basso di
quello del 1991. Ancora peggio
dei risultati era la sensazione di
fatalismo e di impotenza: la
perdita di fiducia nella capacità
della politica pubblica di
capovolgere la situazione. Era
una tragedia: una grande
economia
come
quella
giapponese non ha bisogno né
si merita una recessione
decennale. Le disgrazie del
Giappone non sono così terribili
come quelle di altre nazioni
asiatiche, ma sono durate di più,
con motivazioni di gran lunga
meno convincenti. Tutto ciò
può anche suonare come un
presagio: se è successo a loro,
chi può dire che non possa
succedere anche a noi? Ci è
successo, infatti.
Ma perché è capitato al
Giappone?
Quando il Giappone era il
numero uno
Nessun paese – neanche
l’Unione Sovietica all’epoca dei
piani quinquennali di Stalin –
aveva
mai
vissuto
una
trasformazione così incredibile
come quella del Giappone negli
anni a elevata crescita compresi
tra il 1953 e il 1973. Nell’arco di
vent’anni una nazione di
tradizione agricola diventò la
più grande esportatrice di
acciaio e di automobili, quella di
Tokyo
divenne
l’area
metropolitana più grande e
forse anche più dinamica del
mondo, e la qualità della vita
fece un salto in avanti.
Alcuni occidentali se ne
accorsero. Già nel 1969 il
futurologo
Herman
Kahn
pubblicò La nascita del
superstato
giapponese,
prevedendo che gli elevati tassi
di crescita avrebbero fatto
diventare il Giappone la più
grande economia mondiale
entro l’anno 2000. Ma solo alla
fine degli anni Settanta –
pressappoco quando Ezra Vogel
scrisse il suo bestseller Il
Giappone numero uno –
l’opinione pubblica si rese
davvero conto di cosa fosse
diventato quel paese. Mentre
sofisticati prodotti giapponesi –
soprattutto
automobili
ed
elettronica da consumo –
invadevano
i
mercati
occidentali, la gente cominciò a
chiedersi quale fosse il segreto
del Giappone.
Fa sorridere ripensare al
giorno in cui si cominciò a
parlare di questo paese: la verità
era che l’epoca eroica della
crescita economica giapponese
finì
proprio
quando
gli
occidentali cominciarono a
prendere il Giappone sul serio.
Nei primi anni Settanta, per
motivi che in parte restano
ancora misteriosi, la crescita
rallentò in tutto il mondo
industrializzato. Il Giappone,
che aveva avuto il tasso di
crescita più elevato, subì il più
marcato rallentamento – dal 9%
annuo degli anni Sessanta passò
a meno del 4% dopo il 1973.
Sebbene questo tasso fosse
ancora maggiore di quello di
ogni altro paese industrializzato
(un 50% in più di quello degli
Stati Uniti), a questi ritmi il
Giappone sarebbe diventato la
prima economia mondiale molti
anni dopo l’inizio del XXI
secolo. Tuttavia la crescita del
Giappone era oggetto d’invidia
da parte delle altre nazioni;
molta gente osservava che il
paese aveva trovato non solo un
modo migliore per gestire la sua
economia ma che, almeno in
parte, aveva ottenuto i suoi
successi a spese dei concorrenti
occidentali.
Non
c’è
bisogno
di
descrivere in dettaglio il
dibattito che prese vita riguardo
ai motivi per cui il Giappone
aveva avuto successo. In sintesi
c’erano due scuole di pensiero.
La prima sosteneva che la
crescita era il frutto di alcune
caratteristiche
di
base:
innanzitutto un eccellente livello
educativo e un elevato tasso di
risparmio, e – come sempre –
cercava di utilizzare elementi di
sociologia spicciola per spiegare
perché questo paese fosse così
bravo nel produrre merce di
elevata qualità a prezzi bassi.
L’altra scuola di pensiero
affermava che il Giappone
aveva sviluppato un sistema
economico
completamente
differente, una forma di
capitalismo nuova e più
avanzata.
Il
dibattito
si
concentrò anche sulla filosofia
economica, sulla validità del
pensiero economico occidentale
e, in particolare, sui vantaggi del
libero mercato.
Un elemento su cui si basava
la presunta superiorità del
sistema giapponese era la
gestione dell’economia da parte
del governo. Negli anni
Cinquanta e Sessanta il governo
giapponese – sia il ministero
dell’industria e del Commercio
Internazionale (MITI) sia il
ministero delle Finanze, meno
noto ma forse più influente –
ebbero un ruolo importante
nella gestione dell’economia. I
prestiti bancari e le licenze
d’importazione furono concessi
a industrie e a società
selezionate;
la
crescita
economica fu, almeno in parte,
guidata dalla strategia del
governo, giacché i prestiti
bancari e le licenze di
importazione andavano a settori
e ad aziende favoriti. Nel
momento in cui l’Occidente si
concentrò sul Giappone, il
controllo da parte del governo si
era molto
allentato; ma
l’immagine del «Giappone
spa», un’economia gestita
centralmente, che faceva di
tutto per dominare i mercati
mondiali, rimase forte fino agli
anni Novanta.
Un altro elemento distintivo
dello
stile
economico
giapponese era il fatto che le
principali società fossero tenute
al riparo dalle pressioni
finanziarie a breve termine. I
membri dei keiretsu giapponesi
– gruppi di aziende alleate,
organizzate attorno a una
grande banca – di solito
possedevano grandi quantità di
azioni l’una dell’altra, e
proteggevano così la gestione
aziendale dalle pressioni degli
azionisti esterni. Le aziende
giapponesi
non
dovevano
neanche preoccuparsi troppo
del prezzo delle azioni o della
fiducia del mercato, poiché
raramente
si
finanziavano
vendendo
azioni
od
obbligazioni; era invece la
banca
a
cui
facevano
riferimento che prestava loro il
denaro. Quindi le aziende non
dovevano preoccuparsi della
redditività a breve termine o,
addirittura,
non
dovevano
preoccuparsi della redditività. Si
poteva
pensare
che
le
condizioni finanziarie della
banca avrebbero alla fine posto
dei vincoli agli investimenti del
keiretsu: se i prestiti erano
inesigibili, la banca non avrebbe
forse iniziato a perdere clienti?
Ma in Giappone, come nella
maggior parte dei paesi, i
risparmiatori pensavano che il
governo non avrebbe mai
permesso che i loro risparmi
andassero persi, e quindi
facevano poca attenzione a
come le banche impiegavano i
loro soldi.
Questo sistema, affermavano
sia i suoi ammiratori sia coloro
che lo temevano, faceva del
Giappone un paese in grado di
mantenere lo sguardo in avanti.
Uno dopo l’altro, il governo
giapponese si concentrava sui
settori «strategici», quelli che
servivano da motori di crescita.
Il settore privato veniva
indirizzato a questi settori,
protetto
dalla concorrenza
estera per un breve periodo,
durante il quale le industrie
potevano affinare con una
relativa tranquillità le loro
capacità sul mercato interno.
Poi ci sarebbe stata una vera e
propria corsa alle esportazioni,
durante la quale le aziende
avrebbero addirittura trascurato
il concetto di redditività pur di
conquistare quote di mercato e
avere la meglio sui loro
concorrenti esteri. Con il tempo,
una volta rafforzato il dominio
sull’industria, il Giappone andò
oltre.
Acciaio,
automobili,
videoregistratori,
semiconduttori – poi computer
e aeroplani.
Gli scettici sottolineavano i
punti deboli di questa storia. Ma
anche coloro che assolsero il
Giappone dalla colpa di aver
avuto
un
comportamento
predatorio, che si domandavano
se i maghi del mito fossero
veramente così onniscienti
come si diceva, tendevano a
essere d’accordo sul fatto che il
successo
del
Giappone
dipendeva in qualche modo
dalle caratteristiche distintive
del sistema giapponese. Solo
qualche tempo dopo queste
caratteristiche distintive – la
commistione tra governo ed
economia, la facile concessione
di crediti da parte di banche
garantite dal governo ad aziende
con cui le banche erano alleate
– cominciarono a essere definite
«crony
capitalism»
e
considerate la causa dei
problemi economici.
Le debolezze del sistema
erano comunque già visibili alla
fine degli anni Ottanta.
La bolla, la trappola e il
disastro
All’inizio del 1990 la
capitalizzazione del mercato in
Giappone – il valore totale di
tutte le azioni di tutte le aziende
del paese – era maggiore di
quella degli Stati Uniti, che
aveva
il
doppio
della
popolazione del Giappone e più
di due volte il suo PIL. I terreni,
mai a buon mercato in
Giappone,
erano
diventati
incredibilmente cari: secondo
un famoso detto, nel raggio di
un miglio quadrato [circa 2,59
chilometri quadrati – n.d.r.] dal
Palazzo Imperiale di Tokyo, la
terra valeva più dell’intero stato
della California. Benvenuti
nell’economia
gonfiata,
l’equivalente per il Giappone
dei ruggenti anni Venti.
La fine degli anni Ottanta
rappresentò per il Giappone un
periodo di prosperità, rapida
crescita, bassa disoccupazione e
utili elevati. Ciò nonostante non
c’era
alcun
indicatore
economico
che
potesse
giustificare il fatto che il prezzo
dei terreni e delle azioni fosse
triplicato in quel periodo. Anche
a quell’epoca molti osservatori
pensavano che ci fosse qualcosa
di strano e irrazionale nel boom
finanziario: le aziende che
operavano
in
settori
contraddistinti da lenti tassi di
crescita non potevano essere
considerate titoli in crescita, con
tassi prezzo/utili pari a 60 o più.
Ma, come spesso accade in
mercati che hanno perso la
ragione, gli scettici non avevano
le prove, o semplicemente il
coraggio, per sostenere le loro
idee; la pubblica opinione
giustificava in tutti i modi
l’esistenza di prezzi così alti.
Le bolle finanziarie non sono
un fenomeno nuovo. Dalla
mania per i tulipani alla mania
per Internet, anche i più attenti
investitori
hanno
spesso
difficoltà a non farsi coinvolgere
in queste frenesie collettive, a
mantenere una visione lucida
quando tutti stanno diventando
ricchi. Ma, considerata la fama
dei giapponesi per le strategie di
lungo periodo la sensazione che
il Giappone spa assomigliasse
più a un’economia pianificata
che a un libero mercato aperto a
tutti, le dimensioni della bolla
erano veramente sorprendenti.
La fama che il Giappone si
era fatto a proposito della
capacità
di
effettuare
investimenti a lungo termine si
rivelò esagerata. Gli speculatori
immobiliari,
che
spesso
riuscivano a ottenere guadagni
più elevati pagando sottobanco i
politici, e ulteriori guadagni
grazie a contatti con la yakuza,
per lungo tempo avevano
giocato una parte molto
importante
sulla
scena
giapponese. Gli investimenti
speculativi
in
immobili
arrivarono quasi a provocare
una crisi bancaria negli anni
Settanta; fu evitata solo grazie a
un’impennata dell’inflazione,
che ridusse il valore reale dei
debiti degli speculatori e diede
nuova vita ai debiti che prima
erano
stati
considerati
inesigibili. Tuttavia la sola
dimensione
della
bolla
giapponese
faceva
paura.
C’erano motivi in grado di
spiegare il fenomeno che non si
limitassero a ripetere i concetti
della psicologia della folla?
In realtà la bolla giapponese
era solo uno tra gli scoppi di
febbre speculativa che si
manifestarono nel mondo negli
anni Ottanta. Tutti questi scoppi
avevano
come
comun
denominatore il fatto di essere
in gran parte finanziati da
prestiti bancari – istituzioni
finanziarie
poco
accorte
cominciarono infatti a offrire
credito agli amanti del rischio,
anche agli operatori disonesti, in
cambio di tassi d’interesse al di
sopra della media di mercato. Il
caso più famoso fu quello delle
associazioni statunitensi di
risparmio e di credito –
istituzioni la cui immagine
pubblica era stata a lungo quella
del banchiere di provincia
Jimmy Stewart in La vita è
meravigliosa – che negli anni
Ottanta cominciarono a essere
identificate
con
discutibili
grandi imprenditori immobiliari
texani. Tuttavia problemi di
questo tipo erano presenti
anche in altre nazioni, in
particolare in Svezia, un paese
di cui spesso ci si dimentica
quando si parla di febbre
speculativa. Gli economisti
hanno a lungo sostenuto che
dietro episodi di questo tipo ci
fosse lo stesso principio
economico – uno dei princìpi,
quale quello illustrato dal
modello di recessione della
cooperativa di baby-sitter, a cui
farò più volte riferimento in
questo libro. Il principio è
conosciuto
come
«rischio
soggettivo».
Il termine «rischio morale»
nasce nel settore assicurativo.
Molto tempo fa coloro che
offrivano assicurazioni contro
gli incendi notarono che i
proprietari
di
immobili
assicurati erano spesso vittime
di incendi – particolarmente
quando il valore di mercato
degli immobili scendeva sotto
l’importo
coperto
dall’assicurazione. (A metà
degli anni Ottanta a New York
c’era un certo numero di
proprietari
«a
rischio
d’incendio», alcuni dei quali
compravano edifici a prezzi
inflazionati da una società
fantasma di loro proprietà,
impiegavano questo denaro per
stipulare una grossa polizza
assicurativa e, successivamente,
subivano
casualmente
un
incendio. È proprio un rischio
soggettivo.) Successivamente il
termine cominciò a essere
utilizzato per definire ogni
situazione nella quale una
persona decide la quota di
rischio che si vuole assumere,
mentre un’altra parte si incarica
di risarcire la perdita se le cose
vanno male.
Il denaro preso a prestito
produce intrinsecamente un
rischio
soggettivo.
Immaginiamo che io sia una
persona in gamba, ma senza
capitale; e che, fidandovi della
mia intelligenza, decidiate di
darmi in prestito un miliardo di
dollari, da investire in un
qualsiasi modo che reputi
adeguato, a patto che prometta
di restituirlo in un anno. Anche
se mi applicate un alto tasso di
interesse, questo è un grande
affare: mi prendo il miliardo, lo
investo in qualcosa che può
rendere un sacco di soldi, ma
può anche finire male, e
comincio a incrociare le dita. Se
l’investimento dà i suoi frutti,
allora divento ricco; in caso
contrario, dichiaro il fallimento
e me ne vado. Se viene testa
vinco io, se viene croce perdi tu.
Ovviamente questo è il
motivo per cui nessuno presta
un miliardo di dollari a chi non
dispone di un suo capitale,
anche se si tratta della persona
più intelligente del mondo. I
creditori normalmente pongono
condizioni ai debitori riguardo a
come questi ultimi possono
utilizzare i soldi ottenuti; e
coloro che prendono a prestito
sono normalmente obbligati a
rischiare un certo ammontare di
denaro proprio, in modo da
essere incentivati a evitare
perdite.
Qualche volta coloro che
offrono
capitali
paiono
dimenticarsi di queste regole
elementari e prestano grandi
somme senza chiedere nulla a
gente che sembra sapere
perfettamente quello che sta
facendo:
affronteremo
l’incredibile storia degli «hedge
funds» nel capitolo 6. In altri
casi è proprio l’obbligo a
rischiare un certo ammontare di
denaro di proprietà della
persona che chiede il prestito a
diventare fonte d’instabilità sul
mercato. Quando i beni
acquistati con denaro preso a
prestito perdono di valore, i
proprietari possono trovarsi di
fronte a una «chiamata di
margine addizionale»: devono
aggiungere denaro proprio
oppure ripagare i loro debitori
vendendo i beni, abbassando
ulteriormente i prezzi, un
processo che ha avuto un ruolo
importante nella crisi finanziaria
attuale. Lasciando da parte
questi aspetti molto particolari,
c’è un altro motivo più semplice
che spiega la ragione per cui
talvolta non vengono rispettate
le regole: il gioco del rischio
soggettivo si gioca infatti alle
spalle dei contribuenti.
Ricordate quello che ho
scritto riguardo alle banche del
keiretsu: i clienti credono che i
risparmi siano al sicuro, perché
li garantisce il governo. Lo
stesso si può dire riguardo a
tutte le banche del mondo
industrializzato e di gran parte
delle altre banche. Gli stati
moderni,
anche
se
non
garantiscono esplicitamente i
depositi, non si possono
permettere che vedove e orfani
perdano i risparmi di una vita
semplicemente perché li hanno
versati nella banca sbagliata,
così come non possono farsi da
parte quando un’inondazione
spazza via le case costruite sulla
pianura che è stata allagata.
Solo il peggior conservatore
potrebbe affermare il contrario;
il risultato è che le persone non
si preoccupano di dove
costruiscono le loro case e si
preoccupano ancor meno della
banca in cui versano i loro
risparmi.
Questa
mancanza
d’attenzione offre una buona
opportunità agli uomini d’affari
senza scrupoli. Basta aprire una
banca che abbia una bella sede
e un nome attraente. Attirare
depositi
pagando
elevati
interessi, se questo è permesso,
o in caso contrario offrendo
tostapane o qualsiasi altro
aggeggio in omaggio. Quindi
dare in prestito i soldi raccolti, ai
più elevati tassi d’interesse, a
speculatori
da
strapazzo
(preferibilmente ai vostri amici,
o addirittura a voi stessi, coperti
da una diversa ragione sociale).
I
risparmiatori
non
vi
chiederanno spiegazioni in
merito alla qualità dei vostri
investimenti, dato che sanno di
essere in ogni caso protetti. E
voi sapete di avere una sola
alternativa: se l’investimento va
bene diventate ricchi, se va male
potete
semplicemente
andarvene e lasciare che il
governo sistemi le cose.
D’accordo, non è tanto facile,
perché i legislatori non sono
così stupidi. Dagli anni Trenta
agli Ottanta, infatti, questi
comportamenti
sono
stati
piuttosto rari tra i banchieri,
perché i legislatori hanno fatto
più o meno le stesse cose che
avrebbe fatto un privato prima
di lasciarmi giocare con un
miliardo di dollari dato in
prestito.
Hanno
posto
condizioni agli usi che le banche
potevano fare del denaro dei
risparmiatori, in modo da
evitare che si corressero rischi
troppo elevati. Hanno chiesto ai
proprietari delle banche di
rischiare un certo ammontare di
denaro proprio. E, in una forma
più sottile, forse addirittura non
intenzionale, i legislatori hanno
anche limitato la competizione
tra
banche,
dando
alle
autorizzazioni a operare sul
mercato un valore quasi di
esclusiva; chi riceveva un ’
autorizzazione
era
poco
incentivato
a
giocarsela
assumendosi
rischi
che
potevano fare fallire la banca.
Negli anni Ottanta, tuttavia,
queste condizioni caddero in
disuso in molti paesi. Il motivo
fu
in
gran
parte
la
liberalizzazione.
Tradizionalmente le banche
erano prudenti, ma anche molto
conservatrici;
forse
non
riuscivano a indirizzare il
capitale verso gli impieghi più
redditizi. Per cambiare la
situazione,
sostenevano
i
riformatori, erano necessarie più
libertà e più competizione:
lasciate che le banche prestino
dove preferiscono e date la
possibilità a più operatori di
spartirsi
il
denaro
dei
risparmiatori. In qualche modo i
riformatori dimenticavano che
tutto ciò avrebbe dato alle
banche una maggiore libertà
nell’assumersi rischi eccessivi e
che, riducendo il valore
d’esclusiva
delle
loro
autorizzazioni, sarebbero state
meno incentivate a seguire un
comportamento prudente. Le
dinamiche
di
mercato,
soprattutto l'aumento delle fonti
alternative di finanziamento
aziendale,
ridussero
ulteriormente i margini di
profitto dei banchieri che
seguivano ancora le vecchie e
sicure abitudini.
Di conseguenza negli anni
Ottanta ci fu una specie di
epidemia globale di rischi
soggettivi. Pochi paesi possono
vantarsi di essere riusciti a
gestire
la
situazione
–
sicuramente non gli Stati Uniti,
dove la cattiva gestione dei
risparmi
e
dei
crediti
rappresentò
un
classico
esempio di un modo di
prendere le decisioni in maniera
imprudente, poco avveduta e
talvolta corrotta. Il Giappone,
dove tutti i rapporti – tra il
governo e l’economia, tra le
banche e i loro clienti, tra quello
che era e non era garantito dal
governo – risultavano poco
trasparenti, fu particolarmente
colpito all’avvento di un regime
finanziario con meno regole. Le
banche giapponesi erano quelle
che prestavano di più, e allo
stesso tempo quelle che si
facevano meno scrupoli; e così
aiutarono a gonfiare la bolla
fino
a farle raggiungere
dimensioni enormi.
Prima o poi le bolle
scoppiano sempre. Lo scoppio
giapponese, come si scoprì
successivamente, non fu del
tutto spontaneo: la Bank of
Japan, preoccupata dagli eccessi
speculativi, nel 1990 cominciò
ad aumentare i tassi d’interesse
in modo da far uscire un po’ di
aria dal pallone. All’inizio
questa politica non raggiunse lo
scopo che si era prefissa, ma a
partire dal 1991 i prezzi dei
terreni
e
delle
azioni
cominciarono
a
diminuire
drasticamente, fino a ridursi nel
giro di pochi anni al 60% del
loro valore massimo.
Inizialmente, e in realtà anche
per parecchi anni dopo, le
autorità giapponesi sembravano
aver considerato tutto ciò come
un fatto salutare – un ritorno a
corsi azionari più realistici. Ma
lentamente ci si rese conto che
la fine dell’economia gonfiata
non aveva portato la salute
economica, ma un malessere
sempre più profondo.
Una depressione nascosta
Al contrario del Messico nel
1995, della Corea del Sud nel
1998, e dell’Argentina nel 2002,
il Giappone non ha mai vissuto
un anno di inequivocabile,
catastrofico declino economico.
Nel decennio successivo allo
scoppio della bolla, il PIL reale
del Giappone è diminuito solo
in due occasioni.
Ma anno dopo anno la
crescita non raggiunse più i
livelli precedenti e rimase
sempre al di sotto delle sue
potenzialità.
Nel decennio
successivo al 1991 ci fu
solamente un anno in cui il
Giappone ebbe un tasso di
crescita che poteva ricordare
quello di un anno medio del
decennio precedente. E anche
con una stima conservativa del
tasso potenziale di crescita
dell’economia giapponese – la
produzione che si sarebbe
potuta ottenere utilizzando tutte
le risorse umane e le materie
prime – ci fu solo un anno in
cui l’output effettivo crebbe
quanto il tasso potenziale.
Gli economisti utilizzano una
delle loro espressioni più
complicate per descrivere la
situazione
che
stava
attraversando il Giappone: una
«recessione in crescita». Una
recessione in crescita è ciò che
accade quando un’economia
cresce, ma non abbastanza
velocemente da tenere il passo
con la capacità di espansione
dell’economia, così che sempre
più macchinari e lavoratori
restano
inutilizzati.
Normalmente le recessioni in
crescita sono piuttosto rare,
perché i boom e i momenti di
declino tendono ad aumentare
di velocità, e di conseguenza
producono rapida crescita o
marcato declino. Il Giappone,
tuttavia, ha vissuto una crescita
in
recessione
lunga
un
decennio, che ha lasciato il
paese così al di sotto delle sue
potenzialità da far coniare una
nuova etichetta: la crescita in
depressione.
La stessa lentezza con la
quale l’economia del Giappone
si è deteriorata è un grande
motivo di perplessità. Nel paese
la depressione ha preso piede
lentamente e dunque non c'è
mai stato (fino allo scorso anno)
un momento in cui la gente ha
chiesto a gran voce al governo
di affrontare di petto la
situazione. Allo stesso modo il
motore economico giapponese
ha gradualmente perso potenza,
piuttosto che subire una brusca
frenata, e il governo ha
costantemente aggiornato verso
il basso i propri parametri di
successo,
continuando
a
considerare la continua crescita,
anche
se
inferiore
alle
potenzialità, il risultato delle
proprie politiche. (Al momento
in cui scrivo i funzionari
giapponesi si stanno vantando
dei successi raggiunti – grazie a
grandi investimenti in opere
pubbliche – nell’ottenere una
crescita leggermente superiore
allo
zero
nell’ultimo
quadrimestre del 1998, come se
ciò
rappresentasse
una
completa
inversione
di
tendenza.) Allo stesso tempo gli
analisti giapponesi e stranieri
hanno cercato di sostenere che,
poiché il Giappone era cresciuto
lentamente per così tanto
tempo, non poteva crescere più
velocemente.
Quindi
le
politiche
economiche giapponesi sono
state caratterizzate da un
originale mix di soddisfazione e
fatalismo – e da una grande
incapacità
di
prendere
seriamente in considerazione i
motivi per cui le cose erano
andate a finire così male.
La trappola del Giappone
Non c’è niente di misterioso
riguardo
all’inizio
della
recessione giapponese del 1991:
presto o tardi la bolla finanziaria
doveva scoppiare e, una volta
successo, avrebbe determinato
un declino negli investimenti,
nei consumi e quindi nella
domanda complessiva. La
stessa cosa accadde negli Stati
Uniti dopo che scoppiò la bolla
azionaria degli anni Novanta, e
poi ancora dopo lo scoppio
della bolla immobiliare del
decennio
successivo.
La
domanda, tuttavia, è perché i
policy maker giapponesi, e in
particolare la banca centrale,
non sono riusciti a rimettere in
moto l’economia.
È giunto il momento di
tornare
alla
storia
della
cooperativa
di
baby-sitter.
Immaginiamo che il mercato
azionario statunitense crolli,
minando
la
fiducia
dei
consumatori.
Tutto
ciò
comporterebbe necessariamente
una recessione disastrosa?
Consideriamola
in
questo
modo: quando diminuisce la
fiducia da parte dei consumatori
è come se, per un qualche
motivo,
un
socio
della
cooperativa avesse iniziato ad
avere meno voglia di uscire, più
ansioso di accumulare i buoni
per una giornata di pioggia.
Questo potrebbe in realtà
condurre a una recessione – ma
non necessariamente, se i
responsabili fossero attenti e
rispondessero semplicemente
stampando più buoni. Questo è
esattamente ciò che il nostro più
importante fornitore di buoni,
Alan Greenspan, ha fatto nel
1987, ed è ciò che secondo me
potrebbe fare alla prossima
occasione.
Immaginate che Greenspan
non
risponda
abbastanza
velocemente e che l’economia
entri veramente in recessione.
Niente panico: anche se il più
importante fornitore di buoni si
è momentaneamente distratto,
può sempre capovolgere la
situazione stampandone di più
– vale a dire portando avanti
una politica di espansione
monetaria, come quelle che
misero fine alle recessioni del
1981-82, del 1990-91 e del 2001.
Cosa dire di tutti gli
investimenti sbagliati conclusi
durante il boom? Si tratta in
gran parte di capitale perduto.
Ma non ci sono validi motivi
per credere che gli investimenti
sbagliati fatti nel passato
debbano
necessariamente
portare a un crollo della
produzione oggi. La capacità
produttiva può non essere
cresciuta così come si credeva,
ma non è ancora crollata;
perché
non
stampare
abbastanza
denaro
per
mantenere alta la spesa, così
che l’economia possa utilizzare
pienamente il suo potenziale?
Ricordate, la storia della
cooperativa racconta che le
recessioni non sono punizioni
per i peccati che abbiamo
commesso, sofferenze che il
destino
ci
riserva.
La
cooperativa di Washington non
iniziò ad avere problemi perché
i suoi soci erano baby-sitter
incapaci e inefficienti; i
problemi non nascondevano la
perdita dei valori fondanti della
cooperativa o un fenomeno di
«crony baby-sitterismo». Si era
in presenza di un problema
tecnico – poche persone a
caccia di pochi buoni – che
poteva, come effettivamente
accadde,
essere
risolto
analizzandolo
lucidamente.
Quindi
la
storia
della
cooperativa dovrebbe evitarci di
cadere nel fatalismo e nel
pessimismo; la conclusione
sembra essere quella che le
recessioni sono sempre curabili,
anche senza troppa fatica.
Allora perché il Giappone
non si è fermato dopo lo
scoppio della bolla? Come è
stato possibile che il Giappone
sia stato colpito da una
recessione apparentemente non
gestibile – una crisi dalla quale
non sembrava possibile uscire
limitandosi a stampare nuovo
denaro? Bene, se proseguiamo
ancora un po’ nella storia della
cooperativa non è difficile
immaginarsi
qualcosa
che
ricorda parecchio i problemi del
Giappone – e vedere le possibili
soluzioni.
Prima di tutto dobbiamo
immaginarci una cooperativa i
cui soci si rendono conto che il
loro sistema presenta un punto
debole: ci sono momenti in cui
una coppia può avere bisogno
di uscire diverse volte una dopo
l’altra, arrivando a esaurire i
propri buoni e non avendo
quindi più la possibilità di
lasciare in custodia i propri
bambini, anche se disposta a
fare successivamente molto
lavoro di baby-sitter. Per
risolvere questo problema la
cooperativa
potrebbe
permettere ai soci di prendere a
prestito buoni extra nei
momenti
di
bisogno
–
ripagando i buoni così ottenuti
facendo da baby-sitter in un
secondo tempo. (Possiamo
adattare la storia un po’ meglio
al
funzionamento
dell’economia
reale
immaginando che le coppie
possono
anche
prendere
prestito i buoni l’una dall’altra;
il tasso d’interesse in questo
primitivo mercato dei capitali
svolge un ruolo simile a quello
del tasso di sconto.) Per evitare
che i soci abusino di questo
privilegio, i responsabili devono
tuttavia stabilire alcune regole –
che obbligano i soci a
rimborsare più buoni di quanti
non ne hanno ricevuti in
prestito.
Con questo sistema le coppie
hanno riserve di buoni più
limitate di prima, consapevoli
che in caso di bisogno possono
chiederne altri in prestito. I
responsabili della cooperativa,
inoltre, dispongono di un nuovo
strumento di gestione. Quando
è facile trovare baby-sitter ma
difficile offrire servizi di babysitter, le condizioni alle quali i
soci possono prendere a prestito
i buoni vengono rese più
favorevoli, poche famiglie che
fanno da baby-sitter, queste
condizioni vengono viceversa
appesantite, spingendo così la
gente a uscire di meno.
In altre parole questo
modello più sofisticato di
cooperativa dispone ora di una
banca centrale in grado di
stimolare
un’economia
depressa riducendo i tassi
d’interesse, e di raffreddarne
una
troppo
vivace
aumentandoli.
Ma in Giappone i tassi
d’interesse sono
diminuiti
praticamente a livello zero e,
tuttavia, l’economia è sempre in
fase di recessione. La nostra
storia ha improvvisamente
smesso di esserci utile?
Immaginate che la domanda
e l’offerta di baby-sitter abbiano
un
andamento
stagionale.
Durante l’inverno, quando è
freddo e buio, le coppie non
vogliono uscire spesso, ma si
mostrano disponibili a stare in
casa a sorvegliare i figli degli
altri – accumulando così buoni
che possono essere usati nelle
belle serate estive. Se questo
andamento stagionale non è
così marcato, la cooperativa è
ancora in grado di mantenere in
equilibrio la domanda e l’offerta
di baby-sitter diminuendo i tassi
d’interesse nei mesi invernali e
aumentandoli
in
estate.
Immaginate però che la
stagionalità sia molto forte. Di
conseguenza in inverno, anche
con un tasso d’interesse pari a
zero, ci sono più coppie
disposte a fare da baby-sitter
che coppie desiderose di uscire;
questo significa che le coppie
che
vogliono
accumulare
occasioni di divertimento estivo
sono ancora meno disposte a
usare i buoni in inverno, con la
conseguenza che ci sono ancor
meno opportunità di fare da
baby-sitter… la cooperativa
entra così in un periodo di
recessione pur avendo un tasso
d'interesse pari a zero.
E gli anni Novanta sono stati
l’inverno dello scontento per il
Giappone. Forse a causa
dell’invecchiamento
della
popolazione, forse perché si
avverte un diffuso nervosismo
riguardo al futuro, i cittadini
giapponesi non erano disposti a
spendere così tanto da utilizzare
completamente la capacità
produttiva del paese, pur
avendo un tasso d’interesse pari
a zero. Il Giappone, dicono gli
economisti, era caduto nella
temibile
«trappola
della
liquidità»; bene, ciò che avete
appena
letto
è
una
banalizzazione di quello che
significa la trappola della
liquidità e di come ci si può
cadere.
Il Giappone alla deriva
La tradizionale risposta a una
recessione è quella di tagliare i
tassi d’interesse – di permettere
alla gente di prendere in prestito
a condizioni più favorevoli i
buoni per baby-sitter, così che
si possa ricominciare a uscire. Il
Giappone è stato piuttosto lento
nel tagliare i tassi d’interesse
dopo lo scoppio della bolla, ma
successivamente li ha tagliati
subito a zero, e non è ancora
abbastanza. E ora?
La classica risposta, quella
tradizionalmente associata al
nome di John Maynard Keynes,
è che se il settore privato non
spende
abbastanza
per
mantenere
la
piena
occupazione, se ne deve
occupare il governo. Offrite al
governo la possibilità di
prendere in prestito denaro, di
utilizzare i fondi così raccolti
per
finanziare
progetti
d’investimento pubblico – che
possibilmente servano anche a
qualcosa di utile. ma questa è
una considerazione marginale –
e, di conseguenza, di creare
occupazione, in modo da
incentivare la gente a spendere,
da aumentare ancora più
l’occupazione e così via. Negli
Stati
Uniti
la
Grande
Depressione finì grazie a un
ingente programma di lavori
pubblici finanziato dal deficit,
conosciuto sotto il nome di
Seconda guerra mondiale;
perché non tentare di resuscitare
la crescita giapponese con
qualcosa di simile, anche se più
pacifico?
Il Giappone in realtà ci ha
provato. Negli anni Novanta il
governo ha adottato una serie di
provvedimenti
volti
a
incentivare la domanda, e ha
iniziato a costruire strade e
ponti, anche se il paese non ne
aveva davvero bisogno. Tutte le
volte che sono stati messi in
atto, questi provvedimenti
hanno direttamente incentivato
la creazione di posti di lavoro e
hanno anche fornito stimoli
all’economia nel suo insieme.
Il problema è che questi
provvedimenti non sembravano
riuscire
a
stimolare
sufficientemente lo yen. Nel
1991 il governo giapponese
aveva un surplus di bilancio
piuttosto considerevole (2,9%
del prodotto interno lordo); nel
1996, al contrario, il deficit era
pari al 4,3% del PIL. Tuttavia il
motore economico stava ancora
girando, seppure a stento. Nel
frattempo i deficit sempre più
alti cominciavano a preoccupare
il ministro delle Finanze
giapponese, che aveva timori
sulla tenuta della situazione nel
lungo periodo. Il grande
problema era l’andamento
demografico (in realtà aveva
anche molto a che vedere con
gli elevati tassi di risparmio
giapponesi e la bassa domanda
d’investimenti). Alla pari di altri
paesi, il Giappone ha vissuto un
boom di nascite seguito da una
fase di rallentamento, e ha ora
di fronte a sé la prospettiva di
un rapporto sempre più elevato
tra pensionati e lavoratori attivi.
Il problema del Giappone è però
molto più grave: la sua
popolazione in età da lavoro si
sta riducendo sempre più e il
numero di pensionati cresce
rapidamente. Poiché i cittadini
in pensione rappresentano un
ingente onere per i governi –
che forniscono trattamenti
previdenziali
e
assistenza
sanitaria – i tradizionali principi
fiscali sostengono che il
Giappone dovrebbe creare un
fondo di garanzia per far fronte
alle spese future, per non
rischiardi avere deficit sempre
più grandi.
Nel 1997 prevalse un
atteggiamento di responsabilità
fiscale e il primo ministro
Ryutaro Hashimoto aumentò le
tasse per ridurre il deficit di
bilancio.
Immediatamente
l’economia cadde però in
un’ennesima fase di recessione.
Si decise così di tornare a
finanziare la spesa con deficit di
bilancio. Nel 1998 il Giappone
approntò un massiccio nuovo
programma di lavori pubblici.
Ma i problemi fiscali erano
ormai venuti a galla e non era
più possibile nasconderseli. Gli
investitori si accorsero che il
Giappone prevedeva di avere un
deficit del 10% sul PIL e che la
percentuale di debito statale sul
PIL era ancora superiore al
100%; si tratta di cifre tipiche
dei paesi dell’America Latina a
rischio
di
iperinflazione.
Nessuno si aspettava che ciò
potesse accadere al Giappone,
ma gli investitori cominciavano
a preoccuparsi un po’ della
solidità a lungo termine delle
finanze statali. In breve, il
tentativo
di
stimolare
l’economia con la spesa
finanziata dal deficit sembrava
aver raggiunto il limite.
A quali altre opzioni si poteva
fare ricorso?
Se la spesa pubblica è una
classica risposta a un’economia
in crisi, un’altra possibile
risposta è quella di rifornire di
denaro le banche. Un punto di
vista ampiamente condiviso è
che la Grande Depressione durò
così a lungo perché la crisi
bancaria del 1930-31 inflisse
danni di lungo termine al
sistema creditizio. Secondo
questo punto di vista c’erano
uomini d’affari che sarebbero
stati disposti a spendere di più
se avessero avuto accesso al
credito. Ma i banchieri che
avrebbero potuto concedere
questi prestiti avevano chiuso i
battenti o non erano in grado di
raccogliere i fondi, perché la
fiducia della gente nei confronti
delle banche era stata messa
duramente alla prova. Nel caso
della cooperativa di baby-sitter
ciò equivale a dire che c’è gente
disposta a uscire in inverno e a
fare da baby-sitter in estate, ma
che non riesce a trovare
nessuno che le dia in prestito i
buoni necessari.
Le
banche
giapponesi
avevano in realtà accumulato
molti debiti inesigibili durante
gli anni della bolla economica, e
la lunga stagnazione che seguì
ne rese inesigibili molti altri. Al
momento in cui sto scrivendo la
maggior parte delle banche non
ha ancora ben chiaro quanti
siano i debiti che non saranno
mai più restituiti, ma tutti sanno
che molte banche o non hanno
capitale oppure ne hanno molto
meno di quello che richiede la
legge. Una possibile teoria in
grado di spiegare la recessione
giapponese è dunque che il
paese si trovasse in una trappola
di liquidità soprattutto perché le
sue
banche
erano
finanziariamente deboli; una
volta sistemate le banche,
l’economia
poteva
solo
riprendersi. Alla fine del 1998 il
parlamento giapponese riuscì a
predispone un
piano
di
salvataggio da 500 miliardi di
dollari rivolto alle banche.
Ma un’altra opzione a
disposizione del Giappone era
fare tutto il necessario per
produrre un po’ di inflazione.
Questa opzione richiede un
minimo di spiegazione.
La verità è che per lungo
tempo gli economisti non si
sono soffermati a riflettere a
sufficienza sulle trappole della
liquidità. Prima delle difficoltà
che ha vissuto il Giappone negli
anni Novanta, l’ultimo grande
sistema che sembrò essere
caduto in una trappola di questo
tipo erano gli Stati Uniti della
fine degli anni Trenta. E gli
storici dell’economia hanno
tendenzialmente minimizzato la
significatività
di
quell’esperienza
affermando
che non era una vera trappola
della liquidità – dalla quale la
Federal Reserve poteva tirarci
fuori se solo ci avesse provato
seriamente – o che eravamo
caduti nella trappola solo grazie
a una serie di errori incredibili,
che difficilmente si sarebbero
ripetuti. Di conseguenza, non
appena alla metà degli anni
Ottanta si cominciò ad avere
sentore della trappola in cui era
caduto
il Giappone,
gli
economisti erano quasi tutti
impreparati – e, se mi è
permesso muovere qualche
critica nei confronti della mia
professione, poco interessati a
questo argomento. Continuo a
meravigliarmi di quanti pochi
economisti in giro per il mondo
si siano resi conto che il
problema della trappola in è
caduto
il Giappone
era
importante sia come problema
pratico sia come sfida al
pensiero economico.
Ma l’economia è, come ha
detto il grande economista
vittoriano Alfred Marshall, «non
un insieme di verità, ma una
spinta alla scoperta della verità».
Per esprimere lo stesso concetto
in una maniera più semplice, i
vecchi modelli possono essere
utilizzati per risolvere i nuovi
problemi. Come abbiamo visto
nell’ultima versione della storia
della cooperativa di baby-sitter,
un modello nato per spiegare
perché una banca centrale riesce
normalmente a curare una
recessione tagliando i tassi
d’interesse, può anche servire a
descrivere in quali casi questo
semplice rimedio non funziona.
Questa storia, nella sua versione
aggiornata, si rivela anche in
grado di una trappola di
liquidità, o a come evitare di
entrarci.
Ricordate:
il
problema
principale della cooperativa di
baby-sitting durante i mesi
invernali è che la gente vuole
risparmiare quello che ha
guadagnato facendo da babysitter per poi utilizzarlo durante
l’estate, anche a un tasso
d’interesse pari a zero. Ma
complessivamente i soci della
cooperativa
non
possono
mettere da parte quanto hanno
fatto in inverno per usarlo in
estate; quindi, se tutti gli
individui vanno in questa
direzione, non
può
che
innescarsi
una
recessione
invernale.
La soluzione, un qualsiasi
economista
dovrebbe
immediatamente
rendersene
conto, è quella di formulare un
prezzo equo: rendere ben chiaro
a tutti che i buoni guadagnati in
inverno si svalutano se vengono
conservati fino all'estate – vale a
dire, cinque ore di baby-sitter a
credito
in
inverno
si
trasformano in sole quattro ore
in estate. Tutto ciò incentiva la
gente ad anticipare la domanda
delle loro ore di baby-sitter e
quindi aumenta le opportunità
di offrire ore di baby-sitter.
Potreste essere tentati di
pensare che c’è qualcosa di
poco chiaro in tutto questo –
che ciò equivale a espropriare i
risparmi della gente. Ma la realtà
è che la cooperativa come
insieme non può mettere in
banca le ore invernali per
utilizzarle in estate, quindi deve
effettivamente modificare gli
incentivi ai soci per permettere a
questi ultimi di scambiare su
una base paritaria le ore
invernali per quelle estive.
Ma, nel nostro sistema
economico non da baby-sitter,
che cosa corrisponde ai buoni
che perdono di valore durante i
mesi estivi? La risposta è
l’inflazione, che riduce nel
tempo il valore del denaro. O
per essere più precisi, ciò che
può far uscire un’economia da
una trappola di liquidità è
un'aspettativa d’inflazione –
che
dissuade
la
gente
dall’accumulo eccessivo di
risparmi. Se si prende sul serio
la possibilità di una trappola di
liquidità – e il caso del
Giappone dimostra chiaramente
che dovremmo farlo – è
impossibile
sfuggire
alla
conclusione che l’inflazione
può essere un bene, perché ci
aiuta a uscire dalla trappola.
Sono
arrivato
a
queste
conclusioni servendomi della
storia della cooperativa di babysitter, ma è possibile arrivare alla
medesima
conclusione
utilizzando uno qualsiasi dei
tradizionali modelli matematici
di cui si servono abitualmente
gli economisti per discutere di
politiche monetarie. In realtà c’è
stata una vera e propria scuola
di pensiero che afferma che una
moderata inflazione può essere
utile se si vuole combattere la
recessione. Eppure, i difensori
dell’inflazione hanno dovuto
contrastare un’opinione molto
consolidata, che ritiene che la
stabilità dei prezzi rappresenti
una
situazione
sempre
desiderabile, e che promuovere
l’inflazione significa creare
incentivi perversi e pericolosi.
La convinzione che la stabilità
dei prezzi sia importante non
trova
fondamento
nei
tradizionali modelli economici –
al contrario, la teoria che si
legge sui libri di testo, se
applicata
alle
particolari
circostanze
del
Giappone,
propone
come
naturale
soluzione proprio l’inflazione.
Ma la teoria economica
tradizionale e il pensiero
economico convenzionale non
sempre vanno di pari passo –
un conflitto che sarebbe
diventato via via più evidente a
mano a mano che un sempre
maggior numero di paesi
avrebbe
dovuto
prendere
decisioni coraggiose per far
fronte alla crisi finanziaria.
La ripresa del Giappone
Intorno al 2003, l’economia
giapponese ha cominciato
finalmente a dare segni di
ripresa. Il PIL reale ha iniziato a
crescere in misura leggermente
superiore al 2% all’anno, la
disoccupazione è calata, e
l’opprimente deflazione che
affliggeva l’economia (e non
faceva che peggiorare la
trappola
di
liquidità)
è
diminuita, anche se non c’erano
segni di un’effettiva inflazione.
Che cosa era andato per il verso
giusto?
La
risposta
stava
principalmente
nelle
esportazioni.
Negli
anni
intermedi del decennio gli Stati
Uniti hanno accumulato enormi
deficit, importando ingenti
quantità di prodotti industriali.
Alcuni di questi prodotti
venivano dal Giappone, anche
se il grosso della crescita
riguardava le importazioni dalla
Cina e da altre economie
emergenti.
Ma
anche
il
Giappone ha tratto beneficio
dalla crescita dell’export cinese,
perché molti prodotti industriali
fabbricati in Cina contengono
componenti
di
origine
giapponese.
Un
aspetto
negativo del boom delle
importazioni americane era
dunque
l’ascesa
delle
esportazioni
giapponesi,
insieme
alla
ripresa
dell’economia giapponese.
Ma l’uscita del Giappone da
quella
trappola
restava
provvisoria. Nel momento in cui
scrivevo queste note, il call
money rate del Giappone
(l’equivalente del tasso di
sconto praticato dalla Federal
Reserve) era appena dello 0,5%.
La Bank of Japan aveva perciò
margini minimi per ridurre i
tassi d’interesse di fronte alla
recessione
che
sembrava
profilarsi.
4. IL CROLLO
DELL’ASIA
La Thailandia non è proprio
quello che si è soliti chiamare
un piccolo paese. Ha più
abitanti dell’Inghilterra o della
Francia, la capitale Bangkok è
un
grande
incubo
metropolitano, con un traffico
leggendario.
Tuttavia
l’economia
mondiale
ha
dimensioni
incredibilmente
vaste e, dal punto di vista
commerciale, la Thailandia
occupa un posto alquanto
marginale. Nonostante la rapida
crescita registrata negli anni
Ottanta e Novanta, resta un
paese povero; i suoi abitanti
hanno un potere d’acquisto che,
complessivamente, è inferiore a
quello degli abitanti del
Massachusetts.
Si
poteva
credere che le condizioni
economiche della Thailandia, al
contrario di quelle di una
superpotenza quale il Giappone,
interessassero solo i thailandesi,
le nazioni confinanti e le
industrie che avevano diretti
interessi finanziari nel paese.
Ma nel 1997 la svalutazione
della moneta thailandese, il
badi, provocò una valanga
finanziaria che seppellì gran
parte dell’Asia. La principale
domanda da porsi è perché sia
successo e come sia veramente
potuto succedere. Ma prima di
passare ai «come» e ai
«perché», diamo un’occhiata al
«cosa»: la storia del boom
thailandese, il suo crollo, e la
diffusione della crisi in tutta
l’Asia.
Il boom
La Thailandia è entrata a far
parte del miracolo asiatico in
tempi relativamente recenti.
Tradizionalmente era un paese
dedito
all’esportazione
di
prodotti agricoli e cominciò a
diventare un centro industriale
di una certa importanza solo
negli anni Ottanta, allorché le
aziende straniere – specialmente
quelle giapponesi – iniziarono
ad aprire stabilimenti. Ma
quando il paese decollò, lo fece
in maniera molto evidente:
mentre i contadini si spostavano
dalla campagna alle città,
mentre i buoni risultati ottenuti
dal primo gruppo di investitori
stranieri incoraggiavano altri
arrivi, la Thailandia cresceva a
un tasso dell’8% annuo. Ben
presto i famosi templi di
Bangkok furono circondati da
grattacieli
di
uffici
e
appartamenti; la Thailandia
divenne un paese dove milioni
di persone uscivano dalla
povertà assoluta per iniziare una
vita per lo meno decente, e dove
alcuni
si
arricchivano
enormemente.
Fino ai primi anni Novanta la
maggior parte degli investimenti
che promossero questa crescita
provenivano dai risparmi dei
thailandesi stessi: il capitale
straniero costruì stabilimenti
che
producevano
per
l’esportazione, ma le attività
economiche
di
minori
dimensioni erano finanziate da
uomini d’affari locali e dai
risparmi di questi ultimi; i nuovi
edifici per uffici e appartamenti
furono finanziati dai depositi
bancari delle famiglie. Nel 1991
il debito estero della Thailandia
era leggermente inferiore alle
sue esportazioni annue – non
una percentuale di poco conto,
ma comunque entro i normali
parametri di sicurezza. (Lo
stesso
anno
il
debito
dell’America
Latina
era
mediamente 2,7 volte le
esportazioni.)
Negli anni Novanta, tuttavia,
l’autosufficienza finanziaria del
paese cominciò a erodersi. In
gran parte la spinta venne
dall’esterno. La soluzione della
crisi finanziaria dell'America
Latina, descritta nel capitolo 2,
rese di nuovo allettante investire
nel Terzo Mondo. La caduta del
comunismo, avendo diminuito
la minaccia di un cambiamento
radicale, rese meno rischiosa
l’idea di investire al di fuori dei
confini del mondo occidentale.
Nei primi anni Novanta i tassi
d'interesse
dei
paesi
industrializzati
erano
eccezionalmente bassi, perché
le banche centrali stavano
cercando di tirare fuori le
proprie economie da una
leggera recessione, e molti
investitori andavano all’estero
in cerca di guadagni più alti,
forse la cosa più importante fu
che i fondi d’investimento
coniarono un nuovo nome per
quello che precedentemente si
chiamava Terzo Mondo o paesi
in via di sviluppo: ora erano
«paesi emergenti», la nuova
frontiera delle opportunità
finanziarie.
Gli investitori risposero in
massa all’appello. Nel 1990 i
flussi di capitale privato verso i
paesi in via di sviluppo
ammontavano a 42 miliardi di
dollari, e agenzie governative
come il Fondo Monetario
Internazionale o la Banca
Mondiale all’epoca stavano
facendo più investimenti nel
Terzo Mondo di quanto non
stessero facendo tutti gli
investitori privati messi assieme.
Nel 1997, tuttavia, mentre il
flusso di capitale pubblico
aveva subito un rallentamento, i
flussi privati diretti verso i paesi
in via di sviluppo erano
aumentati di cinque volte, fino
ad arrivare a 256 miliardi di
dollari. All’inizio la maggior
parte del denaro andò in
America Latina, specialmente in
Messico; ma dopo il 1994 si
rivolse sempre più verso le
economie, apparentemente più
sicure, dell'Estremo Oriente.
Come arrivava il denaro a
Bangkok o Giacarta da Tokyo o
da Francoforte? (La maggior
parte dei prestiti nei confronti
dell’Asia erano giapponesi o
europei – le banche statunitensi,
per scelta o per caso, rimasero
in parte a guardare.)
Che fine faceva il denaro
quando arrivava a destinazione?
Seguiamo il suo percorso passo
per passo.
Cominciamo con una tipica
transazione:
una
banca
giapponese elargisce un prestito
a una società finanziaria
thailandese, un’istituzione il cui
obiettivo principale è quello di
operare come una sorta di
cinghia di trasmissione nei
confronti degli investimenti
stranieri. La società finanziaria
dispone ora di yen, che utilizza
per concedere un prestito a un
tasso d’interesse più alto a una
società di costruzioni locale.
Quest’ultima
vuole
però
prendere a prestito bath e non
yen, poiché deve pagare la terra
e i propri dipendenti in valuta
locale. Quindi la società
finanziaria si rivolge al mercato
valutario
internazionale
e
cambia gli yen in bath.
Il
mercato
valutario
internazionale, come tutti gli
altri mercati, è governato dalla
legge
della
domanda
e
dell’offerta:
aumenta
la
domanda per qualcosa e,
normalmente, il suo prezzo
cresce. Vale a dire che la
domanda di bath da parte della
società finanziaria tenderà a far
aumentare il valore del bath nei
confronti delle altre valute.
Durante gli anni di boom la
Banca Centrale thailandese si
era però impegnata a mantenere
un tasso di cambio fisso tra il
bath e il dollaro USA. Per
riuscire in questo compito
avrebbe dovuto compensare
ogni aumento di domanda di
bath con un equivalente
incremento dell’offerta: vendere
i bath e comprare valuta estera
come dollari o yen. Quindi il
risultato indiretto di questo
prestito iniziale in yen sarebbe
stato un aumento sia nelle
riserve in valuta estera della
Bank
of
Thailand,
sia
nell’offerta
di
valuta
thailandese.
E,
complessivamente, ci sarebbe
anche stata un’espansione del
credito – non solo il prestito
fornito
direttamente
dalla
società finanziaria, ma anche
ulteriori crediti fomiti dalle
banche nelle quali venivano
depositati i bath da poco
stampati; e, siccome gran parte
del denaro dato in prestito
avrebbe finito per tornare alle
banche sotto forma di nuovi
depositi, tutto ciò avrebbe
finanziato ulteriori nuovi prestiti
e così via, secondo il classico
processo di «moltiplicazione
della base monetaria». (La mia
descrizione della crisi creditizia
argentina del 1995 rappresenta
un esempio di questo processo,
ma al contrario.)
Mentre arrivavano sempre
più prestiti dall’estero, il
risultato fu quindi una massiccia
espansione del credito, che
alimentò una serie di nuovi
investimenti. Alcuni di questi
investimenti servirono
per
costruire edifici, in gran parte
destinati a uffici e appartamenti,
ma ci furono pure molti casi di
vera e propria speculazione,
soprattutto immobiliare, ma
anche nel mercato azionario.
All’inizio del 1996 le economie
dell’Estremo
Oriente
cominciavano ad assomigliare
all’«economia
gonfiata»
giapponese degli ultimi anni
Ottanta.
Perché le autorità monetarie
non misero un freno al boom
speculativo? In realtà ci
provarono,
ma
non
ci
riuscirono. In tutte le economie
asiatiche le banche centrali
cercarono
di «sterilizzare»
l’ingresso di capitale: obbligata
a vendere bath sul mercato
valutario internazionale, la Bank
of Thailand avrebbe cercato di
ricomprare quei bath vendendo
buoni del tesoro, prendendo
così in prestito il denaro che
aveva appena stampato. Ma
questo processo finì per
aumentare i tassi d’interesse
locali, rendendo i prestiti
dall'estero ancora più allettanti e
facendo affluire ancora più yen
e dollari. Gli sforzi fallirono e i
crediti continuarono a crescere.
L’unico modo con cui la
Banca Centrale avrebbe potuto
evitare al denaro e al credito di
gonfiarsi come un pallone
sarebbe stato rinunciare al tasso
fisso di cambio – lasciare
semplicemente che il valore del
bath
aumentasse. Ma a
quell’epoca sembrò una cattiva
idea: un bath più forte avrebbe
reso le esportazioni thailandesi
meno competitive sui mercati
mondiali (perché i salari e gli
altri costi sarebbero stati più
elevati se espressi in dollari) e,
in generale, i thailandesi
pensavano che un tasso di
cambio fisso aumentava la
fiducia dei mercati e che il loro
paese era troppo piccolo per
sopportare
le
continue
fluttuazioni dei tassi di cambio
alle quali gli Stati Uniti sono
abituati.
Di conseguenza il boom
continuò la sua corsa. In
seguito, come raccontano i libri
di testo, l’espansione monetaria
e del credito iniziò ad
autolimitarsi. L’aumento degli
investimenti, unito a un
incremento della spesa da parte
di consumatori arricchitisi da
poco, portò a un rapido
sviluppo delle importazioni; il
boom
dell’economia
fece
aumentare
gli
stipendi,
rendendo
così
meno
competitive le esportazioni
thailandesi (in particolar modo
perché la Cina, un grande
concorrente della Thailandia,
aveva svalutato la sua valuta nel
1994), e facendo rallentare la
crescita delle esportazioni. Il
risultato fu un grande deficit
commerciale; invece di servire
ad alimentare capitale locale e
crediti, i prestiti in valuta
straniera cominciarono a essere
utilizzati
per
pagare
le
importazioni.
E perché no? Alcuni
economisti hanno sostenuto –
così come quelli messicani
avevano fatto nei primi anni
Novanta – che i deficit
commerciali della Thailandia,
della Malesia e dell'Indonesia
non erano segni di debolezza,
ma di forza economica, e
testimoniavano che i mercati
funzionavano così come ci si
aspettava
facessero.
Ripetiamolo ancora una volta:
da un punto di vista prettamente
contabile un paese che attira un
saldo positivo di capitale deve
avere un deficit di conto
corrente di uguali dimensioni.
Quindi se pensate che i flussi di
capitale verso l’Estremo Oriente
siano
economicamente
giustificati, altrettanto devono
esserlo i deficit commerciali. E
perché mai non doveva avere
senso che il mondo investisse
molto denaro in Estremo
Oriente. considerati i tassi
record di crescita e la stabilità
economica? Dopotutto non si
trattava di governi che si
concedevano spese folli: mentre
la Malesia e l’Indonesia
partecipavano alla costruzione
di grandiosi progetti pubblici, i
loro bilanci erano più o meno in
pareggio. Quindi questi deficit
commerciali erano frutto delle
decisioni di privati.
Un numero sempre maggiore
di osservatori cominciò tuttavia
ad avvertire un certo disagio
mentre i deficit della Thailandia
e della Malesia crescevano al 6,
7, 8% del prodotto interno lordo
– situazioni che il Messico
aveva vissuto prima della «crisi
tequila».
L’esperienza
messicana aveva convinto
alcuni di noi che i flussi
internazionali
di
capitale,
sebbene fossero frutto solo
delle decisioni dei settori privati,
non meritavano per questo
necessariamente la fiducia; la
miopia degli investitori riguardo
alle
prospettive
dell’Asia
ricordava molto da vicino quella
mostrata solo un paio di anni
prima riguardo all’America
Latina.
E
l’esperienza
messicana suggeriva anche che
quando l’opinione del mercato
fosse cambiata, la situazione
sarebbe stata difficile da gestire.
Avremmo anche dovuto
notare che l’idea che i prestiti
asiatici fossero frutto di libere
decisioni prese dai settori privati
non rappresentava tutta la
verità. L’Estremo Oriente, come
il Giappone durante gli anni
dell’economia gonfiata, aveva
un
problema
di
rischio
soggettivo – un problema che
presto sarebbe stato chiamato
«crony capitalism».
Torniamo a occuparci della
nostra
società
finanziaria
thailandese, l’istituzione che
prendeva a prestito gli yen e che
diede inizio al processo di
espansione del credito. Chi
erano queste società finanziarie?
Non erano, come si può
credere, banche ordinarie: in
linea di principio avevano al
massimo qualche cliente che
depositava il denaro presso di
loro. Allo stesso modo erano
diverse dalle banche d’affari
occidentali, incaricate di fornire
informazioni specializzate che
potevano aiutare a destinare i
fondi verso gli impieghi più
redditizi. In definitiva, quale era
la loro ragione d’essere? Che
cosa aggiungevano di nuovo?
La risposta, estremamente
sintetica, è: i collegamenti
politici – spesso, in realtà, il
proprietario
della
società
finanziaria era parente di un
funzionario governativo. Quindi
affermare che le decisioni in
merito a quanto prendere in
prestito e quanto investire
fossero prese solo dai settori
privati non ha molto senso. In
realtà i prestiti utilizzati per
finanziare le aziende non erano
garantiti come i risparmi e i
prestiti negli Stati Uniti. Si può
perdonare alle banche straniere
che prestavano il denaro a
società finanziarie vicine al
governo il fatto di aver pensato
che avrebbero ricevuto un po’
di garanzie in più, che il
governo avrebbe trovato il
modo di salvare la società se i
suoi investimenti non avessero
dato i risultati sperati. Alla fine
quelli che fornivano il denaro
dall’estero
avrebbero
effettivamente avuto ragione:
infatti, quando arrivò la crisi, in
circa nove casi su dieci gli
stranieri che prestavano alle
società finanziarie furono aiutati
dal governo thailandese.
Adesso
osserviamo
la
situazione dal punto di vista del
proprietario
della
società
finanziaria, una persona vicina
agli ambienti governativi. In
linea di massima quest’ultimo
poteva prendere in prestito
denaro a bassi tassi d’interesse
senza che nessuno gli facesse
alcuna
domanda.
Di
conseguenza veniva spontaneo
prestare questo denaro a un
tasso d’interesse più elevato ad
amici che lavoravano nel settore
immobiliare, le cui operazioni
speculative potevano finire male
– ma non necessariamente. Se
tutto fosse andato bene non ci
sarebbe stato nessun problema:
entrambi avrebbero fatto un
sacco di soldi. Se le cose non
fossero andate come si sperava,
la situazione non era così
terribile: il governo avrebbe
trovato il modo di salvare la
società finanziaria. Se esce testa
vince la società finanziaria, se
esce
croce
perdono
i
contribuenti.
In un modo o nell’altro si
assisteva a situazioni di questo
tipo in tutti quei paesi che
sarebbero presto entrati in crisi.
In
Indonesia
le
società
finanziarie svolsero un ruolo più
importante:
le
tipiche
transazioni
dubbie
rappresentavano prestiti delle
banche straniere direttamente a
società controllate da persone
vicine al presidente. (L’esempio
più
evidente
è
quello
dell’operazione che fece fallire
la
Peregrine
Investment
Holdings di Hong Kong: un
prestito fatto direttamente alla
società di taxi del figlio di
Suharto.) In Corea le maggiori
banche che prendevano a
prestito erano effettivamente
controllate dalle chaebol, le
grandi
conglomerale
che
avevano dominato l’economia
nazionale e – fino a poco tempo
fa – anche il sistema politico. In
tutta la regione, quindi, le
implicite garanzie prestate dai
governi
davano
vita
a
investimenti più rischiosi e
meno promettenti di quanto
sarebbero stati se non fossero
state prestate queste garanzie,
alimentando così quello che
sarebbe diventato un boom
speculativo.
Alla luce di tutto ciò non ci si
deve
dunque
meravigliare
troppo se la crisi cominciava a
prendere forma. Ma nessuno si
rese conto di quanto sarebbe
stata dura.
2 luglio 1997
Nel 1996 e nella prima metà
del 1997 la struttura creditizia
che aveva fatto nascere il boom
thailandese cominciò a tornare
sui suoi passi. In parte ciò
avvenne a causa di eventi
esterni: alcuni mercati in cui
venivano esportati prodotti
thailandesi si indebolirono, e la
svalutazione
dello
yen
giapponese rese un po’ meno
competitiva
l’industria
dell’Estremo Oriente. La realtà
era che il proprietario della bisca
aveva avuto la meglio sui
giocatori, così come succede
sempre: un maggior numero di
investimenti
speculativi
finanziati, direttamente o meno,
da debiti esteri a condizioni
vantaggiose, finirono male.
Alcuni speculatori fallirono e
alcune
società
finanziarie
chiusero i battenti. E gli
investitori stranieri divennero
sempre più riluttanti all’idea di
concedere in prestito altro
denaro.
La perdita di fiducia era in un
certo senso un processo che si
autorafforzava. Fino a che i
prezzi
immobiliari
e
le
quotazioni delle azioni erano
cresciuti, anche gli investimenti
più
dubbi
sembravano
interessanti. Quando la bolla
cominciò a sgonfiarsi le perdite
iniziarono
ad
aumentare,
causando un ulteriore calo della
fiducia e riducendo ancora di
più la concessione di nuovi
debiti. Anche prima della crisi
del 2 luglio il prezzo dei terreni
e delle azioni era caduto ben al
di sotto dei valori massimi.
Il
rallentamento
nella
concessione
di
prestiti
dall’estero creò problemi anche
alla Banca Centrale. In presenza
di un minor afflusso di dollari e
di yen, la domanda di bath sui
mercati valutari esteri diminuì;
allo stesso tempo restò invariata
la necessità di cambiare il bath
in valute estere per pagare le
importazioni. Per evitare che
diminuisse il valore del bath, la
Bank of Thailand fu quindi
obbligata a fare il contrario di
quello che aveva fatto quando il
denaro estero cominciava ad
affluire: andò sul mercato per
scambiare dollari e yen con i
bath, in modo da sostenere la
propria
valuta.
Ma
c’è
un’importante differenza tra il
cercare di mantenere a livelli
bassi la propria valuta e il
cercare di mantenerla a livelli
alti: la Bank of Thailand può
aumentare l’offerta di bath
quanto vuole, perché deve solo
stamparli; ma non può stampare
dollari. Quindi la sua abilità nel
mantenere alto il livello del bath
incontrò un grosso limite:
presto o tardi le riserve
sarebbero finite.
L’unico modo per sostenere
il valore della valuta sarebbe
stato ridurre il numero di bath in
circolazione, facendo aumentare
i tassi d’interesse e rendendo
ancora una volta conveniente
prendere in prestito dollari per
reinvestirli in bath. Ma tutto ciò
poneva problemi di diverso
genere. Mentre il boom degli
investimenti stava finendo,
l’economia thailandese aveva
rallentato la sua corsa – si
costruivano meno immobili, il
che aveva come conseguenza
un minor numero di occupati,
un reddito più basso e una
battuta d’arresto di tinta
l’economia. Non si trattava di
una vera e propria recessione,
tuttavia l’economia non viveva
più ai livelli ai quali si era
abituata
in
precedenza.
Aumentare i tassi d’interesse
avrebbe voluto dire scoraggiare
ulteriormente gli investimenti e
forse condurre l’economia alla
recessione.
L’alternativa era non porre
ostacoli all’andamento della
valuta: non acquistare più bath e
lasciar cadere il tasso di cambio.
Ma anche questa era una
opzione poco attraente, non
solo perché una svalutazione di
questo tipo avrebbe colpito la
reputazione del governo, ma
perché le banche, le società
finanziarie e le altre attività
economiche
thailandesi
avevano contratto debiti in
dollari; se il valore del dollaro
nei confronti del bath fosse
aumentato, molti di loro
sarebbero diventati insolventi.
Di conseguenza il governo
thailandese oscillò tra possibili
alternative. Non voleva lasciar
cadere il bath; allo stesso tempo
non era intenzionato a prendere
i severi provvedimenti che
avrebbero
bloccato
la
diminuzione delle riserve. Si
limitò
ad
aspettare,
apparentemente nell’attesa che
succedesse qualcosa.
Tutto ciò era perfettamente
prevedibile: si trattava del
classico preliminare a una crisi
valutaria, quello
che gli
economisti amano modellizzare
– e che gli speculatori amano
provocare. Mentre era sempre
più evidente che il governo non
era capace di dare un giro di vite
all’economia nazionale, e si fece
più concreta l’eventualità di
lasciare fluttuare il bath. Ma
poiché tutto ciò non era ancora
successo, c’era ancora tempo
per avvantaggiarsi da questa
prospettiva. Finché il tasso di
cambio bath-dollaro sembrò
poter rimanere stabile, il fatto
che in Thailandia i tassi
d’interesse fossero parecchi
punti al di sopra di quelli degli
Stati Uniti servì come incentivo
a contrarre debiti in dollari e a
concedere prestiti in bath. Ma,
una volta che si fece altamente
probabile l’eventualità che il
bath sarebbe presto stato
svalutato, l’incentivo ottenne
risultati opposti – contrarre
debiti in bath, aspettarsi che il
valore in dollari di questi debiti
si sarebbe presto ridotto, ed
entrare in possesso di dollari,
aspettandosi che il valore in
bath di questi titoli sarebbe
presto aumentato. I locali
uomini d’affari prendevano in
prestito in bath e ripagavano i
loro debiti in dollari; i
thailandesi
benestanti
vendettero i loro buoni del
tesoro e ne acquistarono di
statunitensi; infine non bisogna
sottovalutare il fatto che alcuni
grandi fondi d’investimento
internazionali
avessero
cominciato a prendere in
prestito bath e a convertire i
propri ricavi in dollari.
Tutte
queste
operazioni
avevano in comune la vendita di
bath e l’acquisto di altre valute;
di conseguenza la Banca
Centrale fu obbligata ad
acquistare ancora più bath per
evitare che la valuta crollasse e,
così facendo, le riserve di valuta
straniera si esaurirono ancora
più velocemente – il che
rinforzò
ulteriormente
la
sensazione che il bath fosse in
procinto di essere svalutato.
Stava prendendo forma una
classica crisi valutaria.
Qualsiasi
esperto
di
economia monetaria può dirvi
che, una volta che le cose sono
giunte a questo punto, il
governo deve prendere una
decisione immediata, in una
direzione o
nell’altra: o
difendere a tutti i costi la valuta,
oppure
lasciare
che
quest’ultima vada per conto
suo. Ma di solito per i governi è
difficile prendere una qualsiasi
decisione. Come molti altri
governi
che
l’avevano
preceduta, e senza dubbio come
molti altri che seguiranno, la
Thailandia aspettò finché le sue
riserve si esaurirono; nel
tentativo di convincere i mercati
che la sua posizione fosse più
forte di quanto non era in realtà,
fece sembrare più grandi le
riserve, annunciando improvvisi
riporti valutari (vale a dire
prendere in prestito dollari ora e
restituirli in un secondo tempo).
Ma, sebbene in alcuni momenti
la
pressione
sembrasse
allentarsi, subito dopo la
situazione tornava esattamente
come prima. All'inizio di luglio
era ormai chiaro che i giochi
erano fatti. Il 2 luglio i
thailandesi lasciarono fluttuare
liberamente il bath.
Fino a quel momento non era
successo
niente
di
sorprendente.
L’esaurimento
delle riserve, gli attacchi
speculativi su una valuta
chiaramente debole, erano tutte
conseguenze
perfettamente
prevedibili. Ma, nonostante la
recente esperienza della «crisi
tequila», la maggior parte della
gente
pensava
che
la
svalutazione del bath avrebbe
molto probabilmente messo
fine
a
questa
storia:
un’umiliazione per il governo,
forse anche una brutta sorpresa
per qualche settore economico,
ma niente di catastrofico. Di
sicuro la Thailandia non aveva
niente di simile al Messico.
Nessuno poteva accusarla di
avere
raggiunto
«stabilità,
riforme e nessuna crescita»; non
c’era
nessun
Càrdenas
thailandese
in
attesa
di
appoggiare un programma
economico populista. E quindi
non ci sarebbe stata una
recessione devastante.
Si sbagliavano.
Il disastro
Ci sono due domande un po’
diverse da porsi riguardo alla
recessione che si diffuse in Asia
all’inizio della svalutazione
thailandese. La prima riguarda
la meccanica di quanto
avvenne: come fu possibile la
recessione?
Perché
la
svalutazione di una piccola
economia ha provocato un
crollo degli investimenti e della
produzione in una regione così
vasta? L’altra domanda, in certo
senso più profonda, è: perché i
governi non riuscirono, o forse
non poterono, prevenire la
catastrofe? Che cosa era
successo
alla
politica
macroeconomica?
Ci vuole un po’ di tempo per
trovare risposta a questa
seconda
domanda,
anche
perché è stata oggetto di grandi
discussioni tra esperti. Quindi
lasciamo
questa
seconda
risposta al prossimo capitolo e
cerchiamo semplicemente di
descrivere i fatti.
Quando tutto va bene, non
succede niente di terribile se si
fa perdere valore a una valuta.
Quando
l’Inghilterra
abbandonò la difesa della
sterlina nel 1992, la valuta si
svalutò di circa il 15% e quindi
si stabilizzò: gli investitori
pensaroche il peggio fosse
passato, che una valuta con un
valore più basso avrebbe aiutato
le esportazioni del paese e che,
di conseguenza, l’Inghilterra era
diventata una nazione migliore
di
prima
per
effettuare
investimenti. Alcune stime
suggerirono che il bath avrebbe
dovuto perdere circa il 15% del
suo valore per rendere ancora
una volta competitiva sul fronte
dei costi l’industria thailandese,
e quindi ci si poteva aspettare
una svalutazione più o meno di
questa entità. Ma invece la
valuta precipitò: il prezzo di un
bath
espresso
in
dollari
aumentò del 50% nel corso dei
mesi successivi, e sarebbe
aumentato ancora di più se la
Thailandia
non
avesse
drasticamente aumentato i tassi
d’interesse.
Perché il bath crollò in questo
modo? In sintesi la risposta è:
«panico»; ma esistono diversi
tipi di panico. Quale era quello
in questione?
Talvolta
il
panico
è
semplicemente panico: una
reazione irrazionale da parte
degli investitori non giustificata
dall’attuale situazione. Un
esempio potrebbe essere quello
del breve crollo del dollaro
avvenuto nel 1981, dopo che un
pazzo armato aveva ferito
Ronald Reagan. Si trattò di un
episodio sconvolgente; ma
anche se Reagan fosse morto, la
stabilità
del
governo
statunitense e la continuità delle
sue politiche difficilmente ne
avrebbero risentito. Quelli che si
mantennero lucidi e non
abbandonarono
il
dollaro
furono ricompensati per non
aver perso la testa.
In economia, tuttavia, è
molto più importante il tipo di
panico che, qualsiasi sia il
motivo che lo fa nascere, si
auto-giustifica.
Il
classico
esempio è quello della corsa agli
sportelli: quando i correntisti
cercano di ritirare tutti allo
stesso momento i loro risparmi,
la banca è obbligata a vendere i
suoi beni a prezzi bassissimi,
entrando di conseguenza in
bancarotta; i correntisti che non
si lasciano prendere dal panico
hanno conseguenze peggiori di
quelli
che
effettivamente
perdono la testa.
E in realtà ci furono alcune
corse agli sportelli in Thailandia,
e ancora di più in Indonesia. Ma
prestare attenzione solo a
queste corse agli sportelli
vorrebbe dire prendere la
metafora troppo alla lettera.
Quel che successe in realtà fu
che si creò un processo
circolare di deterioramento del
sistema finanziario e di perdita
di fiducia; le corse agli sportelli
ne sono solo un aspetto.
L’illustrazione pubblicata qui
a fianco descrive questo
processo, che in qualche modo
si manifestò in tutte le
economie dell’Asia colpite dalla
crisi. Iniziate da una qualsiasi
parte dello schema – per
esempio dalla perdita di fiducia
nei confronti della valuta e
dell’economia
thailandese.
Questa perdita di fiducia spinge
gli investitori, sia thailandesi sia
stranieri, a portare il proprio
denaro fuori dal paese. Tutto
ciò, se nel frattempo le altre
variabili non hanno subito
cambiamenti, fa perdere valore
al bath. Considerato che la
Banca Centrale thailandese non
poteva più mantenere alto il
valore
della
sua
valuta
acquistandola
sui
mercati
internazionali (perché non
aveva più dollari o yen da
spendere), l’unica cosa che
poteva fare era aumentare i tassi
d’interesse e ritirare dalla
circolazione un po’ di bath.
Sfortunatamente
sia
la
diminuzione del valore della
valuta, sia l’aumento dei tassi
d’interesse crearono problemi
finanziari all’economia, per le
società finanziarie e per le
aziende. Da un lato molte di
queste ultime avevano debiti in
dollari, che improvvisamente si
fecero più pesanti, in quanto
aumentò il numero di bath
necessari per acquistare un
dollaro; dall’altro lato molte di
queste società avevano anche
debiti in bath, che divennero
difficili da onorare al crescere
dei tassi d’interesse. E la
combinazione di più alti tassi
d’interesse e bilanci in rosso
con un sistema bancario che
spesso si mostrava incapace di
concedere il più sicuro dei
prestiti, portò alla riduzione
delle spese da parte delle
aziende, e causò una recessione
che a sua volta finì per
peggiorare ulteriormente i ricavi
e i bilanci. Tutte queste brutte
notizie
provenienti
dall’economia
finirono
inevitabilmente per ridurre
ancora di più la fiducia, e per
l’economia fu un disastro.
Il circolo vizioso della crisi
finanziaria
Lasciando da parte tutti i
complicati
dettagli
(che
vengono ancora esaminati a uno
a uno dai ricercatori), la storia
sembra piuttosto chiara –
specialmente perché qualcosa di
simile era già avvenuto in
Messico nel 1995. Quindi per
quale
motivo
gli
effetti
disastrosi della svalutazione
thailandese colsero tutti alla
sprovvista? La risposta più
semplice è che, mentre molti
economisti avevano capito la
complessità di questa storia – la
teoria del circolo vizioso tra
fiducia,
mercati finanziari,
economia reale e di nuovo
fiducia – nessuno capiva quanto
il processo potesse risultare
potente nella pratica. Di
conseguenza nessuno capì
quanto
poteva
risultare
esplosiva la dinamica circolare
della crisi.
Facciamo un esempio. In una
sala convegni un microfono fa
sempre un eco di ritorno: i
suoni raccolti dal microfono
vengono
amplificati
dagli
altoparlanti, e quanti escono da
questi ultimi vengono a loro
volta raccolti dai microfoni, e
così via. Ma fino a che la stanza
non genera un eco eccessivo
questo processo si limita a
essere smorzato non crea
problemi. Aumentate un po’
troppo il volume, tuttavia, e il
processo aumenta in maniera
spropositata: ogni più piccolo
rumore viene registrato dal
microfono,
amplificato,
registrato
di
nuovo
e
improvvisamente ci si trova in
mezzo a fischi fastidiosissimi.
Quel che importa, in altre
parole, non è solo il processo in
sé stesso, ma la sua forza;
quello che ha colto tutti di
sorpresa era scoprire che il
volume era stato girato al
massimo.
In realtà ci sono tuttora
persone che stentano a credere
che un’economia di mercato
possa rivelarsi così instabile,
che il processo descritto
nell’illustrazione
possa
veramente essere così forte da
provocare una crisi esplosiva.
Ma in realtà accadde proprio
questo – come possiamo
dedurre dal modo con cui si è
diffusa la crisi.
Il contagio
Probabilmente c’è un buon
motivo per cui gli importanti
convegni
di
finanza
internazionale, in particolare
quelli che discutono di crisi
internazionali, hanno di solito
sede in località agresti – perché
il sistema monetario del
dopoguerra ha preso forma
presso l’Hotel Washington di
Bretton Woods o perché molti
dei ministri finanziari e dei
governatori
delle
banche
centrali si riuniscono tutte le
estati al Jackson Lake Lodge in
Wyoming. Forse l’ambiente
gradevole
aiuta
questi
personaggi importanti a lasciarsi
alle spalle le lotte quotidiane e a
concentrarsi, sebbene per breve
tempo, su temi di più ampia
portata. In ogni caso, all’inizio
dell’ottobre 1997 – quando la
crisi
asiatica
stava
già
prendendo forma, ma la sua
gravità non era ancora così
evidente – un certo numero di
banchieri,
funzionari
ed
economisti si riunirono a
Woodstock, nello stato del
Vermont, per fare il punto della
situazione.
A quell’epoca la Thailandia
era già in gravi difficoltà; anche
la valuta della vicina Malesia era
stata colpita; e la rupia
indonesiana era stata svalutata
circa del 20%. La sensazione
generale era che la Thailandia
avesse gettato la sventura su sé
stessa; e si mostrava poca
comprensione nei confronti
della Malesia, che negli ultimi
anni, al pari della Thailandia,
aveva avuto grandi deficit di
spese correnti, e il cui primo
ministro aveva peggiorato le
cose
denunciando
pubblicamente gli speculatori.
Ma tutti concordavano sul fatto
che, mentre l’Indonesia aveva
fatto bene a lasciare deprezzare
la sua valuta – in realtà la
gestione
economica
dell’Indonesia fu oggetto di più
di un apprezzamento – la
debolezza della rupia non era
assolutamente
giustificata.
Dopo tutto, il deficit di spesa
corrente sul PIL dell’Indonesia
non era mai stato neanche
paragonabile a quello dei paesi
confinanti – a meno del 4% del
PIL, il deficit dell’Indonesia era
in realtà inferiore, per esempio,
a quello dell’Australia. Le
esportazioni del paese – in parte
materie
prime,
in
parte
produzioni a elevata intensità di
lavoro – sembravano solide; e
in generale l’economia appariva
fondamentalmente sana.
Nel giro di tre mesi
l’Indonesia si sarebbe ritrovata
in condizioni ancora peggiori di
quelle del resto dell’Estremo
Oriente, ormai vicina a una delle
peggiori recessioni economiche
della storia mondiale; la crisi si
era diffusa non solo in Estremo
Oriente, ma persino in Corea
del Sud, un lontano paese il cui
PIL era due volte quello
dell’Indonesia e tre volte quello
della Thailandia.
Quasi sempre ci sono validi
motivi che spiegano il contagio
economico. Un vecchio detto
afferma che quando gli Stati
Uniti starnutiscono il Canada si
prende l’influenza; tutto ciò non
deve meravigliare, considerato
che gran parte dei beni prodotti
in Canada vengono venduti agli
Stati Uniti. Le economie
asiatiche colpite dalla crisi erano
collegate tra di loro: la
Thailandia
rappresenta
un
mercato per i prodotti malesi, e
viceversa. La situazione può
essere stata aggravata anche dal
fatto che le economie asiatiche
vendevano tutte prodotti simili:
quando la Thailandia svalutò la
sua valuta, l’abbigliamento
esportato verso l’Occidente
divenne più a buon mercato, e
di conseguenza in Indonesia si
ridussero anche i margini di
profitto di chi produceva beni
simili.
Ma tutte le analisi indicavano
che non poteva esserci stato un
solo motivo alla base del
diffondersi della crisi tra
economie in difficoltà. In
particolare la Thailandia, come
mercato di sbocco o come
concorrente,
rappresentava
veramente una cosa da nulla nei
confronti della più grande
economia della Corea del Sud.
Una più potente fonte di
contagio poteva essere stata
quella dei legami finanziari. Non
che i thailandesi fossero grandi
investitori in Corea, o che i
coreani lo fossero in Thailandia;
ma i flussi di denaro verso la
regione erano spesso stati opera
di «fondi d’investimento dei
mercati
emergenti»,
che
gestivano senza distinzione i
titoli di tutti i paesi della zona.
Quando
cominciarono
a
giungere cattive notizie dalla
Thailandia, il denaro fu ritirato
da questi fondi e, dunque, da
tutti i paesi della regione.
Ancora
più
importante,
tuttavia, era il modo con cui le
economie
asiatiche
erano
collegate tra di loro nella mente
degli investitori occidentali. La
voracità degli investitori nei
confronti della regione era stata
alimentata da un ipotetico
«miracolo asiatico»; quando si
scopriva che, dopo tutto,
l’economia di una nazione non
era così miracolosa, questa
scoperta faceva perdere la
fiducia nei confronti di tutti gli
altri paesi della regione. Magari
le persone che si riunirono a
Woodstock
consideravano
effettivamente
l’Indonesia
diversa dalla Thailandia, ma
l’investitore della strada era
mesicuro e, per premunirsi da
ogni eventuale rischio, decideva
di ritirare tutti i suoi soldi.
Ci si rese conto che, quali che
fossero le differenze tra quelle
economie, le accomunava la
tendenza a lasciarsi prendere da
un
panico
che
si
autoalimentava. Le persone che
si erano riunite a Woodstock si
sbagliavano
in
merito
all'Indonesia, e gli investitori
che si lasciavano prendere dal
panico avevano visto giusto;
non perché i primi avevano
travisato le virtù dell’Indonesia,
ma
perché
avevano
sottovalutato
la
sua
vulnerabilità. In Malesia, in
Indonesia, in Corea, come in
Thailandia, la perdita di fiducia
dei mercati diede vita a un
circolo vizioso di collasso
economico e finanziario. Non
aveva importanza che queste
economie fossero solo in parte
collegate tra di loro da flussi
commerciali. Queste economie
erano collegate tra di loro nella
mente degli investitori, che
consideravano i problemi di
un’economia asiatica come una
cattiva notizia che riguardava
anche tutte le altre; e quando
un’economia ha la tendenza a
lasciarsi prendere da un panico
che si autoalimenta, la capacità
di comprensione fa la stessa
fine.
Perché l’Asia? Perché il
1997?
Perché
l’Asia
visse
una
terribile crisi economica e
perché quest’ultima iniziò nel
1997? Forse vi state chiedendo
quali siano stati gli eventi che
hanno fatto precipitare la
situazione o, ancora meglio, vi
state domandando il motivo
della straordinaria vulnerabilità
dell’Asia.
Se insistete nel dare la colpa
dell’inizio della crisi asiatica a
qualche fatto specifico, eccovi
una lista di quelli che sono
normalmente considerati i
principali sospetti. Uno è il tasso
di cambio tra dollaro e yen: tra il
1995 e il 1997 il valore dello
yen, che era misteriosamente
arrivato a livelli stratosferici,
crollò. Dato che la maggior
parte delle valute asiatiche erano
più o meno agganciate al
dollaro, questo faceva sembrare
più care le esportazioni sia sui
mercati giapponesi sia sui
mercati
dove
queste
esportazioni
erano
in
competizione con i prodotti
giapponesi, causando così un
rallentamento dell’export. La
svalutazione della Cina del
1994,
e
l’accresciuta
competitività derivante dal
basso costo del lavoro cinese,
ebbero come effetto la riduzione
delle
esportazioni
dalla
Thailandia e dalla Malesia.
Inoltre si assisteva a quel tempo
a un calo della domanda
mondiale per l’elettronica e, in
particolare,
per
i
semiconduttori, un’area nella
quale le economie asiatiche
avevano
cercato
di
specializzarsi.
In precedenza, però, l’Asia
era riuscita a liberarsi da
difficoltà ben peggiori. Il crollo
del prezzo del petrolio nel 1985,
per esempio, rappresentò un
grande colpo per le esportazioni
di
petrolio
dall’Indonesia;
tuttavia l’economia riuscì a
crescere anche in mezzo alle
brutte notizie. La recessione del
1990-91 non fu molto forte ma
colpì comunque gran parte del
mondo industrializzato, ridusse
la domanda per le esportazioni
asiatiche, ma non rallentò
assolutamente la crescita della
regione. La vera domanda da
porsi era dunque che cosa fosse
cambiato in Asia (o, forse, nel
mondo) per far sì che queste
brutte notizie si trasformassero
in una valanga economica.
Alcuni asiatici, soprattutto il
primo
ministro
malese
Mahathir, avevano una risposta
pronta:
la
cospirazione.
Mahathir, tuttavia, affermava
non solo che il panico in Asia
era
stato
deliberatamente
orchestrato
da
operatori
finanziari come George Soros,
ma che lo stesso Soros agiva
dietro istruzioni del governo
statunitense, che voleva così
soffocare le ambizioni asiatiche.
Col passare del tempo la
demonizzazione di Mahathir nei
confronti degli hedge funds
cominciò a sembrare un po’
meno stupida di quanto non
apparisse all'inizio. In realtà il
ruolo degli hedge funds sembra
ora sufficientemente importante
da dedicare a questo tema un
intero capitolo del presente libro
(il capitolo 6). Ma questo ruolo
divenne rilevante soprattutto nel
1998 (proprio il momento in
cui, casualmente, le attività di
Soros e degli altri furono molto
in contrasto con la politica
statunitense); dunque la teoria
della cospirazione non riesce a
spiegare il motivo per cui la crisi
ebbe inizio.
D’altro
canto
molti
occidentali hanno raccontato la
storia del crollo asiatico come
una favola a sfondo morale,
secondo la quale le economie
hanno ricevuto la giusta
punizione per i peccati di
nepotismo
compiuti
in
precedenza. Dopo la catastrofe
ognuno tirava fuori la sua storia
sugli eccessi e la corruzione
della regione – sulle società
finanziarie, sui grandiosi piani
della Malesia per un «corridoio
tecnologico», sulle fortune
accumulate
dalla
famiglia
Suharto,
sulla
bizzarra
diversificazione
delle
conglomerate
coreane
(la
sapevate quella del produttore
d’abbigliamento intimo che
aveva
comprato
un
comprensorio sciistico che a sua
volta avrebbe dovuto essere
rivenduto a Michael Jackson?).
Ma questo tentativo di buttarla
sulla morale offre più di uno
spunto problematico.
Prima di tutto, mentre il
nepotismo e la corruzione erano
fenomeni indubbiamente reali
in Asia, non rappresentavano
certamente qualcosa di nuovo. I
chaebol della Corea erano in
pratica delle società familiari
mascherate
da
aziende
moderne, i cui proprietari
avevano il privilegio di ricevere
un trattamento particolare –
accesso preferenziale al credito,
alle licenze d’importazione, ai
sussidi governativi – per anni e
anni. E furono anni di crescita
economica spettacolare. Non si
trattava di un buon sistema
secondo
gli
standard
occidentali; ma funzionò bene
per trentacinque anni. Lo stesso
si può dire, su scala ridotta, per
tutti i paesi che furono coinvolti
nella crisi. Perché i loro limiti
divennero
improvvisamente
visibili solo nel 1997?
Inoltre, se la crisi era una
punizione per i peccati delle
economie asiatiche, per quale
motivo economie che avevano
raggiunto diversi livelli di
sviluppo
crollarono
tutte
insieme? Nel 1997 la Corea
poteva quasi essere considerata
una nazione sviluppata, con un
reddito pro capite paragonabile
a quello dei paesi dell’Europa
del sud, mentre l’Indonesia era
ancora un paese molto povero,
dove il progresso poteva essere
misurato in quante calorie la
gente riusciva a consumare al
giorno. Come è stato possibile
che una coppia di paesi così
diversi
entrasse
in
crisi
contemporaneamente?
L’unica risposta che ha un
qualche senso, almeno per me,
è che la crisi non fosse (o, per lo
meno, non lo fosse del tutto)
una punizione per i peccati
commessi
in
precedenza.
Queste economie avevano
effettivamente commesso degli
errori, ma il principale limite
restava la tendenza a vivere
momenti di panico che si
autoalimentavano.
Torniamo alle corse agli
sportelli: nel 1931 circa la metà
delle banche degli Stati Uniti
fallirono. Queste banche non
erano tutte uguali. Alcune erano
gestite molto male; alcune
avevano
affrontato
rischi
eccessivi, anche alla luce di
quello che sapevano prima del
1929; altre ancora erano ben
gestite, sebbene in maniera
piuttosto conservatrice. Ma
quando il panico si diffuse nella
nazione e i risparmiatori
cominciarono dappertutto a
chiedere
immediatamente
indietro il loro denaro, niente di
tutto
questo
ebbe
più
importanza: sopravvissero solo
le banche che erano state
estremamente conservatrici, che
avevano mantenuto in contanti
una percentuale di depositi che
in tempi normali sarebbe stata
considerata eccessiva. Allo
stesso
modo
l’economia
thailandese era stata gestita
molto male, aveva chiesto in
prestito troppo denaro e aveva
investito in progetti ben poco
trasparenti; l’Indonesia, a causa
di tutta la sua corruzione, era
molto meno colpevole e
possedeva veramente le virtù
che le persone di Woodstock
avevano immaginato; ma in
presenza del panico queste
distinzioni non avevano più
importanza.
Le economie asiatiche erano
più vulnerabili al panico
finanziario nel 1997 di quanto
non lo fossero state cinque o
dieci anni prima? Sicuramente
sì – ma non a causa del
nepotismo o di quella che
generalmente viene considerata
una cattiva gestione statale.
Erano invece diventate più
vulnerabili, perché si erano
aperte ai mercati finanziari –
erano infatti diventate economie
più libere –, e perché si erano
avvantaggiate della popolarità
acquisita presso gli operatori
internazionali
e
l’avevano
utilizzata per contrarre ingenti
debiti nei confronti del mondo
esterno.
Questi
debiti
rafforzarono il legame tra
perdita di fiducia, collasso
finanziario e così via, rendendo
ancora più radicato il circolo
vizioso che caratterizzava la
crisi. Il problema non era che il
denaro fosse speso malamente;
in qualche caso lo era, in
qualche caso no. In realtà i
nuovi debiti, al contrario di
quelli vecchi, erano in dollari – e
proprio questo si rivelò essere il
motivo che portò l’economia
alla rovina.
Epilogo: Argentina, 2002
L’Argentina non è un paese
asiatico. (Ma guarda un po’!)
Eppure, nel 2002 ha vissuto una
crisi di tipo asiatico, che ha dato
una
dimostrazione
dolorosamente chiara di come
certe politiche economiche
ultraelogiate possano condurre
un paese al disastro.
Ho riassunto brevemente la
storia monetaria dell’Argentina
nel capitolo 2. Dopo anni e anni
di uso irresponsabile e di abuso
della stampa di nuova moneta,
nel 1991 il governo argentino
tentò di mettere fine a tutto ciò
adottando un currency board
(regime legale di cambio fisso,
n.d.t.) che avrebbe dovuto
fungere
da
raccordo
permanente tra il peso argentino
e il dollaro usa. A ogni peso in
circolazione
doveva
corrispondere un dollaro di
riserve monetarie, senza alcuno
spazio di discrezionalità. E
questa stabilità monetaria, si
sperava, avrebbe assicurato una
prosperità protratta nel tempo.
Come abbiamo visto in
precedenza, l’Argentina era
andata molto vicino al disastro
nel 1995, quando l’onda di
ritorno della crisi messicana fu lì
lì per abbattere il sistema
bancario. Ma con l’attenuarsi
della crisi è tornata la fiducia.
Gli
osservatori
stranieri
continuavano
a
elogiare
sperticatamente
l’economia
argentina e i suoi gestori, e i
capitali esteri tornavano ad
affluire, prevalentemente sotto
forma di prestiti in dollari, a
imprese ai cittadini argentini.
Ma alla fine degli anni
Novanta, tutto cominciò ad
andare per il verso sbagliato.
All’inizio, il problema era la
rigidità del sistema dei tassi di
cambio, che eguagliava il peso
al dollaro. Non sarebbe stato un
grosso problema se l’Argentina,
come il Messico, avesse avuto
un elevatissimo interscambio
commerciale con gli Stati Uniti.
Ma basta guardare la cartina
geografica: l’Argentina non è
più vicina agli Stati Uniti che
all’Europa, e in effetti ha più
interscambio commerciale con
l’Europa c con il vicino Brasile
che con gli Stati Uniti. E il
sistema valutario dell’Argentina
non garantiva tassi di cambio
stabili né rispetto all’euro, né
rispetto al real, la moneta del
Brasile. Tendeva, all’opposto, a
causare fluttuazioni immotivate
in questi tassi di cambio, e
quindi
nella
posizione
commerciale dell’Argentina. Se,
per esempio, il dollaro si fosse
apprezzato
sull’euro,
per
qualunque ragione, l’effetto
sarebbe stato di mettere le
esportazioni argentine fuori
mercato per i compratori
europei.
Ed è esattamente quello che è
accaduto all’Argentina a partire
dai primi anni Novanta. Da una
parte, il dollaro si apprezzò
moltissimo sull’euro – a un
certo punto il dollaro valeva
appena 0,85 dollari, contro 1,26
al momento in cui scrivo.
Dall’altra il Brasile, contagiato
dalla crisi finanziaria della
Russia (vedi capitolo 6), svalutò
pesantemente il real. L’effetto
combinato di queste variazioni
nei tassi di cambio fu quello di
togliere
competitività
alle
esportazioni
argentine,
spingendo il paese in una
recessione.
Con il tracollo dell’economia
argentina, gli investitori esteri
persero fiducia. Il flusso dei
capitali diretti nel paese si
invertì, creando una strozzatura
nel credito. E come era
accaduto nel 1995, il venir meno
dei fondi esteri causò anche una
crisi bancaria.
Il governo argentino tentò
disperatamente di arginare la
crisi che si acuiva di giorno in
giorno. Ridusse la spesa
pubblica
aggravando
la
recessione, nella speranza di
riconquistare la fiducia degli
investitori esteri. Limitò i
prelievi bancari, una misura che
provocò tumulti davanti al
palazzo
presidenziale
(ricorderete la scena delle
massaie
che
sbattevano
rumorosamente
pentole
e
pentolini). Sembrava che non
funzionasse più niente. E alla
fine del 2001 il governo si
ritrovò nell’impossibilità di
mantenere la parità tra dollaro e
peso. Il valore del peso
argentino crollò nel giro di
pochi giorni da un dollaro a
circa trenta centesimi.
I risultati iniziali della crisi
valutaria furono catastrofici,
proprio come era avvenuto in
Asia. Poiché molte imprese e
molti cittadini argentini si erano
indebitati
in
dollari,
il
deprezzamento del peso rispetto
alla divisa americana ebbe un
effetto devastante sui bilanci,
portando in molti casi al
fallimento.
L’economia
si
bloccò: il PIL reale diminuì
dell'11% nel 2002, dopo essere
sceso del 4% nel 2001.
Complessivamente, l’economia
argentina fece registrare tra il
1998 e il 2002 una contrazione
del 18%, degna della Grande
Depressione.
Nei cinque anni successivi,
l’Argentina ha avuto un grosso
recupero, anche grazie a un
accordo che consentiva al suo
governo di rimborsare solo una
trentina di cent per ogni dollaro
di debito estero. (Uno dei titoli
che ho trovato più brillanti in
assoluto era quello di un
rapporto della Reuters sulla
rinegoziazione
del
debito:
«L’Argentina ai creditori: e
adesso fateci causa»). Ma è
stata un’esperienza terrificante.
E mentre questo libro andava in
stampa,
l’Argentina
era
nuovamente in crisi.
La domanda più
importante
La maggior parte dei
commentatori della crisi asiatica
avrebbe facilmente da ridire
sulla tesi di questo capitolo.
Alcuni potrebbero affermare
che il danno causato da prestiti
troppo rischiosi era maggiore di
quanto ritengo io; altri ancora
potrebbero
sostenere,
al
contrario, che le economie
stavano vivendo una fase
positiva e che la crisi era giunta
del
tutto
inaspettata.
Il
meccanismo della crisi – i ruoli
giocati dai fallimenti delle
banche, dai prezzi immobiliari,
dai tassi di cambio, dai tassi
d’interesse e così via – sarà,
forse per molti anni, oggetto di
grandi discussioni. Nonostante
tutto, credo che questa tesi
possa meritare una certa
accoglienza.
Il
punto
realmente
controverso – quello su cui ci si
scalda di più, perché chi critica
il modo in cui fu gestita la crisi
critica anche quelli che l’hanno
gestita – è politico. Perché i
governi non sono riusciti a fare
di più per limitare i danni?
5. PERVERSIONE
POLITICA
Nel dicembre del 1930, non
appena fu evidente che la
recessione in atto non era
ordinaria,
John
Maynard
Keynes cercò di spiegare
all’opinione pubblica quanto
stava avvenendo. «Abbiamo dei
problemi
al
motorino
d’avviamento», dichiarò. Si
trattava, in un certo senso, di
un’affermazione degna di un
radicale,
perché
quanto
dichiarato equivaleva a dire che
il motore economico non
sarebbe ripartito da solo, ma
aveva bisogno di una spinta da
parte del governo. In realtà
Keynes si era comportato da
conservatore: aveva affermato
che il problema del motore non
era così grave e che si poteva
risolvere
con
alcuni
accorgimenti tecnici. In un
momento in cui nel mondo la
maggior parte degli intellettuali
era convinta che il capitalismo
fosse destinato al fallimento,
che
solo
passando
a
un’economia
pianificata
centralmente
l’Occidente
avrebbe potuto uscire dalla
Grande Depressione, Keynes
aveva invece detto che il
capitalismo non era spacciato,
che bastavano alcuni piccoli
interventi – conservando la
proprietà privata e la capacità
decisionale dei privati – per far
funzionare il sistema.
In effetti, alla faccia degli
scettici,
il
capitalismo
sopravvisse, ma, anche se chi
oggi si dichiara entusiasta del
libero mercato fa fatica ad
ammetterlo, la sopravvivenza la
si deve in gran parte ai
suggerimenti di Keynes. La
Seconda guerra mondiale offrì
l’occasione che Keynes stava
aspettando da anni; ma il libero
mercato sopravvisse non solo
perché si riuscì a uscire dalla
depressione, ma anche perché ci
si convinse che le politiche
macroeconomiche – tagliare i
tassi d’interesse o aumentare il
deficit statale per combattere le
recessioni
–
potevano
mantenere più o meno stabile
un'economia di libero mercato
in presenza di un tasso di quasi
completa occupazione. In effetti
il capitalismo e i suoi
economisti avevano stretto una
sorta di patto con l’opinione
pubblica: d’ora in poi il libero
mercato non ci creerà più
problemi,
perché
ormai
sappiamo abbastanza cose per
evitarci
ulteriori
Grandi
Depressioni.
Questo implicito accordo ha
anche un nome: negli anni
Cinquanta Paul Samuelson, in
un suo famoso libro, la chiamò
«sintesi
neoclassica».
Io
preferisco chiamarla «sintesi
keynesiana».
Negli Stati Uniti e in molti
altri paesi industrializzati questa
sintesi viene ancora oggi
apprezzata. È vero, ci sono
ancora recessioni qua e là.
Tuttavia, quando queste ultime
prendono forma, tutti si
aspettano che la Federal
Reserve faccia quello che ha
fatto nel 1975, nel 1982 e nel
1991: tagliare i tassi d’interesse
per
far
riprendere
fiato
all’economia. Ci aspettiamo
anche che il Presidente e il
Congresso,
se
necessario,
taglino le tasse e aumentino la
spesa per incentivare questo
processo. Sicuramente non ci
aspettiamo che una recessione
possa essere gestita, come fece
Herbert Hoover, aumentando le
tasse, diminuendo la spesa e
aumentando i tassi d’interesse.
Ma quando il disastro
finanziario colpì l’Asia, le
politiche con cui risposero
questi paesi furono quasi
l’opposto di quelle adottate
dagli Stati Uniti per fronteggiare
la recessione. L’austerità fiscale
era all’ordine del giorno, si
aumentarono i tassi d’interesse,
spesso a livelli assolutamente
punitivi. Tutto ciò non avveniva
perché i politici di questi paesi
fossero
stupidi
o
male
informati. Al contrario, la
maggior parte di loro conosceva
molto
bene
la
sintesi
keynesiana, al punto che nel
passato avevano anche cercato
di aderire a questo filone di
pensiero (ricordate l’elogio della
Banca Mondiale per la loro
«ortodossia pragmatica»). In
ogni caso, una volta che la crisi
aveva fatto la sua comparsa, le
politiche dei paesi asiatici
furono in gran parte dettate da
Washington – vale a dire dal
Fondo
Monetario
Internazionale e dal segretario al
Tesoro statunitense. E alla testa
di queste istituzioni c’erano
persone molto preparate: si
potrebbe dire che mai nella
storia così tanti economisti di
primo piano hanno ricoperto
cariche così elevate.
Ma allora come mai persone
tanto intelligenti hanno potuto
consigliare a economie di
mercato
emergenti
delle
politiche
assolutamente
perverse alla luce della dottrina
economica tradizionale? (Se gli
Stati Uniti avessero aumentato
le imposte e i tassi d’interesse di
fronte a una recessione, anche
noi avremmo subito un tracollo
economico.) In breve la risposta
è: «per la paura degli
speculatori».
Ma
questa
sintetica risposta ha senso solo
se inserita in un certo contesto –
più precisamente se dedichiamo
un po’ di tempo a capire i
problemi del sistema monetario
internazionale.
La mancata evoluzione del
sistema monetario
internazionale
Una volta il mondo aveva
una sola valuta, il «globo». Era
ben gestita: la Global Reserve
Bank
(chiamata
amichevolmente Glob), sotto la
direzione di Alan Globspan,
fece un lavoro ragionevolmente
buono aumentando l’offerta di
moneta globale quando il
mondo minacciava di cadere in
recessione, e stabilizzando
l’offerta quando cominciavano
a esserci avvisaglie di inflazione.
In seguito, alcuni si sarebbero
ricordati del regno del globo
come di un’età dell’oro.
Soprattutto gli uomini d’affari
apprezzavano questo sistema
perché potevano comprare e
vendere dappertutto con poche
difficoltà.
Tuttavia in questo paradiso
c’era un problema. Sebbene
un’attenta gestione del «globo»
riuscisse a evitare al mondo nel
suo complesso di restare in balìa
di alti e bassi, lo stesso non si
poteva dire per ogni singolo
pezzo del puzzle. Spesso
c’erano addirittura conflitti
d’interesse riguardo alla politica
monetaria. Qualche volta la
Glob avrebbe allentato la sua
politica
monetaria
perché
l’Europa e l’Asia erano sull’orlo
di una recessione; ma questa
massa di denaro avrebbe
innestato un boom speculativo
in Nord America. In altri
momenti la Glob si sarebbe
sentita obbligata a limitare
l’offerta di moneta per arrestare
l’inflazione in Nord America,
intensificando
così
una
recessione in corso in Sud
America. E poiché non c’erano
singole
valute
per
ogni
continente,
i
governi
continentali non potevano fare
niente a questo riguardo.
In seguito la frustrazione
aumentò e il sistema entrò in
crisi. Al posto del «globo» ogni
continente introdusse una sua
propria valuta e cominciò a
studiare politiche economiche
adatte alle proprie necessità.
Quando l’economia europea era
in fase espansiva, si poteva
ridurre l’offerta di euro; quando
l’America Latina entrava in
recessione si poteva aumentare
l’offerta di «latino». L’idea che
una sola politica monetaria
potesse servire a tutti gli scopi
non era più valida.
Tuttavia si scoprì presto che,
dopo aver risolto un problema
se ne presentava un altro,
perché i tassi di cambio tra
valute continentali presentavano
ampie fluttuazioni. Per esempio
si poteva pensare che il tasso di
cambio tra l’euro e il «latino»
sarebbe stato influenzato dal
mercato: dai latinoamericani che
scambiavano la loro valuta in
euro, così da poter comprare
prodotti europei, e viceversa.
Diventò presto chiaro, però, che
il mercato era dominato dagli
investitori
–
gente
che
comprava e vendeva valute per
comprare azioni e obbligazioni.
E, visto che la domanda per
questi investimenti era molto
mutevole, e spesso anche molto
speculativa, il valore delle valute
si dimostrò altrettanto instabile.
Infine anche la gente comune
cominciò a speculare sul valore
delle valute. Il risultato fu quello
di rendere discontinui gli
andamenti dei tassi di cambio,
creando
così
un
clima
d’incertezza per le aziende, che
non potevano mai essere sicure
di quanto valessero le azioni e le
obbligazioni che detenevano sui
mercati esteri.
Di
conseguenza,
alcuni
continenti
cercarono
di
stabilizzare i tassi di cambio –
comprando e vendendo sul
mercato internazionale così da
mantenere costante il valore
dell’euro espresso in «afros», o
del «gringo» espresso in
«latino». Tuttavia le banche
centrali si riservarono il diritto,
se necessario, di modificare il
tasso di cambio che si erano
poste come obiettivo – per
esempio svalutando la propria
valuta se si voleva ridurre la
disoccupazione.
Purtroppo si scoprì che
questo sistema offriva agli
speculatori bersagli troppo
facili: quando un continente
aveva difficoltà economiche e si
pensava che stesse preparando
una svalutazione, gli speculatori
cominciavano a vendere in
anticipo la valuta; questo
costringeva le banche centrali
del continente o ad alzare i tassi
d’interesse, peggiorando così la
situazione, oppure a svalutare
immediatamente. L’alternativa –
l’ultima a disposizione – era
quella
di
combattere
direttamente gli speculatori,
ponendo vincoli ai movimenti
di capitale.
Di conseguenza i continenti
del mondo furono costretti a
scegliere uno dei tre «regimi
valutari», ognuno dei quali
aveva un
grosso
limite.
Potevano scegliere di mantenere
una
politica
monetaria
indipendente, e lasciare dunque
fluttuare indisturbato il tasso di
cambio; questo li lasciava liberi
di combattere la recessione, ma
introduceva un fastidioso clima
di incertezza nel mercato.
Potevano fissare un valore del
tasso di cambio e cercare di
convincere i mercati che non
avrebbero mai svalutato; tutto
ciò avrebbe reso più semplici e
sicure le trattative sui mercati,
ma avrebbe riportato a galla il
problema di una sola politica
economica in grado di risolvere
tutti i problemi. In alternativa,
potevano
continuare
a
mantenere un sistema flessibile,
vale a dire fissare un tasso di
cambio
ma riservarsi la
possibilità
di
modificarlo;
questa soluzione era però
attuabile
solo
se
si
controllavano i movimenti di
capitale, un’operazione difficile
nella pratica oltre che molto
onerosa, e che – come ogni
altro divieto su transazioni
potenzialmente redditizie –
rappresentava una grande fonte
di corruzione.
D’accordo, d’accordo, non è
andata proprio così. Non è mai
esistito il «globo»; la cosa che
gli si è avvicinata di più è stato
lo standard aureo degli anni
antecedenti il 1930, che
fortunatamente
non
fu
concepito per evitare gli alti e i
bassi dell’economia mondiale.
Ma la nostra storia immaginaria
serve a chiarire un po’ meglio la
complessità del dilemma a tre
punte, o «trilemma», che le
economie nazionali si sono
successivamente trovate di
fronte nel sistema economico
globale.
Proviamo a immaginarla così.
Ci sono tre cose che chi si
occupa di macroeconomia
desidera per il proprio sistema
economico. La prima è la
discrezionalità nella politica
monetaria, così da poter
combattere le recessioni e
ridurre l’inflazione. La seconda
è tassi di cambio stabili, così
che i mercati possano operare in
un clima contraddistinto da una
non eccessiva incertezza. La
terza, infine, è la liberalizzazione
degli scambi internazionali – in
particolare lasciare alla gente la
possibilità di scambiare le valute
a loro piacimento.
Quello che ci insegna la storia
del «globo» è che le nazioni non
possono
raggiungere
contemporaneamente tutti e tre
questi obiettivi; al massimo
possono raggiungerne due.
Possono
abbandonare
la
stabilità del tasso di cambio, il
che significa adottare un tasso
di cambio variabile, come
hanno fatto gli Stati Uniti o
l’Australia.
Possono
abbandonare
la
politica
monetaria discrezionale, il che
significa fissare un tasso di
cambio stabile, così come ha
fatto l’Argentina negli anni
Novanta, e arrivare persino a
dire addio alla propria valuta,
così come hanno fatto i paesi
dell’Europa
continentale.
Oppure possono abbandonare il
principio della libertà di mercato
e imporre controlli sui capitali; è
quello che hanno fatto molti
paesi tra gli anni Quaranta e gli
anni Sessanta, ed è quello che la
Cina sta facendo oggi.
Quale tra queste tre risposte
imperfette è la migliore? Ci
sono persone che pensano che i
benefici derivanti da tassi di
cambio stabili siano parecchi, e
che i benefici di una politica
monetaria indipendente siano
sopravvalutati.
A
queste
persone piace puntualizzare che
gli Stati Uniti, sebbene coprano
quasi un intero continente, se la
cavano molto bene con una sola
valuta; circa 300 milioni di
europei hanno da poco adottato
una valuta comune; quindi
perché non fare lo stesso
prendendo a riferimento tutto il
mondo?
Molti economisti
faranno però notare che gli Stati
Uniti hanno caratteristiche
molto particolari, che facilitano
l’adozione di una sola valuta: i
lavoratori si spostano più
velocemente
da
regioni
depresse a regioni più ricche,
così che un’unica politica
monetaria riesce, bene o male, a
gestire il tutto. L’introduzione
dell’euro, la nuova valuta
europea, rappresenta in realtà
una
decisione
piuttosto
controversa, e molti economisti
si chiedono se l’Europa è
abbastanza simile agli Stati Uniti
per adottare un’unica valuta. In
realtà almeno le principali
economie
europee
sono
sufficientemente simili l’una
all’altra, e collegate tra di loro in
maniera abbastanza forte, così il
più delle volte una politica che
risulta giusta per la Francia lo è
anche per la Germania, e
viceversa. Tuttavia è difficile
immaginare
una
politica
monetaria che risulti adatta sia
al Giappone sia agli Stati Uniti,
se non addirittura all’Argentina
e
agli Stati Uniti.
Di
conseguenza,
solo
pochi
economisti
hanno
ancora
nostalgia per l’epoca dello
standard aureo, o immaginano
di poter introdurre il «globo»;
l’indipendenza
monetaria
nazionale, o addirittura quella
regionale, viene considerata
tuttora
un
requisito
indispensabile.
D’altro canto i controlli sul
capitale che, nell’immediato
dopoguerra, hanno permesso
alle economie industrializzate di
combinare tassi di cambio fissi
a politiche keynesiane, oggi non
sono più di moda. Il problema
fondamentale a proposito dei
controlli è quello di saper
distinguere
tra
transazioni
internazionali
«buone»
e
«cattive». Uno speculatore che
ritira il suo denaro dalla Malesia
perché vuole approfittare della
svalutazione agisce contro gli
interessi della società; un
esportatore malese che si
conquista i clienti esteri
permettendo a questi ultimi di
dilazionare i pagamenti per la
merce acquistata, sta aiutando il
proprio paese a farsi strada
nell’economia mondiale. Ma
immaginiamo che l’esportatore,
sospettando che il ringgit venga
presto svalutato, chieda ai
propri clienti di pagare in dollari
e li incoraggi a far passare un
lungo periodo di tempo prima
di saldare i conti. L’effetto è lo
stesso di quello raggiunto
acquistando
dollari
dietro
pagamento di ringgit sul
mercato nero. Ci sono molti
altri modi con i quali si può
spostare il confine tra attività
economiche
produttive
e
speculazioni
valutarie.
La
conseguenza è che tutti i
tentativi volti a controllare la
speculazione possono essere
facilmente raggirati e che il
governo può limitare la
speculazione solo imponendo
onerosi vincoli alle transazioni
ordinarie (per esempio, limitare
il credito che gli esportatori
possono concedere ai loro
clienti). Cinquant’anni fa la
maggior parte dei governi
credeva che questi vincoli
avessero un prezzo che valeva
la pena di pagare. Oggi viviamo
invece in un mondo che ha
riscoperto le virtù del libero
mercato, nutre sospetti riguardo
a ogni possibile intervento dello
stato, ed è particolarmente
cosciente che più cose si
proibiscono, maggiori sono le
occasioni che si sviluppino
forme
di
corruzione
e
nepotismo.
Tutto ciò conduce ai tassi di
cambio liberi di fluttuare che, a
partire dalla metà degli anni
Novanta, la maggior parie degli
economisti ha cominciato a
considerare il minore dei tre
mali. È vero, i tassi di cambio,
considerata
la
situazione
economica generale, si sono
ripetutamente
rivelati
più
variabili di quanto avrebbero
dovuto (negli ultimi cinque anni
il tasso dollaro-yen è passato da
120 a 80, a quasi 150, per poi
tornare sotto i 110, il tutto in
assenza di cambiamenti di
rilievo
nei
fondamentali
economici); e anche coloro che
optano per la libera oscillazione
concordano che le regioni più
integrate al loro interno, quelle
che
costituiscono
«aree
valutarie ottimali», dovrebbero
adottare la forma più evoluta di
tasso di cambio fisso, la valuta
comune. (Il fatto che l’Europa
rappresenti davvero un’area di
questo tipo è tutto un altro
discorso.) Ma, in linea di
massima l’alternativa preferita
da molti economisti – quella più
coerente
con
la
sintesi
keynesiana, perché lascia liberi i
paesi di adottare sia politiche di
libero mercato sia di piena
occupazione – è rappresentata
dal tasso di cambio libero di
fluttuare.
Le virtù di un tale sistema,
quando funziona, non sono
difficili da dimostrare. Gli Stati
Uniti traggono giovamento dal
fatto che il cambio del dollaro
sui mercati esteri sia lasciato
libero di oscillare; mentre i tassi
dollaro-yen
e dollaro-euro
possono subire preoccupanti
andamenti
a
spirale,
la
preoccupazione
passa
sicuramente in secondo piano
rispetto alla libertà d’azione che
la mancanza di un preciso
obiettivo di tasso di cambio
offre alla Federal Reserve –
l’abilità
di
tagliare
immediatamente e velocemente
i tassi d’interesse quando si
avvicina una recessione o una
crisi valutaria.
Ancora meglio, consideriamo
l’esempio dell’Australia durante
la crisi asiatica. Nel 1996 un
dollaro australiano valeva circa
80 centesimi di dollaro USA.
Nell’estate del 1998 questo
valore era sceso a poco meno di
60 centesimi di dollaro USA. La
cosa
non
dovrebbe
meravigliare: gran parte delle
esportazioni australiane vanno
in Giappone o verso le «tigri» in
difficoltà.
Ma
l’Australia,
eccetto che durante l’estate del
1998, quando sembrava oggetto
di un attacco coordinato da
parte degli hedge funds (ne
parlerò più diffusamente nel
prossimo capitolo), non cercò di
stimolare la propria valuta, o
acquistandola
sui
mercati
internazionali o aumentando i
tassi d’interesse. Al contrario, il
deprezzamento della valuta non
andò oltre una certa soglia;
quando cadde il dollaro
australiano,
gli
investitori
considerarono la cosa come
un’opportunità per investire a
buon mercato in un’economia
che continuavano a considerare
solida. E questa fiducia era
giustificata
dal
«miracolo
australiano»: negli ultimi anni,
nonostante la dipendenza dai
mercati asiatici, l’Australia ha in
realtà vissuto un momento di
grande sviluppo in coincidenza
con la crisi asiatica.
Ma se l’Australia è riuscita
così facilmente a evitare di
restare
intrappolata
dalla
catastrofe economica dei suoi
vicini, perché non sono riusciti a
fare altrettanto l’Indonesia o la
Corea del Sud?
La minaccia speculativa
Immaginatevi un sistema
economico imperfetto. (Quale
sistema economico è perfetto?)
Magari il governo ha un deficit
di bilancio che, anche se non
rappresenta una minaccia per la
liquidità, si sta riducendo più
lentamente di quanto dovrebbe,
o magari le banche con le quali
ha stretto collegamenti politici
hanno concesso troppi prestiti a
persone non molto affidabili.
Ma, per quanto si possa
affermare dando un’occhiata ai
soli numeri, non esistono
problemi che non possano
essere affrontati con la buona
volontà e attraversando un certo
periodo di stabilità.
In seguito, per un qualche
motivo – forse una crisi
economica sull’altra faccia del
pianeta
–
gli investitori
cominciano a innervosirsi e
ritirano in massa il denaro.
Improvvisamente il paese è in
difficoltà, il suo mercato
azionario crolla, i suoi tassi
d’interesse
aumentano.
Si
potrebbe pensare che gli
investitori più saggi considerino
questo momento quello giusto
per acquistare. Dopo tutto, se la
situazione economica non è
cambiata, non vuole forse dire
che le azioni sono ora
sottovalutate?
Ma,
come
abbiamo visto nel capitolo 4, la
risposta
è
«non
necessariamente». Il crollo del
valore degli asset può portare al
collasso di banche che in
precedenza erano considerate
sane; la recessione economica,
gli elevati tassi d’interesse, e un
tasso di cambio svalutato
possono portare alla bancarotta
società sane; peggio ancora, le
difficoltà economiche possono
portare
instabilità
politica.
Probabilmente
comprare
proprio quando tutti stanno
cercando il modo più veloce per
uscire, non rappresenta dopo
tutto un’idea così buona; forse
è meglio seguire gli altri e
affrettarsi all’uscita.
In linea di principio, quindi, è
possibile che la perdita di
fiducia nei confronti di un paese
produca una crisi economica in
grado di giustificare la perdita di
fiducia – che i paesi siano
oggetto di quelli che gli
economisti chiamano «attacchi
speculativi
che
si
autoalimentano». Mentre molti
economisti
si
mostravano
scettici riguardo all’importanza
di queste crisi che si
autoalimentano,
l’esperienza
degli anni Novanta in America
Latina
e
in
Asia
ha
definitivamente risolto questi
dubbi, per lo meno dal punto di
vista pratico.
La cosa buffa è che, una volta
presa in seria considerazione
l’eventualità di una crisi che si
autoalimenta, la psicologia del
mercato diventa un fattore
cruciale – talmente importante
che, entro certi limiti, le
aspettative e i pregiudizi degli
investitori entrano a far parte
della situazione economica
generale – perché credere in
qualcosa equivale a renderla
reale.
Immaginate, per esempio,
che tutti siano convinti che
l’Australia,
nonostante
la
dipendenza
dal
capitale
straniero (per decenni ha
accumulato notevoli deficit di
spese correnti, più del 4% del
prodotto interno lordo), sia un
paese fondamentalmente solido,
dal quale ci si può aspettare
stabilità politica ed economica.
La risposta del mercato a un
declino del dollaro australiano
potrebbe dunque essere: «Bene,
è finita, compriamo prodotti
australiani»,
e
l’economia
trarrebbe giovamento da questa
reazione. La buona immagine
del mercato verrebbe di
conseguenza confermata.
Immaginiamo per contro che,
nonostante
vent’anni
di
continuo progresso, la gente
non sia ancora convinta che
l’Indonesia non è più il paese di
Un
anno
vissuto
pericolosamente.
Di
conseguenza, se la rupia
dovesse cadere la gente
potrebbe affermare: «Mio Dio,
stanno tornando i brutti
momenti di una volta»; la
conseguente fuga di capitali
porterebbe
a
una
crisi
finanziaria, economica e politica
e la cattiva immagine del
mercato subirebbe così una
conferma.
In altre parole sembra che la
sintesi keynesiana sia una
soluzione
temporanea.
L’opinione degli economisti che
la miglior soluzione al trilemma
monetario internazionale, anche
se imperfetta, sia quella dei tassi
d’interesse fluttuanti, si basa
sull’esperienza di paesi quali il
Canada, l’Inghilterra e gli Stati
Uniti. Ma negli anni Novanta un
paese del Terzo Mondo dopo
l’altro – il Messico, la
Thailandia,
l’Indonesia,
la
Corea – hanno scoperto di
essere soggetti a regole diverse.
Sempre più spesso i tentativi di
gestire piccole svalutazioni
hanno portato a un improvviso
crollo di fiducia. È proprio
questo problema di fiducia che
può spiegare perché la sintesi
keynesiana sia andata in mille
pezzi.
La fiducia in gioco
Nell’estate del 1998 il Brasile
stava ancora vivendo una
recessione
economica;
la
disoccupazione
stava
aumentando,
mentre
all’inflazione – il tradizionale
problema del Brasile – era
seguita una maggiore stabilità
dei
prezzi,
e
alcuni
cominciavano addirittura a
parlare di deflazione. Poi il
fallimento
della
riforma
economica in Russia provocò
un attacco al real brasiliano (per
quale motivo? Vedi capitolo 6) e
il paese andò a chiedere aiuto
agli Stati Uniti e al Fondo
Monetario Internazionale. Il
Brasile voleva sia denaro –
disponeva ancora di 40 miliardi
di dollari di riserve in valuta
estera, ma chiedeva in appoggio
l’apertura di una linea di credito
– sia, ancora di più, una sorta di
certificato di buona condotta
sulle sue politiche, che potesse
servire
a
convincere
gli
investitori a interrompere la
fuga di capitali. Prometteva in
cambio
di
adottare
un
programma di «stabilizzazione»
dell’economia.
Quindi in che cosa consisteva
il programma – studiato,
ricordate bene, per un paese con
un’economia in fase recessiva e
un basso tasso d’inflazione?
Tasse più elevate, una minore
spesa
pubblica
e
il
mantenimento
di
tassi
d’interesse estremamente alti (il
Brasile aveva aumentato i tassi
di circa il 50% quando era
iniziata la crisi). In altre parole il
governo brasiliano implementò
una politica monetaria e fiscale
estremamente
rigida,
che
avrebbe portato il paese
all’orribile
momento
di
recessione del 1999.
Il programma predisposto per
il Brasile era veramente
eccessivo; rappresentava quasi
una caricatura delle politiche
decise
in
Asia
l’anno
precedente. Ma, come le
caricature, enfatizzava molte
delle caratteristiche peculiari di
queste politiche. Al cuore delle
politiche
imposte
da
Washington a tanti dei paesi in
crisi, c’è una versione quasi
opposta
della
sintesi
keynesiana: in presenza di una
crisi economica si chiedeva ai
paesi di aumentare i tassi
d’interesse, diminuire la spesa e
aumentare le tasse.
Per
quale
motivo,
sessant’anni dopo Keynes,
qualcuno avrebbe mai potuto
pensare che fosse una buona
idea ignorare completamente gli
insegnamenti
della
sintesi
keynesiana? La risposta sta nel
doppio standard e nel bisogno
di ottenere a tutti i costi la
fiducia del mercato.
Prima di tutto si scartò la
soluzione australiana – lasciare
che la valuta perdesse valore. Il
tasso di cambio fisso tra il real
brasiliano e il dollaro era stato il
fulcro del programma di riforma
del paese, che aveva portato la
stabilità dei prezzi dopo un
periodo di elevata inflazione.
Sia il Brasile sia Washington
temevano che abbandonare il
tasso fisso avrebbe colpito la
fiducia degli investitori. È vero,
si sarebbe anche potuto pensare
che il real era, per esempio,
sopravvalutato del 20% e che
una svalutazione del 20%
avrebbe fatto più bene che male
al paese. Ma nessuno credeva
che una svalutazione del 20%
fosse possibile: come aveva
detto un rappresentante del
governo degli Stati Uniti, «Per i
paesi in via di sviluppo non
sono
possibili
piccole
svalutazioni».
Come si poteva evitare una
svalutazione del real Il Fondo
Monetario
Internazionale
poteva fornire il denaro che,
assieme alle riserve di valuta
estera del paese, poteva essere
utilizzato per sostenere il corso
della valuta sui mercati. Ma il
denaro sarebbe presto finito se
non fosse stato fatto niente per
bloccare la fuga di capitali.
L’unica alternativa a portata di
mano era quella di imporre tassi
d’interesse molto alti, così da
convincere la gente a tenere i
propri soldi in Brasile anche se
c’era il sospetto che la valuta
potesse presto essere svalutata.
Ma non è tutto. Quando i
mercati decisero che il Brasile
stava correndo rischi seri,
decisero anche che il problema
numero uno del paese era
rappresentato dal suo grande
deficit di bilancio. A questo
punto potreste chiedervi il
perché di questa decisione. A
quell’epoca
il
governo
brasiliano non aveva un debito
così grande – molto più basso,
in percentuale sul reddito
nazionale, di quello di molti
paesi europei o del Giappone. E
gran parte del deficit era in
realtà una conseguenza della
crisi; gli alti tassi d’interesse
avevano fatto aumentare i
pagamenti di interessi da parte
del governo, mentre l’economia
in recessione faceva diminuire
gli introiti fiscali. (Con un livello
di disoccupazione e tassi
d’interesse nella norma, il
deficit di bilancio del Brasile
sarebbe
stato
piuttosto
modesto.) Ma qual era il motivo
della discussione? Gli investitori
credevano che il Brasile avrebbe
avuto una crisi disastrosa se il
deficit
non
fosse
stato
prontamente ridotto, e avevano
ragione perché loro stessi
avrebbero
incentivato
lo
sviluppo di questa crisi.
(Successe effettivamente così,
nel gennaio 1999.)
Il punto è che, poiché gli
attacchi speculativi possono
autoalimentarsi, non è più
sufficiente ottenere la fiducia
mercati con una politica che si
basa solo sui fondamentali . Il
bisogno di conquistare la
fiducia può
effettivamente
impedire a un paese di seguire
politiche altrimenti sensate, e
obbligarlo a seguire strade che
in altre condizioni verrebbero
considerate sbagliate.
Consideriamo
ora
la
situazione dal punto di vista
degli di Washington. Questi
ultimi si trovarono ad avere a
che fare con sistemi economici
che godevano di poca fiducia
presso gli investitori; quasi per
definizione un paese che ha
chiesto aiuto agli Stati Uniti o al
Fondo Monetario internazionale
ha già avuto problemi valutari o
ha corso rischi simili. Il
principale
obiettivo
degli
economisti di Washington è
quindi quello di ammorbidire il
giudizio del mercato. Ma poiché
le crisi possono autoalimentarsi,
una sana politica economica
non è sufficiente a riconquistare
la fiducia del mercato; bisogna
tenere in considerazione le
aspettative, i pregiudizi, i
capricci del mercato. Oppure si
deve tener conto di quelle che
potrebbero essere le aspettative
del mercato.
Ecco
come
la
sintesi
keynesiana ha finito per fare
una brutta fine: oggi in effetti la
politica
economica
internazionale ha poco a che
fare
con
l’economia.
È
diventata più che altro un
esercizio
di
psicologia
dilettantistica, con il quale il
Fondo
Monetario
Internazionale e il segretario al
Tesoro hanno cercato di
convincere i paesi a fare cose
che speravano sarebbero state
percepite dal mercato come
rassicuranti.
Nessuna
meraviglia, quindi, che i libri
d’economia non siano stati utili
quando la crisi fece la sua
comparsa.
Sfortunatamente i libri di
testo non sparirono del tutto
dalla circolazione. Immaginate
che Washington fosse nel
giusto, che un paese minacciato
dal panico degli investitori per
evitare di essere colpito da una
crisi
devastante
dovesse
aumentare
il
suo
tasso
d’interesse, tagliare la spesa e
difendere la sua valuta. Rimane
pur vero che politiche monetarie
e fiscali restrittive, in presenza
di una valuta sopravvalutata,
creano recessione. Che rimedio
ha offerto Washington a questo
proposito? Nessuno. Il ruolo
che si pensava di dover svolgere
nel conquistare la fiducia del
mercato sostituì le normali
attività di politica economica.
Sembra assurdo, ma è proprio
così.
Siamo dunque riusciti a
risolvere il mistero con il quale
avevamo concluso il capitolo 4:
perché la politica non è riuscita
a contrastare il devastante
circolo vizioso che ha fatto
crollare un’economia dopo
l’altra? La risposta è che le
persone responsabili di queste
politiche credevano di doversi
concentrare sulla fiducia del
mercato e ciò ha significato
assecondare, piuttosto che
contrastare,
le
politiche
economiche
che
avevano
aggravato i problemi.
Ma era proprio necessario
giocare questo gioco?
Il Fondo Monetario
Internazionale ha
peggiorato la situazione?
Nessuno ama in particolar
modo il Fondo Monetario
Internazionale: se qualcuno lo
amasse sarebbe un cattivo
segno. Il Fondo Monetario
Internazionale è infatti per i
governi nazionali un «prestatore
di ultima istanza»: è il posto
dove andare a chiedere soldi
quando si hanno problemi. E i
prestatori dell’ultima ora hanno
un concetto di amore molto
particolare: ti danno ciò di cui
hai bisogno, piuttosto che
quello che desideri, e ti
obbligano a darti da fare
attivamente nel processo di
risanamento.
Un
Fondo
Monetario materno e affettuoso
non potrebbe svolgere bene il
suo compito.
Ma non è necessariamente
vero il contrario: non è
sufficiente che la gente odi il
Fondo
Monetario
Internazionale per dire che
quest’ultimo sta facendo bene il
suo lavoro. E, da quando è
scoppiata la crisi in Asia, le
lamentele riguardo al molo del
Fondo
Monetario
Internazionale
non
sono
mancate. Sono poche le
persone che credono che il
Fondo
Monetario
Internazionale (e il segretario al
Tesoro degli Stati Uniti, che in
realtà decide le politiche del
Fondo
Monetario
Internazionale) abbia in realtà
fatto nascere la crisi, o abbia
gestito la crisi in maniera
sbagliata, così da peggiorare le
cose più di quanto fosse
necessario. Hanno ragione?
Cominciamo con la parte più
facile: le due cose che il Fondo
Monetario Internazionale ha
chiaramente sbagliato.
Prima di tutto, quando il
Fondo
Monetario
Internazionale fu chiamato in
causa
dalla
Thailandia,
dall’Indonesia e dalla Corea,
chiese
subito
che
si
predisponesse un piano di
austerità fiscale – che si
aumentassero le tasse e che si
tagliasse la spesa, così da evitare
che aumentasse il deficit di
bilancio. Era difficile capire
perché tutto ciò facesse parte
del programma, visto che in
Asia (a differenza del Brasile
dell’anno successivo) nessuno
tranne il Fondo Monetario
Internazionale
sembrava
considerare i deficit di bilancio
un problema rilevante. E il
tentativo di raggiungere questi
obiettivi di bilancio ebbe un
doppio effetto su questi paesi:
dove gli obiettivi furono
soddisfatti,
la
recessione
peggiorò e la domanda si
ridusse; dove non lo furono, si
esasperò in maniera gratuita la
sensazione che le cose fossero
fuori
controllo,
e
di
conseguenza si alimentò il
panico.
In secondo luogo il Fondo
Monetario Internazionale chiese
riforme «strutturali» – vale a
dire cambiamenti che andassero
ben oltre le politiche monetarie
e fiscali – come condizione per
concedere prestiti alle economie
in difficoltà. Alcune di queste
riforme, quale, per esempio, la
chiusura delle banche il cui
comportamento si era rivelato
poco trasparente, si può dire
siano state utili per gestire la
crisi finanziaria. Altre ancora,
come, per esempio, la richiesta
all’Indonesia di smetterla con la
concessione
di
monopoli
redditizi alle persone vicine alla
cerchia
presidenziale,
sembravano avere poco a che
fare con il mandato ricevuto dal
Fondo
Monetario
Internazionale. È vero, il
monopolio sui chiodi di
garofano (che gli indonesiani
amano mettere nelle sigarette)
era una cosa vergognosa, un
evidente caso di nepotismo. Ma
cosa c’entrava con il tentativo di
tutelare la rupia?
Se all’epoca aveste chiesto
spiegazioni ai funzionari del
Fondo
Monetario
Internazionale,
avrebbero
risposto che era un ennesimo
tentativo di ridare fiducia al
mercato. All’epoca i deficit di
bilancio non erano ancora un
problema, ma i funzionari
pensavano che lo sarebbero
presto diventati; ritenevano
anche che fosse importante che
i paesi dimostrassero con
chiarezza
che
stavano
combattendo il nepotismo e la
corruzione, che convincessero i
mercati di avere veramente
cambiato il loro modo di
operare. In altre parole si
potrebbe dire che all’epoca i
governi dovevano dimostrare la
loro
serietà
infliggendosi
punizioni – poco importa se
queste punizioni avevano o
meno un diretto collegamento
con i problemi – perché solo
così potevano riconquistare la
fiducia dei mercati.
Se questa era la teoria, in
seguito si scoprì che era
sbagliata. Gli obiettivi di
bilancio
furono
successivamente ammorbiditi, e
nessuno ci prestò attenzione; al
momento in cui sto scrivendo i
mercati sembrano una volta di
più tendere al rialzo in Corea,
anche se le riforme strutturali
sono in ritardo. Nel frattempo la
grande ampiezza di vedute delle
richieste del Fondo Monetario
Internazionale, oltre a far
nascere i sospetti che gli Stati
Uniti stessero cercando di
utilizzare la crisi per imporre la
propria
visione
ideologica
sull’Asia, riuscì ad assicurare un
lungo periodo di litigi tra i
governi asiatici e i loro salvatori;
in questo periodo la crisi di
fiducia
peggiorò
progressivamente.
In tal modo il Fondo
Monetario Internazionale fece
un po’ di confusione su due
importanti capitoli del piano di
salvataggio. Ma i capitoli
veramente
importanti
riguardavano i tassi d’interesse
e i tassi di cambio. Fu fatta
confusione anche a questo
proposito?
Ecco quello che fece il Fondo
Monetario Internazionale: in
Asia (a differenza del Brasile
che, come ho detto, era una
specie
di caricatura
dei
programmi asiatici) non disse ai
paesi di difendere a tutti i costi il
valore delle loro valute. Invece
disse loro di aumentare i tassi
d’interesse, nel tentativo di
persuadere gli investitori a
lasciare il loro denaro dove era.
Alcuni critici del Fondo
Monetario Internazionale –
soprattutto Jeffrey Sachs di
Harvard – dissero che questa
era la cosa peggiore che si
potesse fare. Sachs crede, in
effetti, che i paesi asiatici
avrebbero potuto e dovuto
comportarsi come l’Australia,
lasciando
semplicemente
svalutare la propria valuta
finché
quest’ultima
fosse
apparsa a buon mercato agli
occhi degli investitori, e che se
lo avessero fatto non ci sarebbe
mai stata una grande recessione.
Il
Fondo
Monetario
Internazionale risponde che
l’Asia non è l’Australia: che
lasciare cadere le valute senza
controllo avrebbe portato a una
«ipersvalutazione», e che il
risultato sarebbe stato una
grande
preoccupazione
finanziaria
(perché
molte
aziende avevano contratto debiti
denominati in dollari) e una
crescente
inflazione.
Il
problema alla base di questa
analisi è che, naturalmente, la
grande
preoccupazione
finanziaria ci fu in ogni caso,
aiutata dagli alti tassi d’interesse
e dalla recessione; quindi, nella
migliore delle ipotesi, si può
dire che il Fondo Monetario
Internazionale evitò un circolo
vizioso solo facendone partire
un altro.
Questa stessa osservazione fa
da comun denominatore a
molte critiche che provengono
da destra, che affermano che il
Fondo
Monetario
Internazionale avrebbe dovuto
invitare i paesi a difendere a tutti
i costi i loro tassi di cambio.
Tutto ciò avrebbe veramente
potuto evitare la perdita di
fiducia nelle valute asiatiche;
ma non avrebbe potuto fare
niente per evitare la perdita di
fiducia nelle economie asiatiche
e il disastro economico sarebbe
comunque successo.
Lasciare
semplicemente
cadere le valute sarebbe stata
una soluzione migliore? Sachs
afferma che non aumentando i
tassi d’interesse i governi
avrebbero evitato di alimentare
il panico finanziario; il risultato
sarebbe stato di poco conto,
scarse svalutazioni e una
produzione molto maggiore.
Questa tesi, che all’epoca delle
crisi asiatiche sembrava non
plausibile a molte persone (me
compreso), acquistò credibilità
nel gennaio del 1999, quando
Washington fece un chiaro
errore nei confronti del Brasile;
ma troverete una trattazione più
estesa su questo argomento nel
capitolo 7.
Di sicuro, tuttavia, all’epoca
non esistevano molte altre
alternative valide. Sembrava che
le regole del sistema finanziario
internazionale non riuscissero a
offrire più vie d’uscita a molti
paesi in via di sviluppo. E
dunque non era colpa di
nessuno se le cose erano andate
a finire così male.
Il che non vuol dire che di
questa storia non si sia mai
approfittato nessuno.
6. I PADRONI
DELL’UNIVERSO
Nel passato, prima del trionfo
del capitalismo, lo speculatore –
il ricco criminale che manipola i
mercati a discapito degli onesti
lavoratori – rappresentava una
figura di primo piano nella
cultura popolare. Ora, con la
caduta del comunismo, i
successi della globalizzazione e
il generale recupero di fiducia
nei confronti del libero mercato,
lo speculatore ha fatto la stessa
fine delle streghe e degli
stregoni. Oh, solo i più radicali
difensori
del
laissez-faire
negano che ci siano stati casi in
cui la gente ha trattato sulla base
di informazioni riservate e ha
addirittura manipolato il prezzo
di un’azione o di una materia
prima. Ma si è trattato di crimini
di poco conto; i grandi eventi
finanziari, quelli che hanno
plasmato il destino delle
nazioni, si sviluppano su
mercati di gran lunga troppo
vasti perché sia plausibile la
teoria del complotto. Nessuna
persona, nessun gruppo di
persone
riuscirebbe
a
influenzare il valore di una
valuta
o
addirittura
di
un’economia
di
medie
dimensioni, non è vero?
Be’, in realtà tutto ciò è
possibile. Uno degli aspetti più
originali delle crisi economiche
degli anni Novanta è stato il
ruolo svolto dagli hedge funds,
in grado di acquisire un
temporaneo controllo di azioni
ben superiore al capitale versato
dai loro proprietari. Senza alcun
dubbio i fondi d’investimento,
con i loro alti e bassi, hanno
messo a soqquadro i mercati e,
almeno in alcuni casi, la figura
dello speculatore è ritornata.
Il mostro
Gli hedge funds
non
minimizzano i rischi. In realtà
fanno più o meno l’opposto.
Secondo il dizionario Webster il
verbo «to hedge»{2} vuol dire
cercare di evitare o di
minimizzare
la
perdita
decidendo
investimenti
o
prendendo decisioni che si
compensino tra di loro. Vale a
dire minimizzare i rischi così da
avere la certezza che le
fluttuazioni del mercato non
minaccino le proprie ricchezze.
Al contrario, quello che
fanno gli hedge funds è cercare
di ottenere i maggiori vantaggi
possibili dalle fluttuazioni del
mercato. Il classico meccanismo
degli hedge funds è quello di
operare allo scoperto su alcune
azioni – cioè promettere di
acquistare queste ultime a un
prezzo fisso e a una data futura
– e a termine con altre ancora.
Si genera profitto quando il
prezzo delle prime si riduce (e
in tal modo possono essere
acquistate alla data prefissata in
maniera più conveniente), e
quando il prezzo delle seconde
aumenta.{3}
Il vantaggio di questo tipo di
gestione finanziaria è che può
dare buoni guadagni agli
investitori degli hedge funds. Il
fondo può infatti effettuare
operazioni che vanno oltre la
propria capacità finanziaria, in
quanto gli acquisti a termine
vengono effettuati in gran parte
con il denaro che proviene dalle
operazioni allo scoperto. In
realtà l’unico motivo per cui
l’hedge fund deve disporre di
un capitale è che deve
convincere la controparte delle
operazioni allo scoperto di
essere in grado di garantire
quanto promesso. Gli hedge
funds di migliore fama sono
stati in grado di effettuare
operazioni con un valore
complessivo centinaia di volte
più grande del capitale conferito
dai risparmiatori; ciò significa
che un punto percentuale di
aumento nel prezzo delle
proprie azioni, o di riduzione
nelle
proprie
passività,
raddoppia il valore del capitale.
Lo svantaggio, naturalmente,
è rappresentato dal fatto che gli
hedge funds possono perdere
denaro con molta facilità.
Movimenti di capitale che non
sarebbero in grado di destare
preoccupazioni agli investitori
ordinari possono invece far
sparire velocemente un hedge
fund, o per lo meno fargli
perdere le opportunità di
condurre a termine le operazioni
allo scoperto – in altre parole
possono spingere quelli che
hanno prestato azioni o altri
titoli a farsi restituire subito
tutto.
Quanto sono grandi gli hedge
funds? In realtà nessuno lo sa,
perché fino a poco tempo fa
nessuno pensava che fosse
necessario saperlo. Fino allo
scorso autunno ai fondi
d’investimento – come a molte
altre istituzioni finanziarie – è
stata concessa ampia libertà
d’azione. Questo perché gli
stessi
investitori
non
sembravano avere bisogno di
protezione: la maggior parte
degli hedge funds stabiliva una
soglia minima d’investimento
molto elevata (talvolta anche di
10 milioni di dollari) e, di
conseguenza, gli investitori
erano normalmente gente molto
ricca, che i governi ritenevano
perfettamente in grado di
badare a sé stessa. E gli hedge
funds, al contrario delle banche,
la cui solidità doveva essere
controllata
nell’interesse
generale, non sembravano avere
un ruolo chiave nei sistemi
finanziari. Non ultimo il fatto
che gli hedge funds – avendo
solo bisogno di capitali limitati
da parte di un ridotto numero di
persone – potevano stabilire offshore la propria residenza
legale, in cui operare senza
fastidiose
interferenze.
Controllare le loro operazioni
non sarebbe impossibile, ma
sarebbe sicuramente difficile.
Inoltre, per molto tempo, è stata
opinione condivisa da tutti, per
lo meno negli Stati Uniti, che
non ce ne fosse bisogno.
Ma in un certo senso si
trattava di una reazione molto
strana, perché già nel 1992 un
famoso hedge fund aveva
chiaramente dimostrato il peso
che poteva avere un investitore
con
un
elevato
d’indebitamento.
tasso
La leggenda di George
Soros
George Soros, un ungherese
rifugiatosi negli Stati Uniti e in
seguito divenuto imprenditore,
fondò il suo Quantum Fund nel
1969. Nel 1992 era già
miliardario, considerato «il più
grande investitore del mondo» e
famoso per la generosità e la
creatività dimostrate nelle sue
attività filantropiche. Ma a
Soros
–
profondamente
ambizioso da un punto di vista
sia finanziario sia intellettuale,
che desiderava che le proprie
dichiarazioni filosofiche fossero
prese sul serio quanto quelle
economiche – tutto ciò non era
sufficiente. Come lui stesso ha
affermato, cercò un’occasione
che lo facesse diventare non
solo ricco, ma anche famoso,
così da permettergli di usare il
proprio nome per promuovere
le attività senza fini di lucro.
L’opportunità la trovò in
Inghilterra. Nel 1990 l'Inghilterra
era
entrata
nell’European
Monetary System’s Exchange
Rate Mechanism (il Sistema
monetario europeo, lo SME),
un sistema di tassi di cambio
fissi concepito come una fase
intermedia
che
avrebbe
successivamente portato al varo
della valuta europea. Come era
accaduto
agli
sfortunati
continenti della nostra storia sul
«globo», tuttavia, l’Inghilterra si
accorse
che
la
politica
monetaria che era stata
obbligata a seguire non era
compatibile con i suoi obiettivi.
A quell’epoca l’Europa non
aveva una Banca Centrale
Europea; mentre c’era una
parvenza
di
simmetria
monetaria tra i paesi, in realtà
ognuno
prendeva
come
esempio la politica della
Bundesbank tedesca. E la
Germania era in una situazione
veramente peculiare rispetto al
resto dell’Europa: dopo aver
portato
a
termine
la
riunificazione, era costretta a
spendere ingenti somme per
ricostruire la Germania dell’Est.
Con il timore che queste spese
avrebbero creato inflazione, la
Bundesbank manteneva elevati
tassi d’interesse, per evitare il
surriscaldamento della propria
economia.
Nel
frattempo
l’Inghilterra,
che
era
probabilmente entrata nello
SME a un tasso di cambio
troppo alto, viveva un momento
di profonda recessione, e il suo
governo si trovava di fronte a
una crescente insoddisfazione
popolare.
I
funzionari
governativi
cercavano
di
nascondere la tentazione di
uscire dallo SME; ma si
diffondeva il dubbio che la
realtà fosse diversa.
Sembrava avvicinarsi una
crisi valutaria e Soros decise
non solo di scommettere su
questa crisi, ma addirittura di
provocarla.
Concettualmente
il
meccanismo sul quale si basava
questa scommessa è semplice,
anche se i dettagli sono molto
più complessi. Il primo passo fu
compiuto quasi segretamente:
senza dare nell’occhio il
Quantum Fund aprì infatti linee
di credito, che gli permisero di
prendere in prestito circa 15
miliardi di dollari in sterline
inglesi. Successivamente, una
volta cambiate le sterline in
dollari, l’operazione mostrò
apertamente il suo vero volto:
Soros rese il più possibile
pubbliche le operazioni allo
scoperto nei confronti della
sterlina, concedendo interviste
ai quotidiani finanziari e
dichiarando di ritenere la
sterlina
prossima
alla
svalutazione. Se tutto fosse
andato bene gli investitori si
sarebbero precipitati a vendere
le sterline e il governo inglese
sarebbe stato costretto ad
arrendersi e a svalutare la
propria moneta.
Il piano funzionò. Soros
cominciò il suo assalto alla
sterlina in agosto. Nel giro di
poche settimane l’Inghilterra
aveva speso 50 miliardi di
dollari sui mercati internazionali
per difendere la sterlina, senza
alcun
risultato.
A metà
settembre il governo aumentò i
tassi d’interesse per difendere la
valuta, ma la decisione si rivelò
politicamente
inaccettabile;
dopo soli tre giorni l’Inghilterra
uscì dallo SME, e la sterlina fu
lasciata libera di fluttuare (lo è
ancor oggi). In questo modo
Soros non solo guadagnò in
poco tempo circa un miliardo di
dollari, ma si guadagnò anche la
fama
del
più
famoso
speculatore di tutti i tempi.
Ma che cosa fece in realtà
Soros? Bisogna porsi tre
domande.
Innanzitutto, Soros mise in
difficoltà una valuta che avrebbe
in ogni caso conservato il suo
valore? Probabilmente no. Il
fatto è che da tempo la sterlina
era oggetto di pressioni, e molti
economisti (sebbene non molti
operatori del mercato) avevano
il sospetto che l’Inghilterra
dovesse uscire dallo SME.
Nessuno può provarlo con
certezza, ma sono piuttosto
sicuro che il tentativo inglese di
unirsi al club monetario
europeo
era
comunque
destinato a fallire, con o senza
Soros.
Così facendo, Soros riuscì
comunque ad accelerare i tempi,
facendo svalutare la sterlina
prima di quanto sarebbe
successo? Quasi sicuramente sì,
ma la vera domanda è chiedersi
di quanto accorciò i tempi. Una
volta di più non è possibile
affermare una cosa con assoluta
certezza, ma è mia opinione
personale che nel breve periodo
le
condizioni
economiche
avrebbero in ogni caso portato
l’Inghilterra fuori dallo SME, e
che Soros abbia ridotto i tempi
solo di alcune settimane.
In conclusione, Soros ha
fatto del male alle sue vittime? Il
governo presieduto dal primo
ministro John Major non si
riprese mai più dall’umiliazione.
Ma, dopotutto, si può affermare
che nel complesso Soros abbia
fatto un favore alla nazione. La
perdita di valore della sterlina
non causò una crisi economica:
la
valuta
si
stabilizzò
spontaneamente circa un 15%
più in basso rispetto al suo
precedente valore. Senza più
l’obbligo di dover sostenere la
sterlina, il governo inglese fu in
grado di ridurre i tassi
d’interesse. (Norman Lamont,
ministro del Tesoro britannico,
dichiarò che «si era messo a
cantare nella vasca da bagno»
con sollievo quando venne
meno una stabilità monetaria
che, solo pochi giorni prima,
aveva dichiarato assolutamente
inviolabile. Il suo sollievo era
prematuro: la maggior parte
degli inglesi ci guadagnò dalla
svalutazione, ma lui fu presto
obbligato a dimettersi.) La
combinazione tra minori tassi
d’interesse e tassi di cambio più
competitivi fece rapidamente
migliorare l’economia inglese,
che nel giro di pochi anni ha
portato il suo tasso di
disoccupazione a livelli che
prima
venivano
ritenuti
irraggiungibili. Per l’inglese
medio l’attacco di Soros alla
sterlina ha avuto conseguenze
quasi esclusivamente positive.
Dopo tutto, quindi, non è
stata una storia così terribile. È
vero, gli europei che avevano
particolarmente
a
cuore
l’unione
monetaria
considerarono gli eventi del
1992 una tragedia; i francesi,
che contrastarono gli attacchi
speculativi del 1992 e del 1993
(per
un
breve
periodo
lasciarono fluttuare il franco, ma
presto lo riportarono all’interno
della banda dello SME),
consideravano
ancora
gli
speculatori come emissari del
diavolo. Ma nel mondo
anglosassone la storia di Soros e
della sterlina non venne mai
interpretata come un presagio di
futuri problemi.
Tutto cambiò, invece, con la
crisi asiatica e ci si rese conto
che i risultati della speculazione
potevano rivelarsi anche molto
meno piacevoli.
La pazzia del primo
ministro Mahathir
Provate a immaginarvi quel
che deve avere provato. Era
riuscito a gestire le difficili
politiche e le etnie del suo paese
con grande abilità: aveva
tranquillizzato la maggioranza
malay con il programma
bumjputra («figlio della terra»),
offrendole
un
trattamento
economico
preferenziale,
riuscendo allo stesso tempo a
non offendere la minoranza
cinese, molto importante per la
vita economica del paese. Aveva
reso la Malesia una delle mete
preferite dalle multinazionali,
riuscendo allo stesso tempo a
conservare una politica estera
indipendente, in qualche modo
anche antioccidentale, che
gratificava una popolazione a
maggioranza islamica. E, sotto
la sua guida, il paese aveva
approfittato pienamente del
miracolo asiatico: l’economia
aveva ripreso la sua corsa, gli
uomini d’affari stranieri, da Bill
Gates in giù, lo corteggiavano e
nell’estate del 1997 «Time» lo
dichiarò uno dei cento leader
più significativi al mondo nel
settore tecnologico.
In realtà non fu tutto rose e
fiori. Alcuni dei suoi amici e dei
membri della sua famiglia si
erano arricchiti con molta
facilità; alcuni stranieri lo
accusavano
di
avere
atteggiamenti megalomani, di
voler costruire gli edifici più alti
del mondo, una nuova capitale
e
un’area
dedicata
alla
produzione tecnologica. Ma, nel
complesso, aveva tutte le
ragioni per sentirsi soddisfatto
dei risultati raggiunti.
In seguito, e molto in fretta,
le cose cominciarono
a
peggiorare. Una crisi valutaria
aveva colpito i paesi vicini –
bene, questo era un problema
loro. Di conseguenza, però, il
denaro cominciò a defluire
anche dal suo paese; e si trovò
di
fronte
all’umiliante
alternativa di lasciar cadere il
valore della valuta o di
aumentare i tassi d’interesse, e
ognuna delle due soluzioni
avrebbe
creato
problemi
finanziari ai settori produttivi
che sembravano così solidi.
Come si era potuti arrivare a
questo punto?
In realtà dunque, Mahathir
Mohamad, primo ministro
malese, non dovrebbe essere
accusato così severamente per
avere dato ascolto a teorie
cospirative. Dopotutto solo
cinque anni prima George Soros
aveva macchinato dietro le
quinte per far svalutare la
sterlina e il Quantum Fund
aveva speculato sulle valute
dell’Estremo Oriente nel corso
degli ultimi anni. Cosa c’era di
più ovvio che incolpare delle
sue
sventure
il
famoso
speculatore?
Nonostante tutto Mahathir
avrebbe comunque dovuto
tenere la bocca chiusa. In un
momento in cui la fiducia nei
confronti della sua economia
stava già diminuendo, anche
l’idea che farneticasse di una
cospirazione americana contro
l’Asia – alludendo al fatto che
forse si trattava di una
cospirazione ebrea – non era
esattamente la giusta ricetta per
una simile situazione.
Tra l’altro fu chiaro che aveva
torto. Il Quantum Fund aveva
speculato contro la Thailandia,
ma non era certamente stato
l’unico. La fuga di capitali dalla
Malesia fu sicuramente operata
in gran parte degli stessi malesi
– in particolare proprio da parte
di qualche uomo d’affari
arricchitosi grazie ai favori di
Mahathir.
Nonostante tutto Mahathir
perseverò sulla sua strada,
continuando ad attaccare Soros
in occasione delle conferenze
stampa e dei discorsi ufficiali.
Solo dopo parecchi mesi,
quando
le
condizioni
dell’economia
malese
apparvero davvero allarmanti, si
tranquillizzò, per paura di
disturbare i mercati. Forse si
rese anche conto del fatto che la
maggior parte del mondo
considerava infantili le sue
lamentele;
cospirazioni
di
questo tipo non succedono mai
nel mondo reale. Una di queste,
però, accadde veramente.
L’attacco a Hong Kong
Hong Kong ha per lungo
tempo occupato un posto
speciale nel cuore dei sostenitori
del libero mercato. In un’epoca
in cui la maggior parte dei paesi
del Terzo Mondo credeva che il
protezionismo
e
la
pianificazione statale fossero gli
unici strumenti di crescita,
Hong Kong aveva un mercato
libero e una politica che
concedeva piena libertà agli
uomini d’affari – dimostrando
in tal modo che un’economia
così aperta poteva crescere a
tassi di sviluppo che i teorici
non avrebbero mai ritenuto
possibili. La città-stato aveva
anche ripreso la moda del
currency board, che alcuni
conservatori pensavano fosse il
primo passo verso il ritorno al
gold standard. Anno dopo anno
la
Heritage
Foundation,
piuttosto conservatrice, aveva
fatto salire Hong Kong ai primi
posti della sua «classifica della
libertà economica».
Ma Hong Kong aveva
sofferto in seguito alla crisi
asiatica. È però difficile
incolpare chi all’epoca si
occupò di governare la città: la
sua economia, più di ogni altra
nella regione, era infatti gestita
secondo la legge, con banche
ben funzionanti e severe
politiche di bilancio. C’erano
stati pochi segnali di nepotismo
rampante prima della crisi e,
durante il primo anno, non si
erano verificate neppure fughe
di capitale a causa del panico.
Tuttavia la città si trovava
chiaramente nel posto sbagliato
al momento sbagliato. Mentre i
paesi confinanti vivevano un
momento
di
recessione,
l’attività economica cominciava
a perdere colpi: i giapponesi
avevano smesso di fare
shopping,
le
aziende
dell’Estremo
Oriente
non
acquistavano più i servizi delle
banche di Hong Kong. Ancora
peggio, il severo sistema di
Hong Kong, il currency board,
imponeva che il tasso di cambio
fosse fissato saldamente a 7,8
nei confronti del dollaro
statunitense, anche se molti altri
paesi asiatici avevano svalutato,
rendendo
improvvisamente
Hong Kong molto più cara di
Bangkok e persino di Tokyo. Il
risultato fu una profonda
recessione, la peggiore che si
ricordi a memoria d’uomo.
Inevitabilmente
ci
si
cominciò a porre i dubbi più
atroci. Hong Kong avrebbe
veramente difeso a tutti i costi il
tasso di cambio? Alcuni uomini
d’affari di Hong Kong chiesero
apertamente alla Monetary
Authority di svalutare la
moneta, per rendere di nuovo
competitivi i propri prezzi.
Queste richieste non furono
accettate, e il governo dichiarò
che il tasso non poteva essere
modificato; ma aveva detto la
stessa cosa anche il governo
inglese nel 1992. E che cosa dire
della Cina? Il gigante asiatico
scampò per un pelo alla prima
ondata di crisi, in gran parte
grazie ai controlli valutari (vedi
il capitolo 8), ma nell’estate del
1998 già si scorgevano i primi
segnali
di
rallentamento
economico
e,
contemporaneamente, cominciò
a correre voce che anche la
valuta cinese stesse per essere
svalutata – il che avrebbe
peggiorato
ulteriormente
i
problemi di Hong Kong.
La maggior parte delle
persone
considerò
questo
insieme di eventi una raffica di
brutte notizie; ma alcuni hedge
funds ci videro invece alcune
opportunità da sfruttare.
Non esistono, per ovvie
ragioni, dati precisi su quello
che successe tra l’agosto e il
settembre del 1998, ma ecco la
cronaca riportata da alcuni
funzionari di Hong Kong e da
alcuni operatori. Un limitato
numero di fondi d’investimento
– sicuramente tra questi c’era il
Quantum Fund di Soros e il
meno famoso ma ugualmente
importante Tiger Fund Julian
Robertson, più al massimo due
o
tre
altri
ancora
–
cominciarono a fare il doppio
gioco nei confronti di Hong
Kong. Vendettero a Hong Kong
dei titoli allo scoperto – vale a
dire che presero in prestito titoli
dai loro proprietari, quindi li
vendettero in cambio di dollari
di Hong Kong (con la promessa
a
questi
proprietari,
naturalmente, di riacquistare i
titoli e di restituirli – pagando
un sovrapprezzo per il fatto di
aver potuto disporre dei titoli
per un certo periodo di tempo).
Successivamente i dollari di
Hong Kong furono cambiati in
dollari statunitensi. Gli hedge
funds stavano scommettendo
che tra due eventi possibili, se
ne sarebbe verificato uno. La
prima alternativa era che il
dollaro di Hong Kong sarebbe
stato svalutato, e avrebbero così
guadagnato dalla speculazione
valutaria; la seconda alternativa
era che l’autorità monetaria di
Hong Kong avrebbe difeso la
sua valuta aumentando i tassi
d’interesse, il che avrebbe fatto
scendere il mercato azionario
locale, e gli hedge funds
avrebbero così guadagnato sui
titoli detenuti allo scoperto.
Secondo i funzionari di Hong
Kong i fondi d’investimento
non si limitavano però a
scommettere su questi due
eventi: come Soros nel 1992,
stavano facendo il possibile
perché
questi
eventi
si
concretizzassero. Le vendite dei
dollari di Hong Kong vennero
ampiamente
pubblicizzate,
effettuate in grandi volumi,
programmate con regolarità,
così da essere sicuri che il tutto
non passasse inosservato. Senza
far nomi i funzionari di Hong
Kong affermano anche che
furono pagati i giornalisti e gli
inviati
perché
scrivessero
articoli dove dicevano che il
dollaro di Hong Kong o il
renminbi cinese, o entrambi,
erano sul punto di essere
svalutati. In altre parole,
cercarono deliberatamente di far
svalutare la valuta.
I
fondi
d’investimento
organizzarono il piano di
comune accordo? È possibile:
mentre un esplicito accordo
teso a manipolare, per esempio,
il prezzo di azioni Microsoft vi
porterebbe direttamente in
prigione,
una
simile
cospirazione contro il mercato
valutario di Hong Kong (che nel
1998 aveva all’incirca lo stesso
valore di capitalizzazione) riuscì
apparentemente
a
passare
attraverso le maglie della legge.
È comunque probabile che i
protagonisti chiave abbiano
cercato di coordinare il proprio
operato
con
allusioni e
strizzatine d’occhio, magari
anche in maniera più esplicita
su un campo da golf o attorno a
una buona bottiglia di vino.
Dopo tutto nell’operazione non
erano coinvolte poi così tante
persone e tutti conoscevano
perfettamente le regole del
gioco.
In realtà alcuni osservatori
intuirono che la storia potesse
nascondere ancora altri risvolti.
In quello stesso periodo i
Quattro (o Cinque, o quello che
erano) di Hong Kong stavano
effettuando altre operazioni.
Questi ultimi cominciarono a
operare allo scoperto nei
confronti dello yen – perché i
tassi d’interesse in Giappone
erano bassi e si pensava che lo
yen sarebbe potuto crollare con
il dollaro di Hong Kong – come
nei confronti del dollaro
australiano,
del
dollaro
canadese
e
così
via.
Diventarono
anche
grandi
venditori di alcune di queste
valute.
Potreste
quindi
considerare Hong Kong come
epicentro di un’operazione
contro gran parte della regione
dell’Asia-Pacific, forse la più
grande cospirazione di mercato
di tutti i tempi.
E non vi sbagliereste di
molto. Dopo tutto che cosa
poteva fare Hong Kong? Il suo
mercato valutario era vasto in
confronto a quello della
maggior parte dei paesi in via di
sviluppo, ma era piccolo in
confronto alle risorse di cui
potevano disporre gli hedge
funds;
si
diceva
che,
complessivamente,
le
operazioni allo scoperto di
questi presunti cospiratori
ammontavano a circa 30
miliardi
di
dollari,
che
equivalgono a 1,5 trilioni di
dollari venduti allo scoperto sul
mercato valutario statunitense.
Inoltre l’accesso al mercato di
Hong Kong era libero, e molto
probabilmente
lo
sarebbe
rimasto a lungo: una città la cui
fama dipende in gran parte dal
fatto di permettere alla gente di
fare tutto quello che vuole con il
proprio denaro, senza alcuna
interferenza arbitraria da parte
del governo, non avrebbe
neanche osato accennare a
eventuali controlli sui capitali.
Dopo tutto sembrava un piano
ben congegnato, con alte
probabilità di successo.
Inaspettatamente Hong Kong
reagì.
La reazione fu orchestrata
utilizzando i fondi dell'Autorità
monetaria di Hong Kong
(HKMA). La HKMA disponeva
all’epoca di vaste risorse.
Ricordatevi che a Hong Kong
vigeva il currency board, così
che ogni 7,8 dollari di Hong
Kong in circolazione erano
garantiti
da
un
dollaro
statunitense; ma all’epoca la
HKMA aveva messo da parte
un numero di dollari ancora più
alto. Come si poteva mobilitare
questa ricchezza contro gli
hedge funds? Utilizzandola per
acquistare azioni sul mercato
valutario locale – quindi
aumentando i prezzi e facendo
perdere denaro agli hedge funds
– che avevano venduto allo
scoperto
queste
azioni.
Naturalmente,
per
poter
raggiungere questo scopo, gli
acquisti dovevano avvenire su
larga scala, in modo da
compensare almeno gli acquisti
allo scoperto effettuati dagli
hedge funds. Le autorità
disponevano senza problemi
delle risorse necessarie a
effettuare tali acquisti.
Perché gli hedge funds non
avevano previsto una tale
risposta? Perché non pensavano
che il governo di Hong Kong
avrebbe
voluto
rischiare
l’inevitabile reazione da parte
dei conservatori – delusi dal
fatto che un libero mercato di
tale fama avesse tentato di
manipolare i prezzi di mercato.
E la reazione non si fece
aspettare. Le decisioni del
governo erano «insensate»,
tuonò Milton Friedman; la
Heritage Foundation cancellò
formalmente la candidatura
della città-stato a bastione della
libertà economica; gli articoli
dei giornali paragonavano Hong
Kong alla Malesia, che aveva
appena imposto severi controlli
sul capitale. Il ministro delle
Finanze Donald Tsang cominciò
a girare per il mondo, cercando
di spiegare le decisioni agli
investitori e di rassicurarli che il
suo governo era rimasto
favorevole al capitalismo; ma
era un compito difficile.
Per un certo periodo gli
hedge funds pensarono che,
sull’onda di queste reazioni, le
autorità
di
Hong
Kong
avrebbero fatto marcia indietro.
Riacquistarono i titoli allo
scoperto (vale a dire che
pagarono
ai
precedenti
proprietari
dei
titoli
un
sovrapprezzo per ottenere il
diritto di posticipare la loro
restituzione) e aspettarono le
successive mosse del governo.
Il quale, poi, aumentò la posta
in gioco, istituendo nuove
regole che limitavano la vendita
allo scoperto, obbligando di
conseguenza gli investitori di
Hong Kong che avevano dato in
prestito le loro azioni a farsele
restituire; tutto ciò costrinse i
fondi d’investimento a porre
fine alle loro operazioni, e fece
sorgere ulteriori lamentele.
Dopo di che l’intera storia di
Hong Kong passò in secondo
piano, perché una curiosa serie
di eventi mondiali obbligò gli
stessi hedge funds a ridurre il
loro ritmo d’attività.
L’economia Potëmkin
Nel
1787
l’imperatrice
Caterina di Russia fece un
viaggio
nelle
provincie
meridionali del suo impero.
Secondo la leggenda il suo
primo
ministro
Grigorij
Aleksandrovič Potëmkin la
precedeva di un giorno di
viaggio,
allestiva
false
scenografie
che
facessero
sembrare più accoglienti i
villaggi disastrati e quindi le
smantellava per ricostruirle alla
tappa successiva. Da quel
momento in poi l’espressione
«villaggio Potëmkin» è stata
utilizzata per riferirsi a scene
apparentemente felici che in
realtà non sono altro che vuote
facciate, che nulla hanno a che
vedere con quanto nascondono
dietro di esse.
Nella seconda metà del 1990
la stessa Russia divenne una
sorta di sistema economico
Potëmkin. La transizione dal
socialismo al capitalismo non è
stata facile per nessuno, ma per
la Russia è stata ancora più
difficile che per gli altri paesi.
Dopo la caduta del comunismo
la sua economia è stata per anni
in una specie di limbo: non
riceve più alcuna guida da parte
del centro, e non è ancora
riuscita a mettere in piedi un
sistema di mercato efficiente.
Perfino ciò che una volta
funzionava, seppure in maniera
approssimativa, ora non era più
in grado di farlo: dalle industrie
che producevano prodotti di
bassa qualità non esce più
niente, le fattorie collettivizzate
sono diventate perfino meno
produttive di quanto fossero
prima, e i tetri anni di Breznev
oggi vengono ricordati come un
momento felice. Ci sono a
disposizione
centinaia
di
migliaia
di
esperti
programmatori,
ingegneri,
scienziati, informatici, ma non si
riesce a trovare loro un lavoro
decente.
Era
una
situazione
spiacevole, ma la Russia aveva
ancora una freccia al suo arco:
in qualità di erede della defunta
Unione Sovietica disponeva
ancora di un grande arsenale di
armi nucleari. Non aveva
esplicitamente minacciato di
vendere le testate nucleari al
miglior offerente, ma il rischio
che prima o poi la cosa potesse
succedere ha certo condizionato
la
politica
occidentale,
obbligando
il
governo
statunitense a non sottovalutare
la faccenda. Dopo che persone
ben informate avevano perso
ogni speranza, gli Stati Uniti
hanno continuato a sperare che
i riformatori russi sarebbero in
qualche modo riusciti a
concludere
la
transizione
interrotta, che gli oligarchi
avrebbero smesso di mostrarsi
così egoisti o, per lo meno, di
avere una visione tanto miope;
così il governo degli Stati Uniti
ha spinto il Fondo Monetario
Internazionale a dare denaro in
prestito alla Russia in modo da
guadagnare del tempo, in attesa
di una stabilizzazione che non si
è mai verificata. (Il «Medley
Report»,
una
newsletter
economica internazionale, ha
scritto che gli Stati Uniti non
stavano, come ha detto
qualcuno, gettando i soldi in
una topaia; stavano gettando i
soldi in un silos di missili
nucleari.)
L’apparente abilità della
Russia nell’utilizzare le sue armi
nucleari come strumento di
minaccia ha a sua volta
incoraggiato
gli
investitori
stranieri a correre a loro volta
dei rischi e a investire nel paese.
Tutti sapevano che il rublo
sarebbe presumibilmente stato
svalutato, magari anche in
maniera massiccia, o che il
governo
russo
poteva
semplicemente decidere di non
onorare più i suoi debiti. Ma,
prima di arrivare a tanto, ci si
poteva facilmente aspettare che
l’Occidente avrebbe concesso
un
ennesimo
prestito
d’emergenza in denaro. Visto
che il debito del governo russo
aveva tassi d’interesse molto
alti, che in alcuni casi arrivavano
addirittura al 150%, era una
bella scommessa per gli
investitori
particolarmente
propensi al rischio – soprattutto
gli hedge funds.
Tuttavia si scoprì che,
dopotutto, la scommessa non
era così bella come sembrava.
Nell’estate
del
1998
la
situazione finanziaria della
Russia si chiarì più velocemente
di quanto non ci si aspettava. In
agosto George Soros (!) affermò
pubblicamente che la Russia
avrebbe dovuto svalutare e
adottare il currency board; il
suo invito diede origine a un
fenomeno di corsa alla valuta, a
un’insufficiente svalutazione in
stile messicano e, quindi, a una
combinazione
tra
collasso
valutario e moratoria sui debiti.
In apparenza l’Occidente aveva
fatto tutto il possibile: questa
volta non c’era più nulla da fare.
Improvvisamente i buoni del
tesoro russi potevano essere
venduti al massimo per una
percentuale del loro valore
nominale, e miliardi di dollari
andarono in fumo. (Che cosa
era successo nel frattempo
all’arsenale nucleare? Buona
domanda, ma è meglio non
pensarci.)
La quantità di denaro perso
in Russia era insignificante –
non più di quello che si perde
quando, per esempio, il mercato
azionario degli Stati Uniti cala di
un paio di punti in percentuale,
il che non accade poi così di
rado. Ma queste perdite
cadevano pesantemente sulle
spalle di un ristretto numero di
operatori
finanziari
molto
indebitati, e questo significa che
alla fine tutto ciò provocò effetti
di grande portata anche in altre
parti del mondo. Per un paio di
settimane sembrò davvero che il
crollo finanziario della Russia
avrebbe
trascinato
tutta
l’economia mondiale.
Il panico del 1998
Nell’estate del 1998 le
operazioni gestite dagli hedge
funds nel mondo non erano
solo rischiose, ma terribilmente
complesse. C’era tuttavia un
modello a cui ci si poteva
rivolgere. Tipicamente questi
fondi conducevano operazioni
allo scoperto su titoli sicuri – il
cui valore sarebbe difficilmente
crollato – e su titoli facilmente
liquidabili in caso di necessità.
Allo stesso tempo conducevano
operazioni a termine su titoli
rischiosi e non liquidabili. In tal
modo un hedge fund poteva
condurre
operazioni
allo
scoperto su titoli di stato
tedeschi, che sono sicuri e facili
da vendere, e allo stesso tempo
condurre operazioni a termine
su titoli danesi garantiti da
ipoteche (su immobili), un poco
più rischiosi e difficili da
vendere nel breve periodo.
Oppure condurre operazioni
allo scoperto su buoni del
tesoro giapponesi e a termine su
quote del debito russo.
In linea di principio i mercati
hanno sempre storicamente
stabilito un prezzo piuttosto alto
per i titoli sicuri e facilmente
liquidabili, perché i piccoli
investitori non amano correre
rischi e non sanno mai con
precisione quando potranno
avere bisogno di utilizzare i loro
soldi. Tutto ciò rappresentava
un’opportunità d’oro per gli
hedge funds, che potevano
minimizzare
il
rischio
diversificando con attenzione il
proprio
portafoglio
titoli
(acquistando un mix di titoli
diversi, così che i guadagni
ottenuti su uno di questi
dovevano
teoricamente
compensare le perdite subite su
un altro), e che normalmente
non si trovavano mai nella
condizione di avere un urgente
bisogno di denaro. È proprio
servendosi di queste leve
finanziarie che gli hedge funds
sono riusciti, anno dopo anno, a
fare così tanti soldi.
Nel 1998, tuttavia, furono in
molti a capire questi trucchi e
l’elevata competizione tra hedge
funds aveva reso sempre più
difficile guadagnare su questo
genere
di
operazioni.
Successivamente alcuni hedge
funds cominciarono a restituire
il denaro agli investitori,
dichiarando che non riuscivano
a trovare un numero sufficiente
di opportunità per utilizzarlo.
Cercarono di prendere in
considerazione anche nuove
remote
opportunità
d’investimento, lasciandosi così
coinvolgere
in
situazioni
apparentemente
molto
rischiose.
Quello che nessuno capì, se
non quando la catastrofe si era
ormai verificata, è che il tasso di
competitività tra hedge funds, il
cui obiettivo era approfittare
delle più remote opportunità di
guadagno esistenti sul mercato,
aveva in realtà creato un
meccanismo
finanziario
infernale.
Ecco
come
funzionava.
Immaginatevi che un hedge
fund – chiamiamolo Relativity
Fund – abbia acquistato una
grande quantità di buoni del
tesoro russi. Poi la Russia
diventa inadempiente, e l’hedge
fund perde un milione di dollari,
o giù di lì. Questa perdita
preoccupa
le
controparti
dell’operazione allo scoperto –
le persone che hanno dato in
prestito le loro azioni e i loro
titoli,
affinché
venissero
restituiti in futuro – che
finiscono per chiedere la
restituzione anticipata. Tuttavia
il Relativity Fund non dispone
ancora di questi titoli; deve
ricomprarli, il che vuole dire che
deve vendere altri titoli per
disporre dei contanti necessari.
Poiché il Relativity Fund
rappresenta un grande operatore
sul mercato, quando comincia a
vendere, i prezzi dei titoli sui
quali ha investito scendono.
Nel frattempo il rivale del
Relativity Fund, il Pussycat
Fund, ha anch’esso investito i
suoi soldi in molti degli stessi
titoli. Quindi nel momento in
cui il Relativity Fund è
obbligato
a
vendere
rapidamente su vasta scala,
anche il Pussycat Fund subisce
pesanti
perdite;
anche
quest’ultimo si trova obbligato
a garantire le sue operazioni allo
scoperto vendendo, facendo
scendere i prezzi degli altri titoli.
In tal modo crea problemi
all’Elizabethan Fund… e così
via.
Se tutto ciò vi fa tornare alla
mente la storia del disastro
finanziario dell’Asia, che ho
raccontato nel capitolo 4, avete
ragione: in sostanza si tratta di
un processo dello stesso tipo,
che ha a che fare con un circolo
vizioso di prezzi in calo e bilanci
disastrati. Nessuno pensava che
una cosa simile potesse
succedere di nuovo nel mondo
moderno, ma in realtà è
capitata, e le conseguenze sono
state allarmanti.
Si scoprì che gli hedge funds
si erano mostrati così assidui
nell’effettuare operazioni di
arbitraggio tra premi sulla
liquidità e sul rischio, che per
molti titoli loro erano il
mercato; quando gli hedge
funds provarono tutti assieme a
vendere, sul mercato non si
riuscivano a trovare altri
acquirenti. E così, dopo anni in
cui avevano continuato a
diminuire, i premi sulla liquidità
e sul rischio raggiunsero
rapidamente
livelli
inimmaginabili perché gli hedge
funds furono costretti a
liquidare le proprie posizioni. I
buoni del tesoro statunitensi a
29
anni
–
un
titolo
assolutamente sicuro, nel senso
che se il governo statunitense fa
una brutta fine, tutto il resto
dell’economia lo segue –
offrivano tassi d’interesse molto
più alti dei buoni a trent’anni,
che vengono negoziati su un
mercato più grande e sono
quindi più facili da vendere. Le
obbligazioni
emesse
dalle
società
private
devono
normalmente
offrire
un
rendimento più alto del debito
del governo degli Stati Uniti, ma
lo spread era improvvisamente
aumentato di parecchi punti
percentuali. E i titoli garantiti da
ipoteche commerciali – gli
strumenti
finanziari
che
finanziano indirettamente gran
parte
degli
investimenti
immobiliari per uso non
residenziale – non riuscivano
assolutamente a essere piazzati.
Nel corso di una riunione a cui
ho preso parte, i partecipanti
chiesero a un rappresentante
della Federal Reserve che stava
descrivendo la situazione che
cosa fare per risolverla.
«Pregare», fu la risposta.
Nella realtà, fortunatamente,
la Federal Reserve non si limitò
a pregare. Prima di tutto
organizzò
il
salvataggio
dell’hedge fund che era stato
più colpito: il Long Term
Capital Management (LTCM),
con sede nel Connecticut.
La storia del LTCM è ancora
più incredibile di quella di
George Soros. Soros è una
figura che appartiene a una
lunga tradizione, quella dello
spavaldo scalatore finanziario –
non così diversa, in fondo, da
quella di Jim Fisk o di Jay
Gould. Chi dirigeva il Long
Term Capital, tuttavia, erano
personaggi
tipicamente
moderni:
brave
persone
competenti, che utilizzavano
formule e computer per mettere
nel sacco il mercato.
Il fondo aveva tra i suoi
dipendenti due Nobel e alcuni
tra i loro migliori allievi.
Credevano
che
studiando
attentamente le correlazioni
storiche tra valori azionari
avrebbero potuto gestire meglio
i loro portafogli titoli – operare a
termine su alcuni titoli e allo
scoperto su altri – che
garantivano alti ritorni con un
rischio molto inferiore a quello
che
la
gente
avrebbe
immaginato. E, anno dopo
anno, i risultati arrivarono
puntuali, tanto che la gente che
prestava loro il denaro non si
domandava più se la società
aveva veramente abbastanza
capitale da poter essere
considerata sicura.
Poi il mercato iniziò a perdere
la bussola.
Non è ancora ben chiaro se le
perdite del LTCM furono il
risultato di un disastro che
normalmente accade una volta
nella vita, e che quindi non
poteva essere previsto, o se
l’improvvisazione dei modelli
statistici che venivano utilizzati
non permetteva di considerare
la comparsa di eventi fortuiti su
così vasta scala. (Non è neppure
chiaro
se
questa
improvvisazione, se in realtà fu
tale, sia stata deliberata – ancora
una volta un rischio soggettivo.)
Qualunque sia stata la causa, a
settembre fu fatto un richiamo
di margine di garanzia alla
società – venne cioè chiesto di
depositare più denaro contante
in aggiunta a quello depositato
dai clienti, oppure di rimborsare
completamente questi ultimi –
che
non
poteva
essere
soddisfatto.
Divenne
improvvisamente chiaro che
l’LTCM era diventato un
operatore così grande sui
mercati che, se fosse fallito, e le
sue posizioni finanziarie fossero
state liquidate, avrebbe diffuso il
panico su vasta scala.
Perciò era indispensabile
trovare una soluzione. Alla fine
non fu necessario stanziare il
denaro dei contribuenti: la New
York Federal Reserve riuscì a
convincere un gruppo di banche
ad acquistare la maggioranza
del capitale del LTCM in
cambio di un’iniezione di
contanti di cui quest’ultima
aveva disperatamente bisogno;
e, una volta che i mercati si
calmarono di nuovo, le banche
scoprirono alla fine di avere
fatto un buon affare.
Anche
dopo
questo
salvataggio, tuttavia, non si
poteva certamente pensare di
avere superato la crisi. Quando
la Federal Reserve tagliò i tassi
d’interesse del solo 0,25% in
occasione della sua tradizionale
riunione di settembre, la
decisione deluse i mercati e la
situazione
finanziaria,
già
parecchio disastrata, la gente fu
presa
dal
panico
e
improvvisamente prese a fare
confronti tra la crisi finanziaria e
le corse allo sportello che
avevano gettato gli Stati Uniti
nella Grande Depressione; J.P.
Morgan arrivò persino a
prevedere una severa recessione
nel 1999.
Ma la Federal Reserve aveva
un asso nella manica. Di norma
i tassi d’interesse vengono
modificati solo quando si
riunisce il Federal Open Market
Committee, all’incirca ogni sei
settimane. Durante la riunione
di quel settembre, tuttavia, il
comitato aveva concesso ad
Alan Greenspan il potere
discrezionale di tagliare i tassi
d’interesse di un ulteriore
quarto di punto se fosse stato
necessario. Il 15 ottobre
Greenspan sorprese i mercati
annunciando proprio quella
riduzione – e, miracolosamente,
i mercati si ripresero. Quando la
Federal Reserve tagliò di nuovo
i tassi nel corso della successiva
riunione, il panico si trasformò
in euforia. Alla fine del 1998
tutti gli inusuali premi sulla
liquidità erano scomparsi e il
mercato azionario stava ancora
una volta stabilendo nuovi
record.
È importante riconoscere che
i funzionari della Federal
Reserve non sono così sicuri di
sapere perché siano riusciti
effettivamente a salvare la
situazione.
Nel
momento
peggiore della crisi sembrava
che tagliare i tassi d’interesse
non avrebbe sortito alcun
effetto – dopo tutto, se nessuno
può prendere a prestito, che
differenza fa cambiare i tassi? E
se ognuno avesse creduto che il
mondo stava avvicinandosi alla
fine, il panico avrebbe dato vita
– come è successo in molti altri
paesi – a una profezia che si
autoalimenta. In retrospettiva
Greenspan si comportò come
un generale che passa in
rassegna
la
sua
armata
demoralizzata, tira fuori la
spada e la incoraggia, e in
qualche modo riesce a cambiare
il corso della battaglia: ben fatto,
ma meglio non contarci troppo
la prossima volta.
In realtà alcuni funzionari
della Federal Reserve si
preoccuparono del fatto che la
gente
potesse
aver
sopravvalutato le loro capacità –
una nuova forma di rischio
morale, dice un consulente di
Greenspan, convinto che la
Federal possa tirar fuori da
qualunque crisi l’economia e i
mercati. Ma con la crisi del 2008
i limiti che condizionano il
potere della FED sono apparsi
in tutta la loro evidenza.
Prima di arrivarci, però,
parliamo della leggenda di Alan
Greenspan,
e
spieghiamo
perché è andato tutto per il
verso sbagliato.
7. LE BOLLE DI
GREENSPAN
Per più di diciotto anni, dal
maggio 1987 al gennaio 2006,
Greenspan è stato presidente
del Board of Governors della
Federal
Reserve.
Quella
posizione, di per sé, ne faceva
uno dei banchieri centrali più
potenti del mondo. Ma
l’influenza di Greenspan andava
molto al di là dei suoi poteri
formali: era
il Maestro,
l’Oracolo, il membro più
autorevole del Committee to
Save the World, come si leggeva
in un articolo di copertina
pubblicato da «Time» nel 1999.
Quando
ha
lasciato
l’incarico, Greenspan lo ha fatto
in piena gloria. Alan Blinder,
della Princeton University, lo ha
definito il più grande banchiere
centrale
della
storia.
In
occasione di una delle sue
ultime apparizioni al Congresso,
è stato salutato come una sorta
di messia monetario: «Lei ha
guidato la politica monetaria
attraverso crolli di Borsa,
guerre, attacchi terroristici e
calamità naturali», ha dichiarato
un deputato. «Ha dato un
grande
contributo
alla
prosperità degli Stati Uniti e il
paese le è profondamente
grato».
Poco meno di tre anni dopo,
veniva additato alla pubblica
esecrazione.
La
parabola
di
Alan
Greenspan va ben oltre la sua
moralità personale. Dimostra
anche che i responsabili della
politica economica si erano
convinti di avere tutto quanto
sotto controllo, per poi scoprire,
con orrore – e con lo sconforto
del paese – che non era così.
L’era di Greenspan
Come ha fatto Greenspan a
diventare una vera e propria
leggenda? In gran parte perché
ha governato la Federal Reserve
in un periodo di andamento
generalmente
positivo
dell’economia. Gli anni Settanta
e gli anni Ottanta sono stati
caratterizzati da gravi shock –
da tassi di inflazione e di
disoccupazione a due cifre, e
dalle peggiori crisi economiche
dai tempi della
Grande
Depressione. Per contro, l’era di
Greenspan è stata relativamente
serena. L’inflazione è sempre
stata bassa e le due recessioni
che si sono susseguite durante il
suo mandato sono durate
appena diciotto mesi, almeno
secondo la cronologia ufficiale
(vedi oltre). L’occupazione era
relativamente elevata: alla fine
degli anni Novanta e poi ancora
a metà del decennio successivo,
il tasso di disoccupazione è
sceso a livelli che non si
vedevano dagli anni Sessanta. E
per gli investitori finanziari, gli
anni di Greenspan sono stati
fantastici: l’indice Dow-Jones
ha superato i diecimila punti e il
prezzo delle azioni è cresciuto
mediamente di oltre il 10%
l’anno.
Quali sono effettivamente i
meriti di Greenspan per questa
eccellente
performance
dell’economia?
Sicuramente
meno di quelli attribuitigli. È
stato il suo predecessore, Paul
Volcker, a mettere sotto
controllo
l’inflazione,
realizzando quell’obiettivo con
drastiche politiche monetarie
che hanno causato un forte
rallentamento dell’economia ma
hanno poi spezzato la schiena
alla psicologia inflazionistica.
Dopo il duro e impopolare
lavoro di Volcker, Greenspan ha
potuto godersi tutti i benefici.
Il
buon
andamento
dell’economia aveva anche
poco a che fare con la politica
monetaria. Negli anni di
Greenspan le aziende americane
hanno capito finalmente come
usare
efficacemente
l’informatica.
Quando
si
introduce una nuova tecnologia
ci vuole spesso qualche tempo
prima di vedere i benefici
economici, perché le aziende
devono riorganizzare la propria
struttura
per
sfruttare
adeguatamente l’innovazione. Il
classico esempio è quello della
corrente elettrica. Anche se
negli anni Ottanta del 1800 le
macchine elettriche erano ormai
largamente disponibili, all’inizio
le aziende continuavano a
costruire le fabbriche con il
vecchio
sistema:
edifici
multipiano in cui le macchine
venivano stipate in spazi
ristretti, in base all’esigenza di
avere nei sotterranei un grosso
motore a vapore che azionasse
le aste e le pulegge. Fu solo
dopo la Prima guerra mondiale
che le aziende si accorsero di
non aver più bisogno di una
fonte centralizzata di energia, e
costruirono fabbriche a un solo
piano dalla pianta aperta, con
molto
spazio
per
lo
spostamento dei materiali.
La stessa cosa è avvenuta per
l’informatica.
Il
microprocessore
è
stato
inventato nel 1971, e nei primi
anni Ottanta
i personal
computer erano già molto
diffusi. Ma per molto tempo
ancora gli uffici sono stati gestiti
nello stesso modo in cui lo
erano all’epoca della carta
carbone. Solo a metà degli anni
Novanta le aziende hanno
imparato realmente a sfruttare la
nuova tecnologia per creare
uffici in rete, aggiornamenti
continui delle scorte, e così via.
A quel punto si è verificata una
fortissima accelerazione nel
tasso
di
crescita
della
produttività degli Stati Uniti –
ossia l’output che produce un
lavoratore medio in un’ora.
Questo
incremento
della
produttività ha fatto lievitare i
profitti e ha contribuito a
mettere
sotto
controllo
l’inflazione, favorendo il buon
andamento dell’economia sotto
Greenspan; ma il presidente
della FED non c’entrava per
niente.
Pur non avendo sconfitto
l’inflazione, né creato la
rivoluzione della produttività,
Greenspan
ha
avuto
effettivamente un approccio
particolare alla gestione della
politica monetaria, che all’epoca
sembrava funzionare bene. Qui
bisognerebbe sottolineare la
parola «sembrava», ma prima di
arrivarci vediamo quali erano le
caratteristiche distintive del suo
operato alla presidenza della
FED.
Il guidatore designato
dell’America
Alan Greenspan non è stato il
presidente più «longevo» della
fed. Quell’onore spetta a
William McChesney Martin Jr.,
che guidò la Federal Reserve dal
1951 al 1970. Le filosofie
monetarie dei due uomini non
avrebbero potuto essere più
diverse. Martin dichiarò a suo
tempo che il compito della FED
era «portare via la coppa del
punch quando la festa comincia
a decollare». Intendeva dire che
la fed dovrebbe alzare i tassi di
interesse per impedire a
un’economia in forte crescita di
surriscaldarsi eccessivamente
producendo inflazione. Ma
quella frase veniva interpretata
anche nel senso che la fed
dovrebbe cercare di prevenire
«l’esuberanza irrazionale» – una
tipica espressione di Greenspan
– nei mercati finanziari.
Pur avendo segnalato il
pericolo
dell’eccessiva
esuberanza, Greenspan non ha
mai fatto molto per contenerla.
Ha
usato
l’espressione
«esuberanza irrazionale» in un
discorso del 1996 in cui faceva
capire, senza dirlo apertamente,
che c’era in corso una bolla
speculativa sui prezzi delle
azioni. Ma non ha alzato i tassi
di interesse
per
frenare
l’eccessivo entusiasmo dei
mercati. Non ha cercato
neppure di imporre dei limiti
sulle operazioni a riporto. Ha
atteso invece che la bolla
scoppiasse, nel 2000, per poi
intervenire.
Come spiega causticamente,
ma correttamente, un articolo
della Reuters, Greenspan ha
agito come un genitore che
ammonisce severamente degli
adolescenti a non esagerare, ma
non mette fine alla festa e
rimane pronto a esercitare il suo
ruolo di guidatore designato
quando il divertimento è finito.
Per correttezza nei confronti
di Greenspan bisogna dire che
molti economisti, di entrambi i
partiti politici, hanno condiviso
questa sua dottrina. E la verità è
che la scelta di Greenspan di
non interferire nell’andamento
positivo
dell’economia
ha
funzionato bene almeno sotto
un aspetto: probabilmente, la
spettacolare creazione di posti
di lavoro registrata negli anni
della presidenza Clinton non
sarebbe stata così spettacolare
se ci fosse stato qualcun altro al
timone della FED. La figura
sottostante,
che
mostra
l’andamento del tasso di
disoccupazione negli Stati Uniti
a partire dall’inizio del 1987, è
molto eloquente. I dati ufficiali
sulla recessione sono indicati
dalle barre ombreggiate. La
caratteristica dominante di
questo grafico è il vistoso calo
della disoccupazione tra il 1993
e il 2000, un declino che ha fatto
scendere
il
tasso
di
disoccupazione al di sotto del
4% per la prima volta dal 1970.
In effetti, non è stato Greenspan
a causare questo declino; ma
non
l’ha
minimamente
contrastato. E questa benevola
indifferenza nei confronti del
calo della disoccupazione era
eterodossa e costituiva al tempo
stesso, come si è visto, anche
l’atteggiamento giusto.
Tra l’inizio e la metà degli
anni
Novanta,
la
tesi
convenzionale (che condividevo
anch’io) – era che se il tasso di
disoccupazione fosse sceso
intorno al 5,5%, l’inflazione
avrebbe
cominciato
ad
accelerare.
Fonte: Federal Reserve Bank of
St. Louis 2008. I dati sul tasso
di disoccupazione provengono
dal Bureau of Labor Statistics
dell’US Department of Labor; i
dati sulle recessioni
intervenute nell’economia USA
provengono dal NBER.
Sembrava quella la lezione
dei due decenni precedenti. In
effetti, l’inflazione aveva subito
una forte accelerazione alla fine
degli anni Ottanta, quando il
tasso di disoccupazione si era
avvicinato al 5%. A metà degli
anni Novanta, quando il tasso di
disoccupazione è sceso al di
sotto di quella tradizionale
soglia di pericolo, un gran
numero di economisti hanno
invitato Greenspan ad alzare i
tassi di interesse per prevenire
una ripresa dell’inflazione.
Greenspan, tuttavia, si è
rifiutato di agire prima di aver
visto
un’effettiva
ripresa
dell’inflazione.
Ha
detto
pubblicamente
che
l’accelerazione intervenuta nella
crescita
della
produttività
avrebbe potuto modificare la
storica relazione tra bassa
disoccupazione e accelerazione
dell’inflazione, e ha usato
questa argomentazione per
rinviare l’incremento dei tassi di
interesse fino alla prova provata
dell’effettivo
aumento
dell’inflazione. E si è visto che
qualcosa, in realtà, era cambiato
nell’economia. (Gli economisti
devono ancora decidere che
cosa.) La disoccupazione era
scesa a livelli che non si
vedevano da decenni, eppure
l’inflazione restava ferma. E il
paese avvertiva un senso di
prosperità che non si ricordava
dagli anni Sessanta.
Quanto alla creazione di
nuovi posti di lavoro, la
decisione di lasciare sul tavolo
la coppa del punch mentre
impazzava la festa si è rivelata
una mossa eccellente. Ma
quanto
all’esuberanza
irrazionale
dei
mercati
finanziari,
la
politica
di
Greenspan ha avuto meno
successo. Solo dopo la sua
uscita di scena si sarebbe capito
veramente quanto era stato
improvvido.
Le bolle di Greenspan
Come ho detto prima,
Greenspan metteva in guardia
contro l’esuberanza irrazionale,
ma non ha mai agito
concretamente per frenarla. E
per la verità, l’ex presidente
della FED detiene quello che io
credo
essere
un
record
insuperato tra i banchieri
centrali:
durante
la
sua
presidenza non c’è stata una
sola bolla speculativa sugli
asset, ma ce ne sono state due:
la prima sulle azioni e la
seconda sulle case.
Il grafico riportato alla pagina
seguente mostra la tempistica e
l’entità di queste due bolle. Una
linea mostra il rapporto tra
prezzi delle azioni e utili
aziendali,
un
indicatore
comunemente usato per capire
se le azioni hanno un prezzo
ragionevole. L’altra mostra un
indicatore comparabile per i
prezzi delle case: il rapporto tra i
prezzi delle abitazioni negli Stati
Uniti e gli affitti medi, espresso
sotto forma di indice in cui il
1987 è uguale a 100. Potete
vedere chiaramente la bolla
azionaria degli anni Novanta
seguita dalla bolla degli
immobili
nel
decennio
successivo. Complessivamente,
i prezzi delle case non si sono
mai allontanati dalla norma
storica quanto i prezzi delle
azioni. Ma si tratta di
un’indicazione fuorviante, sotto
vari
aspetti.
Anzitutto,
l’acquisto
della
casa
è
un’operazione
molto
più
importante degli investimenti
azionari, specie per le famiglie
della classe media, per cui la
casa costituisce di solito l’asset
principale. In secondo luogo, il
boom nei prezzi delle case è
stato ineguale: nella parte
centrale degli Stati Uniti, dove i
terreni edificabili abbondano, i
prezzi delle case non hanno mai
superato di molto il tasso di
inflazione; ma nelle zone
costiere, specialmente in Florida
e nella California meridionale, i
prezzi sono saliti ben oltre il
doppio del normale rapporto
con gli affitti. Infine, il sistema
finanziario si è dimostrato
molto più vulnerabile agli effetti
collaterali della caduta dei prezzi
degli immobili che non agli
effetti collaterali di un crollo
azionario, per delle ragioni che
spiegherò nel capitolo 9.
Come si sono determinate
queste bolle? La bolla azionaria
degli anni Novanta rifletteva
probabilmente due fattori. Uno
di essi, un estremo ottimismo
sul potenziale di profitto
dell’information technology, ha
ricevuto
una
grandissima
attenzione.
Il rapporto prezzo-utili
evidenziato nella figura è stato
calcolato da Robert Shiller
della Yale University, che
confronta i prezzi delle azioni
con gli utili medi del decennio
precedente – per eliminare le
fluttuazioni di breve periodo
dei profitti dovuti alle fasi di
boom e alle fasi di crisi.
L’indice dei prezzi delle
abitazioni è l’indice nazionale
Case-Shiller, mentre i dati
relativi agli affitti provengono
dal Bureau of Economie
Analysis.
L’altro, il crescente senso di
sicurezza
sull’andamento
dell’economia, la convinzione
che l’epoca delle pesanti
recessioni fosse definitivamente
alle spalle, non ha avuto
altrettanta considerazione. Ma i
due fattori hanno concorso a
spingere i prezzi delle azioni a
livelli stratosferici.
Oggi tutti conoscono la bolla
delle dot.com, simboleggiata
probabilmente al meglio dal
fenomeno Pets.com che ha
trasformato un modello di
business
assai
dubbio,
accompagnato da un’abile
campagna pubblicitaria, in una
valutazione astronomica. Ma il
problema non ha riguardato
solo le dot.com. In quasi tutti i
settori, le aziende dicevano che
le nuove tecnologie avevano
cambiato tutto, e che le vecchie
regole sui limiti che si
frapponevano al profitto e alla
crescita non si applicavano più.
In non pochi casi, abbiamo poi
saputo, queste storie edificanti
erano sostenute da frodi
contabili. Ma il punto principale
era che gli investitori, visti gli
enormi guadagni conseguiti dai
primi acquirenti di titoli
Microsoft e da altri azionisti che
avevano puntato sull’IT, erano
disposti a credere che molte
altre aziende fossero in grado di
realizzare un analogo miracolo.
In tutto ciò c’era naturalmente
un
equivoco
di
fondo:
nell’economia non c’era posto
per tutte le future Microsoft che
la gente pensava di aver
identificato. Ma la pubblicità ha
una sua eterna efficacia, e la
gente era disposta a sospendere
le proprie facoltà razionali.
Sembravano esserci anche
delle ragioni più serie per
acquistare azioni. Era ben noto
agli economisti e agli esperti di
finanza che le azioni erano
sempre state un
ottimo
investimento, almeno per coloro
che erano disposti a tenerle a
lungo in portafoglio. In
economia c’era una ricca
letteratura sul mistero del
«premio azionario»: le azioni
facevano regolarmente tanto
meglio
di
investimenti
alternativi come le obbligazioni,
che non si riusciva a capire
perché la gente non ci mettesse
tutti i suoi soldi. La risposta
stava probabilmente nella paura:
le grandi perdite azionarie degli
anni Trenta e il ricordo più
recente di come le azioni si
erano volatilizzate in presenza
della stagflazione degli anni
Settanta – il valore reale delle
azioni diminuì del 7% all’anno
tra il 1968 e il 1978 –
obbligavano gli investitori a un
atteggiamento di cautela. Ma
nonostante la persistenza della
Grande Moderazione, con una
bassa inflazione e l’assenza di
gravi recessioni, la paura è
venuta gradualmente meno.
Libri come Dow 36.000, che si
basava su
una versione
ingarbugliata della letteratura sul
premio azionario (gli autori
avevano
completamente
sbagliato i calcoli, ma chi
sarebbe andato a controllare?),
sono
diventati
autentici
bestseller.
E con l’incremento dei corsi
azionari, la bolla ha cominciato
ad
autoalimentarsi.
Indipendentemente
dalle
argomentazioni più o meno
ragionevoli a favore degli
investimenti azionari, intorno al
1998 la gente vedeva che
chiunque avesse acquistato
delle azioni aveva guadagnato
un sacco di soldi, mentre chi
stava prudentemente a guardare
rimaneva a bocca asciutta.
Perciò sempre più fondi hanno
puntato sul mercato azionario, i
prezzi sono cresciuti ancora e la
bolla
ha
continuato
a
espandersi,
apparentemente
senza limiti.
Ma naturalmente un limite
c’era. Come ha osservato
Robert Shiller, l’autore di
Irrational Exuberance, una
bolla speculativa sugli asset è
una sorta di catena di
Sant’Antonio in cui le persone
continuano a fare soldi finché ci
sono altri gonzi da sfruttare. Ma
alla fine i gonzi finiscono, e
l’intera piramide crolla. Nel
caso delle azioni, il punto
massimo è stato raggiunto
nell’estate del 2000. Nei due
anni successivi le azioni hanno
perso in media il 40% del loro
valore.
Poco dopo ha cominciato a
gonfiarsi la bolla successiva.
La bolla immobiliare, in un
certo senso, era ancora meno
giustificata di quella azionaria
del decennio precedente. Sì, era
del tutto insensato esaltarsi per
Pets.com e per tutte le altre
imprese online, ma si stava
comunque aprendo un nuovo
ed
eccitante
universo
tecnologico
da
sfruttare.
Aggiungeteci il fatto che la
performance macroeconomica
era effettivamente migliorata –
la stagflazione non era più una
minaccia consistente, e le
fluttuazioni del ciclo economico
sembravano essersi attenuate –
e c’erano tutti i presupposti per
credere che certe regole del
passato non si applicassero più.
Ma che cosa giustificava una
bolla
speculativa
sulle
abitazioni? Sappiamo perché i
prezzi delle case hanno
cominciato ad aumentare: nei
primi anni di questo decennio i
tassi di interesse erano molto
bassi, per ragioni che spiegherò
tra poco, il che rendeva
attraente la prospettiva di
investire in immobili. E
naturalmente ciò giustificava
una certa lievitazione dei prezzi.
Non giustificava, tuttavia, la
convinzione che le vecchie
regole non si applicassero più.
Le case sono case: gli americani
sono abituati da sempre ad
acquistare la casa con il mutuo,
ma è difficile capire perché
intorno al 2003 qualcuno
avrebbe dovuto credere che i
princìpi fondamentali di questo
sistema
di
finanziamento
fossero venuti meno. In base a
una lunga esperienza, sapevamo
che chi compra casa non
dovrebbe accollarsi dei mutui
che non può permettersi di
pagare, e che dovrebbe
anticipare
una
somma
sufficiente a sostenere un
moderato calo dei prezzi pur
mantenendo un valore positivo.
I bassi tassi di interesse
avrebbero dovuto tutt’al più
modificare al ribasso l’entità
delle rate di pagamento del
mutuo.
Abbiamo assistito invece a
un completo abbandono dei
princìpi tradizionali. Questo
fenomeno era dovuto in
qualche misura all’esuberanza
irrazionale di singole famiglie
che vedevano i prezzi degli
immobili salire continuamente e
stabilivano di dover entrare nel
mercato, senza preoccuparsi di
come rimborsare il mutuo. Ma
era dovuto in misura maggiore a
un sensibile mutamento delle
pratiche di finanziamento. Agli
acquirenti si concedevano
mutui
immobiliari
senza
anticipo o con un anticipo
irrisorio, con rate mensili che
andavano molto al di là della
loro capacità di rimborso – o
diventavano
inaccessibili
quando veniva rialzato il basso
interesse iniziale. Gran parte di
questi finanziamenti a rischio
rientravano nella categoria dei
cosiddetti «subprime», ma il
fenomeno era molto più vasto.
E non erano solo gli acquirenti a
basso reddito, o appartenenti a
minoranze svantaggiate, ad
accendere mutui che non
potevano ripagare; lo facevano
tutti.
Perché gli enti finanziatori
hanno allentato i vincoli?
Anzitutto, si erano convinti che
i prezzi delle case avrebbero
continuato
a
crescere
all’infinito. E finché i prezzi
salgono, al finanziatore non
interessa più di tanto se il
mutuatario è in grado di pagare
le rate; se sono troppo alte,
l’acquirente
può
iscrivere
un’ipoteca sull’immobile per
avere più liquidità o, nella
peggiore delle ipotesi, può
vendere la casa e rimborsare il
mutuo. In secondo luogo, i
finanziatori
non
si
preoccupavano della qualità dei
propri mutui perché non li
tenevano in portafoglio. Li
vendevano a degli investitori,
che non capivano che cosa
stavano comprando.
La «cartolarizzazione» dei
prestiti
immobiliari
–
l’assemblaggio di un gran
numero di mutui, seguito dalla
vendita agli investitori di quote
dei pagamenti ricevuti dai
mutuatari – non è una pratica
nuova. In effetti è stata avviata
da Fannie Mae, l’agenzia di
finanziamenti sponsorizzata dal
governo che fu costituita negli
anni Trenta. Ma fino alla grande
bolla
immobiliare,
la
cartolarizzazione era quasi
completamente limitata ai mutui
«prime»: quelli concessi a delle
persone che erano in grado di
anticipare
una
somma
consistente e avevano un
reddito sufficiente a rimborsare
le rate. Di tanto in tanto
andavano in default anche
questi mutuatari, a seguito della
perdita del lavoro o di una
emergenza sanitaria; ma i tassi
di insolvenza erano bassi e gli
acquirenti di titoli basati sui
mutui sapevano, a grandi linee,
a che cosa potevano andare
incontro.
L’innovazione finanziaria che
ha
reso
possibile
la
cartolarizzazione dei mutui
subprime
è
stata
la
collateralizated debt obligation,
o CDO. La CDO offriva quote
dei pagamenti di un pool di
mutui – ma non tutte le quote
nascevano uguali. Alcune erano
«senior», ossia godevano di un
«privilegio»
rispetto
ai
pagamenti
effettuati
dai
mutuatari. Solo dopo la
soddisfazione di questi crediti
privilegiati, venivano liquidati i
creditori di secondo e terzo
grado. In linea di principio,
questo meccanismo avrebbe
dovuto fare delle quote senior
un investimento oltremodo
sicuro: anche se alcuni prestiti
fossero andati in default, quanto
era
probabile
che
ne
«saltassero» abbastanza da
porre dei problemi per il cash
flow delle quote privilegiate?
(Era molto probabile, si è poi
scoperto – ma all’epoca non si
sapeva). Le agenzie di rating
erano disposte perciò ad
attribuire la tripla A alle quote
«senior» delle CDO, anche se i
mutui sottostanti erano a
rischio. Questo atteggiamento
ha aperto la strada al
finanziamento su vasta scala dei
mutui subprime, perché ci sono
molti investitori istituzionali,
come i fondi pensione, che
vogliono solo titoli garantiti
dalla tripla A ma erano
dispostissimi ad acquistare degli
asset finanziari classificati AAA
che
davano
rendimenti
notevolmente più elevati dei
normali bond.
Finché i prezzi degli immobili
continuavano a salire, tutto
sembrava andare per il verso
giusto, e la piramide finanziaria
continuava a crescere. C’erano
poche insolvenze, i titoli basati
sui mutui davano rendimenti
elevati, e il mercato immobiliare
continuava a crescere. Alcuni
economisti, incluso per la verità
il
sottoscritto,
avevano
segnalato la formazione di una
grande bolla speculativa sugli
immobili, la cui implosione
avrebbe creato gravi rischi per
l’economia. Ma i numi tutelari
del nostro sistema economico si
sono dichiarati di tutt’altro
avviso. Alan Greenspan, in
particolare, ha dichiarato che un
forte declino nei prezzi delle
case appariva «del tutto
improbabile». Ci poteva essere,
al massimo, qualche «bollicina»
nei mercati immobiliari locali,
ma non c’era comunque una
bolla nazionale.
In realtà c’era, e ha
cominciato a sgonfiarsi nel 2006
– prima lentamente e poi con
sempre maggiore velocità. A
quel punto Greenspan non era
più presidente della FED,
avendo lasciato il posto a Ben
Bernanke. Ma Greenspan aveva
ancora una fortissima influenza:
la
FED
(e
con
lei
l’amministrazione Bush) era
convinta che gli effetti della crisi
immobiliare
si
potessero
«contenere»; che Bernanke,
come
Greenspan,
potesse
fungere da guidatore designato
dell’America.
Ma l’esperienza successiva
all’implosione
della
bolla
azionaria avrebbe dovuto far
capire chiaramente che si
trattava di una fiducia mal
riposta.
Quando le bolle scoppiano
Ciò che è accaduto subito
dopo l’implosione della bolla
azionaria degli anni Novanta
viene descritto di solito in questi
termini: dopo l’implosione della
bolla, l’economia Americana è
entrata in recessione, ma
Greenspan
ha
ridotto
aggressivamente i tassi di
interesse e ha rapidamente
ribaltato la situazione. La
recessione è stata modesta, in
quanto non ha comportato
grosse diminuzioni del PIL, e
breve, in quanto è durata
appena otto mesi.
La vera storia è un’altra:
ufficialmente la recessione è
stata breve, ma il mercato del
lavoro
ha
continuato
a
deteriorarsi per molto tempo
dopo la fine ufficiale della
recessione. Lo potete vedere
nella figura di pagina 161: il
tasso di disoccupazione (la
barra
ombreggiata)
ha
continuato a salire anche nei
mesi successivi. La fase di
decrescita dell'occupazione è
durata in effetti due anni e
mezzo, non otto mesi.
Forse vi chiederete perché, in
questo caso, la recessione è
stata dichiarata conclusa tanto
presto. Be’, negli Stati Uniti le
date ufficiali di inizio e fine della
recessione vengono determinate
da un comitato indipendente di
economisti, legati al National
Bureau of Economie Research.
Il comitato prende in esame
tutta una serie di indicatori –
occupazione,
produzione
industriale, consumi, PIL. Se
tutti questi indicatori puntano al
ribasso, si dichiara la recessione.
Alla fine del 2001, la
produzione industriale e il PIL
erano in crescita, seppure
lentamente; di qui la fine della
recessione ufficiale. Ma come
abbiamo visto, il mercato del
lavoro era ancora in declino.
E la FED era seriamente
preoccupata per la debolezza
del mercato del lavoro e per il
rallentamento
generale
dell’economia, che sembrava
ricordare fin troppo da vicino la
situazione del Giappone negli
anni
Novanta.
Greenspan
avrebbe poi scritto di aver
temuto
una
«deflazione
corrosiva». Perciò ha continuato
a tagliare i tassi di interesse, fino
ad abbassare il tasso di sconto
all’1%.
Quando alla fine la politica
monetaria ha fatto presa, è stato
grazie
al
mercato
delle
abitazioni. Gli scettici dicono
che Greenspan è riuscito a
rilanciare
l’economia
solo
sostituendo alla bolla azionaria
una bolla immobiliare. E la
domanda che tutti avrebbero
dovuto porsi (ma pochi si sono
posti) era: «Che cosa accadrà
quando si sgonfierà la bolla
immobiliare?» La FED era
riuscita a malapena a tirar fuori
l’economia dalla crisi ingenerata
dalla bolla azionaria, e ci era
riuscita solo perché aveva avuto
la fortuna che si creasse un’altra
bolla al momento giusto.
Sarebbe riuscita a ripetere
l’impresa?
Alla fine, quando è scoppiata
la
bolla
immobiliare,
le
conseguenze sono state peggiori
di
quanto
si
potesse
immaginare. Perché? Perché il
sistema era cambiato con
modalità che nessuno aveva
capito fino in fondo.
8. IL SISTEMA
BANCARIO-OMBRA
Le banche sono istituzioni
meravigliose,
quando
funzionano. E di solito è così.
Ma quando non funzionano,
può scatenarsi un putiferio –
come è avvenuto Fanno scorso
negli Stati Uniti e in gran parte
del mondo.
Ma l’epoca delle crisi
bancarie
non
era
finita
settantanni fa? Le banche non
sono regolamentate, assicurate,
stragarantite? Sì e no. Sì per le
banche tradizionali; no per gran
parte del sistema bancario
moderno.
Per capire il problema,
conviene fare una breve storia
dell’attività bancaria e della sua
regolamentazione.
Storia semplificata
dell’attività bancaria
Le banche moderne sono
state create dagli orafi, che oltre
a fabbricare gioielli (la loro
attività principale), avevano
sviluppato
un
redditizio
business collaterale tenendo in
custodia le monete di altre
persone:
avendo
solide
casseforti, le botteghe degli orafi
offrivano più sicurezza ai ricchi
rispetto, mettiamo, a un forziere
nascosto sotto il letto. (Pensate
a Silas Marner.)
A un certo punto gli orafi
scoprirono di poter rendere
ancora più redditizio quel
business collaterale prendendo
una parte delle monete che
avevano
in
deposito
e
prestandole a interesse. Forse
penserete che così facendo si
siano creati dei problemi: che
cosa sarebbe successo se i
legittimi
proprietari
delle
monete date a prestito si fossero
presentati e ne avessero preteso
la consegna immediata? Ma gli
orafi avevano capito che in base
alla legge delle medie si trattava
di un’ipotesi quanto mai
improbabile: in un determinato
giorno alcuni dei depositanti
sarebbero venuti a pretendere
indietro le loro monete, mentre
gli altri non si sarebbero fatti
vedere. Bastava perciò tenere di
riserva solo una piccola parte
delle monete in deposito; tutte
le altre si potevano mettere a
frutto. Nasceva così l’attività
bancaria.
Ogni tanto, tuttavia, le cose si
mettevano terribilmente male.
Si spargeva la voce – forse vera
o forse falsa – che gli
investimenti della banca erano
andati male, per cui non aveva
più fondi per rimborsare i
depositanti. Bastava quella voce
per indurre i depositanti a
ritirare in fretta e furia i loro
soldi prima che sparissero del
tutto – quella che definiamo
«corsa agli sportelli». E la corsa
agli sportelli mandava spesso in
fallimento la banca anche se la
voce era falsa: per raccogliere
rapidamente fondi, la banca
doveva svendere i propri asset a
prezzi di liquidazione; e a quei
prezzi non avrebbe certamente
avuto asset sufficienti a sanare
le posizioni debitorie nei
confronti
dei
depositanti.
Poiché le corse agli sportelli,
anche se basate su voci false,
potevano mandare in fallimento
istituzioni in ottima salute,
questi eventi si sono trasformati
in profezie autoavverantisi: una
banca poteva fallire non perché
giravano delle voci circa i suoi
investimenti che sarebbero
andati male, ma semplicemente
perché si diceva che avrebbe
subito una corsa agli sportelli.
E a causare questo rumor
poteva essere il fatto che altre
banche
avevano
dovuto
rimborsare
in
massa
i
depositanti. La storia del
sistema finanziario degli Stati
Uniti prima della Grande
Depressione è costellata di
«panici»: il panico del 1873, il
panico del 1907, e così via.
Questi panici erano quasi
sempre contagiose serie di corse
agli sportelli in cui il tracollo di
ogni banca minava la fiducia in
altre banche, e le istituzioni
finanziarie crollavano come le
tessere del domino.
Detto per inciso, qualunque
somiglianza
tra
questa
descrizione dei panici anteDepressione e il contagio
finanziario che ha travolto
l’Asia alla fine degli anni
Novanta non è per nulla
casuale. Tutte le crisi finanziarie
tendono
fatalmente
ad
assomigliarsi.
Il problema delle crisi
bancarie dovute al panico ha
ovviamente messo in moto la
ricerca di una soluzione. Tra la
guerra civile e la Prima guerra
mondiale, gli Stati Uniti non
avevano una banca centrale – la
Federal Reserve fu creata nel
1913 – ma avevano un sistema
di «banche nazionali» che erano
soggette
a
una
limitata
regolamentazione. E in alcuni
distretti i banchieri misero
assieme le proprie risorse per
creare
«stanze
di
compensazione» locali che
avrebbero
garantito
congiuntamente i depositi dei
clienti nell’eventualità di una
corsa agli sportelli; e alcuni
governi statali cominciarono a
offrire un’assicurazione sui
depositi giacenti presso le
banche.
Il panico del 1907, tuttavia,
mise in luce i limiti di questo
sistema
(e
prefigurò
sinistramente la crisi attuale).
Quella crisi ebbe inizio nei
«trust» di New York, istituzioni
para-bancarie che accettavano
depositi ma erano nate in
origine per gestire solo grandi
patrimoni. Poiché avrebbero
dovuto impegnarsi unicamente
in attività a basso rischio, i trust
erano meno regolamentati e
avevano meno vincoli di riserva,
e meno riserve liquide, delle
banche nazionali. Ma con il
boom economico del primo
decennio del XX secolo, i trust
iniziarono a speculare nel
mercato immobiliare e nel
mercato azionario, da cui le
banche nazionali erano escluse.
Essendo meno regolamentati
delle banche nazionali, i trust
potevano
corrispondere ai
depositanti dei rendimenti più
elevati.
Nel
frattempo
sfruttavano la reputazione di
solidità delle banche nazionali, e
i depositanti li consideravano
altrettanto
sicuri.
Di
conseguenza,
crebbero
rapidamente: nel 1907 il valore
totale degli asset posseduti dai
trust di New York era uguale al
totale degli asset posseduti dalle
banche nazionali. Intanto, i trust
avevano rifiutato di entrare a far
parte
della
New
York
Clearinghouse, un consorzio di
banche nazionali newyorkesi
che garantivano l’una la solidità
dell’altra, perché ciò avrebbe
imposto loro di tenere riserve
liquide
più
elevate,
comprimendo i profitti.
Il panico del 1907 iniziò con
il fallimento del Knicker-bocker
Trust,
un
grande
trust
newyorkese che fallì dopo aver
finanziato
una
disastrosa
speculazione azionaria su vasta
scala. Gli altri trust di New York
finirono immediatamente sotto
pressione, mentre i depositanti
terrorizzati facevano lunghe
code per ritirare i propri fondi.
La New York Clearinghouse si
rifiutò di intervenire e di
finanziare i trust, che si
trovarono tutti quanti, anche i
più sani, in gravissime difficoltà.
Nel giro di due giorni, una
dozzina
di
grandi
trust
andarono in fallimento. I
mercati finanziari si bloccarono
e la Borsa ebbe un tracollo
perché gli investitori non
riuscivano a ottenere credito; e
la fiducia nelle imprese venne
meno.
Per fortuna, l’uomo più ricco
di New York, un banchiere di
nome J.P. Morgan, intervenne
rapidamente per mettere fine al
panico. Rendendosi conto che
la crisi si stava diffondendo e
che avrebbe inghiottito ben
presto istituzioni in piena salute,
non solo trust, ma anche
banche, collaborò con altri
banchieri, ricchi finanzieri come
John D. Rockefeller, e il
segretario al Tesoro degli Stati
Uniti per sostenere le riserve
delle banche e dei trust in modo
che potessero reggere all’ondata
di ritiri. Quando i depositanti
ebbero la certezza di poter
riavere tutti i loro soldi, il panico
finì. Anche se durò poco più di
una settimana, insieme al crollo
del mercato azionario, esso
decimò l’economia. Ne seguì
una recessione durata quattro
anni, che fece diminuire la
produzione
dell'11%
e
aumentare la disoccupazione
dal 3% all’8%.
Anche se il disastro era stato
evitato per un pelo, aspettarsi
che J.P. Morgan salvasse il
mondo una seconda volta non
sembrava una buona idea,
neppure nella Gilded Age.
Perciò al panico del 1907 seguì
una riforma del sistema
bancario. Nel 1913 il sistema
delle banche nazionali fu
eliminato e venne creato il
Federal Reserve System con
l’obiettivo di costringere tutte le
istituzioni che raccoglievano
depositi a tenere adeguate
riserve e ad aprire i conti a
periodiche ispezioni da parte
degli enti regolatori.
Pur avendo standardizzato e
centralizzato la gestione delle
riserve, il nuovo regime non
eliminava la minaccia delle
corse agli sportelli – e la crisi
bancaria più drammatica della
storia si determinò nei primi
anni
Trenta.
Con
il
rallentamento dell’economia, i
prezzi
delle
commodity
precipitarono; questa situazione
colpì duramente i già indebitati
agricoltori
americani,
scatenando una serie di default
sui prestiti, seguita da corse agli
sportelli che si susseguirono nel
1930, nel 1931 e nel 1933,
partendo in tutti e tre i casi da
banche del Midwest per
estendersi poi a tutto il paese.
C’è un consenso pressoché
unanime tra gli storici sul fatto
che sia stata la crisi bancaria a
trasformare
una
pesante
recessione
nella
Grande
Depressione.
La risposta fu la creazione di
un sistema molto più tutelato. Il
Glass-Steagall Act separava le
banche in due categorie: le
banche
commerciali,
che
accettavano depositi, e le
banche d’investimenti, che non
li accettavano. Le banche
commerciali erano soggette a
pesanti restrizioni sui rischi da
assumere; in cambio avevano
un immediato accesso al credito
erogato dalla FED (la cosiddetta
discount window); e cosa più
importante in assoluto, i loro
depositi erano garantiti dal
contribuente.
Le
banche
d’investimenti erano molto
meno regolamentate, ma ciò era
sopportato perché, in quanto
istituzioni che non accettavano
depositi, non erano esposte alle
temutissime corse agli sportelli.
Il nuovo sistema ha protetto
l’economia dalle crisi finanziarie
per quasi settant’anni. Ci sono
stati spesso dei momenti difficili
– soprattutto negli anni Ottanta,
quando una combinazione di
sfortuna e di politiche improprie
portò al fallimento di molte
savings & loans (casse di
risparmio), una categoria di
banche
che
avevano
il
predominio
nei
mutui
immobiliari. Poiché i depositi
giacenti presso le S&L erano
assicurati a livello federale, sono
stati i contribuenti a pagare il
conto, nell’ordine del 5% del
PIL (l’equivalente di oltre
settecento miliardi di dollari di
oggi). Il tracollo delle S&L ha
causato
una
temporanea
rarefazione del credito, una
delle cause principali della
recessione
del
1990-1991,
visibile nella figura di pagina
161. Ma è stata molto pesante.
Ci hanno detto che l’epoca delle
crisi bancarie era finita, ma non
lo era.
Il sistema bancario-ombra
Che cos’è una banca?
Può sembrare una domanda
idiota. Sappiamo tutti che cos’è
una banca: un grande edificio
tutto marmi – ok, oggi potrebbe
benissimo
essere
un
microsportello all’interno di un
centro commerciale – in cui i
cassieri ritirano e danno soldi,
ed espone sulla vetrina la scritta
«FDIC insured».
Dal punto di vista di un
economista, tuttavia, le banche
non vengono definite in base al
loro aspetto esteriore, ma in
base a ciò che fanno.
Dall’epoca
di
quegli
intraprendenti orafi al giorno
d’oggi,
la
caratteristica
essenziale dell’attività bancaria
è la promessa di una pronta
fornitura di liquidità a coloro
che le affidano i propri soldi,
anche se la banca investe gran
parte di quei soldi in asset che
non si possono liquidare da un
momento all’altro. Qualunque
istituzione o entità che svolga
questo lavoro si considera una
banca, anche se non risiede in
un grande edificio tutto marmi.
Considerate, per esempio
uno strumento noto come
«auction-rate security», che è
stato inventato dalla Lehman
Brothers nel 1984 ed è divenuto
una fonte preferenziale di
finanziamento
per
molte
istituzioni, dalla Port Authority
of New York and New Jersey al
Metropolitan Museum of Art di
New York. Lo strumento
funzionava così: delle persone
prestavano soldi a lungo
termine
all’istituzione
finanziatrice;
in
termini
giuridici, quei soldi si potevano
vincolare fino a trent’anni. A
intervalli frequenti, tuttavia,
l’istituzione teneva una piccola
asta in cui potenziali nuovi
investitori si contendevano il
diritto di sostituire gli investitori
che volevano uscire. Il tasso di
interesse determinato da questa
competizione tra offerte si
sarebbe applicato al titolo fino
all’asta successiva e così via. Se
l’asta falliva – perché non
c’erano abbastanza offerenti da
lasciare uscire tutti quelli che
volevano uscire – il tasso di
interesse sarebbe salito a un
livello penalizzante, mettiamo,
del 15%; ma era un’eventualità
estremamente
improbabile.
L’idea alla base di un titolo il cui
tasso veniva stabilito attraverso
un’asta era riconciliare il
desiderio dei finanziati di avere
a disposizione fondi di lungo
termine con il desiderio dei
finanziatori di poter riavere
prontamente i loro soldi.
Ma è esattamente quello che
fa una banca.
Eppure
le
«auction-rate
securities» sembravano offrire a
tutti condizioni più favorevoli
rispetto a quelle offerte dal
rapporto bancario tradizionale.
Coloro che investivano in questi
titoli ottenevano dei tassi di
interesse più elevati rispetto a
quelli che avrebbero ottenuto
sui depositi bancari, mentre le
istituzioni emittenti pagavano
tassi più bassi di quelli che
avrebbero pagato sui prestiti a
breve termine. Milton Friedman
ci ha insegnato che i pasti
gratuiti non esistono, eppure le
auction-rate
securities
sembravano offrire proprio
quello. Come facevano?
Be’, la risposta appare ovvia,
quantomeno
in
un’ottica
retrospettiva: le banche sono
fortemente
regolamentate;
devono tenere delle riserve
liquide, mantenere un capitale
elevato e contribuire al sistema
di assicurazione dei depositi.
Raccogliendo fondi attraverso
quei titoli, il cui tasso di
rendimento veniva determinato
mediante un’asta, i clienti
potevano
aggirare
queste
disposizioni e i relativi costi. Ma
le auction-rate securities non
erano tutelate dalla rete di
sicurezza del sistema bancario.
Sta di fatto che il sistema
delle auction-rate securities, che
nel momento più favorevole
valeva quattrocento miliardi di
dollari, è crollato all’inizio del
2008. Una dopo l’altra, le aste
fallivano perché i nuovi
investitori che avrebbero dovuto
sostituire gli investitori in uscita
erano troppo pochi. Coloro che
pensavano di poter riavere
immediatamente indietro i
propri soldi hanno scoperto così
da un giorno all’altro che quei
fondi erano immobilizzati in
investimenti pluridecennali da
cui non potevano uscire. E il
fallimento di ogni asta causava
il fallimento di un’altra asta.
Dopo aver toccato con mano i
pericoli di questi schemi di
investimento
fin
troppo
sofisticati, chi voleva più
immettere denaro fresco nel
sistema? Ciò che è accaduto alle
auction-rate securities era, fatta
eccezione per il nome, una
contagiosa serie di corse agli
sportelli.
Il parallelismo con il panico
del 1907 dovrebbe essere
evidente. Nei primi anni del XX
secolo i trust, le istituzioni
parabancarie che sembravano
offrire condizioni più favorevoli
perché in grado di operare al di
fuori
del
sistema
regolamentativo,
crebbero
rapidamente, per poi diventare
l’epicentro
di
una
crisi
finanziaria. Un secolo dopo, è
accaduta la stessa cosa.
Oggi, le istituzioni e gli enti
che agiscono da «banche-non
banche» vengono generalmente
denominati «sistema bancario
parallelo» o «sistema bancarioombra». Penso che questa
seconda definizione sia più
descrittiva, e
anche
più
pittoresca.
Le
banche
tradizionali, che ricevono i
depositi e fanno parte del
Federal
Reserve
System,
operano più o meno alla luce
del sole, con una contabilità
trasparente e sotto la costante
vigilanza degli enti regolatori.
Le attività delle istituzioni che
non accettano depositi ma sono
banche di fatto, per contro,
sono molto più opache. In
effetti, fino all’arrivo della crisi
pochi sembrano aver capito
quanto era diventato importante
il sistema bancario-ombra.
Nel giugno 2008 Timothy
Geithner, il presidente della
New York Federal Reserve
Bank, ha tenuto un discorso
all’Economic Club di New York
in cui ha cercato di spiegare
perché la fine della bolla
immobiliare avrebbe potuto
causare dei gravissimi danni
finanziari (Geithner non lo
sapeva, ma il peggio doveva
ancora arrivare). Anche se il
discorso era necessariamente
scritto nel linguaggio delle
banche centrali, con una
pesante dose di gergo tecnico,
lo shock di Geithner per la
misura in cui il sistema era
sfuggito
al
controllo
si
percepisce chiaramente:
La struttura del sistema
finanziario si è modificata
radicalmente durante il boom,
con una fortissima crescita
della quota di asset collocati
al di fuori del sistema
bancario tradizionale. Questo
sistema
finanziario
nonbancario è diventato enorme,
specie nei mercati del credito
e dei finanziamenti. All’inizio
del 2007, gli asset-backed
commercial paper, sotto forma
di veicoli strutturati di
investimento, di auction-rate
securities, di tender option
bond e note di domanda a
tasso
variabile, valevano
complessivamente circa 2,2
trilioni di dollari. Gli asset
finanziati da un giorno all’altro
in triangolazioni pronti contro
termine sono saliti a 2,5
trilioni di dollari. Gli asset
detenuti dai fondi speculativi
sono saliti a circa 1,8 trilioni
di
dollari.
Gli
stati
patrimoniali delle
cinque
principali
banche
di
investimenti sono arrivati a
totalizzare 4 trilioni di dollari.
Per fare un confronto, nello
stesso periodo, gli asset
complessivi delle prime cinque
banche degli Stati Uniti erano di
poco superiori a 6 trilioni di
dollari e gli asset complessivi
dell’intero sistema bancario
sfioravano i 10 trilioni di dollari.
Dopodiché Geithner ha preso
in considerazione tutta una serie
di strumenti finanziari, non solo
le auction-rate securities, che
facevano parte del «sistema
finanziario non bancario»: enti
che non erano banche dal punto
di vista regolamentativo, ma
esercitavano
comunque
l’attività bancaria. E ha
proseguito
sottolineando
l’estrema
vulnerabilità
del
nuovo sistema:
L’entità degli asset di lungo
termine
rischiosi
e
relativamente
illiquidi,
finanziati da passività di
brevissimo termine, ha reso
molti dei veicoli e delle
istituzioni che operano in
questo sistema finanziario
parallelo
vulnerabili
alla
classica corsa agli sportelli;
ma senza le tutele, come
l’assicurazione dei depositi, di
cui dispone il sistema bancario
per ridurre questi rischi.
In effetti, parecchi dei settori
descritti da Geithner sono già
crollati: le auction-rate securities
sono sparite, come ho già detto;
l’asset-backed
commercial
paper (titoli di debito a breve
termine emessi da fondi che
hanno investito i soldi in asset
di lungo termine, tra cui
obbligazioni sorrette dai mutui)
ha perso qualunque attrattiva;
due delle cinque maggiori
banche di investimento sono
fallite e un’altra si è fusa con
una banca tradizionale; e così
via. Si scopre inoltre che
Geithner non aveva individuato
alcuni altri grossi punti di
vulnerabilità: in effetti, il
governo
ha
dovuto
nazionalizzare
l’AIG,
la
compagnia di assicurazioni più
grande del mondo, e il carry
trade – una pratica speculativa
internazionale che trasferiva
fondi dal Giappone e da altri
paesi a bassi tassi di interesse a
investimenti
a
più
alto
rendimento in altri paesi – è
imploso mentre questa nuova
edizione andava in stampa.
Ma rinviamo l’analisi della
crisi al prossimo capitolo, e
interroghiamoci invece su ciò
che l’ha determinata: perché si è
permesso al sistema di diventare
così vulnerabile?
Indifferenza malevola
La crisi finanziaria ha
scatenato inevitabilmente la
caccia ai colpevoli. Alcune
accuse erano totalmente false,
come la tesi, popolare nella
destra, secondo cui tutti i nostri
problemi sarebbero stati causati
dal Community Reinvestment
Act, che avrebbe obbligato le
banche a prestare soldi ai
membri delle minoranze che
volevano comprare casa e poi
non sono più stati in grado di
rimborsare i mutui. In realtà,
quella legge è stata approvata
nel 1977, il che impedisce di
capire come la si possa
incolpare di una crisi che si è
determinata ben tre decenni
dopo. In ogni caso, il
Community Reinvestment Act
si applicava solo alle banche di
deposito, che hanno avuto una
quota minima di insolvenze
durante la bolla immobiliare.
Altre accuse contengono un
briciolo di verità, ma sono più
ingiuste
che
giuste.
I
conservatori puntano il dito su
Fannie Mae e Freddie Mac, le
agenzie
sponsorizzate
dal
governo che hanno avviato la
cartolarizzazione, incolpandole
di aver causato la bolla
immobiliare e la fragilità del
sistema finanziario. Il briciolo di
verità è che Fannie e Freddie,
che
erano
enormemente
cresciute tra il 1990 e il 2003 –
soprattutto perché erano venute
a riempire il vuoto creato dal
tracollo di molte casse di
risparmio – avevano erogato dei
prestiti non adeguatamente
garantiti, ed erano state al centro
di scandali amministrativi. Ma
l’attenzione
pubblica
che
avevano attirato per effetto di
quegli scandali ha tenuto Fannie
e Freddie sostanzialmente ai
margini durante il periodo più
«caldo» della bolla immobiliare,
tra il 2004 e il 2006. Di
conseguenza, le due agenzie
hanno avuto solo un ruolo
secondario nell’epidemia di
insolvenza sui prestiti.
Nella sinistra si tende a dare
la colpa della crisi alla
deregolamentazione – e in
particolare all’abrogazione, nel
1999, del Glass-Steagall Act,
che ha consentito alle banche
commerciali
di
entrare
nell’investment
banking
e
quindi di assumersi maggiori
rischi. In un’ottica retrospettiva,
si trattava sicuramente di una
mossa nella direzione sbagliata
e potrebbe aver contribuito
indirettamente alla crisi: per
esempio, alcune delle rischiose
strutture finanziarie create negli
anni del boom erano le
operazioni «fuori bilancio» delle
banche commerciali. Ma la crisi,
in linea generale, non ha
riguardato
istituzioni
deregolamentate che si sono
assunte nuovi rischi. Ha
riguardato i rischi assunti da
istituzioni che non erano mai
state regolamentate.
E secondo me, è questo il
nodo cruciale. Quando il
sistema bancario-ombra si è
espanso per rivaleggiare con il
sistema bancario tradizionale o
superarlo in importanza, i
politici e i funzionari governativi
avrebbero dovuto rendersi
conto che stavamo ricreando
quella vulnerabilità finanziaria
che aveva reso possibile la
Grande Depressione – e
avrebbero
dovuto
reagire
estendendo la regolamentazione
e la rete di sicurezza finanziaria
in modo da coprire queste
nuove
istituzioni.
Dei
personaggi influenti avrebbero
dovuto fissare una regola molto
semplice: qualunque entità che
faccia quello che fa una banca,
qualunque entità che dev’essere
salvata nei momenti di crisi
come vengono salvate le
banche,
dovrebbe
essere
regolamentata come una banca.
In realtà, la crisi del fondo
Long
Term
Capital
Management, descritta nel
capitolo 6, avrebbe dovuto
costituire una preziosa lezione
sui pericoli apportati dal sistema
bancario-ombra.
Certamente
erano in tanti a sapere quanto si
era avvicinato al collasso il
sistema.
Ma questo monito è stato
ignorato, e non si è fatto
alcunché per estendere la
regolamentazione. Anzi, lo
spirito dei tempi – e l’ideologia
dell’amministrazione di George
W.
Bush
–
erano
profondamente contrari alla
regolamentazione.
Questo
atteggiamento era simboleggiato
da una foto ufficiale scattata nel
2003, in cui i rappresentanti
delle
varie
agenzie
che
partecipano alla supervisione
sulle banche usavano forbici da
giardino e una sega elettrica per
«disboscare» in effigie la massa
delle disposizioni regolatone.
Più
concretamente,
l’amministrazione Bush ha
usato il potere federale, inclusi
gli oscuri poteri dell’Office of
the
Comptroller
of
the
Currency, per bloccare i
tentativi dei singoli stati di
imporre una certa supervisione
sull’erogazione
dei
mutui
subprime.
Nel frattempo, coloro che si
sarebbero dovuti preoccupare
della fragilità del sistema
cantavano invece le lodi della
«innovazione
finanziaria».
«Non solo le singole istituzioni
finanziarie sono diventate meno
vulnerabili a shock derivanti da
fattori di rischio sottostanti», ha
dichiarato Alan Greenspan nel
2004, «ma anche il sistema
finanziario nel suo complesso è
diventato più resiliente».
Dunque, i rischi crescenti di
una crisi per il sistema
finanziario e per l’economia
nella sua totalità sono stati
ignorati o sottovalutati. E la crisi
è arrivata.
9. LA SOMMA DI
TUTTE LE PAURE
Il 19 luglio 2007 il DowJones Average Industrial ha
superato per la prima volta i
14.000 punti. Due settimane
dopo, la Casa Bianca ha
pubblicato un «fact sheet» in
cui vantava la performance
dell’economia
sotto
l’amministrazione Bush: «Le
politiche a favore della crescita
messe in atto dal presidente
contribuiscono a mantenere la
nostra economia forte, flessibile
e
dinamica»,
recitava
il
documento. E i problemi già
visibili nel mercato immobiliare
e nei mutui subprime? Erano
«sostanzialmente contenuti», ha
detto il segretario al Tesoro
Henry Paulson in un discorso
che ha tenuto il primo agosto a
Beijing.
Il 9 agosto la banca francese
BNP Paribas ha sospeso i ritiri
da tre dei suoi fondi – iniziava
così la prima grande crisi
finanziaria del XXI secolo.
Mi verrebbe da dire che la
crisi non ha alcun punto di
contatto con ciò che abbiamo
visto in precedenza. Ma sarebbe
più esatto dire che è molto
simile a tutto ciò che abbiamo
visto in precedenza, però tutto
insieme: l’implosione di una
bolla immobiliare paragonabile
a quella che si è creata in
Giappone alla fine degli anni
Ottanta; un’ondata di corse agli
sportelli paragonabile a quelle
dei primi anni Trenta (che ha
coinvolto il sistema bancarioombra, anziché le banche
convenzionali);
un
grosso
problema di liquidità negli Stati
Uniti, analogo a quello che si
era già presentato in Giappone;
e ultimamente una discontinuità
dei flussi internazionali di
capitale e un’ondata di crisi
valutarie fin troppo simile a
quella che si è avuta in Asia alla
fine degli anni Novanta.
Andiamo per ordine.
La crisi immobiliare e la
sua ricaduta
La grande bolla immobiliare
degli Stati Uniti ha cominciato a
sgonfiarsi nell’autunno del 2005
– ma la gente ci ha messo un
po’ di tempo ad accorgersene.
Siccome i prezzi erano talmente
saliti che acquistare una casa era
diventato impossibile per molti
americani – anche senza
anticipo, e con dei mutui a tassi
allettanti – le vendite hanno
cominciato a rallentare.
Come scrivevo all’epoca, si
sentiva un sibilo, come se l’aria
cominciasse a fuoriuscire dalla
bolla.
Ma i prezzi delle case hanno
continuato a salire ancora per
un po’. Ce lo si poteva
aspettare. Le case non sono
come le azioni, con un prezzo
unico di apertura che cambia di
minuto in minuto. Ogni casa è a
sé, e i venditori mettono in
conto di dover attendere
qualche tempo prima di trovare
un acquirente. Di conseguenza,
i prezzi tendono a basarsi sul
valore
di
analoghe
compravendite concluse negli
ultimi tempi: i venditori non
cominciano a ridurre i prezzi,
finché
non
diventa
dolorosamente evidente che
non riceveranno un’offerta in
linea con la richiesta. Nel 2005,
dopo un periodo prolungato in
cui il prezzo delle case era salito
costantemente di anno in anno,
i venditori si aspettavano che il
trend continuasse; perciò i
prezzi
richiesti
hanno
continuato effettivamente a
salire, nonostante il calo delle
vendite.
Ma alla fine della primavera
2006, la debolezza del mercato
cominciava a essere evidente. I
prezzi
hanno
iniziato
a
scendere, prima lentamente e
poi sempre più velocemente.
Nel secondo trimestre del 2007,
stando all’utilizzatissimo indice
Case-Shiller, i prezzi delle
abitazioni erano scesi di appena
il 3% rispetto al picco massimo
di un anno prima.
Nell’anno successivo sono
diminuiti di oltre il 15%.
Naturalmente, il calo era molto
più rilevante nelle regioni che
avevano avuto le bolle più
consistenti, come la parte
costiera della Florida.
Ma anche il graduale declino
iniziale dei prezzi immobiliari ha
fatto venir meno gli assunti su
cui si basava il boom dei mutui
subprime.
Come
forse
ricorderete,
il
principale
fondamento razionale di questi
prestiti era la convinzione che,
per il finanziatore, contava ben
poco se il finanziato poteva
effettivamente rimborsare le
rate: finché i prezzi delle case
continuavano
a salire, i
mutuatari in difficoltà potevano
rifinanziare il prestito o saldare
il mutuo vendendo la casa. Non
appena i prezzi delle case hanno
cominciato a scendere, anziché
a salire, e gli immobili sono
diventati pressoché invendibili, i
tassi di insolvenza hanno
cominciato a crescere. E a quel
punto è venuta alla luce un’altra
dolorosa verità: il pignoramento
non è solo una tragedia per i
proprietari di case, ma è anche
un pessimo affare per il
finanziatore. Tra il tempo che ci
vuole per reimmettere sul
mercato una casa pignorata, le
spese legali, il degrado che si
crea
inevitabilmente
negli
alloggi vuoti, eccetera, i creditori
che portano via la casa al
debitore
recuperano
normalmente solo una parte,
circa la metà, del valore
originario del mutuo.
Potreste domandarvi allora:
perché non accordarsi con il
proprietario dell’abitazione per
ridurre le rate ed evitare i costi
del pignoramento? Be’, tanto
per cominciare, un’operazione
di questo tipo costa, e richiede
del personale. E i mutui
subprime non venivano quasi
mai stipulati da banche che li
tenevano
in
portafoglio;
venivano stipulati da altri
soggetti, che li vendevano
rapidamente
a
istituzioni
finanziarie le quali, a loro volta,
«impacchettavano» pool di
mutui in collateralizated debt
obligations (CDO) vendute agli
investitori. La gestione dei
mutui veniva lasciata ad
apposite strutture, che non
avevano né le risorse né, in
generale,
l’incentivo
a
provvedere alla ristrutturazione
del prestito. C’è ancora un’altra
considerazione: la complessità
dell’engineering
finanziario
sottostante ai mutui subprime,
che distribuiva la proprietà dei
mutui tra un gran numero di
investitori con diversi gradi di
«privilegio», creava formidabili
ostacoli giuridici a qualunque
tipo di indulgenza sul debito.
Dunque la ristrutturazione
era
sostanzialmente
impensabile, il che comportava
necessariamente l’esecuzione di
costosi
pignoramenti.
Di
conseguenza, i titoli di credito
sorretti da mutui subprime si
sono trasformati in pessimi
investimenti non appena il
boom
immobiliare
ha
cominciato a sgonfiarsi.
Il primo momento della verità
è arrivato all’inizio del 2007,
quando il problema dei mutui
subprime è apparso per la prima
volta in tutta la sua entità. Come
forse ricorderete, le CDO
prevedevano una graduazione
nel livello di privilegio delle
quote: i titolari delle quote più
«senior», quelle a cui le agenzie
di rating avevano attributo la
tripla A, avevano la priorità sui
pagamenti, mentre quelli che
avevano le quote meno
privilegiate, a cui era attribuito
un rating inferiore, venivano
pagati
solo
dopo
la
soddisfazione dei creditori
privilegiati. Intorno al febbraio
2007 si è capito che le quote
meno affidabili in termini di
rating avrebbero probabilmente
subito pesanti perdite, e il loro
prezzo è crollato. A quel punto
l’erogazione
dei
mutui
subprime
è
praticamente
cessata:
siccome
nessuno
voleva più acquistare le quote
meno privilegiate, non si
potevano più riconfezionare e
vendere i mutui subprime, e
questa forma di finanziamento è
venuta meno. Il che, a sua volta,
eliminando
una
fonte
importante
di
domanda
immobiliare, ha peggiorato la
crisi in atto.
Ma per un lungo periodo gli
investitori hanno continuato a
credere che le quote «senior» di
quelle
CDO
fossero
ragionevolmente
tutelate.
Nell’ottobre 2007, le quote dei
pool di mutui subprime che
avevano avuto la tripla A si
vendevano ancora a un valore
molto vicino al nominale. Alla
fine, tuttavia, si è capito che in
tutto ciò che aveva a che fare
con il mercato immobiliare non
c’era più niente di sicuro – né le
quote senior, né i mutui
concessi a persone teoricamente
solvibili che avevano versato
cospicui anticipi.
Perché? Per la dimensione
stessa della bolla immobiliare. A
livello nazionale, nell’estate del
2006,
le
case
erano
probabilmente sopravvalutate di
oltre il 50% e quindi, per
eliminare la sopravvalutazione, i
prezzi dovevano diminuire di un
terzo.
In
alcune
aree
metropolitane
la
sopravvalutazione era molto
maggiore. A Miami, per
esempio, i prezzi delle case
erano circa il doppio rispetto a
quanto
avrebbero
potuto
giustificare i fondamentali.
Dunque, in alcune aree ci si
poteva aspettare che alcuni
prezzi diminuissero almeno del
50%.
In altre parole, praticamente
chiunque avesse acquistato una
casa negli anni più caldi della
bolla immobiliare, anche se
aveva versato un anticipo del
20%, si sarebbe trovato ad avere
un valore negativo, nel senso
che il mutuo valeva più della
casa. In effetti, al momento in
cui questo libro va in stampa, ci
sono circa dodici milioni di
americani che hanno comprato
una casa e si sono trovati ad
avere un valore negativo. E
costoro sono i primi candidati
all’insolvenza
e
al
pignoramento, quale che sia la
loro estrazione sociale. Tanto
per
cominciare,
alcuni
potrebbero
decidere
semplicemente di «uscire» –
ossia non pagare più il mutuo,
sapendo che saranno ancora in
discrete condizioni finanziarie
anche quando avranno perso la
casa. Non si è mai capito
quanto
sia
veramente
importante il fenomeno della
«uscita» dai mutui, ma ci sono
tante altre strade che portano al
default. La perdita del posto di
lavoro, delle spese mediche
inattese, il divorzio – tutte
queste cose possono impedire a
un neoproprietario di casa di
pagare le rate del mutuo. E se la
casa
vale
meno
del
finanziamento, non c’è modo di
rimborsare il finanziatore.
Quando la gravità della crisi
immobiliare è emersa in tutta la
sua evidenza, si è capito che i
finanziatori avrebbero perso un
sacco di soldi, come gli
investitori
che
avevano
acquistato titoli sorretti dai
mutui. Ma perché dovremmo
piangere per costoro, anziché
per i poveri mutuatari che si
sono trovati senza casa?
Dopotutto, la fine della bolla
immobiliare, a conti fatti,
potrebbe
avere
distrutto
ricchezza per otto trilioni di
dollari. Di essi, quasi sette
trilioni saranno usciti dalle
tasche degli acquirenti di case, e
solo un trilione sarà uscito dalle
tasche degli investitori. Perché
ossessionarsi per quel trilione?
Perché ha innescato il
tracollo del sistema bancarioombra.
La crisi delle banche-non
banche
Come abbiamo visto, nella
prima metà del 2007 c’erano dei
seri tremori finanziari, ma
all’inizio di agosto l’opinione
ufficiale
definiva
ancora
«contenuti» i problemi posti
dalla crisi immobiliare e dai
mutui subprime – e la forza del
mercato azionario indicava che i
mercati condividevano quella
posizione. Poi, senza esagerare,
si è scatenato l’inferno. Che
cosa è successo?
Nel capitolo 8 ho citato Tim
Geithner della New York
Federal Reserve Bank a
proposito dei rischi causati
dall’ascesa
del
sistema
bancario-ombra: «L’entità degli
asset di lungo termine rischiosi
e
relativamente
illiquidi,
finanziati da passività di
brevissimo termine, ha reso
molti dei veicoli e delle
istituzioni che operano in
questo
sistema finanziario
parallelo vulnerabili alla classica
corsa agli sportelli; ma senza le
tutele, come l’assicurazione dei
depositi, di cui dispone il
sistema bancario per ridurre
questi rischi». In quello stesso
discorso,
pronunciato
nel
giugno 2008, Geithner ha
spiegato – in un linguaggio
sorprendentemente vivace per
un banchiere centrale – come si
era verificata effettivamente
quella corsa agli sportelli. Era
iniziata con le perdite legate ai
mutui subprime, che avevano
minato la fiducia nel sistema
bancario-ombra,
e
questa
perdita di fiducia ha avviato un
circolo vizioso di deleveraging:
Quando gli investitori che si
erano affidati a questi strumenti
finanziari – molti fondi gestiti in
maniera conservativa – hanno
ritirato, o minacciato di ritirare, i
loro soldi dai mercati, il sistema
è diventato vulnerabile a un
ciclo
autorinforzantesi
di
liquidazione forzata degli asset,
che ha ulteriormente accresciuto
la volatilità e ridotto i prezzi in
tutta una serie di categorie di
asset. Di conseguenza, i vincoli
sulle operazioni a riporto sono
stati intensificati, oppure sono
stati completamente negati i
finanziamenti ad alcuni clienti,
creando
un’ulteriore
leva
negativa. I margini di liquidità si
sono ridotti perché gli asset
venivano venduti in mercati che
avevano perso la fiducia. La
forza di questa dinamica è stata
esacerbata dalla cattiva qualità
di asset – specie quelli legati ai
mutui immobiliari – che si
erano ormai diffusi in tutto il
sistema. Ciò contribuisce a
spiegare come una quantità
relativamente limitata di asset a
rischio abbia potuto minare la
fiducia degli investitori e di altri
operatori di mercato su una
gamma molto più estesa di asset
e di mercati.
Notate l’enfasi che pone
Geithner su come il valore
declinante degli asset abbia
danneggiato
i
bilanci,
promuovendo
un’ulteriore
liquidazione degli asset, in un
processo che si autoalimentava.
In sostanza, è la stessa logica di
deleveraging che ha determinato
le
crisi
finanziarie
autoalimentate che si sono
verificate in Asia nel 1997 e nel
1998, descritte nel capitolo 4.
Gli operatori più indebitati
hanno riportato delle perdite,
che li hanno indotti a
intraprendere delle azioni che
hanno prodotto ulteriori perdite;
e così via. In questo caso le
perdite si sono determinate
attraverso la svalutazione di
rischiosi
asset
finanziari,
anziché
attraverso
la
svalutazione
della
moneta
nazionale, com’era avvenuto in
India o in Argentina; ma la
dinamica era praticamente la
stessa.
E il risultato di questo
processo autorinforzantesi è
stato in effetti una massiccia
corsa agli sportelli che ha
costretto il sistema bancarioombra a ridimensionarsi, come
aveva fatto il sistema bancario
tradizionale all’inizio degli anni
Trenta.
Le
auction-rate
securities, un business da
trecentotrenta miliardi di dollari,
sono sparite dal mercato. Il
valore dei crediti erogati
attraverso
l’asset-backed
commercial paper, un’altra
forma di attività bancaria di
fatto, è sceso da 1,2 trilioni di
dollari a soli settecento miliardi
di dollari. E così per tutti gli altri
strumenti.
Nei mercati finanziari si sono
cominciate a vedere cose strane.
I tassi di interesse sui buoni del
Tesoro USA — titoli di debito a
breve termine – sono scesi
quasi a zero. Questo perché gli
investitori erano disperatamente
a caccia di titoli sicuri e, come
ha detto un commentatore, le
uniche cose che erano disposti
ad acquistare erano i buoni del
Tesoro e l’acqua minerale (il
debito del governo USA è il più
sicuro del pianeta, non perché
gli Stati Uniti siano il paese più
responsabile della Terra, ma
perché in un ipotetico scenario
in cui il governo americano
andasse in default, crollerebbero
anche tutte le altre istituzioni –
di qui la domanda di acqua
minerale). In alcune occasioni i
tassi di interesse sui bond USA
sono stati addirittura negativi,
perché erano l’unica cosa che i
finanziatori accettavano in
garanzia, e c’era una domanda
enormemente
superiore
all’offerta.
Alcuni mutuatari hanno
contribuito al tracollo del
sistema
bancario-ombra
rivolgendosi
alle
banche
tradizionali. Uno degli aspetti
apparentemente più perversi
della crisi è l’espansione del
credito bancario, che ha creato
confusione in alcuni osservatori:
dov’è il credit crunch (la
strozzatura del credito, n.d.t.)?
si chiedono. Ma l’espansione
del finanziamento bancario
tradizionale
non
ha
compensato, se non in misura
minima, il tracollo del sistema
bancario-ombra.
Il credito al consumo è stato
l’ultimo a risentirne, ma
nell’ottobre 2008 c’erano prove
sempre più evidenti del fatto
che anche le carte di credito
stavano subendo una pesante
contrazione, con la riduzione
dei limiti di affidamento, una
sempre maggiore selezione nella
concessione e una crescente
compressione della capacità di
acquisto dei già nervosi
consumatori americani.
In
tutti
i
settori
dell’economia, alcune aziende e
alcuni individui si vedevano
negare l’accesso al credito,
mentre altri si ritrovavano a
pagare interessi più elevati,
anche se la Federal Reserve
cercava di far diminuire i tassi.
Si stava profilando una trappola
di tipo giapponese per la politica
monetaria degli Stati Uniti.
La FED perde efficacia
Quando è scoppiata la crisi
finanziaria, Alan Greenspan non
era più a capo della Federal
Reserve. Al suo posto –
costretto a far fronte al caos che
si era lasciato dietro – c’era Ben
Bernanke, un ex professore di
economia
di
Princeton.
(Bernanke era il direttore del
dipartimento di economia di
Princeton prima di trasferirsi
alla FED, e mi aveva assunto
quando ero passato a Princeton
dal MIT.)
Dovendo
scegliere
una
persona da mettere a capo della
FED durante questa crisi, non
c’era candidato migliore di
Bernanke. È uno studioso della
Grande Depressione. Le sue
ricerche sul modo in cui la crisi
bancaria
intensificò
la
Depressione lo hanno portato a
dare un importante contributo
teoretico
all’economia
monetaria, focalizzato sul ruolo
della disponibilità del credito e
dei problemi di bilancio alla
restrizione degli investimenti
(mormorate le parole magiche
«Bernanke-Gertler» a un gruppo
di economisti che discutono
preoccupatamene della crisi, e
assentiranno in segno di
apprezzamento).
Inoltre,
Bernanke ha fatto ampie
ricerche sui problemi finanziari
del Giappone negli anni
Novanta. Nessuno era più
preparato di lui, dal punto di
vista intellettuale, a fronteggiare
la drammatica situazione in cui
ci troviamo.
Ma con l’evolversi della crisi,
la FED di Bernanke ha fatto
un’enorme fatica a mettere
sotto controllo i mercati
finanziari o l’economia nel suo
complesso.
La FED deve fare due cose
principali: gestire i tassi di
interesse,
e
quando
è
necessario, fornire liquidità alle
banche. Gestisce i tassi di
interesse acquistando buoni del
Tesoro dalle banche, e quindi
incrementandone le riserve, o
vendendo buoni del Tesoro alle
banche, e quindi riducendone le
riserve. Fornisce liquidità a
determinate
banche
nei
momenti di bisogno, prestando
loro direttamente dei soldi. E fin
dall’inizio della crisi ha usato
aggressivamente
questi
strumenti. La FED ha tagliato il
tasso di sconto federale – il
tasso overnight a cui le banche
si prestano vicendevolmente i
fondi, che è il normale
strumento
della
politica
monetaria – dal 5,25% alla
vigilia della crisi all’1% nel
momento in cui scrivo. «Il totale
dei prestiti ricevuti dalle
istituzioni di deposito da parte
della Federal Reserve», un
indicatore dei finanziamenti
diretti, è passato da poco più di
zero prima della crisi, a oltre
quattrocento miliardi di dollari.
In tempi normali, queste
mosse avrebbero portato a una
ben maggiore agevolazione del
credito. La diminuzione del
tasso di sconto si traduce
normalmente in una riduzione
generalizzata dei tassi di
interesse – tassi di interesse più
bassi sul credito commerciale,
tassi di interesse più bassi sui
finanziamenti alle imprese, tassi
di interesse più bassi sui mutui
immobiliari. E i prestiti alle
banche sono stati sempre
sufficienti a coprire qualunque
carenza di liquidità che si
determinasse
nel
sistema
finanziario. Ma questi non sono
tempi normali, e i precedenti
storici non hanno trovato
applicazione.
La perdita di efficacia della
FED è particolarmente evidente
per quanto riguarda i mutuatari
più a rischio. Come abbiamo
visto, oggi non si fanno più
mutui subprime, tagliando fuori
dal
mercato
immobiliare
un’intera categoria di potenziali
acquirenti. Le aziende che non
hanno il rating più elevato in
termini di affidabilità pagano
tassi di interesse sul credito a
breve termine più elevati di
quelli che pagavano prima della
crisi, anche se i tassi di interesse
controllati dalla FED sono
diminuiti di oltre quattro punti
percentuali. Nel momento in cui
scrivo, il tasso di interesse sulle
obbligazioni
aziendali
classificate BAA è superiore al
9%, contro il 6,5% ante-crisi. Di
conseguenza, i tassi di interesse
che rilevano per le decisioni di
spesa e di investimento sono
saliti, o perlomeno non sono
scesi, nonostante il tentativo
della FED di spingerli verso il
basso.
Ne hanno risentito anche i
mutuatari «prime» (quelli che
godono di tassi più favorevoli
per la loro affidabilità, n.d.t.): il
tasso di interesse sui mutui
trentennali è ancora più o meno
lo stesso dell’estate 2007.
Questo perché la crisi del
sistema
finanziario
ha
praticamente
espulso
dal
mercato i finanziatori privati,
lasciandovi solo Fannie Mae e
Freddie Mac, le agenzie
sponsorizzate dal governo. E
anche Fannie e Freddie si sono
trovate in pessime acque: non
avevano concesso tanti prestiti
insoluti quanto le banche
private, ma ne avevano concessi
alcuni, e avevano un capitale
molto limitato. Nel settembre
2008 il governo federale ha
assunto il controllo di Fannie e
Freddie, un intervento che
avrebbe dovuto ridurre le
preoccupazioni per il loro
indebitamento e fatto diminuire
i tassi di interesse sui mutui. Ma
l’amministrazione Bush ha
negato
recisamente
che
l’indebitamento di Fannie e
Freddie fosse sorretto dalla
piena fiducia del governo
americano, per cui anche dopo
la nazionalizzazione le due
agenzie hanno avuto problemi
nella raccolta di fondi.
Che cosa dire dei prestiti
erogati alle banche dalla Federal
Reserve? Probabilmente hanno
dato una mano, ma non nella
misura attesa, perché le banche
tradizionali non sono al centro
della crisi. Ecco un esempio: se
auction-rate securities avessero
fatto parte del sistema bancario
tradizionale,
gli
emittenti
avrebbero potuto farsi prestare
soldi dalla FED quando alle aste
si presentavano troppo pochi
investitori
privati;
di
conseguenza, le aste non
sarebbero fallite e il settore non
sarebbe crollato. Ma siccome
non facevano parte delle banche
convenzionali, le aste sono
fallite e il settore è crollato, e
non c’erano prestiti della FED
alla Citibank o alla Bank of
America che potessero mettere
fine al processo.
La FED si è trovata così a
fronteggiare una crisi di liquidità
di tipo giapponese, in cui la
politica
monetaria
convenzionale aveva perso ogni
efficacia sull’economia reale.
Certo, il tasso di sconto non è
stato ridotto a zero, ma non
c’erano ragioni di pensare che il
taglio di un altro punto
percentuale avrebbe avuto un
impatto significativo.
Che cos’altro poteva fare la
FED? In uno studio accademico
del 2004, Bernanke aveva
affermato che la politica
monetaria
poteva
essere
efficace, anche in una crisi di
liquidità se c’era la volontà di
«modificare la composizione
dello stato patrimoniale della
banca centrale». Invece di
limitarsi a tenere in portafoglio
buoni del Tesoro e a prestare
soldi alle banche tradizionali, la
FED poteva concedere prestiti
ad altri operatori: banche di
investimenti, fondi, e forse
anche imprese non finanziarie.
E nel 2008 la FED ha istituito
una serie di agenzie speciali
preposte a questo compito: la
TSLF, la PDCF, e così via.
Nell’ottobre 2008 la FED ha
annunciato la decisione di
cominciare ad acquistare anche
commercial paper, mettendosi
praticamente in condizione di
erogare i prestiti che il sistema
finanziario privato non voleva o
non poteva effettuare.
Nel momento in cui scrivo è
ancora possibile che questi
schemi diano dei frutti. C’è da
dire, peraltro, che finora i loro
effetti sono stati deludenti.
Perché? Io dico che è un
problema di sostituzione e di
scala. Quando la FED si attiva
per incrementare il volume delle
riserve bancarie, fa una cosa che
nessun'altra istituzione può fare:
solo la FED può creare base
monetaria, che si può usare
come liquidità corrente o tenere
di riserva presso le banche.
Inoltre, le sue azioni tendono a
essere di vasta portata quanto
alla dimensione delle categorie
di asset coinvolte, perché la
base monetaria è di «soli»
ottocento miliardi di dollari. Per
contro, quando la FED tenta di
sostenere più ampiamente il
mercato del credito, fa una cosa
che fanno anche gli operatori
privati – per cui il credito che
inietta nel sistema potrebbe
essere parzialmente compensato
dai ritiri dei privati – e tenta
anche di smuovere un mercato
molto più vasto: quel mercato
del credito che vale circa
cinquanta trilioni di dollari.
La FED di Bernanke ha avuto
anche il problema di trovarsi
costantemente a rincorrere gli
eventi. La crisi finanziaria
continua a sviluppare nuove
dimensioni, che pochissimi –
inclusi i superesperti della FED
– vedono emergere. Il che mi
porta
ad
analizzare
la
dimensione internazionale della
crisi.
La madre di tutte le crisi
valutarie
Dopo le crisi finanziarie del
1997 e del 1998, i paesi coinvolti
hanno cercato di proteggersi da
una nuova crisi. Hanno evitato
di ricorrere a quei prestiti esteri
che li avevano esposti a una
potenziale
riduzione
dei
finanziamenti over-seas. Hanno
accumulato enormi riserve in
dollari e in euro, che avrebbero
dovuto proteggerli in caso di
emergenza finanziaria. E nella
logica convenzionale, i «mercati
emergenti» – Brasile, Russia,
India, Cina e tutta una serie di
paesi più piccoli, tra cui le
vittime della crisi del 1997,
erano ormai «svincolati» dagli
Stati Uniti, e quindi in grado di
crescere nonostante la crisi in
corso
in
America.
«Lo
sganciamento dagli Stati Uniti
non è un mito», spiegava
l’«Economist» ai suoi lettori nel
mese di marzo. «Ma potrebbe
salvare l’economia mondiale».
Purtroppo
non
sembra
probabile. Anzi, dice Stephen
Jen, chief currency strategist
della
Morgan
Stanley,
«l’atterraggio violento» nei
mercati emergenti potrebbe
essere il «secondo epicentro»
della crisi globale (i mercati
finanziari degli Stati Uniti hanno
costituito il primo epicentro).
Che cosa è accaduto?
Insieme alla crescita del sistema
bancario-ombra, negli ultimi
quindici anni c’è stata un’altra
trasformazione strutturale nel
sistema
finanziario,
determinatasi in gran parte dopo
la crisi asiatica – mi riferisco
all’ascesa della globalizzazione
finanziaria, per cui gli investitori
di ciascun paese detengono
grosse partecipazioni finanziarie
in altri paesi. Nel 1996, alla
vigilia della crisi asiatica, gli
Stati Uniti avevano asset esteri
pari al 52% del PIL, e passività
estere pari al 57% del PIL. Nel
2007, queste cifre erano salite,
rispettivamente, al 128% e al
145% del PIL. Gli Stati Uniti
erano diventati debitori netti;
ma questo aspetto è meno
impressionante
dell’enorme
incremento registrato nelle
partecipazioni incrociate.
Come gran parte di ciò che è
accaduto nel sistema finanziario
negli ultimi due decenni, questo
cambiamento avrebbe dovuto
ridurre il rischio: poiché gli
investitori americani detenevano
gran parte della propria
ricchezza
all’estero,
erano
teoricamente meno esposti a
una crisi finanziaria in America;
e siccome gli investitori esteri
detenevano gran parte della
propria ricchezza negli Stati
Uniti, erano meno esposti a una
crisi finanziaria in patria. Ma in
realtà,
la
maggior
parte
dell’incremento
della
globalizzazione
finanziaria
veniva dagli investimenti di
istituzioni fortemente indebitate,
che stavano facendo varie
scommesse rischiose su scala
internazionale. E quando le cose
si sono messe male negli Stati
Uniti,
questi
investimenti
internazionali hanno agito da
«meccanismo di trasmissione»,
consentendo a una crisi che era
iniziata nel mercato immobiliare
americano di propagarsi a
catena in altri paesi. L’inizio
della
crisi
si
identifica
generalmente nel fallimento di
alcuni fondi speculativi legati a
una
banca
francese;
nell’autunno del 2008, i
problemi causati dai mutui
immobiliari in posti come la
Florida avevano distrutto il
sistema bancario islandese.
Nel caso
dei mercati
emergenti c’era un particolare
elemento di vulnerabilità: il
cosiddetto carry trade. Questo
strumento permette di prendere
a prestito soldi in paesi che
applicano
bassi tassi di
interesse, soprattutto ma non
solo il Giappone, e di prestarli in
paesi che applicano elevati tassi
di interesse, come il Brasile e la
Russia. È stato un business
altamente profittevole finché è
andato tutto bene; ma alla fine
c’è stato un intoppo.
L’evento scatenante sarebbe
stato il default della banca
d’investimenti
Lehman
Brothers, avvenuto il 15
settembre 2008. Nel marzo
2008, quando la Bear Stearns,
un’altra delle cinque grandi
banche
d’investimento,
è
entrata in crisi, la FED e il
Tesoro degli Stati Uniti sono
intervenuti – non per salvare
l’azienda, che è andata in
liquidazione,
ma
per
proteggerne le «controparti»,
ossia coloro a cui doveva dei
soldi o con cui aveva concluso
degli accordi di finanziamento.
C’era la diffusa aspettativa che
la
Lehman
ricevesse
il
medesimo trattamento. Ma il
dipartimento del Tesoro ha
stabilito che le conseguenze di
un eventuale fallimento della
Lehman non sarebbero state
troppo pesanti, e l’ha lasciata
affondare senza offrire alcuna
protezione alle sue controparti.
Di lì a qualche giorno era
chiaro che si era trattato di una
mossa disastrosa: la fiducia è
diminuita ulteriormente, i prezzi
degli asset sono scesi di più, e i
pochi canali di credito rimasti
ancora attivi si sono prosciugati.
La nazionalizzazione di fatto
della
mega
compagnia
assicurativa AIG, decisa pochi
giorni dopo, non è servita ad
arrestare il panico.
E una delle vittime dell'ultima
ondata di panico è stata proprio
il carry trade. Il travaso di fondi
dal Giappone e da altri paesi a
bassi tassi di interesse si era
bloccato, causando una serie di
effetti autorinforzantesi, ben
noti fin dalla crisi del 1997.
Siccome i capitali non uscivano
più dal Giappone, il valore dello
yen è aumentato; e siccome i
capitali non entravano più nei
mercati emergenti, il valore delle
loro monete è diminuito. Ciò ha
causato grandi perdite sul
capitale per tutti coloro che si
erano finanziati in una divisa e
avevano concesso dei prestiti in
un’altra. In alcuni casi, ha fatto
sì che gli hedge funds – e più in
generale il settore dei fondi
speculativi – che avevano fatto
meglio delle attese fino al
tracollo della Lehman Brothers,
cominciassero
a
ridursi
rapidamente. In altri casi, ha
fatto sì che le aziende dei
mercati emergenti che si erano
finanziate a basso costo
all’estero,
si
trovassero
improvvisamente
a
contabilizzare grosse perdite.
Si è scoperto così che i
tentativi messi in atto dai
governi dei paesi emergenti per
proteggersi da un’altra crisi
erano stati vanificati dalla
ingiustificata propensione al
rischio del settore privato. In
Russia, per esempio, banche e
aziende sono andate in massa a
finanziarsi all’estero perché i
tassi di interesse erano inferiori
a quelli praticati sul rublo.
Perciò, mentre il governo russo
accumulava riserve estere per
ben 560 miliardi di dollari, le
aziende e le banche russe
accumulavano debiti esteri per
la
cifra,
non
meno
impressionante, di 460 miliardi
di dollari. Poi, tutt’a un tratto,
queste aziende e queste banche
si sono trovate con le linee di
credito bloccate, mentre il
valore in rubli dei loro debiti
andava alle stelle. E nessuno era
al sicuro: per esempio, le grandi
banche brasiliane hanno evitato
di
assumere
una
forte
esposizione all’estero, ma si
sono trovate ugualmente in
difficoltà perché i loro clienti
nazionali non erano stati
altrettanto prudenti.
Tutto questo aveva molti
punti in comune con precedenti
crisi
valutarie
–
quella
dell’Indonesia nel 1997 e quella
dell’Argentina nel 2002. Ma la
dimensione era molto più vasta.
Si tratta certamente della madre
di tutte le crisi valutarie, e
rappresenta un disastro senza
precedenti per il sistema
finanziario mondiale.
Una crisi globale
La maggior parte di questo
capitolo è stata dedicata agli
aspetti finanziari della crisi. Che
cosa fa presagire tutto questo
per la «economia reale»,
l’economia dei posti di lavoro,
dei salari e della produzione?
Non fa presagire niente di
buono.
Gli Stati Uniti, la Gran
Bretagna, la Spagna e diversi
altri
paesi
avrebbero
probabilmente avuto
delle
recessioni con l’esplosione della
bolla immobiliare anche se il
sistema finanziario non fosse
andato in crisi. La caduta dei
prezzi delle abitazioni ha un
effetto
negativo
diretto
sull’occupazione attraverso il
rallentamento dell’edilizia, e
tende a ridurre i consumi perché
i consumatori si sentono più
poveri e non possono più
accedere ai prestiti ipotecari;
questi aspetti negativi hanno un
effetto moltiplicatore perché il
calo
dell’occupazione
fa
diminuire
ulteriormente
i
consumi. Ciò detto, l’economia
americana ha retto abbastanza
bene alla crisi immobiliare,
soprattutto perché la debolezza
del dollaro ha favorito le
esportazioni,
il
che
ha
contribuito a compensare il
rallentamento dell’edilizia.
Ma il tracollo finanziario
trasformerà certamente quella
che
poteva
essere
una
recessione «normale» – il tasso
di occupazione degli Stati Uniti
ha cominciato a diminuire alla
fine del 2007, ma fino a
settembre del 2008 il declino è
stato piuttosto modesto – in
qualcosa di molto, molto
peggio. L’intensificazione della
crisi del credito dopo il
fallimento
della
Lehman
Brothers, l’improvvisa crisi che
ha colpito i mercati emergenti, il
crollo intervenuto nella fiducia
dei consumatori quando la
dimensione
della
crisi
finanziaria è arrivata sulle prime
pagine dei giornali, sembrano
indicare tutte quante la peggior
recessione mai vista negli Stati
Uniti, e in tutto il mondo, dai
primi anni Ottanta. E molti
economisti si sentirebbero
sollevati se restasse entro quei
limiti.
La cosa che preoccupa di più
è l’inefficacia della politica
monetaria. La recessione del
1981-1982, che ha spinto il
tasso di disoccupazione sopra il
10%, è stata pesantissima; ma
era più o meno frutto di una
scelta deliberata: la FED
perseguiva
una
politica
monetaria molto rigida per
disinnescare l’inflazione, e nel
momento in cui ha stabilito che
l’economia
aveva
sofferto
abbastanza, il suo presidente,
Paul Volcker, ha allentato la
stretta e l’economia è tornata a
correre.
La
devastazione
economica si è trasformata in
una «nuova alba» per l’America
con
una
rapidità
impressionante.
Questa volta, per contro,
l’economia ristagna nonostante
i ripetuti sforzi messi in atto
dalle autorità monetarie per farla
ripartire. Questa impotenza
della politica monetaria ricorda
da vicino ciò che è avvenuto in
Giappone negli anni Novanta.
Ma ricorda anche le vicende
degli anni Trenta. In questo
momento non siamo ancora in
depressione, e nonostante tutto
io non credo che andremo
incontro a una depressione
(anche se non ne sono del tutto
sicuro). Siamo però in presenza
di una tipica economia della
depressione.
10. IL RITORNO
DELL’ECONOMIA
DELLA
DEPRESSIONE
L’economia mondiale non sta
vivendo un momento di
depressione; e, probabilmente,
non è destinata a viverlo
nell’immediato futuro. Ma, se la
depressione non è tornata,
l’economia della depressione –
quel
particolare
tipo
di
fenomeni
che
hanno
caratterizzato
gran
parte
dell’economia mondiale negli
anni Trenta, e che da allora non
si erano più fatti vedere – è
ricomparsa sulla scena. Cinque
anni fa quasi nessuno pensava
che le nazioni moderne
avrebbero
potuto
essere
costrette a sopportare terribili
recessioni per difendersi dalle
speculazioni valutarie; che un
grande paese industrializzato
non sarebbe riuscito a investire
abbastanza per mantenere
occupati lavoratori e industrie;
che anche la Federal Reserve
avrebbe messo in discussione la
propria abilità di fronte al
panico dei mercati finanziari.
Abbiamo
scoperto
che
l’economia mondiale è molto
meno rassicurante di quanto
potessimo immaginare.
Come ha fatto il mondo a
diventare un posto così poco
sicuro? Meglio ancora, cosa
possiamo fare per renderlo più
sicuro? In questo libro vi ho
raccontato molte cose; è
arrivato ora il momento di trarre
una conclusione.
Che cosa è l’economia
della depressione?
Che cosa vuol dire che è
ritornata
l’economia
della
depressione?
Essenzialmente
vuol dire che, per la prima volta
da due generazioni, la scarsità
della domanda – una spesa
privata non sufficiente a
sfruttare la capacità produttiva
che abbiamo a disposizione – è
ormai diventata un chiaro
ostacolo al benessere di gran
parte del mondo.
Noi – e con questo mi
riferisco agli economisti, ma
anche ai politici e in generale a
tutti quelli che hanno un buon
livello d’istruzione – non ce
l’aspettavamo. Quell’insieme di
nozioni che prende il nome di
«economia
dell’offerta»
costituisce una teoria che
funziona male, e che avrebbe
avuto poco successo se non
avesse
fatto
presa
sui
preconcetti della gente; ciò
nonostante, negli ultimi anni, il
pensiero economico si è sempre
più spinto a enfatizzare il ruolo
dell’offerta, piuttosto che quello
della domanda.
Questo fenomeno è in gran
parte frutto di dispute teoriche
tra gli economisti, che – come
succede spesso – filtrano
gradualmente all’esterno, in
forma confusa, ed entrano a far
parte dei discorsi di tutti i giorni.
In breve, la radice delle dispute
teoriche è questa: tutte le
riduzioni
della
domanda
potrebbero andare a posto da
sole, se solo i salari e i prezzi
fossero in grado di adeguarsi
all’aumento
della
disoccupazione. Nella storia
della cooperativa di baby-sitter
uno dei modi in cui la
situazione poteva andare a
posto da sola era che il prezzo
in buoni di un’ora di baby-sitter
diminuisse,
così
da
far
aumentare il potere d’acquisto
dei buoni in circolazione, e da
far tornare la cooperativa alla
piena occupazione. Nella realtà
di tutti i giorni questo non
succede o, se succede, impiega
molto tempo, anche se gli
economisti non hanno ancora
capito esattamente il perché. Di
conseguenza c’è stata una lunga
serie di discussioni accademiche
che ha fatto del dibattito sulla
recessione e sulle sue cause un
vero e proprio campo di
battaglia, nel quale sempre
meno
economisti
osano
avventurarsi; alla fine la gente è
arrivata alla conclusione che, o
gli economisti non capiscono le
recessioni, oppure i rimedi
economici che si concentrano
sulla domanda non sono
attendibili. La verità è che la
buona vecchia macroeconomia
che si concentra sulla domanda
ha ancora molto da dirci – ma i
suoi sostenitori, a differenza dei
suoi critici, non risultano più
convincenti.
Paradossalmente,
se
le
debolezze dell’economia che si
basa sulla domanda sono uno
dei motivi per cui eravamo
impreparati
al
ritorno
dell’economia
della
depressione, lo stesso si può
dire a proposito dei suoi
successi. Mentre gli economisti
discutevano tra di loro se la
politica monetaria dovesse
essere utilizzata per tirare fuori
un’economia dalla recessione,
le banche centrali avevano
tagliato corto e si erano
semplicemente messe a farlo – e
lo avevano fatto così bene che
sembrava improponibile l’idea
che una prolungata recessione
economica
potesse
essere
motivata da una scarsità di
domanda. La Federal Reserve e
le banche centrali degli altri
paesi potevano sempre tagliare i
tassi d’interesse in modo da
mantenere elevata la spesa;
quindi, a eccezione che nel
brevissimo periodo, l’unico
compito
di
un
sistema
economico era quello di
produrre.
Ancora oggi molti economisti
continuano a considerare le
recessioni come un problema di
secondo piano, un oggetto di
studio
poco
degno
d’attenzione; attualmente le
ricerche si concentrano su
argomenti quali il progresso
tecnologico e la crescita di
lungo periodo. Sono argomenti
interessanti,
problemi
importanti, e nel lungo periodo
sono quelli che conteranno di
più – ma, come ha sottolineato
Keynes, nel lungo periodo
saremo tutti morti.
Nel frattempo, nel breve
periodo, il mondo sta passando
da una crisi all’altra, e ognuna
di queste indica che il problema
più importante è oggi quello di
mantenere abbastanza elevato il
livello della domanda. Il
Giappone sta scoprendo che le
tradizionali politiche monetarie
e fiscali non bastano più; se è
capitato al Giappone, come
possiamo essere sicuri che
un’economia
europea,
o
addirittura un’economia in
crescita come quella degli Stati
Uniti, non possa cadere a sua
volta nella stessa trappola? Il
Messico, la Thailandia, la
Malesia, l’Indonesia, la Corea, il
Brasile: un paese in via di
sviluppo dopo l’altro è passato
attraverso una recessione che,
almeno temporaneamente, ha
distrutto anni di progresso
economico, e ha scoperto che le
ricette economiche tradizionali
servono solo a peggiorare le
cose. Una volta di più il vero
interrogativo è come mantenere
il livello della domanda
abbastanza elevato per utilizzare
appieno la capacità produttiva
disponibile. L’economia della
depressione è tornata.
Che cosa c’è in gioco?
Il rischio più immediato che
si corre in seguito al ritorno
dell’economia della depressione
è, naturalmente, che il danno si
possa
diffondere
–
che
l’Argentina, o il Sud Africa, la
Turchia, o (Dio ci aiuti) la Cina
aggiungano il proprio nome alla
lista dei paesi colpiti; che la
deflazione in Europa o il crollo
del mercato azionario negli Stati
Uniti creino condizioni simili a
quelle del Giappone in tutto il
mondo industrializzato. Anche
se tutto ciò rappresenta
un’eventualità piuttosto remota,
il progresso economico corre
oggi un rischio più insidioso,
perché è difficile che i liberi
mercati riescano a sopravvivere
in un mondo dove la scarsità di
domanda
rappresenta
una
minaccia continua.
Ricordatevi della sintesi
keynesiana. Quelli che hanno
fiducia nel libero mercato
tendono a considerare le
cosiddette politiche keynesiane
– gli sforzi del governo volti a
stimolare la domanda – come il
loro nemico numero uno. Ma si
sbagliano, perché in un mondo
dove la domanda è spesso
insufficiente, la libertà dei
mercati risulta essere un
argomento difficile da sostenere.
Cerchiamo di essere concreti
e
facciamo
il
caso
dell’Argentina. Immaginiamo
che
il
currency
board
dell’Argentina sopravviva, o
addirittura
che
il
paese
abbandoni il peso in favore del
dollaro – ma che, ipotesi
alquanto realistica, attraversi
una severa recessione e si trovi
di fronte alla prospettiva di anni
a elevata disoccupazione. Ora
immaginatevi che un potente
sindacato, o un gruppo di
imprenditori, chieda al governo
argentino di proteggere i posti di
lavoro
introducendo
dazi
doganali
o
quote
d’importazione. La risposta più
ovvia a una domanda di questo
tipo è che, così facendo, non si
creano posti di lavoro, ma si
mantiene la situazione così
come è: un dazio doganale può
aumentare l’occupazione in un
settore, ma almeno altrettanti
lavori verranno persi altrove.
Tutto ciò è sicuramente vero
negli Stati Uniti, dove la
pressione inflazionistica creata
dal protezionismo su alcuni
settori economici potrebbe
portare la Federal Reserve ad
aumentare i tassi d’interesse, e
di conseguenza a tagliare un
numero forse anche maggiore di
posti di lavoro in altri settori.
Ma, per un paese con un elevato
tasso
di
disoccupazione,
incapace di far aumentare la
domanda
per timore
di
incentivare la fuga di capitali,
questo modo di affrontare il
problema è semplicemente
sbagliato. In questo preciso
momento un dazio doganale
aumenterebbe l’occupazione in
Argentina, e sostenere il
contrario
sarebbe
intellettualmente
disonesto.
Questo non vuol dire che
l’Argentina – o Israele, o Hong
Kong, o una delle tante
economie che si trovano in una
condizione simile – dovrebbe
diventare protezionista, ma
significa
che
dovremmo
cominciare a pensare a come
aumentare l’occupazione in
queste economie, o il libero
mercato è destinato a perdere
progressivamente la sua ragione
d’essere.
Ancora una volta il giusto
modo per cominciare ad
affrontare il problema è quello
di capire che il libero mercato, e
in particolare la globalizzazione,
hanno fatto molto per la razza
umana; è dunque importante
proteggere e incrementare i
successi finora ottenuti. Oggi
come negli anni Trenta, tuttavia,
non ci si può difendere dalla
globalizzazione solo ripetendo i
mantra del libero mercato,
mentre un sistema economico
dopo l’altro sta crollando. Se
vogliamo che i miracoli
economici si moltiplichino, che
sempre più nazioni passino
dalla povertà più infima a una
vita decente, faremmo meglio a
trovare risposte ai problemi
dell’economia
depressione.
della
Accusare le vittime
Ancor oggi molti non
accettano l’idea che le recenti
crisi
economiche
abbiano
messo in evidenza l’esistenza di
un problema interno al sistema.
Al contrario, puntano il dito
sulle debolezze dei singoli paesi
e sugli errori commessi dai loro
leader. Le banche giapponesi
sono state eccessivamente prive
di
scrupoli,
il
padrone
dell’Indonesia ha esagerato con
la corruzione, i deficit di
bilancio del Brasile hanno
superato ogni limite. Seguite le
giuste politiche e finirete per
stare bene. Indubbiamente, per
ogni nazione che ha sofferto i
tipici problemi dell’economia
della depressione, a un esame
più attento si possono oggi
riscontrare grossi limiti, anche
se prima che le cose fossero
cominciate ad andare male il
paese era elogiato da tutti. Ma
bisogna stare attenti a non trarre
conclusioni affrettate.
Immaginatevi un pezzo di
autostrada che di recente è stato
teatro di un inusuale numero di
incidenti.
Gli
investigatori
esaminano attentamente le
cause di ogni incidente e
praticamente in ogni caso
trovano
una
spiegazione
evidente: il guidatore ha bevuto
troppo, i pneumatici sono
troppo consumati, ha reagito
male a una sbandata, e così via.
La conclusione a cui giungono
gli investigatori è che non è la
strada ad avere problemi, ma i
guidatori. Questa conclusione è
assai poco obiettiva. Prima di
tutto, se si osserva qualunque
guidatore
con
sufficiente
attenzione, si scopre che ha
commesso
una
qualche
imprudenza; questi guidatori
sono forse peggiori della media?
In secondo luogo, anche se si
tratta
di
guidatori
particolarmente
imprudenti,
questo
non
significa
necessariamente che la strada
non abbia avuto una parte di
colpa: i buoni guidatori di solito
subiscono meno incidenti su
qualsiasi strada, ma alle buone
strade non si chiede la
perfezione.
Allo stesso modo non si
chiedono politiche perfette a un
buon sistema economico. È
incredibile osservare quante
delle nazioni che più hanno
sofferto in questi ultimi anni, dal
Giappone alla Corea, erano
state messe sul piedistallo non
molto tempo fa; dato per
assodato che i loro ammiratori
si erano lasciati prendere
eccessivamente la mano, queste
nazioni erano veramente così
mal gestite come la gente oggi è
portata a pensare? O si tratta
semplicemente di un fenomeno
di «razionalizzazione ex post»?
Mettiamola così: se gli Stati
Uniti, che fino a oggi sono
rimasti assolutamente al riparo
dalla crisi di Asia e Sud
America, dovessero barcollare,
dopo un po’ di tempo ci
sarebbe di sicuro qualcuno che
ci spiega perché si siano meritati
questa fine. Naturalmente gli
hedge funds senza scrupoli,
l’entrata sul mercato di piccoli
investitori poco competenti,
l’eccessiva offerta di credito al
consumo, e il conseguente
azzeramento del tasso di
risparmio rappresentano tutti
potenziali disastri.
Quello che colpisce delle crisi
economiche degli ultimi due
anni è che i paesi coinvolti
stavano applicando politiche in
gran parte migliori di quelle del
passato. Come ha affermato un
brasiliano
particolarmente
scoraggiato, «il Brasile non ha
mai avuto un governo così
responsabile; lo scenario non è
mai stato così favorevole al
mondo degli affari; per quale
motivo ci sta capitando tutto
ciò?». E questa frase era
precedente alla catastrofe di
gennaio.
Questo desiderio di accusare
le vittime prende forme diverse.
C’è quella che chiamo «teoria
del pericolo
incombente»,
secondo la quale le recessioni
rappresentano una punizione
meritata, persino necessaria, per
errori commessi in precedenza.
Il Giappone sta pagando ora
(otto anni dopo!) il prezzo per
gli eccessi speculativi della sua
«economia gonfiata», e l’Asia
per il boom «prendi in prestito e
spendi» degli anni Novanta; e
non c’è nient’altro da fare se
non, come ha detto Schumpeter
negli anni Trenta, lasciare che la
depressione faccia il suo corso.
La
teoria
del
pericolo
incombente è particolarmente
allettante non perché offre facili
risposte, ma proprio perché non
le offre; chi fa ricorso a questa
teoria
ha
la
piacevole
sensazione di avere la coscienza
a posto, e di fronte agli altri, in
fondo, può anche vantarsi di
avere un cuore.
Ma
questa
teoria
è
completamente sbagliata. Ci
sono stati senza dubbio degli
eccessi; molti investimenti
andranno persi, anche se le
economie
alla
fine
si
riprenderanno. Tutto ciò non
rappresenta comunque un buon
motivo per affermare che
incauti investimenti fatti nel
passato debbano per forza
lasciare lavoratori esperti senza
lavoro e far chiudere fabbriche
perfettamente funzionanti. Se il
mercato azionario degli Stati
Uniti dovesse crollare domani,
nessuno si aspetta che Alan
Greenspan faccia qualcosa per
evitare perdite ai risparmiatori;
ma di certo lo accuseremmo di
disonestà se non facesse il
possibile per evitare che le
perdite azionarie provochino
disoccupazione di massa.
Una tentazione simile è
quella di considerare una
recessione come la prova che
l’economia
ha
problemi
strutturali che vanno risolti
prima che quest’ultima possa
riprendersi – il che equivale ad
affermare che sarebbe sbagliato
cercare di stimolare la domanda
e stimolare la ripresa, perché
tutto ciò finirebbe per indebolire
la spinta al cambiamento. Il
modello
economico
del
Giappone, ci hanno detto, è
fallito: i suoi manager hanno
una mente troppo ristretta, le
sue aziende sono troppo poco
orientate ai risultati, le sue
banche sono troppo poco
indipendenti dai clienti. Non ci
si deve dunque meravigliare che
l’economia sia stagnante; una
severa recessione, che finirà per
dare un bello scossone al
sistema, alla fine si rivelerà un
toccasana per il futuro del
Giappone. (Un economista
giapponese mi ha detto: «La tua
proposta darebbe solo la
possibilità a queste persone di
continuare a fare affari come
hanno sempre fatto, proprio
quando
le
cose
stanno
finalmente
cominciando
a
cambiare».) Ma non tutti i
grandi problemi sono strutturali
– qualche volta quello di cui ha
bisogno una macchina in panne
è solo di una bella spinta – e,
poiché noi tutti abbiamo
problemi strutturali, sappiamo
bene che il miglior modo per
curarli è con il benessere
piuttosto
che
con
la
depressione.
Inoltre stiamo attenti a non
parlare troppo presto di
successo. Poco prima del crollo
del Brasile a gennaio, i
funzionari di Washington e di
altri paesi stavano cominciando
a mostrarsi particolarmente
soddisfatti. La Corea sembrava
aver superato il peggio; il
Giappone
cominciava
a
mostrare alcuni segni di
crescita; le loro politiche
stavano funzionando. Tutto ciò
equivale a dire che il
programma di sicurezza delle
autostrade funziona perché la
maggior parte delle vittime degli
incidenti
sopravvive
e,
addirittura, cerca di camminare
di nuovo. Dovrà passare ancora
un bel po’ di tempo prima di
poter dire di aver messo
definitivamente fine al ritorno
dell’economia
della
depressione.
Proteggere i ricchi
Il mondo è un posto dove la
giustizia non è di casa. Di solito
i paesi ricchi sono fortunati da
ogni punto di vista. Non solo
sono ricchi ma, di solito, hanno
anche governi stabili ed
efficienti. E di norma gli
investitori e i mercati tendono a
concedere loro il beneficio del
dubbio. Tutto ciò dà loro una
grande libertà d’azione, una
capacità di far fronte ai
problemi economici, che le
nazioni più povere possono
solo invidiare.
Ciò nonostante, il Giappone
ci ha mostrato che perfino una
nazione industrializzata può
rimanere vittima di una
recessione; i paurosi eventi
dello
scorso
autunno
suggeriscono che anche i paesi
industrializzati continuano a
correre il rischio di vivere una
crisi finanziaria. Che cosa
possono fare per proteggersi?
Ho già spiegato quello che
dovrebbe fare il Giappone
(capitolo 4): dopo essere
rimasto bloccato nella sua
trappola della liquidità –
incapace di riprendersi usando i
tradizionali strumenti di politica
monetaria, perché anche un
tasso d’interesse pari a zero non
è abbastanza basso – e dopo
avere esaurito le possibilità di
cavarsela con i deficit di
bilancio, il Giappone deve ora
aumentare radicalmente la sua
offerta di denaro, allo scopo di
convincere i risparmiatori e gli
investitori
che
l’attuale
deflazione si trasformerà in
un’inflazione prolungata, ma
non eccessiva. Quando i
giapponesi decideranno di
perseguire questa strada, il
risultato li sorprenderà; ma ci
vorrà del tempo prima che si
convincano che una decisione
così radicale rappresenta l’unico
modo per uscire da questa
situazione.
Gli Stati Uniti e l’Europa non
sono caduti nelle trappole della
liquidità,
quindi
il
loro
principale compito dovrebbe
essere quello di evitare di
caderci.
La
misura
precauzionale più ovvia è quella
di assicurarsi che l’inflazione
non si abbassi troppo quando la
situazione economica è buona:
si deve fissare un tasso di
riferimento almeno del 2%, così
che i tassi d’interesse reali
possano scendere sotto questa
soglia, o anche arrivare a zero se
la situazione lo richiede. In base
a questi criteri gli Stati Uniti, al
momento in cui sto scrivendo,
stanno facendo più o meno la
cosa giusta; invece la politica
monetaria europea è ancora di
stampo troppo conservatore: la
crescita
sta
rallentando,
l’inflazione è a meno dell’1% e
sta ancora calando e il tasso
d’interesse al 3% è troppo
basso per poter servire a
contrastare future recessioni. Mi
auguro che, quando questo
libro verrà pubblicato, la Banca
Centrale Europea si sarà mossa
in maniera aggressiva per
tagliare i tassi e incentivare la
crescita; se non lo avrà fatto, la
trappola della liquidità potrebbe
nel frattempo avere mietuto
un’altra vittima.
Nel lungo periodo sarebbe
una buona idea cercare di
limitare alcune delle debolezze
messe a nudo dai recenti
episodi avvenuti sul mercato. Il
timore nei confronti degli hedge
funds ha mostrato che i mercati
finanziari, che creano molte
istituzioni con funzioni simili a
quelle delle banche ma prive dei
loro sistemi di sicurezza, hanno
fatto tornare d’attualità il
problema del panico finanziario.
Cerchiamo di capire chi deve
cosa a chi, e costruiamo nuove
porte a tenuta stagna, prima che
la crisi ritorni.
Infine, se la crisi dovesse
comunque arrivare, la regola da
seguire è semplice: tagliare i
tassi d’interesse in maniera
drastica,
senza
esitazione.
Sebbene Greenspan creda che i
titoli azionari statunitensi siano
sopravvalutati, ritengo che non
farà lo stesso errore che hanno
fatto i giapponesi quando la loro
economia è crollata a picco, vale
a dire aspettare a tagliare i tassi
d’interesse quando ormai è
troppo tardi. Ho meno fiducia
della Banca Centrale Europea,
ma speriamo che i suoi
responsabili possano capire.
Nel complesso sento di avere
la coscienza pulita riguardo ai
paesi industrializzati. Quel che
voglio dire è che le soluzioni a
questi problemi non sembrano
necessitare di operazioni troppo
dolorose. In particolare non
esiste nessuno specifico motivo
che indichi che l’inflazione al
2% in Europa e negli Stati Uniti,
o l’obiettivo del 4% in
Giappone,
possa
creare
problemi a qualcuno; per
contrastare l’economia della
depressione
i
paesi
industrializzati non devono
comunque
scendere
a
compromessi sul tema del
libero mercato.
Il compito che si trovano
davanti i paesi in via di
sviluppo, al contrario, sembra
più difficile.
Aiutare i poveri
Mentre stavo finendo questo
capitolo, a Davos l’élite
economica mondiale, invece di
congratularsi a vicenda come
era
solita
fare,
stava
combinando il diavolo a
quattro. Ognuno accusava il
Fondo
Monetario
Internazionale del disastro
avvenuto in Brasile, chiedendo
le dimissioni del direttore e
anche l’abolizione di questa
stessa istituzione. Ma i critici
sembravano più in disaccordo
tra di loro di quanto non lo
fossero nei confronti delle
politiche del Fondo Monetario
Internazionale.
Alcuni
affermavano che il Brasile
avrebbe dovuto fissare in
maniera permanente il valore
del real, una volta per tutte,
istituendo un currency board di
tipo argentino. Altri ancora
sostenevano che la valuta
doveva essere lasciata libera di
fluttuare e che l’errore più
grande era stato quello di
aumentare i tassi d’interesse per
sostenerla.
Altri
ancora,
naturalmente, dicevano che il
Brasile avrebbe dovuto stabilire
controlli sui capitali per limitare
i fenomeni speculativi.
La cosa strana è che tutte
queste critiche erano, fino a un
certo punto, corrette. Forse la
politica del Fondo Monetario
Internazionale – che difende il
tasso di cambio a un costo
enorme, ma che non riesce né a
garantire il successo delle sue
decisioni, né a imporre limiti
alle speculazioni in caso di
fallimento – ha creato il
peggiore di tutti i mondi
possibili. A questo punto
potrebbe
essere
meglio,
piuttosto che rimanere a metà
strada, fare una scelta precisa –
un tasso di cambio libero di
fluttuare, un currency board o
un regime di controlli sul
capitale.
Detto ciò, rimango scettico
sulla possibilità di ritornare al
currency board. Per ripetere ciò
che ho già scritto nel capitolo 6,
il currency board protegge un
paese dalle speculazioni contro
la sua valuta, ma non dalle
speculazioni contro la sua
economia;
forse
si
diminuiscono i rischi, ma non è
detto. E se un currency board
fallisce – cosa probabile, a
meno che le condizioni
politiche siano molto favorevoli
al suo successo – il risultato
sarà una terribile catastrofe, che
lascia
il
governo
senza
credibilità alcuna.
L’altra possibilità è quella di
provare con la svalutazione:
lasciare cadere il valore della
valuta, senza alzare i tassi
d’interesse. Tutto ciò funziona
per i paesi industrializzati; forse
anche in alcuni paesi in via di
sviluppo. Ma alla luce di quello
che è avvenuto in Brasile appare
assai chiaro che la strategia
opposta, quella di aumentare i
tassi d’interesse nel tentativo di
evitare che il denaro esca dal
paese, è perdente da tutti i punti
di vista. Non solo comporta
conseguenze
negative
sull’economia
reale;
alimentando il pessimismo degli
investitori spesso non riesce
neanche a stabilizzare il tasso di
cambio. Si potrebbe dunque
concludere che, se il Brasile non
avesse aumentato i tassi
d’interesse per difendere il real,
la valuta avrebbe evitato di
continuare a perdere valore. È
altrettanto vero che alcuni paesi
asiatici che hanno seguito la
politica
degli
alti
tassi
d’interesse stanno cominciando
a riprendersi; per fortuna non
tutti gli incidenti si rivelano
mortali.
Ma che cosa succede se la
svalutazione non è praticabile,
perché le aziende hanno molti
debiti in valuta estera o perché
la gente perde troppo facilmente
fiducia nella valuta? In questo
caso è difficile immaginare
come evitare il controllo sui
movimenti di capitali, una sorta
di coprifuoco alla fuga di
capitali che facilita il ritorno alla
calma. Molti difensori del libero
mercato reagiranno con orrore a
quest’idea: per loro investire il
denaro dove vogliono è un
sacrosanto diritto. Ma, così
come il diritto alla libera
espressione
non
necessariamente include il
diritto a gridare «Al fuoco!» in
un teatro affollato, il principio
del
libero
mercato
non
necessariamente comporta che
gli
investitori
possano
calpestarsi l’un l’altro in preda
al panico. Perché questo è
proprio quello che succede nel
corso di una crisi. Il Brasile
sarebbe un posto piuttosto
sicuro dove investire, se non
fosse per il rischio della crisi –
vale a dire, sarebbe sicuro se
ogni investitore fosse certo che
gli altri investitori non sono in
procinto di portare all’estero i
loro capitali. Ma gli investitori
non hanno fiducia l’uno
nell’altro, e la crisi inizia
puntualmente.
Il fatto è che, quando la crisi
minaccia di esplodere, sarebbe
nell’interesse non solo del
paese,
ma
degli
stessi
investitori, imporre controlli
d’emergenza sui capitali – come
è nell’interesse di tutti se la
popolazione di una città colpita
dal terremoto
ottiene
il
coprifuoco dal governo. Avere
la certezza che, se necessario, i
controlli verranno imposti,
potrebbe addirittura rassicurare,
e non scoraggiare, gli investitori
di lungo periodo, una volta che
questi ultimi si fossero abituati
all’idea.
Forse un modo facile per
riassumere questo concetto è il
vecchio invito ad andare a
messa se si vuole, ma ad
andarci, dannazione. In una crisi
finanziaria un governo deve
avere un ruolo determinante.
Tuttavia la cosa migliore
sarebbe quella di prevenire la
crisi ancor prima che nasca. È
possibile? Al giorno d’oggi
ognuno è favorevole a ricevere
più informazioni su banche e
aziende, al fatto che i rischi
finanziari siano oggetto di
controlli più attenti, e così via. A
questo punto non resta che
trasformare tutto ciò in realtà.
Abbiamo inoltre bisogno di
trovare il modo per ridurre
l’intensità dei circoli viziosi
descritti nel capitolo 5. Visto
che
stiamo
parlando
di
provvedimenti di lungo periodo,
c’è ancora un po’ di tempo per
discutere; il mio personale
suggerimento è che i governi
tentino di scoraggiare le aziende
nazionali a chiedere prestiti in
valuta estera e, forse, anche a
fare eccessivo affidamento sul
denaro preso a prestito in
generale. Il miglior modo per
raggiungere questo scopo è
probabilmente quello di tassare
le aziende che chiedono prestiti
in valuta estera. I paesi
potrebbero così far cadere le
valute senza provocare collassi
finanziari e, di conseguenza,
prevenire
possibili
crisi
finanziarie.
Non mi piace l’idea che le
nazioni abbiano bisogno di
interferire sull’andamento dei
mercati – che debbano porre dei
limiti al libero mercato, in modo
da proteggerlo. Ma è difficile
immaginare che si possa
continuare a fare a meno di
questi provvedimenti, e a
credere che i mercati finanziari
ricompensino sempre la virtù e
puniscano il vizio.
Orgoglio e pregiudizio
Pochi giorni prima che
scrivessi queste pagine, il
presidente Cardoso rifiutò l’idea
dei controlli sul capitale,
affermando che imporli avrebbe
voluto dire mettere fine alle
speranze del Brasile di poter
mai diventare uno stato di
prim’ordine. Tutto ciò avvenne
mentre le newsletter finanziarie
speculavano sul fatto che il
Brasile
avrebbe
potuto
dichiararsi
inadempiente,
addirittura decidere la chiusura
delle banche, e mentre gli
analisti facevano la gara a chi
aumentava di più la sua stima di
calo della produzione.
Non si poteva fare a meno di
sentirsi dispiaciuti per Cardoso,
che aveva fatto del suo meglio,
ma che non era stato
ricompensato per i suoi sforzi.
Aver scoperto che il Brasile non
era pronto per nuotare nel
mercato mondiale dei capitali
senza
un
salvagente
rappresentava un’umiliazione
terribile. Tuttavia il suo paese
non
poteva
permettersi
un’eccessiva dose di orgoglio.
Aveva bisogno di risolvere la
situazione, e se l’unico modo
per farlo era imporre i controlli
sul capitale, che questi fossero i
benvenuti. Dopo tutto, anche la
maggior parte dei paesi oggi
industrializzati aveva imposto
controlli sui capitali per molti
anni dopo la fine della Seconda
guerra mondiale; questi ultimi
diventarono ricchi e, solo in un
secondo tempo, si aprirono ai
movimenti del libero capitale,
non viceversa.
In verità l’orgoglio è un lusso
che al giorno d’oggi nessuno di
noi può permettersi. Se, come
dice qualcuno, in Giappone il
movimento
d’opposizione
all’espansione monetaria nasce
in parte da funzionari che si
sentono sminuiti da uno yen
debole, che temono che la loro
valuta scompaia ora che l’euro è
il principale antagonista del
dollaro,
questi
ultimi
dovrebbero vergognarsi. A
questo proposito rappresenta
invece un ottimo segnale il fatto
che i funzionari europei, che
fino a poco tempo fa
sembravano considerare un
euro forte il più importante
obiettivo della nuova Unione
Monetaria, stiano ora dando
priorità
al
mantenimento
dell’occupazione e alla lotta alla
deflazione.
Un altro modo con cui
l’orgoglio può ostacolare la
capacità di prendere le decisioni
giuste è rappresentato dal
pregiudizio – e con questo
termine intendo il fatto che
molte
persone
influenti
aderiscano
a
visioni
economiche ortodosse che non
hanno più rilevanza in un
mondo come quello attuale.
Vent’anni fa, anche quando i
paesi industrializzati avevano un
tasso d’inflazione a due cifre,
quando i controlli sugli scambi
con l’estero erano fonte di
grandi distorsioni economiche e
di una diffusa corruzione,
predicare le virtù della stabilità
dei prezzi e della convertibilità
valutaria voleva dire far andare
il mondo nella direzione giusta.
Ma oggi non viviamo più in un
mondo che ha le stesse
caratteristiche di allora, e quelli
che ieri erano gridi di guerra
sono ora diventati dottrine
pericolose. Non volersi chiedere
se l’inflazione a tasso zero
rappresenti una situazione
auspicabile quando il vostro
paese sta per cadere nella
trappola della liquidità, rifiutare
di prendere in considerazione
l’eventualità di controllare i
movimenti di capitale quando i
timori
degli
investitori
cominciano a farsi realtà,
significa dare più valore del
dovuto
alle
politiche
economiche del passato.
Chiunque cerchi di discutere
di economia fuori dai confini
accademici
acquista
rapidamente una visione un po’
cinica. Tuttavia c’è qualcosa di
incredibile a proposito della
rigidità mentale di persone così
importanti, non solo funzionari
governativi, ma anche giornalisti
ed economisti di professione.
L’analisi economica non è, o in
ogni caso non dovrebbe essere,
un insieme di regole valide in
tutte le occasioni; dovrebbe
invece essere un modo di
pensare, qualcosa che permetta
di adattare le risposte a un
mondo in continua evoluzione.
Quello che continua a dare
valore all’economia è proprio il
fatto che dai vecchi modelli si
possono
imparare
nuove
soluzioni – capire come si
sviluppano le recessioni può
essere utile per uscire da una
situazione che non si riesce a
curare con gli strumenti
tradizionali. Ma l’anno passato
sono
rimasto
colpito
nell'osservare quanta gente
continui a rifiutare questo modo
di pensare, e si ostini a mettere
assieme nuovi modelli solo per
giustificare le vecchie soluzioni.
Quelli che si preoccupavano di
portare in pareggio i bilanci
quando il problema numero
uno era quello dei deficit fuori
controllo,
oggi
insistono
nell'affermare che aumentare le
tasse e tagliare la spesa può
aiutare
a
prevenire
una
recessione, perché aumenta il
livello di fiducia. Quelli che
volevano prezzi stabili quando
l’inflazione era il rischio
principale, ora affermano che
«la gestione dell’inflazione»
avrà un futuro, perché in
Giappone – ma in nessun altro
posto al mondo – una valuta più
debole e tassi d’interesse reali
più bassi hanno finito per
ridurre la domanda. Se queste
affermazioni si fossero basate
su politiche non ortodosse,
allora sarebbero giustamente
state giudicate prive di senso;
insistere
nel
difendere
l’ortodossia, invece, sembra che
al giorno d’oggi non rappresenti
un reato.
Tutto ciò ci riporta al senso
più
profondo
che
ha
accompagnato
il
ritorno
dell’economia
della
depressione.
Si potrebbe riassumere la
situazione economica attuale
con la frase «Non si può
mangiare senza pagare»; vale a
dire che ci sono risorse limitate,
che per avere più di una cosa
devi accettare di averne meno di
un’altra, che non si può
continuare a non soffrire.
L’economia della depressione,
tuttavia, si occupa di studiare
situazioni in cui, se solo
riuscissimo ad approfittarne, si
potrebbe
effettivamente
mangiare senza pagare, perché
ci sono risorse non sfruttate che
aspettano solo di esserlo. Nel
1930 John Maynard Keynes
scrisse che «ci siamo ficcati in
un bel pasticcio, abbiamo
dovuto cominciare a guidare
una macchina estremamente
sensibile di cui non conosciamo
il funzionamento». Nel suo
mondo – e nel nostro – non
sono le risorse, o le virtù, a
mancare, ma la capacità di
comprensione.
Non riusciremo mai a
imparare quanto dovremmo,
tuttavia, se non iniziamo ad
affrontare lucidamente i nostri
problemi e a seguire i nostri
pensieri,
ovunque
ci
conducano. Alcuni affermano
che i problemi del Giappone, o
dei paesi emergenti dell’Asia, o
del Brasile sono strutturali e che
non
esiste
alcuna
cura
disponibile
nell’immediato;
credo invece che gli unici veri
ostacoli strutturali al benessere
del mondo siano le dottrine
obsolete che annebbiano la
mente degli uomini.
{1}
Si tratta di un orientamento interventista della
politica economica di ispirazione keynesiana,
secondo il quale l’autorità di governo può e deve
calibrare i propri interventi sulla domanda
complessiva per una regolazione precisa del
livello dell’attività produttiva e dell’occupazione,
[n.d.t.]
{2}
Il verbo «to hedge», da cui deriva «hedge
funds» (fondi d’investimento), vuol dire
«limitare», [n.d.t.]
{3}
La terminologia «allo scoperto» e «a termine»
è tecnica, ma si rivela troppo utile per non essere
usata in questo libro. In linea di massima «a
termine» significa mettersi in una posizione per
cui si guadagna se i prezzi aumentano – la
classica situazione che hanno di fronte gli
investitori quando acquistano azioni, immobili o
altro. «Allo scoperto» significa invece mettersi in
una posizione per cui si guadagna se i prezzi
diminuiscono. Per vendere un’azione in questo
modo, la si deve chiedere in prestito dal suo
proprietario, con la promessa di restituirla
successivamente – e quindi la si vende. L’azione
deve essere riacquistata prima della data di
restituzione; l’operazione si basa tutta sulla
previsione che il prezzo, entro quella data,
scenderà. Chi vende l’azione entra in possesso di
denaro liquido, che può essere investito in
qualcosa d’altro – in altre parole sarà possibile
effettuare un’operazione allo scoperto su qualche
altra azione. Naturalmente i proprietari delle
azioni prese a prestito devono essere sicuri che
chi effettua l’operazione allo scoperto disponga
di un sufficiente ammontare di denaro liquido per
ricomprare successivamente le azioni, quindi
possono eventualmente chiedere in cambio una
qualche forma di garanzia. Quando un investitore
che si impegna in un’operazione allo scoperto va
incontro a pesanti perdite, di solito si rende conto
di non essere più in grado di prendere a prestito
come prima. A questo punto, quando questi
investitori cominciano ad avere un certo peso sul
mercato, le conseguenze, come vedremo tra
breve, possono essere molto particolari.