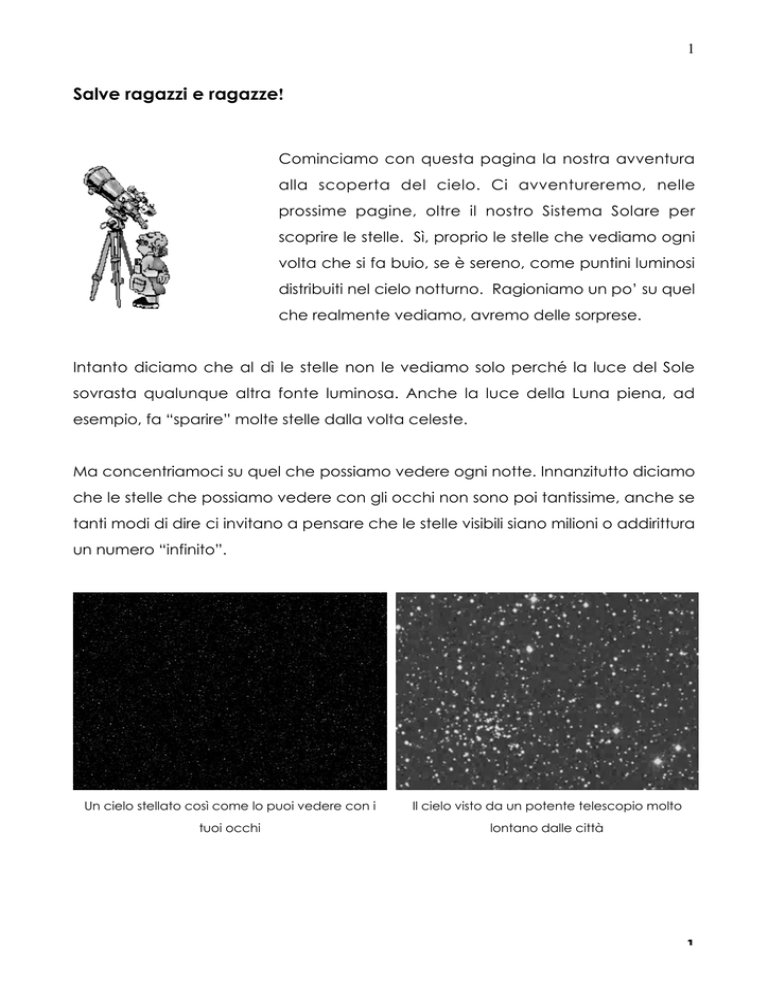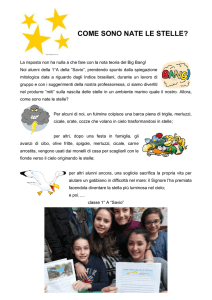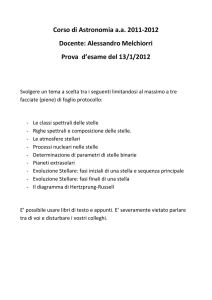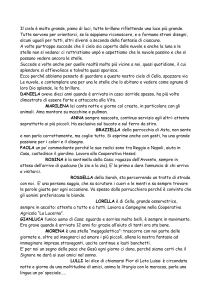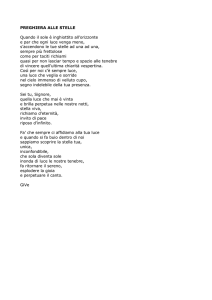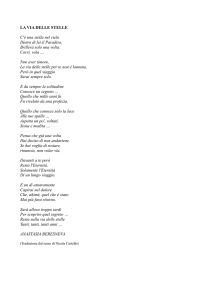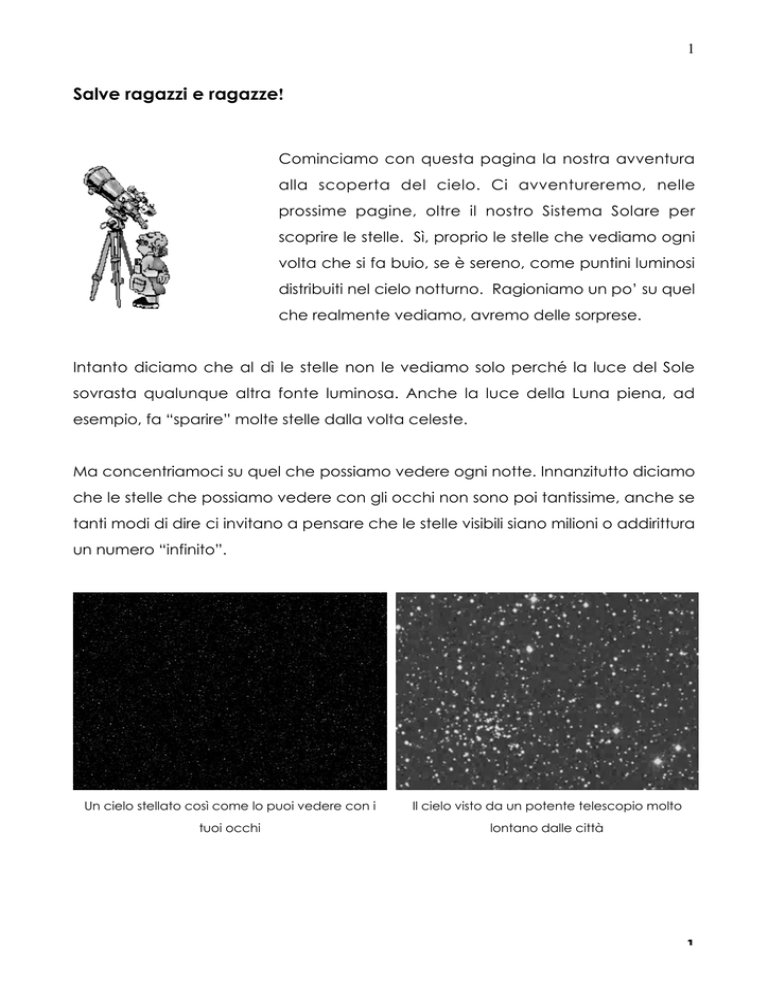
1
Salve ragazzi e ragazze!
Cominciamo con questa pagina la nostra avventura
alla scoperta del cielo. Ci avventureremo, nelle
prossime pagine, oltre il nostro Sistema Solare per
scoprire le stelle. Sì, proprio le stelle che vediamo ogni
volta che si fa buio, se è sereno, come puntini luminosi
distribuiti nel cielo notturno. Ragioniamo un po’ su quel
che realmente vediamo, avremo delle sorprese.
Intanto diciamo che al dì le stelle non le vediamo solo perché la luce del Sole
sovrasta qualunque altra fonte luminosa. Anche la luce della Luna piena, ad
esempio, fa “sparire” molte stelle dalla volta celeste.
Ma concentriamoci su quel che possiamo vedere ogni notte. Innanzitutto diciamo
che le stelle che possiamo vedere con gli occhi non sono poi tantissime, anche se
tanti modi di dire ci invitano a pensare che le stelle visibili siano milioni o addirittura
un numero “infinito”.
Un cielo stellato così come lo puoi vedere con i
Il cielo visto da un potente telescopio molto
tuoi occhi
lontano dalle città
1
2
Ad occhio nudo possiamo vedere distintamente circa 4-5000 stelle in una notte
bella trasparente e scura, magari in un luogo distante dalle luci artificiali. In città il
numero di stelle visibili è molto minore, proprio per la presenza di luci artificiali: in
una piazza molto illuminata, di una grande città ma anche di un piccolo paese, il
numero di stelle visibili si riduce in modo drastico, arriva a poche decine. Come
abbiamo già detto, spesso basta poco per tornare a vedere un bel cielo, è
sufficiente scostarsi da fonti di luce molto forti. Le stelle visibili ad occhio sono
quindi molte ma non moltissime, ma cosa vediamo noi effettivamente? Per
esagerare potremmo dire che quel che vediamo è un cielo “sbagliato” rispetto a
quello reale.
La luce che ci arriva dalle stelle,
infatti, quando entra nell’atmosfera
può venire deviata nella sua
traiettoria. L’atmosfera si comporta,
in qualche modo, come l’acqua
all’interno di un recipiente, un
acquario per esempio o una
boccia per i pesci rossi, che altera la
posizione in cui noi vediamo gli
oggetti.
Di quanto si spostano le stelle per questo effetto varia al variare della loro
posizione in cielo.
La posizione delle stelle che stanno allo zenit, ovvero esattamente sulla nostra
verticale, sopra la nostra testa, non subisce alcuna deviazione, ma, man mano
che scendiamo verso l’orizzonte, l’effetto diventa più cospicuo. A metà strada fra
lo zenit e l’orizzonte la deviazione dovuta alla rifrazione è già cospicua, circa un
trentesimo del diametro della Luna. Ma se scendiamo ancora diventa assai più
forte: all’orizzonte la posizione della stella ci appare spostata di ben mezzo grado,
praticamente tanto quanto è il diametro apparente della Luna. Quello che
vediamo di notte è quindi l’ immagine delle stelle che viene deviata dalla
2
3
posizione che le spetterebbe tanto più quanto più ci si allontana dallo zenit verso
l’orizzonte.
Potete fare una piccola esperienza con
una torcia luminosa piccola ed una
boccia d’acqua, o l’acquario se
l’avete. Fatevi aiutare da un compagno
o qualcuno di casa, voi state da una
parte della boccia d’acqua, dall’altra
parte il vostro compagno muoverà la
torcia a destra e sinistra e in alto e in
basso, ma sempre in modo che sia
puntata su di voi.
Noterete facilmente la differenza fra la posizione reale della torcia luminosa e
quella che vi appare.
È per questo effetto dovuto alla rifrazione che agisce differentemente a seconda
della altezza della stella sull’orizzonte che, se per esempio siamo in riva al mare o
abbiamo davanti una pianura , vediamo all’alba il Sole prima che sorga ed al
tramonto lo vediamo ancora per qualche minuto dopo che è effettivamente
tramontato. È la rifrazione che va a “pescare” il Sole e sposta la sua immagine
apparente sopra l’orizzonte di mezzo grado, facendocelo vedere qualche minuto
“prima” all’alba e ancora per qualche minuto al tramonto.
Ma questo è solo l’inizio, un altro effetto che sposta la posizione vera delle stelle
nella volta celeste è l’aberrazione. A tenerne conto con precisione è piuttosto
complicata, ma il concetto che sta alla base è semplice da capire. L’aberrazione
è stata “scoperta” da James Bradley nel 1729, quando i telescopi erano assai
rudimentali e non c’erano computer per fare i conti. La luce che ci proviene dalle
stelle viene deviata a causa del moto della Terra. Noi ovviamente non ce ne
accorgiamo perché la gravità ci tiene sulla crosta terrestre e tutto, compresa la
atmosfera, si muove con noi, ma la Terra, ruotando attorno al Sole, si muove alla
bella velocità di 30 chilometri al secondo (più di 100.000 chilometri all’ora!). La sua
3
4
velocità quindi non è trascurabile rispetto a quella della luce e bisogna tenerne
conto.
Nel suo moto attorno al Sole la Terra
quindi per sei mesi andrà “incontro”
alla luce che ci proviene da una data
stella, mentre per i seguenti sei mesi
andrà nella stessa direzione della luce
stellare.
Per effetto dell’aberrazione le stelle, in un anno, sembrano quindi descrivere in
cielo una minuscola ellissi che ha un diametro, per fissare le idee, di un trentesimo
del diametro della Luna. Per visualizzare questo effetto possiamo pensare a quel
che ci succede quando piove: anche se le gocce di pioggia vengono giù
perfettamente perpendicolari, se ci muoviamo dobbiamo inclinare l’ombrello in
avanti per non bagnarci.
È tutto forse? Nemmeno per idea, non abbiamo preso in considerazione il punto
più importante: la distanza delle stelle. La luce che ci proviene da esse viaggia
alla maggiore velocità possibile in natura: 300.000 km al secondo. Non è poco ed
è molto difficile da immaginare. A questa velocità si può andare da Palermo a
Torino in 1/300 di secondo, o “correre” i cento metri in un trentamilionesimo di
secondo, parecchio di meno del record mondiale ! Per tornare un attimo ad
argomenti che conosciamo bene consideriamo che la luce riflessa dalla Luna ci
arriva in poco più di un secondo, quella emessa dal Sole in circa 8 minuti. Noi
insomma vediamo il sole “vecchio” di 8 minuti. Per arrivare al pianeta più distante,
Plutone, la luce solare impiega circa 5 ore e mezzo .
Le stelle sono tutte molto ma molto più distanti dei corpi del Sistema Solare, anche
la più distante cometa della nube di Oort dista da noi molto meno della più vicina
stella, Proxima della costellazione del Centauro. Proxima, come molti di voi
sapranno, è una parola latina che significa la più vicina e le è stato dato questo
4
5
nome proprio perché è la stella meno distante da noi. La luce che parte da
Proxima del Centauro impiega ben 4 anni per arrivare a noi. Ma tutte le altre sono
molto più distanti e, fra quelle che vediamo ad occhio nudo, ce ne sono alcune
talmente distanti che la loro luce impiega diecine di migliaia di anni per arrivare
fino a noi. Le stelle quindi potrebbero, ora, essere diverse da quelle che vediamo,
ma noi non lo possiamo sapere.
5
6
Quel che vediamo quindi, quando alziamo gli occhi al cielo, è un cielo di stelle la
cui posizione viene alterata da vari effetti e che sono in uno stato “vecchio” di un
tempo che può variare dai pochi anni alle molte migliaia. E non possiamo farci
nulla.
Forse queste considerazioni vi faranno guardare il cielo in modo un po’ diverso,
comunque ci fanno riflettere su una particolarità dell’Astronomia rispetto alle altre
scienze. L’Astronomia è una scienza osservativa, ma non sperimentale. Forse detto
così può sembrare un discorso un po’ filosofico e di poco conto, ma non lo è
affatto ed è molto importante. Cerchiamo di capire perché.
Cambiamo completamente campo e dimentichiamoci per un attimo
dell’Astronomia, delle stelle e tutto il resto.
Supponiamo di essere dei chimici e volere
studiare come si scioglie una sostanza
solida in un liquido. Niente di più facile
basta
prendere,
ad
esempio,
un
contenitore con dell’acqua e del sale e
versare una certa quantità di sale
nell’acqua.
Quello
che
potremo
verificare è che il sale si scioglie
nell’acqua, ma fino ad una certa
quantità. Se continuiamo a versare sale
nell’acqua, infatti, oltre una certa
quantità il sale non si scioglierà più.
Ma per capire bene come funziona la questione possiamo fare di più, possiamo
per esempio usare acqua più fredda, e scopriremmo che la quantità di sale che
riusciamo a sciogliere è minore, oppure potremmo usare acqua più calda. Ma
possiamo anche cambiare liquido o sostanza da sciogliere. Possiamo, in sostanza,
crearci una casistica sperimentale variando le condizioni in cui il fenomeno
6
7
avviene e, soprattutto, ripetere l’esperienza tutte le volte che vogliamo. Su tutti i
dati sperimentali che ci saremo procurati potremo poi ragionare e cercare di
estrarre una legge generale che descriva come una sostanza solida si sciolga in
un liquido.
Anche se esposto in questo modo risulta un po’ semplificato, questo è il modo di
procedere delle scienze sperimentali: sperimentare, misurare e dalle misure
cercare di arrivare alla comprensione del fenomeno osservato e ad una legge
che lo descriva.
Per l’Astronomia non è proprio così. Non possiamo infatti “sperimentare”,
intervenendo sul fenomeno, come abbiamo fatto poco sopra con l’acqua ed il
sale. Non possiamo fare una stella in laboratorio, renderla più calda o più grande.
Come ne usciamo? Come facciamo allora ad applicare il metodo sperimentale
della scienza al caso del cielo?
È semplice se ci pensiamo, tutto quello che possiamo fare è “osservare” i corpi ed i
fenomeni celesti e, da questi, ottenere i dati di cui abbiamo bisogno per capire
come sono fatti e quali fenomeni accadono in cielo.
Le nostre speranze e possibilità di capire le stelle, ad esempio, sono quindi legate
all’unico segnale che ci proviene da quei corpi. Dato che stiamo usando gli occhi
i segnale che ci porta informazioni è la luce visibile. Vedremo più avanti che,
usando dei ricettori diversi dai nostri occhi, avremo molte altre possibilità di
ottenere informazioni. Sembra poco e forse un po’ scoraggiante, ma la luce ci dà
abbastanza informazioni per ricostruire come sono distribuite le stelle nel cielo , di
cosa sono “fatte” e cosa “accade” in questi oggetti. È proprio questo che
impareremo nelle prossime pagine. Per ora cerchiamo di ripensare a quello che
fino ad ora abbiamo detto su quel che vediamo realmente in cielo quando
guardiamo le stelle ad occhio nudo.
La luce che vediamo ci dà infatti due diversi tipi di informazione: osservando
quanta luce ci arriva da una determinata stella ci permette di capire dove essa è
situata e, come vedremo, quanto distante è da noi. Ma della luce possiamo
anche fare una analisi quantitativa.
7
8
Fa parte della nostra esperienza comune osservare
come la luce del Sole sia composta di vari
componenti che, miscelati, ci danno una
apparenza complessiva di colore bianco. Ma
basta un arcobaleno, o il riflesso della luce
sull’acqua in determinate condizioni o il suo
passaggio attraverso qualche vetro spesso per far
apparire
i “colori” di cui la luce solare è
composta.
La analisi della luce, delle sue componenti, ci racconta molto del corpo da cui
proviene ed in particolare quali elementi chimici sono coinvolti nel fenomeno che
ha portato alla emissione di quella luce. Se volete potete costruire il semplice
“spettrografo” descritto nell’allegato ed eseguire le varie esperienze per
sperimentare in modo semplice e convincente quel che abbiamo appena detto.
Per riassumere in Astronomia possiamo quindi solo osservare la luce che ci arriva
dalle stelle, da questa possiamo capire dove sono le stelle, conoscere la loro
distanza e quindi posizionarle correttamente in 3 dimensioni e ricostruire la loro
distribuzione nello spazio. L’analisi della luce che ci arriva, ad esempio con uno
spettrografo, ci permette anche di capire di cosa sono composte le stelle e quali
sono le condizioni fisiche in cui si trovano.
Ricorda che se vuoi avere altre
informazioni, vedere più immagini
o anche rivolgere una domanda
direttamente ad un astronomo
puoi
recarti
sul
sito
Web
www.scopriticielo.it. Entra nel sito e
clicca sul tuo Osservatorio, quello
di Monte Arancio.
8