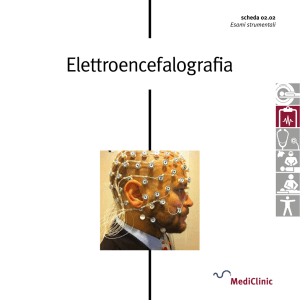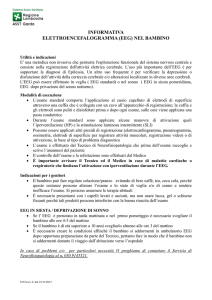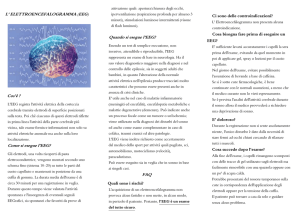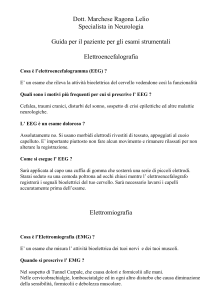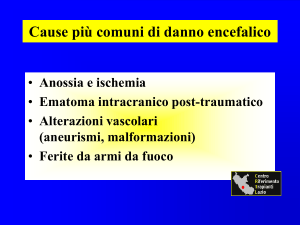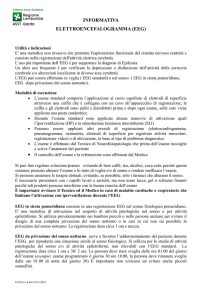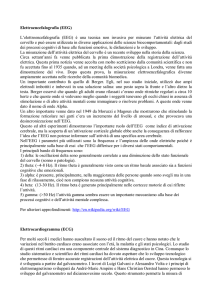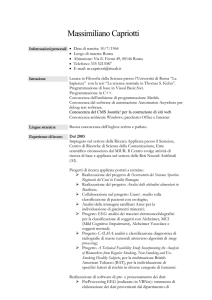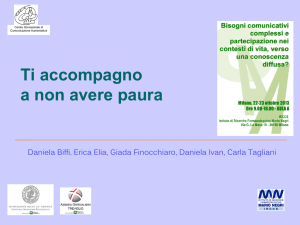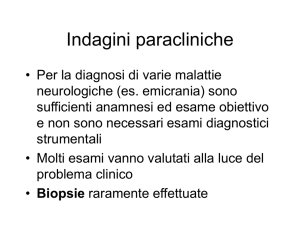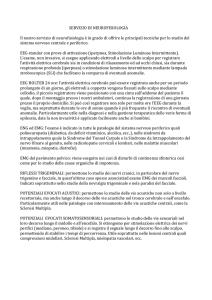Elettrogenesi corticale e EEG
Dott. Vittorio Govoni
Clinica Neurologica
A.A. 2009 – 2010
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
V anno Secondo Semestre
Elettrogenesi corticale e EEG
l’attività dei neuroni della corteccia cerebrale è coordinata in modo tale
da indurre variazioni del campo elettrico registrabili dal capo
questa osservazione di Berger (1924) è all’origine dell’EEG,
registrazione sistematica delle variazioni di potenziale raccolte dagli
elettrodi distribuiti sul capo (registrazione multicanale dell’attività
elettrica di superficie del cervello)
Basi fisiologiche dell’EEG
l’interpretazione fisiologica dell’EEG è complessa e non del tutto chiarita: i
principali neuroni corticali sono orientati secondo un asse perpendicolare alla
superficie delle circonvoluzioni cerebrali
i dendriti si espandono negli strati più superficiali della corteccia mentre l’assone si
dirige in profondità nella sostanza bianca
pirenoforo e dendriti si articolano con un gran numero di terminazioni sinaptiche su
cui si esercitano azioni eccitatorie (PPSE) e inibitorie (PPSI)
Basi fisiologiche dell’EEG
la propagazione di correnti locali provoca il continuo sommarsi di PPSE e PPSI
sulla membrana cellulare
se la depolarizzazione della regione vicina all’origine dell’assone raggiunge il livello
soglia si produce una scarica neuronale (una scarica di potenziali d’azione propagati
lungo l’ assone)
le influenze sinaptiche sul pirenoforo hanno un effetto diretto sulla produzione di
questa scarica
le influenze sui dendriti agiscono indirettamente modulando il grado di eccitabilità
del neurone (la probabilità che esso risponda con una scarica a un dato eccitamento
afferente)
Basi dell’EEG
EEG è la somma delle attività unitarie che si svolgono in seno a una grande
popolazione di neuroni sottostanti l’elettrodo
l’osservazione di “ritmi” e di “figure” fisiologiche nell’EEG dimostra che l’attività
dei neuroni non è anarchica ma che essi sono sottoposti a meccanismi che ne
assicurano la sincronizzazione
Basi dell’EEG
la sincronizzazione è di grado estremo nella crisi epilettica che si manifesta
con la comparsa di “figure” patologiche specifiche (dette “epilettiformi”) di
grande ampiezza
la comparsa di figure patologiche “epilettiformi” di grande ampiezza
riflette la sincronizzazione della scarica di una vasta popolazione di neuroni
cerebrali (scarica eccessiva ipersincrona)
le basi dell’EEG
si pensa che i ritmi permanenti dell’EEG derivino da variazioni periodiche della
polarizzazione dei dendriti (“modulazione”)
questa “modulazione” è relativamente indipendente dall’attivazione specifica dei
neuroni corticali (dalla scarica neuronale, dalla scarica di potenziali d’azione
propagati lungo l’assone) per quanto questa tende a farla scomparire (“reazione
d’arresto” del ritmo alfa all’apertura degli occhi)
si pensa che questa “modulazione” dipenda da effetti sinaptici eccitatori e inibitori
dendritici di cui gli interneuroni corticali sono la fonte principale
le basi dell’EEG
l’attività corticale non è anarchica ma sottoposta a una regolazione da parte di meccanismi
posti a distanza (sistemi sottocorticali profondi mediani e paramediani a proiezione corticale
diffusa)
la maturazione dell’EEG e le modificazioni in funzione del livello di coscienza dimostrano il
ruolo spettante a tali sistemi di controllo
nel sonno si osservano cambiamenti caratteristici dell’ EEG in sequenza (rallentamento
globale progressivo dell’attività di fondo, onde aguzze al vertice, fusi del sonno e complessi K
che riflettono un’attività corticale sincrona altamente organizzata
tecnica di registrazione dell’EEG
l’ordine di grandezza degli eventi registrati è 10-100 microvolt
l’EEG ha richiesto lo sviluppo di sistemi di amplificazione
il metodo di esplorazione è standardizzato (sistema internazionale 10-20)
da 20 a 30 elettrodi sono posti simmetricamente sulle due metà del capo
un sistema di commutatori permette di selezionare diverse combinazioni di
derivazioni tra gli elettrodi (montaggi)
tecnica di registrazione dell’EEG
nella modalità di registrazione abituale, bipolare, gli elettrodi sono posti in
serie lineari: trasversali (anteriore, media, posteriore) e
longitudinali (superiore e inferiore)
nella modalità monopolare ogni elettrodo è collegato a un elettrodo di
riferimento comune
ritmi cerebrali
nell’ EEG si osservano variazioni periodiche dei potenziali registrati (dette
ritmi meglio caratterizzati dalla frequenza che dall’ampiezza)
il ritmo alfa, 8-13 Hz, compare nel soggetto in stato di riposo sensoriale
(veglia rilassata a occhi chiusi, attività mentale “leggera”)
si registra normalmente sui 2/3 posteriori del capo (regione parietotemporo-occipitale) ed è interrotto tipicamente dall’apertura degli occhi
(“reazione d’arresto”) in modo sincrono e simmetrico sulle derivazioni dei
due lati
ritmi cerebrali
sulle regioni anteriori (frontale e centrale “rolandica”) si osservano ritmi in
banda beta ( >13 Hz) di minore ampiezza rispetto all’alfa
sulle regioni temporali si osserva spesso un ritmo di frequenza minore
dell’alfa, in banda theta (4-7 Hz ), più ampio dei ritmi beta anteriori (theta
bi-temporale simmetrico sui due lati)
in certi stati patologici si possono osservare ritmi più lenti (< 4 Hz, ritmi in
banda delta) di varia ampiezza
EEG normale
EEG di un soggetto sano, adulto, vigile, in riposo sensoriale, rilassato, con gli occhi
chiusi presenta un’ attività di fondo in banda alfa “spazializzata” che occupa i 2/3
posteriori del capo (regione parieto-temporo-occipitale) bilaterale, simmetrica,
sincrona e stabile (le asimmetrie di frequenza sono sempre più significative delle
asimmetrie di ampiezza, fino al 50%)
i ritmi beta si registrano sulle regioni frontali e centrali (“rolandiche”), i ritmi theta
si possono osservare sulle regioni temporali spesso frammisti all’alfa (ritmo theta
frammisto bi-temporale simmetrico)
si osserva la “reattività” del ritmo alfa che viene interrotto dall’apertura degli occhi
in modo sincrono e asimmetrico sui due emisferi e sostituito bilateralmente da ritmi
rapidi
manovre di attivazione
il sonno, la privazione di sonno, l’iperpnea (HPN) e la stimolazione luminosa
intermittente (SLI) possono provocare la comparsa di figure epilettiformi (assenti
nell’EEG a riposo) e vengono chiamate nel loro complesso manovre (prove) di
attivazione; nell’ EEG di routine si esegue la prova dell’iperpnea (HPN) e la SLI,
l’iperventilazione, sopratutto nel bambino, tende a produrre ritmi più lenti, più ampi
e più regolari
la SLI può interrompere il ritmo alfa e determinare la comparsa di potenziali
posteriori, bilaterali simmetrici e sincroni che si ripetono al ritmo della SLI
(“trascinamento” fotico posteriore, bilaterale sincrono e simmetrico)
EEG nello sviluppo
la maturazione delle strutture cerebrali si associa a una modificazione
progressiva dell’EEG
nel prematuro si registrano ritmi rapidi di bassa ampiezza (non
sincronizzati sui due emisferi)
nel neonato a termine l’attività è ampia, lenta, instabile
nei primi 2-3 anni l’ EEG accelera e tende a organizzarsi sottoforma di un
ritmo theta a 4-5 Hz
il ritmo alfa compare a 5 anni, in seguito l’evoluzione prosegue fino all’età
adulta e avanzata
figure EEG patologiche
le più specifiche tra quelle che si inscrivono sui ritmi di fondo sono le
figure epilettiformi
figure che si stagliano chiaramente sull’attività di fondo: punte (figure
puntute bi- e tri-fasiche molto rapide, < 1/12 di secondo, <83 mmsec),
onde puntute (figure aguzze bi- e tri-fasiche rapide (<1/5 di secondo, < 200
mmsec), complessi di punta-onda, complessi di polipunta – onda e
complessi di onda puntuta – onda lenta
EEG patologico
Anomalie diffuse sui due emisferi (“generalizzate sui due emisferi”) sia onde lente
sia figure parossistiche (con inizio e fine improvvisi) vanno interpretate tenendo conto
di età, vigilanza, condizioni di registrazione (a riposo, in iperpnea, SLI) e quadro
clinico; anomalie lente diffuse (a proiezione bi-emisferica) possono dipendere da
un’anomalia non lesionale nel quadro di un’ encefalopatia “diffusa” (metabolica,
endocrina, tossica, iatrogena, infettiva), ma anomalie lente diffuse bilaterali più o
meno sincrone sui due emisferi possono dipendere da un’ alterazione lesionale delle
strutture centrali profonde che controllano normalmente la modulazione dei ritmi
corticali; anomalie epilettiformi diffuse sui due emisferi quando bilaterali sincrone e
simmetriche (c.d. “generalizzate”) sono caratteristiche delle Epilessie Generalizzate
Idiopatiche
anomalie localizzate (“focali”) dell’EEG
le Anomalie Localizzate (“Focali”) riflettono un’alterazione cerebrale circoscritta;
un’alterazione focale può però dipendere anche da una lesione a distanza che
interessa una struttura profonda che proietta su quella regione della corteccia
le anomalie “focali” si caratterizzano per 1) segni EEG deficitari (segni lesionali)
come onde lente (delta o delta-theta) o una riduzione di ampiezza localizzata dei
ritmi cerebrali oppure 2) segni EEG di iperfunzione come le figure “epilettiformi”
che riflettono una scarica neuronale eccessiva parossistica ipersincrona di una
popolazione di neuroni cerebrali (punte, onde puntute, complessi di punta-onda, di
polipunta-onda o di onda puntuta –onda lenta) la semeiologia EEG non è quasi mai
specifica di un’eziologia
EEG nella pratica clinica
l’EEG è un esame di semplice esecuzione, è relativamente poco costoso e
utile in diversi contesti clinici
richiede però la collaborazione del paziente e capacità di rilassamento
psico-fisico
valutazione del paziente con sospetta Epilessia
anomalie epilettiformi con andamento parossistico (anomalie EEG
caratteristiche con inizio e fine improvvisi) durante disturbi accessuali
compatibili con crisi epilettiche stabilisce la diagnosi certa (registrazione
della crisi epilettica)
le crisi epilettiche sono imprevedibili e non è frequente registrare l’EEG
durante una crisi epilettica (importanza della video-EEG)
nonostante ciò l’ EEG di routine è spesso alterato nei periodi intercritici ed
è utile a scopo diagnostico
valutazione del paziente con sospetta Epilessia
le anomalie epilettiformi intercritiche sono di aiuto a questo riguardo anche
se il 20-40% dei soggetti affetti da Epilessia presenta un EEG di routine
privo di anomalie epilettiformi (fino al 50% al primo EEG)
anomalie epilettiformi si osservano però anche in soggetti che non hanno
mai avuto crisi epilettiche (2-7%) ma la loro frequenza è maggiore nei
soggetti epilettici rispetto ai soggetti non epilettici
anomalie epilettiformi intercritiche in un soggetto che ha presentato episodi
accessuali (motori, sensitivi, sensoriali,vegetativi, psichici, alterazioni pure
della coscienza) compatibili con crisi epilettiche aumentano grandemente la
probabilità che il paziente sia affetto da Epilessia
valutazione del paziente con Epilessia
EEG aiuta a classificare il tipo di sindrome epilettica e a selezionare la
terapia anti-epilettica appropriata
nei pazienti affetti da Epilessia Generalizzata Idiopatica con crisi di
Assenza (“Piccolo Male”) EEG presenta in fase critica e in fase intercritica
scariche generalizzate di complessi di punta – onda a 3 Hz
( facilitate da HPN) inscritte su un’attività di fondo normale
nei pazienti con episodi accessuali di alterazione della coscienza causati da
crisi epilettiche focali complesse EEG può mostrare in fase intercritica
scariche focali di figure epilettiformi
durante una crisi epilettica si osserva un’attività elettrica anomala
parossistica caratterizzata da figure epilettiformi di frequenza e ampiezza
variabile a distribuzione localizzata (crisi focale), generalizzata (crisi
generalizzata) o focale secondariamente generalizzata
prognosi del paziente con Epilessia
EEG fornisce indicazioni utili ai fini della prognosi dell’Epilessia
EEG con attività di fondo normale e rare scariche di figure epilettiformi
implica una prognosi più favorevole circa il controllo delle crisi epilettiche
EEG con attività di fondo molto alterata e con frequenti scariche di figure
epilettiformi (EEG molto “attivo”) implica una prognosi sfavorevole circa
il controllo delle crisi epilettiche
interruzione della terapia anti-epilettica
EEG è di aiuto nel decidere se interrompere la terapia anti-epilettica nei
pazienti liberi da crisi epilettiche da diversi anni
la sospensione della terapia ha più probabilità di successo se nell’EEG sono
assenti scariche di figure epilettiformi sia a riposo sia durante le prove di
attivazione (HPN e SLI), però l’EEG fornisce solo un’informazione generica
e nonostante l’assenza di scariche di figure epilettiformi nell’EEG i pazienti
possono comunque presentare crisi epilettiche alla sospensione della terapia
ma il rischio è inferiore (50% vs 75% nelle sintomatiche lesionali)
trattamento dello stato epilettico (SE)
EEG è di scarso aiuto nello SE tonico-clonico (convulsivo) a meno che non
siano stati somministrati farmaci bloccanti la trasmissione neuro-muscolare e il
paziente sia in coma farmacologico indotto con anestetici generali, in questo
caso EEG è utile per indicare il livello di anestesia e per valutare il persistere o
il ripetersi delle crisi epilettiche
nell’ EEG lo SE si caratterizza per la presenza di un’attività epilettifome
continua o il continuo ripetersi di crisi elettriche focali o generalizzate
nello SE non convulsivo con alterazione della coscienza l’EEG permette la
diagnosi e distingue i due tipi principali
nello SE non convulsivo generalizzato tipo assenza (Stato di Assenza) si
osserva un’ attività epilettiforme generalizzata continua di punta-onda a 3 Hz o
il continuo ripetersi di crisi elettriche generalizzate
nello SE focale complesso senza manifestazioni motorie (non convulsivo focale
con alterazione della coscienza) si osserva un’attività epilettifome focale
continua o il continuo ripetersi di crisi elettriche focali
diagnosi di sospetta lesione cerebrale
EEG è stato utilizzato per molti anni quale esame non invasivo nella
diagnosi di sospetta lesione cerebrale
in caso di lesione cerebrale si possono osservare anomalie lente “focali”,
una riduzione d’ ampiezza localizzata dell’attività elettro-corticale
(depressione, attenuazione circoscritta dell’attività di fondo) o
un’alterazione EEG più diffusa (anomalie lente diffuse) all’emisfero
omolaterale alla lesione o a entrambi gli emisferi che in genere riflette
un’alterazione del livello di coscienza causata dalla lesione cerebrale (il
rallentamento è in genere più pronunciato nell’emisfero omolaterale),
inizialmente le anomalie lente diffondono all’emisfero omolaterale alla
lesione quando la lesione è molto vasta o tende a espandersi
La diagnostica per immagini neuroradiologica (TC e RMN encefalo) ha
sostituito l’EEG in questo contesto
diagnosi di sospetta encefalopatia diffusa
onde aguzze trifasiche diffuse sui due emisferi inscritte su un’attività di
fondo globalmente rallentata e scarsamente reagente si osservano spesso
nelle encefalopatie “diffuse” (insufficienza epatica, polmonare, renale)
abbondante attività beta proiettata su tutte le derivazioni, non interrotta
dall’apertura degli occhi associata a un rallentamento globale dell’attività di
fondo suggerisce un’intossicazione da benzodiazepine, barbiturici o altri
farmaci sedativo-ipnotici
diagnosi di malattie neurologiche
alcune malattie neurologiche mostrano all’EEG anomalie caratteristiche che per
quanto non specifiche sono utili nella diagnosi
scariche periodiche di figure epilettiformi (ampie onde puntute ogni 2-4 secondi) in
uno o a volte in entrambi gli emisferi cerebrali più evidenti sulla regione temporale
in un soggetto con alterazione acuta delle funzioni cerebrali suggerisce la diagnosi
di Encefalite da Herpes Simplex
ampie onde puntute diffuse periodiche (ogni 0,5-2 secondi) più evidenti sulle
regioni anteriori dei due emisferi inscritte su un’attività di fondo globalmente
rallentata e depressa in un adulto con demenza subacuta e mioclonie multifocali
( bilaterali asimmetriche e asincrone senza stretto rapporto con le onde puntute
periodiche) suggerisce la diagnosi di malattia di Creutzfelt -Jakob
scariche diffuse di ampie onde delta periodiche (ogni 5-10 secondi) inscritte su
un’attività di fondo rallentata e depressa in un bambino con turbe del
comportamento, declino delle funzioni nervose superiori (linguaggio) e mioclonie
bilaterali periodiche (sincrone e asincrone con le onde delta periodiche) suggerisce
la diagnosi di Panencefalite Sclerosante Subacuta (PESS)
valutazione delle alterazioni della coscienza
Attività elettro-corticale tende universalmente a rallentare nei quadri di depressione della coscienza
la presenza di anomalie epilettiformi può suggerire diagnosi non considerate
le registrazioni seriali dell’EEG nei pazienti in coma contribuiscono alla prognosi e al monitoraggio della
malattia causale
la reattività dell’ EEG agli stimoli sensitivo-sensoriali (richiamo verbale, stimoli acustici non verbali,
dolore) nel coma è utile ai fini diagnostici e prognostici e indica un livello di coma meno profondo
assenza di attività elettrica di origine cerebrale, spontanea e provocata, per un tempo superiore a 30 minuti
(quadro di silenzio elettrico cerebrale, tracciato EEG “isoelettrico”, EEG “piatto”) è una delle condizioni
necessarie per la diagnosi di morte cerebrale
pazienti apparentemente comatosi possono avere in realtà coscienza integra benchè presentino tetraplegia,
paralisi bilaterale dei muscoli faciali, paralisi di sguardo laterale bilaterale e paralisi sopranucleare dei
muscoli a innervazione bulbare (sindrome “locked-in” sindrome da “defferentazione” causata da una
lesione bilaterale del ponte ventrale) hanno un normale EEG di veglia che aiuta a definire la diagnosi