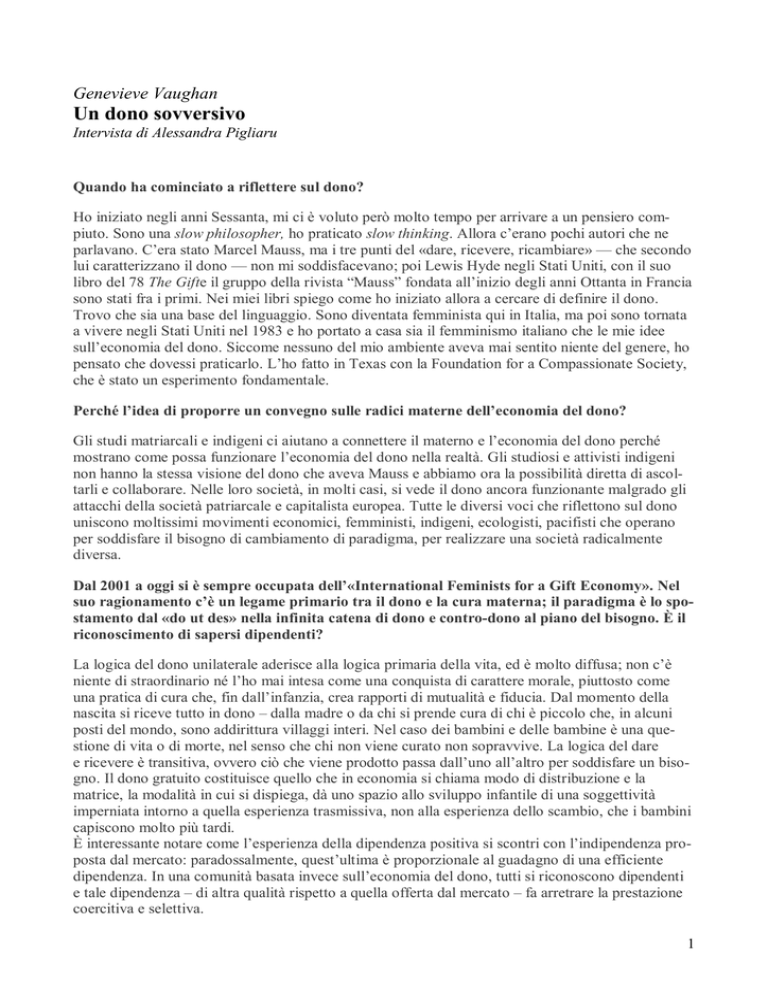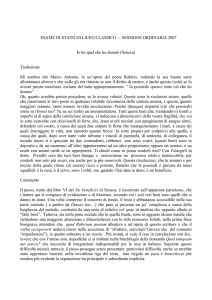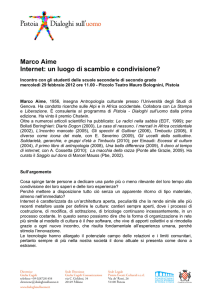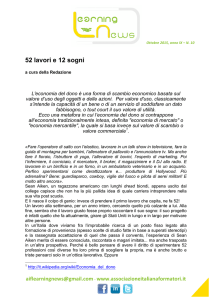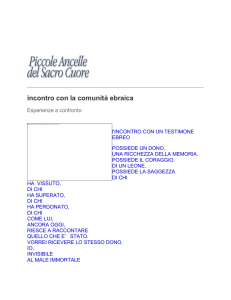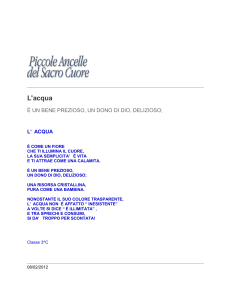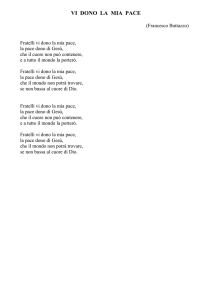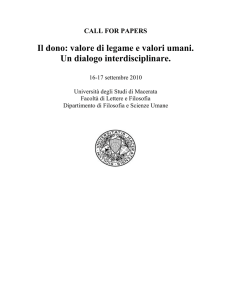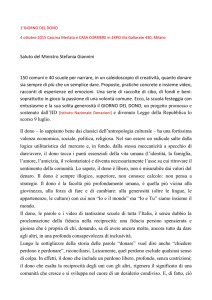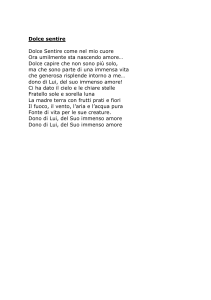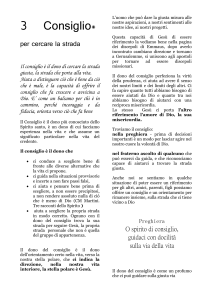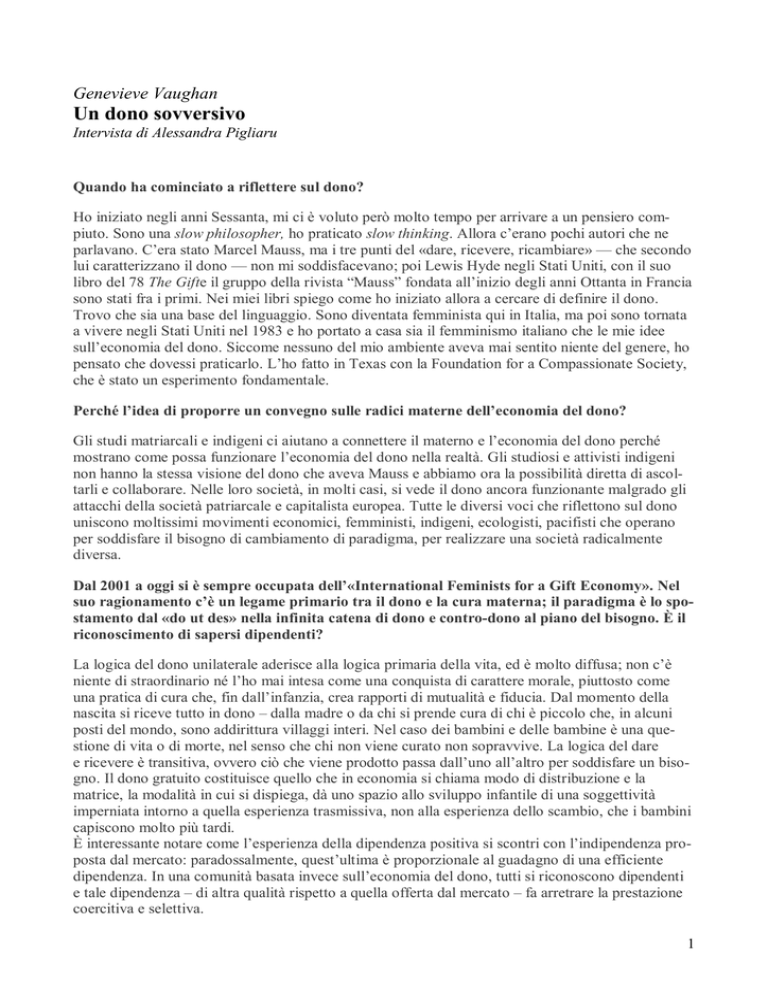
Genevieve Vaughan
Un dono sovversivo
Intervista di Alessandra Pigliaru
Quando ha cominciato a riflettere sul dono?
Ho iniziato negli anni Sessanta, mi ci è voluto però molto tempo per arrivare a un pensiero compiuto. Sono una slow philosopher, ho praticato slow thinking. Allora c’erano pochi autori che ne
parlavano. C’era stato Marcel Mauss, ma i tre punti del «dare, ricevere, ricambiare» — che secondo
lui caratterizzano il dono — non mi soddisfacevano; poi Lewis Hyde negli Stati Uniti, con il suo
libro del 78 The Gifte il gruppo della rivista “Mauss” fondata all’inizio degli anni Ottanta in Francia
sono stati fra i primi. Nei miei libri spiego come ho iniziato allora a cercare di definire il dono.
Trovo che sia una base del linguaggio. Sono diventata femminista qui in Italia, ma poi sono tornata
a vivere negli Stati Uniti nel 1983 e ho portato a casa sia il femminismo italiano che le mie idee
sull’economia del dono. Siccome nessuno del mio ambiente aveva mai sentito niente del genere, ho
pensato che dovessi praticarlo. L’ho fatto in Texas con la Foundation for a Compassionate Society,
che è stato un esperimento fondamentale.
Perché l’idea di proporre un convegno sulle radici materne dell’economia del dono?
Gli studi matriarcali e indigeni ci aiutano a connettere il materno e l’economia del dono perché
mostrano come possa funzionare l’economia del dono nella realtà. Gli studiosi e attivisti indigeni
non hanno la stessa visione del dono che aveva Mauss e abbiamo ora la possibilità diretta di ascoltarli e collaborare. Nelle loro società, in molti casi, si vede il dono ancora funzionante malgrado gli
attacchi della società patriarcale e capitalista europea. Tutte le diversi voci che riflettono sul dono
uniscono moltissimi movimenti economici, femministi, indigeni, ecologisti, pacifisti che operano
per soddisfare il bisogno di cambiamento di paradigma, per realizzare una società radicalmente
diversa.
Dal 2001 a oggi si è sempre occupata dell’«International Feminists for a Gift Economy». Nel
suo ragionamento c’è un legame primario tra il dono e la cura materna; il paradigma è lo spostamento dal «do ut des» nella infinita catena di dono e contro-dono al piano del bisogno. È il
riconoscimento di sapersi dipendenti?
La logica del dono unilaterale aderisce alla logica primaria della vita, ed è molto diffusa; non c’è
niente di straordinario né l’ho mai intesa come una conquista di carattere morale, piuttosto come
una pratica di cura che, fin dall’infanzia, crea rapporti di mutualità e fiducia. Dal momento della
nascita si riceve tutto in dono – dalla madre o da chi si prende cura di chi è piccolo che, in alcuni
posti del mondo, sono addirittura villaggi interi. Nel caso dei bambini e delle bambine è una questione di vita o di morte, nel senso che chi non viene curato non sopravvive. La logica del dare
e ricevere è transitiva, ovvero ciò che viene prodotto passa dall’uno all’altro per soddisfare un bisogno. Il dono gratuito costituisce quello che in economia si chiama modo di distribuzione e la
matrice, la modalità in cui si dispiega, dà uno spazio allo sviluppo infantile di una soggettività
imperniata intorno a quella esperienza trasmissiva, non alla esperienza dello scambio, che i bambini
capiscono molto più tardi.
È interessante notare come l’esperienza della dipendenza positiva si scontri con l’indipendenza proposta dal mercato: paradossalmente, quest’ultima è proporzionale al guadagno di una efficiente
dipendenza. In una comunità basata invece sull’economia del dono, tutti si riconoscono dipendenti
e tale dipendenza – di altra qualità rispetto a quella offerta dal mercato – fa arretrare la prestazione
coercitiva e selettiva.
1
In un momento drammatico come quello che stiamo vivendo, con il neoliberismo che inneggia
all’agonismo, vi è una pesante divaricazione tutta retorica che prevede la gratuità per «meritare di esistere» e il sacrificio. Come fa il dono a non essere divorato o piegato agli interessi
perversi dello sfruttamento contemporaneo?
Il mercato è un meccanismo di appropriazione dei doni. Il plus-lavoro, inteso come lavoro non
pagato, è un dono forzato così come lo sono le risorse naturali – l’acqua per esempio o i semi che
un tempo erano gratuiti e ora sono stati acquisiti, privatizzati e trasformati in merci dalle multinazionali.
Il lavoro delle casalinghe, anche se non è forzato nella stessa maniera, costituisce un dono
all’economia stessa (aumentando il Pil di un’alta percentuale di cui l’entità esatta è ancora dibattuta
da ricercatori come Waring e Ironmonger) poiché i datori di lavoro non devono pagare e quindi il
«dono» delle casalinghe contribuisce al loro profitto.
Il mercato si erge come modello di comportamento, creando un homo economicus che non è mosso
dal bisogno altrui. Si pone come unica misura di benessere, peccato che il dare per ricevere qualcosa in cambio nasconda come unica mira il «dono di profitto» creando l’illusione di essere principio di valore autosufficiente. C’è un modello di convivenza sotteso a tale dinamica, un motto equivalente al mors tua vita mea, un dispositivo vendicativo dell’occhio per occhio ma anche esempi
più insidiosi perché apparentemente positivi – la giustizia come indennizzo del crimine o il senso di
colpa come preparazione al risarcimento. In queste strutture includerei anche il meritare di esistere
o attraverso lo scambio o attraverso il dono. Se sul piano macro-economico il mercato divora il
dono e lo piega ai propri interessi, su quello della pratica quotidiana penso sia importante una presa
di coscienza dell’esistenza di questa economia materna nascosta, per potersi sottrarre al cannibalismo del mercato che vorrebbe piegare universalmente volontà e desideri.
Che cosa esattamente produce questo mercato rovinoso che cerca di servirsi dell’economia del
dono?
Proprio negli ultimi giorni abbiamo tristemente assistito alla rappresentazione dei valori bio-patici
di cui questo mercato è intriso; questi valori sono facilitati dalla negazione o rimozione della memoria storica e di contesti materiali più ampi. La mia amica Charito Basa (presidente del Filipino
Women’s Council, ndr) ha detto che i migranti «vanno dove sono andati i loro soldi»; vengono in
Europa perché prima c’è stato lo sfruttamento dei doni e delle risorse dei loro paesi da parte
dell’Europa (e degli Stati Uniti). Questa accumulazione dei doni nel Nord del mondo ci fa apparire
come se avessimo una grande e ricchissima economia indipendente, anche se facciamo finta di
ignorare la provenienza di quella ricchezza.
Non vogliamo che gli immigrati si impadroniscano del nostro bottino che abbiamo preso da loro.
Così quello che viene prodotto – che deriva dallo statuto dell’homo economicus – è una cecità stupefacente dinanzi ai deboli, agli ultimi, alle vittime di una povertà inaudita e causata dalle guerre
armate anche dall’occidente. Gli uomini e le donne, le bambine e i bambini, che spesso trovano la
morte nel nostro Mediterraneo si spingono fin qui per poter dare da mangiare ai propri figli e alle
proprie figlie, per poter praticare il dono necessario alla loro vita.
“Il manifesto” – 24 aprile 2015
2