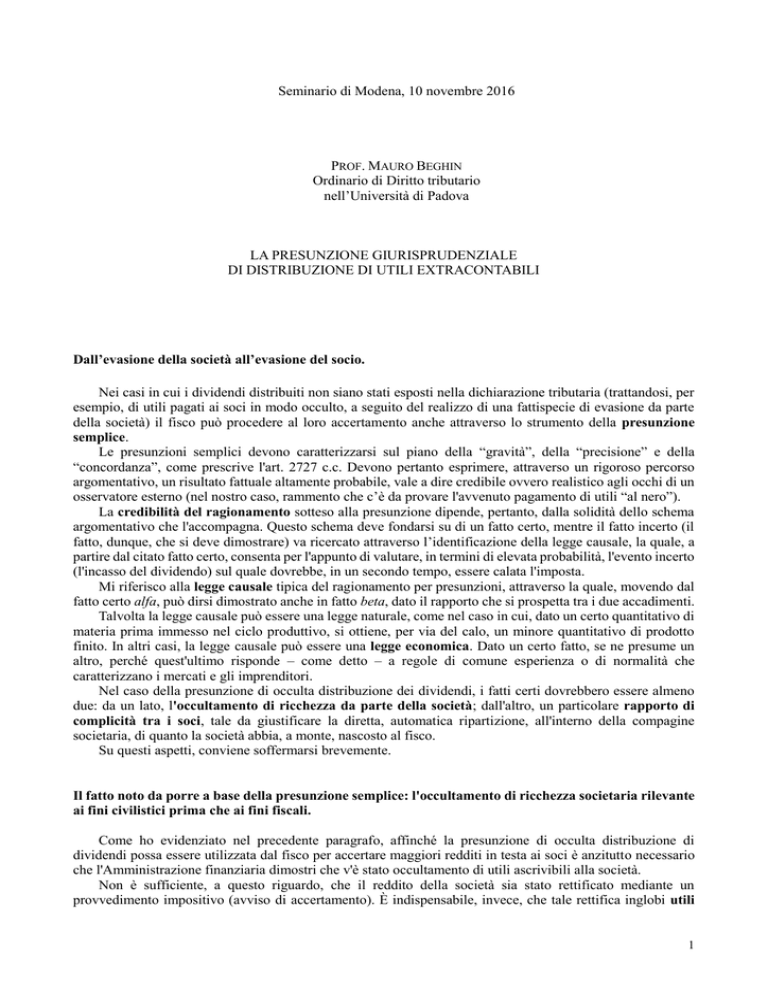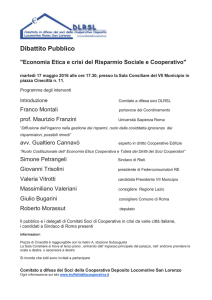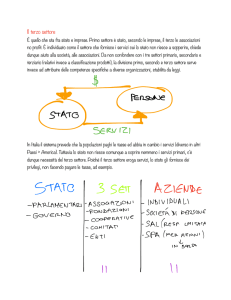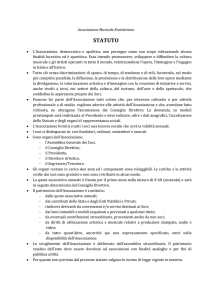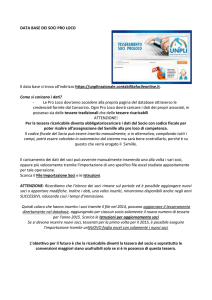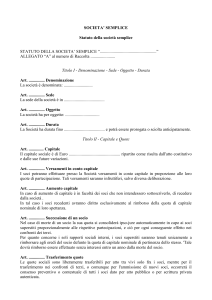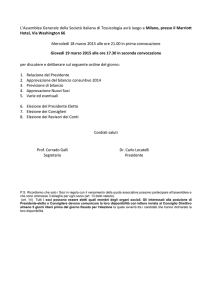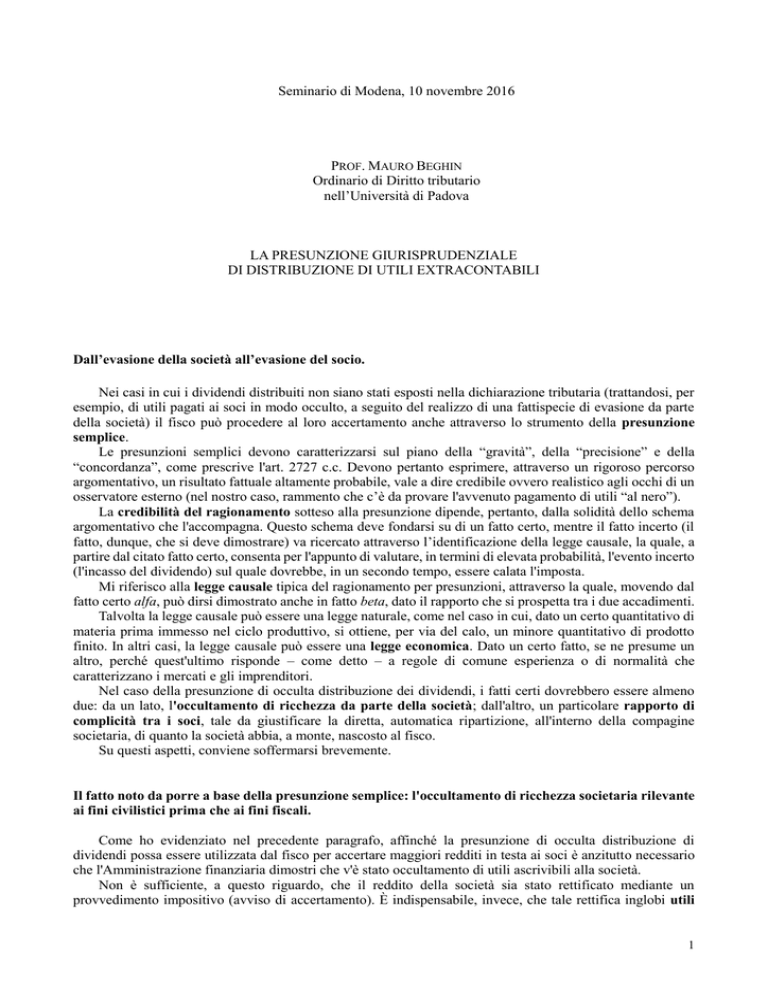
Seminario di Modena, 10 novembre 2016
PROF. MAURO BEGHIN
Ordinario di Diritto tributario
nell’Università di Padova
LA PRESUNZIONE GIURISPRUDENZIALE
DI DISTRIBUZIONE DI UTILI EXTRACONTABILI
Dall’evasione della società all’evasione del socio.
Nei casi in cui i dividendi distribuiti non siano stati esposti nella dichiarazione tributaria (trattandosi, per
esempio, di utili pagati ai soci in modo occulto, a seguito del realizzo di una fattispecie di evasione da parte
della società) il fisco può procedere al loro accertamento anche attraverso lo strumento della presunzione
semplice.
Le presunzioni semplici devono caratterizzarsi sul piano della “gravità”, della “precisione” e della
“concordanza”, come prescrive l'art. 2727 c.c. Devono pertanto esprimere, attraverso un rigoroso percorso
argomentativo, un risultato fattuale altamente probabile, vale a dire credibile ovvero realistico agli occhi di un
osservatore esterno (nel nostro caso, rammento che c’è da provare l'avvenuto pagamento di utili “al nero”).
La credibilità del ragionamento sotteso alla presunzione dipende, pertanto, dalla solidità dello schema
argomentativo che l'accompagna. Questo schema deve fondarsi su di un fatto certo, mentre il fatto incerto (il
fatto, dunque, che si deve dimostrare) va ricercato attraverso l’identificazione della legge causale, la quale, a
partire dal citato fatto certo, consenta per l'appunto di valutare, in termini di elevata probabilità, l'evento incerto
(l'incasso del dividendo) sul quale dovrebbe, in un secondo tempo, essere calata l'imposta.
Mi riferisco alla legge causale tipica del ragionamento per presunzioni, attraverso la quale, movendo dal
fatto certo alfa, può dirsi dimostrato anche in fatto beta, dato il rapporto che si prospetta tra i due accadimenti.
Talvolta la legge causale può essere una legge naturale, come nel caso in cui, dato un certo quantitativo di
materia prima immesso nel ciclo produttivo, si ottiene, per via del calo, un minore quantitativo di prodotto
finito. In altri casi, la legge causale può essere una legge economica. Dato un certo fatto, se ne presume un
altro, perché quest'ultimo risponde – come detto – a regole di comune esperienza o di normalità che
caratterizzano i mercati e gli imprenditori.
Nel caso della presunzione di occulta distribuzione dei dividendi, i fatti certi dovrebbero essere almeno
due: da un lato, l'occultamento di ricchezza da parte della società; dall'altro, un particolare rapporto di
complicità tra i soci, tale da giustificare la diretta, automatica ripartizione, all'interno della compagine
societaria, di quanto la società abbia, a monte, nascosto al fisco.
Su questi aspetti, conviene soffermarsi brevemente.
Il fatto noto da porre a base della presunzione semplice: l'occultamento di ricchezza societaria rilevante
ai fini civilistici prima che ai fini fiscali.
Come ho evidenziato nel precedente paragrafo, affinché la presunzione di occulta distribuzione di
dividendi possa essere utilizzata dal fisco per accertare maggiori redditi in testa ai soci è anzitutto necessario
che l'Amministrazione finanziaria dimostri che v'è stato occultamento di utili ascrivibili alla società.
Non è sufficiente, a questo riguardo, che il reddito della società sia stato rettificato mediante un
provvedimento impositivo (avviso di accertamento). È indispensabile, invece, che tale rettifica inglobi utili
1
che non siano stati rappresentati nel bilancio, perché è evidente che non si può distribuire “al nero” ciò che
non sia stato in precedenza acquisito al patrimonio della società partecipata.
Il lettore è certamente al corrente del fatto che le società commerciali possono distribuire solamente la
ricchezza che esse abbiano preventivamente prodotto sul piano civilistico, non già la ricchezza fiscalmente
rilevante sul piano fiscale. Sto dicendo che non si distribuisce il reddito d'impresa e che, pertanto, quando si
parla di “distribuzione di dividendi” o quando ci si riferisce alle “delibere di distribuzione dei dividendi”,
dovrebbe esser chiaro che l'oggetto della distribuzione è rappresentato solamente dall'utile oppure dalle
riserve di utili (vale a dire dalla ricchezza civilisticamente determinata) che siano stati generati dall'ente
attraverso lo svolgimento dell'attività.
Ne discende che gli avvisi di accertamento i quali possono assumere concretezza in vista della
contestazione dell'eventuale distribuzione occulta dei dividendi sono soltanto quelli che, nel rettificare la
dichiarazione tributaria (o nel prendere il posto di una dichiarazione omessa), rilevino, per l'appunto, anche la
mancata contabilizzazione di ricchezza che avrebbe dovuto concorrere ad incrementare il risultato
civilistico. In modo più semplice, si può dire che, dietro alla contestazione fiscale della quale si sta qui
discutendo, v'è un illecito di natura civilistica, dipendente da omissioni che hanno riguardato le scritture
contabili e il bilancio d'esercizio. Non è detto che questo illecito declini nel reato di falso in bilancio.
Per rendere ancor più chiaro quanto sin qui affermato, il lettore rifletta sui casi, assai frequenti nella pratica
professionale, di contabilizzazione di costi sulla base di fatture emesse dal fornitore per operazioni
oggettivamente inesistenti oppure di omessa contabilizzazione di proventi, non importa se di carattere
ordinario o straordinario.
Il lettore osservi che, nelle fattispecie qui sopra richiamate a mero titolo esemplificativo, l'illecito tributario
è chiaramente preceduto da un illecito contabile. Prima della dichiarazione infedele, infatti, c'è una falsa
rappresentazione in bilancio di fatti aziendali: attraverso la contabilizzazione di documenti riguardanti costi
che non esistono e attraverso la mancata annotazione di proventi concretamente realizzati, si riduce la ricchezza
(l'utile di esercizio) che la società avrebbe potuto distribuire ai soci secondo il procedimento indicato nel codice
civile (assunzione della delibera ed erogazione delle somme).
Da qui, un’ulteriore declinazione del nostro discorso, sulla quale, peraltro, non v'è allo stato attuale
unanime convincimento. C'è da chiedersi, infatti, se la presunzione di occulta distribuzione di dividendi possa
trovare spazio nei casi in cui, pur considerando gli effetti degli illeciti di stampo contabile, la società rimanga,
sul piano civilistico, in perdita.
Il lettore rifletta sul caso della società per azioni Alfa, la quale, nel periodo d'imposta x, abbia approvato
un bilancio con perdita di 1.000, a fronte di un reddito fiscale di 500. Immagini che, attraverso un avviso di
accertamento, l'Amministrazione finanziaria accerti costi fittizi rispettivamente pari a: a) euro 600, nella prima
ipotesi; b) euro 1.100, nella seconda ipotesi; c) euro 2.000, nella terza ipotesi.
Orbene, nell'ipotesi sub a), il reddito imponibile passa da 500 a 1.100, ma la società rimane, sul piano
civilistico, in perdita. Secondo alcuni autori, pertanto, non si potrebbe qui presumere la distribuzione occulta
di dividendi, in difetto di materia (utile) civilisticamente determinata: La perdita civilitica – come detto persiste.
Nelle ipotesi sub b) e sub c), per contro, il reddito passa rispettivamente a euro 1.600 e 2.500, mentre sul
piano civilistico la perdita viene meno. Segnatamente, nel caso sub b) la ricchezza civilistica è pari a euro 100.
Nel caso sub c), ad euro 1.000. Le cifre di 100 e di 1.000 dovrebbero perciò segnare il limite all'interno del
quale potrebbe essere applicata la presunzione di distribuzione occulta dei dividendi.
A mio modo di vedere, il problema qui sopra prospettato (rapporto tra perdite e presunzione di
distribuzione di dividendi) potrebbe essere superato nel senso della possibilità di notificare l’avviso di
accertamento al socio. Ciò per una ragione assai semplice, che potrei riassumere nei termini seguenti: i soci, i
quali abbiano utilizzato la società per realizzare fattispecie di evasione, possono distribuire il ricavato
dell'illecito senza troppo soffermarsi sui vincoli di carattere civilistico. Nel ritornare al caso della
contabilizzazione dei costi fittizi, mi pare corretto sostenere che il formale pagamento di quelle fatture può
consentire la costituzione di una provvista all'esterno del patrimonio della società, della quale i soci possono
essersi, con il trascorrere del tempo, impossessati. Ciò indipendentemente dal fatto che la società abbia
generato, nel periodo di riferimento, utili o perdite. Analogo discorso si può fare per i ricavi introitati dalla
società, ma da questa non contabilizzati, che potrebbero parimenti formare oggetto di spartizione senza
indugiare sull'andamento dell'ente.
In conclusione, reputo che una società la quale si comporti correttamente giammai potrebbe distribuire
dividendi in un contesto operativo caratterizzato da una perdita d'esercizio, dato che tale perdita impedisce
l'assunzione di una delibera in tal senso. Per contro, una società che non si comporti correttamente potrebbe
2
trattare la provvista introitata attraverso l'evasione fiscale in modo del tutto sganciato dalle regole del diritto
societario, immettendola, di fatto, nel circuito della distribuzione a favore dei soci ed infischiandosene, così,
delle
prescrizioni
derivanti
dal
diritto
commerciale.
Per contro, non è possibile attivare la presunzione di distribuzione occulta di dividendi quando la rettifica
del reddito societario non faccia emergere, come ritengo di aver sufficientemente argomentato in questo
paragrafo, maggiori utili civilistici.
Sto pensando ai rilevi riguardanti l'indeducibilità di taluni costi realmente sopportati, dovuta, ad esempio, al
fatto che tale deduzione è tout court vietata dalla legge oppure deve essere posticipata in forza delle regole di
competenza, di certezza o di obiettiva determinabilità. Analogo discorso vale per i proventi, quando siano mandati
a tassazione – di nuovo – in base a rilievi sulla competenza, sulla certezza e sulla obiettiva determinabilità, non
già in virtù di rilievi riguardanti la loro esistenza.
Il lettore rammenti che, a fronte di proventi non contabilizzati, la violazione fiscale si accompagna alla
violazione civilistica. In altre parole, la dichiarazione è infedele, ma dietro a quella infedeltà esiste un illecito
contabile, che ha direttamente inciso sulla veritiera e corretta rappresentazione dell'utile civilistico. Sto dicendo
che, quando il rilievo riguarda la regola della competenza, il provento è contabilizzato, anche se il concorso alla
determinazione del reddito avviene in un periodo d'imposta diverso da quello indicato dalla società.
La base societaria “ristretta” o “familiare”.
Per sostenere la linea argomentativa secondo la quale l'evasione perpetrata dalla società si trasforma in
occulta corresponsione di dividendi ai soci (e, quindi, in ulteriore evasione da parte di questi ultimi soggetti) è
necessario partire dalla dimostrazione di un fatto assai preciso, che possa essere assunto a fondamento della
legge causale sulla quale poggia il ragionamento presuntivo.
Si tratta invero di provare che i soci, ai quali l'Agenzia delle entrate intende contestare l'evasione fiscale
sotto forma di omessa dichiarazione dei dividendi, potevano non soltanto utilizzare la struttura societaria per
il perfezionamento di operazioni commerciali, ma anche disporre, in ragione di talune condizioni ambientali
(caratura della partecipazione, potere decisionale eccetera), delle somme introitate “al nero” dalla società
partecipata. Detto altrimenti, è necessario dimostrare che i soci erano nella condizione, proprio in
considerazione della posizione da essi occupata all'interno di quella compagine, di assicurarsi la disponibilità
della provvista illecitamente generata, a monte, attraverso fattispecie di evasione ascrivibili alla società.
In questa prospettiva, si comprendono appieno le ragioni per le quali, nel confermare la presunzione di
occulta distribuzione degli utili, la giurisprudenza tributaria ha sovente valorizzato l'esistenza di strutture
societarie connotate da pochi soci oppure caratterizzate dalla presenza di soci legati da rapporti di coniugio,
parentela o affinità. È in effetti frequente, nel linguaggio dei giudici ed anche dell'Amministrazione finanziaria,
il riferimento a società “a ristretta base partecipativa” oppure a “a base familiare”, nella prospettiva di
enfatizzare, appunto, il peculiare rapporto esistente tra gli azionisti o tra i quotisti.
La giurisprudenza ritiene che, quando ci si trovi di fronte a simili situazioni, i rapporti tra i soci possano
dirsi ispirati alla “complicità” (soprattutto quando si tratti di soci familiari) oppure al “reciproco controllo”
(quando la società sia a ristretta base partecipativa), cosicché potrebbe reputarsi più che fondata l'idea della
spartizione, in modo occulto, dei frutti dell'evasione ascrivibili all'ente.
Come identificare, però, una società “a ristretta base partecipativa”? E cosa si deve intendere con
l'espressione “società a base familiare”? È sufficiente la ristretta base partecipativa o la base familiare per
sorreggere una presunzione di distribuzione occulta degli utili?
Il lettore avrà già compreso come le fattispecie qui sopra richiamate non siano regolate da una specifica
disposizione di legge: non ci sono disposizioni incentrate, per esempio, sul numero dei soci o sui rapporti
parentali per stabilire se esista o meno una società a base ristretta o a base familiare. Si tratta piuttosto di mere
situazioni fattuali che il fisco valorizza per contestare l'evasione e la cui utilizzabilità a fini dell'accertamento
tributario dipende dalla sostenibilità di una precisa idea. L'idea secondo la quale, proprio in ragione di quel
contesto, sia credibile che quanto la società non abbia dichiarato sotto forma di utile sia stato incamerato dai
soci e tra questi distribuito in ragione delle quote di partecipazione ai risultati dell’ente: entrato, pertanto, nella
materiale disponibilità di ciascun azionista o di ciascun quotista.
L'argomento è assai delicato e necessita di ulteriori approfondimenti. In effetti, l'equazione secondo la
quale “evasione della società = occulta distribuzione di dividendi ai soci” impone di stabilire quale sia, in
3
concreto, l'apporto che i citati soci sono nella condizione di offrire alla gestione dell'ente. La questione non
può che essere affrontata, dunque, caso per caso, senza fare d'ogni erba un fascio.
Procedere caso per caso significa che, con riferimento a ciascuna fattispecie, il fisco dovrà stabilire come
e perché quei soci dovrebbero essersi spartiti i frutti dell'evasione societaria, e in quale quantità. Si tratta di
questione che investe non solo il profilo della motivazione dell'atto di accertamento, ma anche la sua
consistenza del medesimo atto sul piano probatorio, vale a dire sul piano della sua fondatezza.
In altre parole, non è a mio avviso sufficiente che l'avviso di accertamento con il quale viene rettificata la
dichiarazione del socio specifichi, per esempio, che il soggetto fa parte di una struttura nella quale ci sono
«pochi soci», oppure «tre soci» o «cinque soci». Né mi pare sufficiente che l'avviso di accertamento si limiti
all'enunciazione del rapporto di parentela («Tizio è il padre di Caio»), di affinità («Massimo è il cognato di
Rebecca»), di coniugio («Francesca è la moglie di Attilio») o di mera unione («Loretta si è civilmente unita a
Roberto») intercorrente tra i possessori delle quote o i possessori delle azioni.
Senza troppo soffermarsi sull'elasticità dei vocaboli e delle espressioni qui sopra riportate, sulla loro
imprecisione e sulla loro conseguente indeterminatezza, a me pare che, quando si dice che i soci “sono pochi”,
“sono parenti”, “sono coniugi” o “sono conviventi”, non può dirsi solo per questo dimostrato che tra quei
soggetti v'è stato, nel periodo d'imposta di riferimento, complicità nella gestione dell'evasione societaria e nella
distribuzione dei frutti che tale evasione abbia generato. Tanto meno è dimostrato, soltanto per questo, il
passaggio di denaro tra la società e i citati soci.
Insomma, nei casi caratterizzati da una motivazione così generica, che non sono rari nell'esperienza
professionale, la complicità mi sembra più evocata che dimostrata, più sbandierata che fondata su elementi
obbiettivi: difettano invero concrete indicazioni circa il ruolo svolto da questo o da quel socio nell'attività di
gestione dell'ente e circa le ragioni per le quali, fatta pari a 100 l'evasione della società, la cifra di 20, di 40 o
di 55 dovrebbe essere entrata, sotto forma di moneta, nella disponibilità dell'azionista o del quotista.
Ciò che voglio dire è che l'esistenza di pochi soci o di soci familiari è pur sempre compatibile con una
situazione nella quale: a) soltanto alcuni soci abbiano gestito le operazioni “al nero” e successivamente
spartito, senza coinvolgere gli altri, i frutti dell'evasione; b) l'evasione della società sia da ascrivere a soggetti
diversi dai soci (per esempio, l'amministratore o il direttore generale infedele), con conseguente spartizione
del ricavato tra soggetti non facenti parte della compagine societaria; c) l'evasione imputabile alla società sia
– con un gioco di parole – “rimasta in società”, ergo impiegata all'interno del circuito produttivo dell'ente,
per esempio per l'acquisto di nuovi fattori produttivi parimenti “al nero” e, di conseguenza, senza il necessario
coinvolgimento degli azionisti e dei quotisti.
Anche le carature delle partecipazioni possono avere un peso nel sostenere la presunzione di occulta
distribuzione dei dividendi. Con riferimento alla società a ristretta base partecipativa, infatti, credo si possa
configurare una sostanziale differenza tra chi è socio al 70% e chi è socio, invece, al 30% o al 5%. I soci di
minoranza, infatti, soprattutto nei casi in cui non vi siano rapporti di parentela, affinità, coniugio o mera
unione con i soci di maggioranza, possono essere in concreto lontani dalla gestione della società, perché sforniti
di sostanziale potere decisionale. Essi non possono scegliere gli amministratori; non possono pretendere
l'osservanza, da parte di questi ultimi, delle direttive impartite; non decidono quando distribuire i dividendi e
non interferiscono, in generale, con le fasi gestionali della società. È credibile, in altre parole, che non possano
avere alcuna voce in capitolo per quanto attiene alla gestione extra-contabile di operazioni societarie, delle
quali in molti casi non sono nemmeno al corrente.
In tale contesto, l'idea della automatica, occulta distribuzione di utili, oltretutto nel pieno rispetto delle
carature delle partecipazioni, appare non solo infondata, ma talvolta velleitaria e utopistica.
A ciò si aggiunga che, nella pratica professionale, le presunzioni di occulta distribuzione dei dividendi non
sono accompagnate da controlli funzionali a stabilire se vi siano stati, in concreto, pagamenti a favore del socio.
Mancano, in definitiva, le verifiche di stampo bancario-finanziario delle quali ho detto in altra sezione del
volume. Aggiungo che non sono mancati, in concreto, casi nei quali la presunzione di occulta distribuzione di
utili è stata applicata a soci di secondo livello, vale a dire a persone fisiche legate da rapporto partecipativo ad
una società a sua volta legata da rapporto partecipativo (di controllo) ad una seconda società (quest'ultima
sottoposta ad accertamento fiscale). Il provvedimento impositivo notificato a quest'ultima ha costituito il punto
di appoggio per l'accertamento, per saltum, in capo al socio persona fisica.
La conclusione del mio discorso è, a questo punto, lineare. Allorché l'Amministrazione finanziaria faccia
uso di presunzioni semplici per fondare la propria pretesa impositiva, essa deve darsi carico di adattare al caso
specifico la legge causale sulla quale dovrebbe reggersi il ragionamento presuntivo. Questo sforzo di
adattamento deve precedere la formazione del provvedimento impositivo e deve porsi l'obbiettivo di
4
argomentare, nel modo più comprensibile, le ragioni per le quali, data l'evasione della società, si può
immaginare che vi sia stato incasso di utili da parte del socio.
Il regime fiscale dei dividendi dei quali sia stata presunta l'occulta distribuzione ai soci.
Una volta che l'Amministrazione finanziaria abbia contestato la distribuzione occulta di dividendi dalla
società ai soci, si pone il problema della tassazione di tali redditi in capo al presunto percettore.
Non vedo ragioni per non applicare, in questi casi, la disciplina riguardante i redditi di capitale e i redditi
d'impresa, in ragione delle caratteristiche soggettive del socio (che dovrebbe essere una persona fisica, quanto
meno nel caso di rapporti familiari).
Alla presenza di partecipazioni non qualificate, la ritenuta alla fonte del 26%, da applicare a titolo
d'imposta e non a titolo di acconto, espone all'avviso di accertamento la società che ha corrisposto l'utile in
modo occulto, non il socio che lo ha ricevuto.
Infatti, nei rapporti di sostituzione c.d. “totale”, l'obbligazione tributaria nasce in testa al sostituto
(società), non in testa al sostituito (socio). Nei casi di ritenute d'imposta non eseguite e non versate
all'Amministrazione finanziaria, rimane poi ferma la possibilità di coinvolgere, nella fase di riscossione, anche
il sostituito, giusta la previsione dell'art. 35 del DPR n. 602/1973. È l'unico caso nel quale tra sostituto e
sostituito s'instaura un rapporto di coobbligazione, perché, di regola, è il sostituto che risponde “in luogo” del
sostituito.
Nella pratica, può talvolta accadere che, in occasione della formazione del provvedimento impositivo,
l'Amministrazione finanziaria mandi a tassazione l'intero importo del dividendo, senza riconoscere l'esclusione
prevista dal t.u.i.r. Per esempio, può verificarsi il caso nel quale l'imponibilità al 49,72%, oggi prevista per i
dividendi scaturenti da partecipazioni qualificate, si trasformi, nel provvedimento impositivo, in imponibilità
al 100%.
Dietro a questi schemi operativi v'è l'idea stando alla quale il regime di parziale esclusione da imposta dei
dividendi, come fissato dal DPR n. 917/1986, rappresenti una disciplina circoscritta ai soli dividendi che siano
stati corrisposti sulla base di una regolare delibera di distribuzione assunta dalla società partecipata. È
evidente che, nel procedere in questa direzione, i dividendi dovrebbero essere ricondotti a un duplice
raggruppamento: da una parte, quello, appunto, dei dividendi erogati in conformità alle disposizioni del diritto
commerciale; dall'altra, invece, quelli erogati in difformità rispetto a codeste disposizioni, da tassare in modo
diverso - e penalizzante - rispetto ai primi. Insomma, una sanzione impropria.
La soluzione non mi convince, per le ragioni che passo qui di seguito rapidamente a illustrare.
Primo. L'esclusione da imposta, pur parziale, prevista per i dividendi societari, rappresenta una disciplina
volta a evitare fenomeni di doppia imposizione nella tassazione dei redditi della società e dei soci. Siamo di
fronte, in altre parole, ad una regola di coordinamento tra la fiscalità della società e la fiscalità dei soci. Questo
aspetto è già stato affrontato nella sezione del volume dedicata, appunto, alla disciplina sostanziale riservata
ai dividendi. Poiché la società è tassata a monte (e non vi è dubbio che tale tassazione si verifichi nel caso
specifico, perché, se così non fosse, non si porrebbe il problema della presunzione di occulta distribuzione di
utili), al dividendo va riconosciuta l' esclusione da IRPEF.
Secondo. La distinzione tra dividendi distribuiti in modo conforme al diritto commerciale e dividendi privi
di tale caratteristica non appartiene al diritto tributario. La funzione del diritto tributario non consiste nella
scrematura di fattispecie economiche, tanto meno a fini classificatori, ma nella loro individuazione in funzione
del prelievo. Qualora l'Amministrazione finanziaria ritenga, attraverso il proprio provvedimento, che vi sia
stata una distribuzione di utili, la fattispecie va assoggettata a tassazione come tutte le altre distribuzioni, senza
disparità di trattamento.
Terzo. La sovra-tassazione dei dividendi occultamente distribuiti dalla società al socio declina – come
preannunciato - in una sanzione impropria. Attraverso tale particolare modalità impositiva, infatti, si penalizza la
fattispecie: la si stigmatizza mediante l'appesantimento del carico fiscale. Nemmeno questi effetti sono nelle
corde delle disposizioni fiscali. Il diritto tributario – come ho spesso affermato – non serve a sanzionare, ma a
tassare.
(estratto dal volume di Mauro Beghin, Diritto tributario, Padova, Cedam, 2015)
5