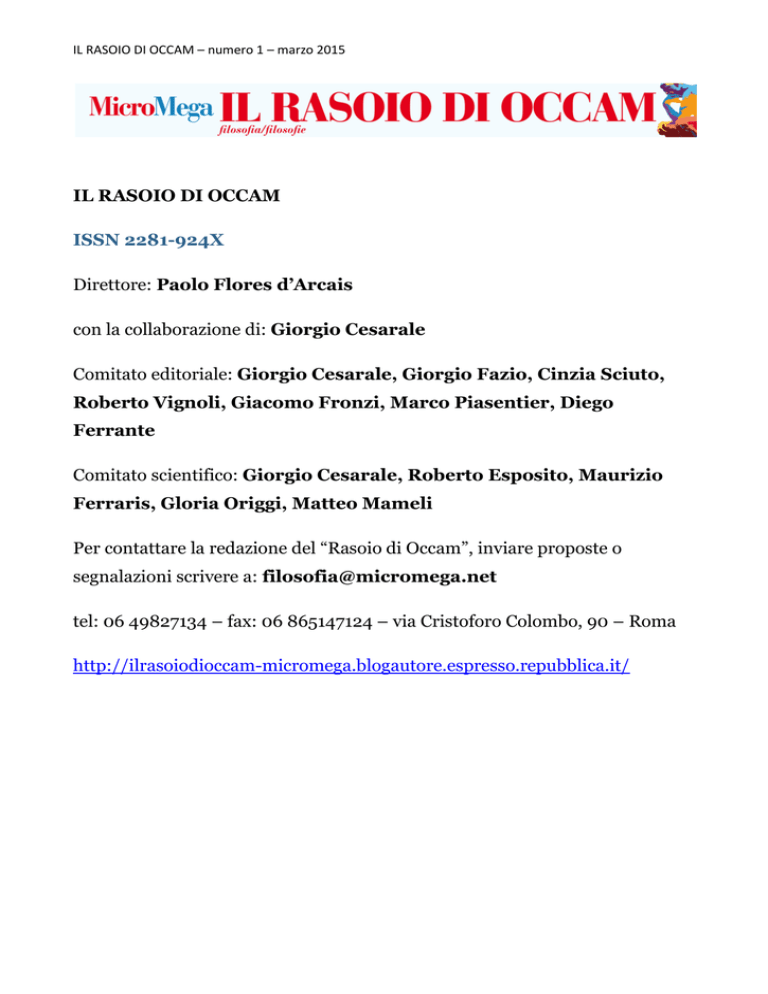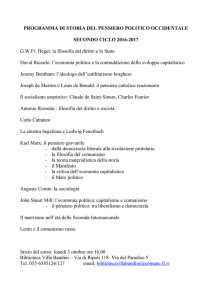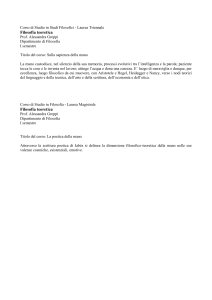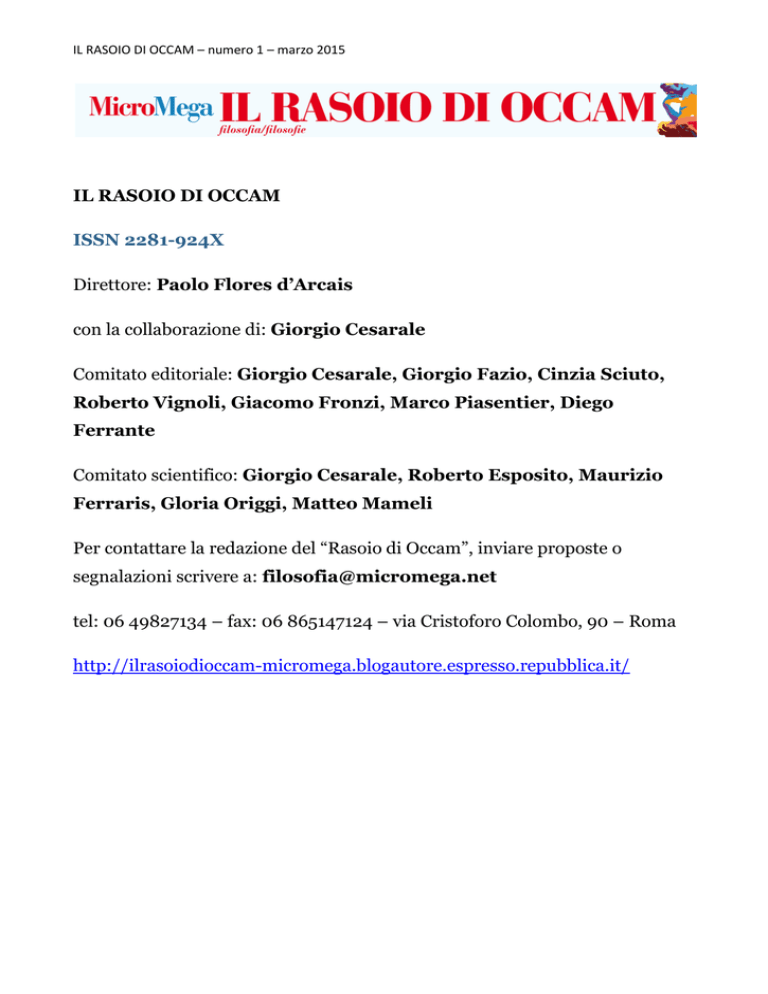
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
IL RASOIO DI OCCAM
ISSN 2281-924X
Direttore: Paolo Flores d’Arcais
con la collaborazione di: Giorgio Cesarale
Comitato editoriale: Giorgio Cesarale, Giorgio Fazio, Cinzia Sciuto,
Roberto Vignoli, Giacomo Fronzi, Marco Piasentier, Diego
Ferrante
Comitato scientifico: Giorgio Cesarale, Roberto Esposito, Maurizio
Ferraris, Gloria Origgi, Matteo Mameli
Per contattare la redazione del “Rasoio di Occam”, inviare proposte o
segnalazioni scrivere a: [email protected]
tel: 06 49827134 – fax: 06 865147124 – via Cristoforo Colombo, 90 – Roma
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
Le metamorfosi della democrazia
di DANIELE LORENZINI
Dopo il successo di Pourquoi désobéir en démocratie?, Albert Ogien e Sandra Laugier tornano a
riflettere sulle profonde trasformazioni contemporanee del rapporto tra governanti e governati
nelle democrazie occidentali. Per loro, il principe démocratie consiste innanzitutto nel valorizzare
le esperienze dei “dominati”, ovvero di coloro che tendono ad essere sistematicamente esclusi dal
“gioco” democratico.
Nel primo libro nato dalla loro collaborazione, Pourquoi désobéir en démocratie? (Paris, La
Découverte, 2010), ora disponibile anche in traduzione italiana[1], Albert Ogien e Sandra Laugier
riflettevano sulle forme contemporanee della disobbedienza civile, proponendo una ridefinizione
della democrazia nei termini di una “democrazia radicale” fondata – come lo era (o meglio, come
avrebbe dovuto esserlo) la democrazia americana nelle concezioni di Ralph Waldo Emerson e di
Henry David Thoreau – sulla possibilità per tutti i cittadini, ad ogni momento, di dire “no”, di
rifiutare di obbedire a una legge o a una disposizione giudicata ingiusta. Lungi dal costituire
un’eccezione, una minaccia o una negazione della democrazia stessa, la disobbedienza si
configurerebbe quindi come il suo fondamento più autentico, contro ogni prospettiva che,
appellandosi a un presunto contratto sociale indefinitamente vincolante, vorrebbe privare i cittadini
dell’opportunità di esprimere il proprio dissenso nei confronti di un governo che è chiamato a
parlare anche a loro nome[2].
Le principe démocratie. Enquête sur les nouvelles formes du politique (Paris, La Découverte, 2014)
si inscrive in una continuità rivendicata con il precedente lavoro, ma si propone di esplorare le
conseguenze dell’estensione contemporanea del campo e del senso della disobbedienza a
movimenti di protesta più importanti e massivi: le occupazioni di piazza, le insurrezioni civili, le
mobilitazioni transnazionali, il cyber-attivismo, e così via. La tesi dei due autori è che questa ondata
mondiale di manifestazioni e di proteste extra-istituzionali che rappresentano, ai loro occhi, una
nuova forma assunta dal politico nelle nostre società, sia cominciata nel gennaio del 2011 a Tunisi,
e che si sia poi diffusa su scala globale, testimoniando – pur nella specificità irriducibile di ogni
situazione e di ogni contesto sociopolitico – la medesima volontà dei cittadini di esercitare
direttamente un controllo sulle decisioni e sull’azione di coloro che li governano e li rappresentano
(p. 7). Questo risveglio della “politica della strada” contribuirebbe, del resto, a smentire
definitivamente la retorica della presunta depoliticizzazione delle società contemporanee: il
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
“politico”[3], in un certo senso, non è mai stato così vivo come lo è oggi – soltanto, esso si è
trasformato, si sta trasformando sotto i nostri occhi.
La tesi di Albert Ogien e Sandra Laugier è che, in queste nuove forme assunte dal politico, sia
possibile riconoscere i contorni di un inedito principe démocratie. Tuttavia, lungi dal voler così
innalzare la democrazia a principio intangibile, gli autori si propongono in realtà semplicemente di
cogliere e analizzare, al di là delle differenze innegabili, gli usi che i cittadini possono fare della
nozione di democrazia nel momento stesso in cui rimettono in discussione la legittimità dei poteri
che li governano (pp. 10-11). E la democrazia, in questo senso, più che come un “principio”, si
configura come una vera e propria “forma di vita”. Ma che tipo di forma di vita?
Il problema è che le rivendicazioni che possiamo raggruppare sotto la medesima parola d’ordine –
“democrazia!” – sono in realtà estremamente varie e talvolta perfino contraddittorie: dignità delle
persone, onestà dei governanti, trasparenza dell’azione pubblica, soppressione dei privilegi di una
“casta”, indipendenza dei mezzi d’informazione, aiuti sociali ai meno abbienti, libertà individuale,
ma anche, sovente, ritorno alla tradizione, necessità di un’autorità forte, rifiuto dell’uguaglianza e
limitazione dei diritti delle persone. Il termine stesso di democrazia mostra quindi di possedere
un’estensione semantica senza precedenti, caricandosi di un’inevitabile ambiguità. Vi è però un
modo per fare chiarezza che può essere desunto dalle analisi di Albert Ogien e Sandra Laugier: i
movimenti che davvero stanno contribuendo a trasformare la nostra idea e la nostra pratica della
democrazia non si caratterizzano solo per uno (sterile, retorico) appello alla democrazia, ma anche e
soprattutto perché la loro azione si colloca deliberatamente al di fuori delle organizzazioni politiche
tradizionali, e perché essi al contempo ricercano l’unanimità nelle proprie rivendicazioni, rifiutano
di darsi un leader unico e un programma, e optano per la scelta (strategica) della non-violenza (p.
20)[4]. Insomma, i movimenti di protesta sui quali gli autori vogliono attirare la nostra attenzione
rivendicano, certo, un principe démocratie, ma nel farlo affermano in realtà due cose: da una parte,
che non viviamo davvero in una democrazia, in una società democratica; e, dall’altra, che è dunque
un compito urgente, fondamentale, per tutti i cittadini, riflettere collettivamente su cosa significhi
vivere in una democrazia, su cosa sia veramente una democrazia.
Domanda alla quale, come sottolineano Albert Ogien e Sandra Laugier, non vi è una risposta
definitiva, ma che costituisce (o meglio, dovrebbe costituire) il fondamento stesso di ogni forma di
vita democratica. Stanley Cavell lo aveva affermato già più di venticinque anni fa, in un libro
recentemente tradotto anche in italiano: la pratica della disobbedienza – così come, potremmo dire,
tutte le nuove forme di rivendicazione politica che possiedono le caratteristiche sopra citate – non
va confusa con un rifiuto della democrazia o con la volontà di porsi al di fuori del “gioco”
democratico. Al contrario, vi è sempre, in queste pratiche e in questi movimenti, una parte
inevitabile di compromesso, un consenso (per quanto minimale) alla società nella sua forma attuale,
non solo perché un “fuori” assoluto non esiste, ma anche e soprattutto perché «lo spazio che ci
separa collettivamente dalla giustizia perfetta, pur essendo a volte doloroso al punto da risultare
insopportabile, è comunque abitabile, e perfino necessario come luogo in cui portare avanti il
cambiamento»[5].
In questa affermazione si può già riconoscere l’idea di una democrazia “radicale” – o meglio,
“perfezionista” – della quale Albert Ogien e Sandra Laugier si fanno promotori. Al cuore del
principe démocratie, infatti, è inscritta a loro avviso una tesi essenziale, spesso considerata ingiusta
o eccessiva, ma che testimonia in realtà del carattere perfezionista di tale concezione della
democrazia:
[L]a democrazia è sempre una democrazia a venire, il passo successivo che siamo chiamati a fare
per realizzarla pienamente, e così via all’infinito. In altri termini, bisogna ammettere che la
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
democrazia è […] uno stato condannato a non essere mai del tutto raggiunto; o un’idea condannata
a non realizzare mai tutte le promesse che contiene (p. 277).
Con una simile operazione teorica, ardita e per certi versi scandalosa, Albert Ogien e Sandra
Laugier tentano dunque di spostare il problema della politica dalle strategie di governo, dalle leggi
e dalle campagne elettorali dei partiti in vista delle elezioni, alle modalità attraverso le quali i
cittadini cercano di riappropriarsi del diritto di esprimere un rifiuto che è, in sé, già politico. Si
tratta, in fondo, dello stesso tipo di rifiuto che Michel Foucault, nel 1978, ha definito nei termini di
un “atteggiamento critico”, ovvero della volontà di non essere governati così, in questo modo, da
queste persone e a questo prezzo[6]. Ma è attraverso una discussione problematizzante delle
concezioni dell’“azione politica” e della “capacità critica” che emergono dalle prospettive di Alain
Badiou, di Toni Negri e Michael Hardt, di Jacques Rancière, di Pierre Bourdieu e di John Dewey,
che i due autori fotografano in modo più preciso l’«esigenza al contempo radicale e ordinaria»
contenuta nel principe démocratie (p. 116). Un principio che, sostengono, si fonda su un’idea
semplice, ma rivoluzionaria: «i problemi pubblici sono inestricabilmente avviluppati in ciò che
costituisce il quotidiano della vita di una società, e coloro che ne fanno l’esperienza sono i più
qualificati a definirli e ad elaborare nei loro confronti le soluzioni più appropriate» (p. 119). Per
questo, ogni cittadino è responsabile quanto ogni altro del destino della collettività nella quale vive;
per questo, i manifestanti e gli “occupanti” di oggi «non si accontentano di “volere” un altro mondo,
da ottenere con ogni mezzo, ma lo creano, qui ed ora, irreversibilmente, nel cuore stesso del mondo
esistente» (p. 225).
NOTE
[1] Cfr. A. Ogien e S. Laugier, Perché disobbedire in democrazia?, Pisa, ETS, 2014.
[2] Cfr. Intervista a Sandra Laugier e Albert Ogien su Pourquoi désobéir en démocratie?, in
«materiali foucaultiani», disponibile online: <http://www.materialifoucaultiani.org/it/materiali/altrimateriali/55-intervista-a-sandra-laugier-e-albert-ogien/113-laugier-ogien-intervista-1.html>
(consultato il 13-01-2015).
[3] Per la distinzione tracciata dagli autori tra la politica e il politico, cfr. A. Ogien e S. Laugier, Le
principe démocratie. Enquête sur les nouvelles formes du politique, Paris, La Découverte, 2014, pp.
23-26.
[4] Per la discussione del carattere strategico della scelta della non-violenza, cfr. ibidem, pp. 222225.
[5] S. Cavell, Condizioni ammirevoli e avvilenti. La costituzione del perfezionismo emersoniano,
Roma, Armando, 2014, capitolo 3.
[6] Cfr. M. Foucault, Illuminismo e critica, Roma, Donzelli, 1997.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
Le ragioni della democrazia (e della sua crisi). Conversazione
con Alessandro Ferrara e Stefano Petrucciani
di GIULIO AZZOLINI
Proprio dopo essere diventata la forma di governo legittima per eccellenza, la democrazia è
sempre più spesso percepita come un regime politico in grave crisi. A partire dai loro ultimi lavori
– The Democratic Horizon (Cambridge University Press) e Democrazia (Einaudi) – Ferrara e
Petrucciani affrontano in chiave filosofico-politica questo paradosso e molti altri problemi: dalla
critica delle concezioni procedurali e competitive della democrazia alla proposta di un approccio
normativo deliberativo, dal rischio di una deriva oligarchica e tecnocratica transnazionale fino alle
conseguenze della crisi economica. Nella convinzione che oggi, per difendere la democrazia,
riflettere sulle sue ragioni sia più utile che coniare nuovi slogan.
Esprimere un giudizio sugli ultimi mesi di “grande trasformazione” della nostra democrazia è forse
prematuro. Di sicuro, però, il 2014 è stato un anno particolarmente fecondo per la riflessione
italiana sulla democrazia. Vi hanno contribuito, tra gli altri, un sociologo e politologo del calibro di
Ilvo Diamanti (con Democrazia ibrida, Laterza-la Repubblica), uno scienziato politico di fama
internazionale come Leonardo Morlino (con Democrazia e mutamenti, Luiss University Press) e la
teorica politica della Columbia University Nadia Urbinati (con Democrazia sfigurata, Egea).
All’esercizio di studio della metamorfosi democratica non poteva dunque sottrarsi la filosofia
politica italiana, che partecipa al dibattito grazie agli originali lavori di Alessandro Ferrara, The
Democratic Horizon. Hyperpluralism and the Renewal of Political Liberalism (Cambridge
University Press, pagg. 257, euro 72), e di Stefano Petrucciani, Democrazia (Einaudi, pagg. 260,
euro 22). Educati rispettivamente alla tradizione liberal statunitense e alla teoria critica
francofortese, i due hanno trovato nell’opera di Jürgen Habermas – del quale il primo è stato allievo
e al cui pensiero il secondo ha dedicato un’importante Introduzione[i] – l’occasione di stabilire un
linguaggio comune e di intendersi su molti temi, primo dei quali la democrazia. Così le differenze
non emergono tanto sugli orientamenti teorici di fondo, quanto piuttosto sugli accenti: oggi Ferrara
è attento soprattutto alle sfide della democrazia liberale, mentre Petrucciani è interessato in
particolar modo alle patologie della democrazia rappresentativa.
Quali sono i motivi che vi hanno spinto a dedicare il vostro ultimo libro a una questione classica
del pensiero politico, come la democrazia?
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
Petrucciani «Il fatto è che oggi, secondo me, la democrazia è la questione centrale della teoria
politica. E lo è per tre ragioni. Prima di tutto, perché è l’unico concetto politico normativo che sia
rimasto in piedi dopo la crisi dei socialismi, dei comunismi e anche di molti liberalismi e
neoliberalismi. In secondo luogo, perché la democrazia è uno straordinario strumento di
legittimazione, nel senso che ormai, se viene presa democraticamente, ogni decisione politica va
rispettata. E il terzo punto è questo: nell’ambito della filosofia politica normativa ci sono state tante
e interessanti teorie della giustizia, però ciascuna di queste, per poter essere eventualmente
implementata, deve passare attraverso il vaglio delle procedure democratiche. La democrazia è
diventata quindi una sorta di meta-dimensione con la quale non si può evitare di fare i conti».
Ferrara «Anch’io muovo dall’idea che la democrazia sia l’unico concetto filosofico-politico
normativo rimasto in piedi, ma lo faccio con una maggiore sfumatura di pessimismo. Soprattutto nel
nostro universo intellettuale e politico, infatti, si percepisce fortemente una “crisi della democrazia”,
per usare un’espressione che sento continuamente ripetere fin da quando ero studente. Nel libro mi
interessava fare il punto su questa storia: da un lato, l’affermarsi della democrazia come orizzonte,
cioè non come una ma come la forma di governo legittima per eccellenza; e dall’altro lato,
contemporaneamente, la percezione di una sua crisi, almeno nelle società industriali avanzate. E
l’asse centrale del libro non propone di smontare le condizioni inospitali per la democrazia, perché
queste sono in larga parte al di là della politica, ma suggerisce di ripensare la democrazia stessa
confrontandosi con quello che ritengo il paradigma più fertile dell’offerta teorica contemporanea, il
liberalismo politico di Rawls».
Se Democrazia presta una grande attenzione alla teoria e alla storia di processi, istituzioni e
soggetti democratici, The Democratic Horizon adotta un registro filosofico-politico molto più
analitico e centrato sul presente. Quali sono le ragioni delle rispettive scelte?
Petrucciani «Io ho provato a scrivere un libro introduttivo alla democrazia. Perché teoria e storia?
Non solo per i banali motivi che bisogna sempre conoscere quello che abbiamo alle spalle, ma
perché, a mio modo di vedere, teoria e storia sono i due poli coi quali la filosofia politica deve
sempre fare i conti. La filosofia politica è una filosofia strana, difficile, particolare, perché ha una
doppia faccia: nei suoi grandi classici attinge a una purezza quasi geometrica e, tuttavia, è sempre
ancorata ai processi storici, il che ovviamente allontana dalla possibilità di fare filosofia in senso
puramente teoretico. Prendiamo ad esempio Thomas Hobbes: grandioso ragionamento logico, ma
naturalmente incomprensibile senza le guerre di religione e i conflitti nell’Inghilterra del suo tempo.
L’ideale che mi sono posto, dunque, è quello di una ricostruzione razionale dei grandi temi e dei
grandi testi della democrazia, cercando di mostrare come attraverso processi che sono largamente
casuali, conflittuali e indeterminati, emergano delle strutture e delle istituzioni che hanno una loro
logica, una loro razionalità».
Ferrara «Sì, io condivido la notazione sull’ancoramento dei concetti centrali della filosofia politica a
un contesto storico. Un conto è parlare di governo legittimo, libertà, potere, giustizia nell’ambito di
una polis e un altro è riferirsi a un impero, un conto è lo Stato-nazione e un altro il mondo di oggi,
che è globalizzato economicamente ma molto meno da un punto di vista politico. La mia scelta
metodologica, però, è stata confrontarsi con un paradigma, quello di Liberalismo politico,
collocandolo nel contesto in cui viviamo oggi, che è già diverso da quello di Rawls. Nella fase di
maturazione che porta al libro del ’93, infatti, egli ha ancora in mente la classica domanda su che
cosa sia una società giusta, su come sia possibile che in una società democratica di liberi ed eguali
conviva secondo giustizia gente che la pensa tanto diversamente. In altre parole, Rawls non ha di
fronte a sé un orizzonte globale e, perciò, tutta la costruzione di Liberalismo politico poggia sulla
possibilità di mettere d’accordo lockeani e rousseauiani. Ma se fosse questa la gamma di differenze
su cui trovare un “consenso per intersezione”[ii], saremmo a cavallo: la realtà è tutt’altra e si può
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
riassumere in quello che chiamo ‘iperpluralismo’. Perciò la sfida è rendere il paradigma di
Liberalismo politico – che, ripeto, nasce come indagine sulle condizioni di possibilità di una società
giusta in un contesto di pluralismo – una traccia per pensare la possibilità che tutti i Paesi della
terra intraprendano un processo di democratizzazione, senza perciò snaturarsi. E, in questo senso,
propongo di de-enfatizzare l’idea rawlsiana di “ragione pubblica”[iii] ed enfatizzare invece quella di
“discorso congetturale”[iv]».
Petrucciani «Sandro, mi sembra che il problema dell’iperpluralismo sia proprio quello posto in
modo radicale dalla nascita del califfato islamico. Come ci può aiutare la teoria rawlsiana a
riguardo? Ricordo che in Liberalismo politico Rawls distingue tra concezioni “ragionevoli” e
“irragionevoli” di pluralismo[v]. Quello dell’Isis sembrerebbe un tipico caso di “irragionevolezza”.
Che cosa ne pensi?».
Ferrara «Secondo me bisogna evitare due estremi. Non si deve interpretare Liberalismo politico
come una teoria della mediazione alla Andreotti, per cui, dato un qualsiasi tavolo negoziale, alla
fine un punto di accordo si trova sempre e comunque. Per Rawls ci sono dei requisiti minimi cui
tutte le visioni politiche devono corrispondere per poter accedere alla mediazione democratica, che
a sua volta si riflette in una costituzione. E questi requisiti, che l’Isis sicuramente non soddisfa,
vanno sotto il titolo di “ragionevolezza”. Detto ciò, non bisogna cadere nell’eccesso opposto, come
fa una certa scolastica post-rawlsiana (penso, ad esempio, all’ultimo libro di Jonathan Quong[vi]):
se si stringe la vite in modo tale per cui “ragionevole” diventa sinonimo di “liberale”, infatti, la
teoria parlerà solo ai già convinti e bandirà come “irragionevoli” tutti coloro che sottoscrivono solo
parzialmente l’universo dei constitutional essentials di un regime democratico. Chi abbia riserve
motivate religiosamente, per esempio, sull’uguaglianza di genere o sulla eguale libertà di culto
religioso, non dovrebbe essere considerato come “irragionevole”, ma come “non completamente
ragionevole”. Ed è qui che diventa centrale la nozione rawlsiana di “congettura”, in cui
l’argomentazione non parte da premesse condivise, come invece nell’idea di “ragione pubblica”, ma
serve a mostrare all’interlocutore politico come, sulla base della sua stessa concezione morale, sia
possibile arrivare a conclusioni compatibili con la democrazia. Quest’operazione, d’altronde, è stata
portata avanti da una micro-tradizione di “congetturalismo” della scuola rawlsiana: penso in
particolare a Andrew March[vii]».
Dopo aver evidenziato scopi e metodi, veniamo alle concezioni della democrazia. Entrambi i
volumi contengono una critica esplicita alle teorie cosiddette “procedurali”: se però Petrucciani
appoggia la tesi della «democrazia procedurale-sostanziale» e richiama l’attenzione sulle
«finalità» della democrazia, Ferrara sviluppa un articolato e originale discorso sulla peculiare
apertura dell’«ethos democratico». Che cos’è dunque la democrazia: procedura, sostanza,
finalità, cultura?
Petrucciani «A mio modo di vedere, la tradizione democratica ha conosciuto una sorta di
progressivo arricchimento. Si parte da una visione puramente procedurale come quella kelseniana,
in parte ripresa da Bobbio, benché il suo sia un proceduralismo in movimento perché il Bobbio
delle “condizioni minime della democrazia”[viii] non è quello delle “promesse non mantenute della
democrazia”[ix]. Superando questa linea, è vero, io mi riconosco in ciò che ha scritto Ferrajoli sulla
“democrazia procedurale-sostanziale”[x]: egli mostra molto bene l’ulteriore passo in avanti delle
democrazie costituzionali moderne, che richiedono sì una serie di procedure ma anche una serie di
contenuti sostantivi, dall’istruzione generalizzata alla sanità pubblica. Ma io andrei anche oltre,
tenendo conto che negli ultimi trent’anni una gran parte della riflessione politica (pensiamo in
particolare a Nussbaum e a Sen) ha posto il problema della democrazia come “sviluppo umano”. Si
oltrepassa progressivamente una visione per la quale la democrazia consiste fondamentalmente
nella garanzia di diritti e procedure e si va verso una visione per la quale si ripensano gli stessi
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
diritti fondamentali che, ereditati dalle rivoluzioni americana e francese, ritroviamo ancora in capo
alle nostre costituzioni. E quindi un tema come la centralità dello sviluppo umano diventa
prioritario sia a livello statale sia a livello macro-regionale o sovranazionale. In breve, una
concezione larga ed espansiva della democrazia è richiesta dal fatto stesso che un pensiero nato con
le rivoluzioni di fine Settecento si è molto evoluto, al punto che anche la migliore riflessione
liberale mette al centro i temi dello sviluppo umano e della crescita delle capacità. Una teoria
democratica oggi non può farne a meno».
Ferrara «La critica del mio libro al proceduralismo punta in una direzione leggermente diversa: più
che le finalità indaga infatti i presupposti di funzionamento del regime democratico. Assumendo per
‘proceduralismo’ un approccio alla democrazia come a un sistema politico identificabile attraverso
certe procedure (è stato citato Kelsen, ma molti altri nomi si potrebbero fare), io mi domando
perché per la prima volta nel 2008 e per la seconda nel 2012 gli Stati Uniti hanno eletto un
presidente di etnia afro-americana, considerando che soltanto nel 2000 l’Alabama aveva abrogato le
leggi contro il matrimonio misto. In nessuno dei grandi Paesi europei potremmo neanche
lontanamente ipotizzare un evento del genere – lasciando stare l’Italia, non in Francia un presidente
di origini algerine, non in Germania un cancelliere di origini turche, non in Inghilterra un primo
ministro di origini pakistane. E allora mi domando: qual è la magica formula procedurale presente
nell’ordinamento degli Stati Uniti e assente in tutti gli ordinamenti europei che consente
un’applicazione così radicale del principio di eguaglianza? Siccome io questa risposta non la vedo,
penso che vada cercata in un’altra direzione, cioè nello sfondo etico, morale, culturale su cui le
regole poggiano. Le stesse procedure, infatti, funzionano in un contesto e non in un altro, a seconda
dell’ethos diffuso, che ha delle radici storiche e certamente non è immutabile, ma si trasforma con
una tempistica che non è a disposizione della politica. Non c’è decreto o legge che lo possa
cambiare».
Proseguiamo nella pars destruens. I due libri condividono anche una critica alla concezione
“competitiva” della democrazia. Quali sono le ragioni di tale posizione? E che cosa pensate della
tesi secondo cui il rischio maggiore per le democrazie occidentali oggi non consisterebbe tanto in
un’eccessiva competizione tra élites partitiche, quanto piuttosto nell’assenza di grandi alternative
tra i programmi presentati all’elettorato?
Ferrara «La concezione economica o elitistico-competitiva della democrazia prevede che i partiti
offrano come prodotti i loro programmi politici e i cittadini-consumatori li comprino con il voto. Il
limite di questa visione è che assume le preferenze degli individui e, quando si aggregano, le
preferenze degli elettorati come dati immediati, non riflessi. Viene dunque a mancare il punto di
forza delle concezioni “deliberative” del processo politico, fotografato già a metà del Settecento da
Rousseau nell’idea di “volontà generale” come contrapposta alla “volontà di tutti”. Per la
concezione deliberativa della democrazia la domanda è: che cosa è bene per noi? E non in astratto,
ma per noi italiani, poniamo, data la nostra storia e quello che vogliamo. Sulla scelta del miglior
sistema elettorale, per fare un altro esempio, la visione elitistica della democrazia smarrisce la
differenza tra il punto di vista dell’attore e il punto di vista più generale, tra la convenienza dei
singoli partiti e il bene comune del Paese, tra “volontà di tutti” e “volontà generale”».
Petrucciani «Sì, la visione elitistica rappresenta la democrazia come una competizione tra élites
politiche che propongono programmi alternativi ai cittadini, i quali poi, per vari motivi, scelgono
quelli che sono in maggiore sintonia con le loro preferenze. Ma effettivamente un nodo critico
emerso da qualche tempo a questa parte è che non si vedono più programmi alternativi. Potremmo
quantomeno dire che si è andato notevolmente riducendo il tasso di alternatività che caratterizza i
programmi politici in competizione. Nella storia del dopoguerra, in Italia ma anche negli altri grandi
Paesi europei, i programmi erano contrapposti quasi da una guerra di religione. Invece i processi
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
degli ultimi vent’anni hanno trasformato completamente questo panorama: vediamo infatti che le
alternative tra le principali forze politiche in campo non sono più così nette. In ragione dei molti e
diversi vincoli con i quali si devono misurare, tante volte le differenze si giocano su sfumature, su
delle virgole, come se le grandi linee di quello che la politica oggi può fare fossero già tracciate.
Insomma, in una situazione caratterizzata da una certa prevalenza dell’economia e della finanza, la
competizione tra alternative si riduce drasticamente».
Ferrara «È un processo storico in cui si sommano tante diverse componenti e che ha tante diverse
sfaccettature. A valenza leggermente più positiva si può dire che nei contesti democratici,
classicamente, si vince al centro».
Petrucciani «Infatti non è del tutto negativo che la politica non sia più guerra di religione e che i
programmi elettorali non siano più così incompatibili. Però, certo, le conseguenze negative ci
sono».
Ferrara «Secondo me, Stefano, la ragione della mancanza di alternatività consiste nella migrazione
del livello di efficacia politica dalla dimensione nazionale a quella sovranazionale. Ma questo
fenomeno dipende anche dalla scala con cui guardiamo alla politica, visto che nelle elezioni locali
l’assenza di grandi alternative c’è già da tempo. Quello che fa impressione è vederla nelle grandi
tornate elettorali nazionali, però questo dato è probabilmente figlio dello stesso vettore storico. Per
cui se ci fossero delle vere elezioni europee, per cinquecento milioni di persone, con una vera sfera
pubblica europea, allora la partita tra i fautori del rigore e quelli della crescita ci sarebbe. Invece
oggi, in qualunque contesa politica europea, la prima domanda dell’elettorato è che il proprio Paese
resti a galla nella competizione globale».
Veniamo ora alla tesi, comune ai due testi, secondo cui la democrazia vivrebbe oggi in Occidente
una condizione di forte disagio. Ferrara paragona la democrazia a una pianta e le condizioni
sociali, economiche, culturali al terreno in cui è radicata. La questione non può che riguardare,
dunque, i motivi per i quali l’epoca contemporanea appare come un ambiente tanto inospitale per
la democrazia…
Ferrara «Alcuni dei veleni che inquinano il terreno in cui la democrazia affonda le sue radici sono
già stati messi a fuoco quasi vent’anni fa da un autore come Frank Michelman[xi]. Il primo fattore
di “inquinamento” è l’enorme estensione degli elettorati. Un effetto paradossale del suffragio
universale, infatti, è la sensazione che il proprio voto non conti più nulla. Eppure è un tratto quasi
ideologico, se pensiamo che negli ultimi anni ci sono stati tre grandissimi pareggi: Bush vs. Gore
nel 2000 e, sei anni dopo, Calderón vs. Obrador in Messico e Prodi vs. Berlusconi in Italia. Eppure
quando si vince o perde per 25 mila voti, il proprio voto fa la differenza eccome. La seconda
condizione che scoraggia la partecipazione è la complessità istituzionale che scollega il voto dalle
sue conseguenze. Tutti noi abbiamo votato alle ultime elezioni, ma rintracciare in che modo
abbiamo contributo alla situazione attuale sarebbe un’impresa difficilissima. Il terzo motivo è la già
richiamata condizione di “iperpluralismo”. La quarta condizione è il carattere anonimo dei processi
di formazione della volontà politica, radicalmente diversa dal faccia a faccia che ancora imperava
nell’Ottocento. Io aggiungerei poi una quinta condizione inquinante il terreno della democrazia,
ossia la stratificazione della cittadinanza. Tutta la dottrina liberaldemocratica si basa sulla fictio che
le persone che vivono dentro un certo territorio geografico, poniamo da Aosta a Lampedusa, siano
italiani. Questo ormai è talmente lontano dalla realtà da delineare delle forme di cittadinanza
stratificata».
Fin qui le condizioni, per così dire, “storiche” di corruzione della democrazia. Quali sono,
invece, i nuovi fattori di inospitalità?
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
Ferrara «Uno è il prevalere della finanza sulla produzione manifatturiera, e se si vuole un’immagine
simbolica è quella del 3 dicembre dell’anno scorso, quando il comune di Detroit, capitale
dell’industria americana, è stato autorizzato a portare i libri in tribunale come una normale Lehman
Brothers che fallisce, messa in ginocchio non dall’opposizione operaia e dalla lotta sindacale ma dal
capitale finanziario di Wall Street. E alla crisi della capacità del lavoro di produrre ricchezza
corrisponde la perdita della capacità di aggregarsi, dotarsi di un’agenda comune e ottenere
rappresentanza politica. Cresce dunque la diseguaglianza e il libro di Piketty, Il capitale nel xxi
secolo [xii], illustra benissimo come questo fatto ostacoli la democrazia. Poi c’è l’accelerazione del
tempo sociale, che fa sì che tutti gli avvenimenti si verifichino in “tempo reale”. Già il giornale
della mattina ci sembra vecchio, perché le vere notizie sono quelle comunicate sul momento. E
questa velocità ha un effetto verticalizzante: diminuendo il tempo della collegialità e della
consultazione, aumenta infatti il potere di chi già occupa posizioni di responsabilità, che sia il
segretario di un partito, il direttore di un giornale, l’amministratore delegato di un’azienda o il capo
di una comunità religiosa. Poi c’è il citato cambio di scala, verso la dimensione sovranazionale, ove
il coordinamento dell’azione politica può avvenire tramite la governance più che tramite il classico
governo. E qui il deficit non è democratico ma teorico. Un’altra condizione è il modificarsi della
sfera pubblica, con la crisi della capacità di orientamento dei grandi media di qualità, per cui le
opinioni sono polverizzate e difficili da valutare. E l’ultima condizione, dovuta alla riflessione di
Bruce Ackerman[xiii], consiste in una pratica enormemente sottovalutata nell’analisi delle difficoltà
della democrazia, ovvero il sondaggio a ritmo continuo sul gradimento dell’azione di governo da
parte dell’elettorato. A causa di questo strumento, la legittimità percepita dell’azione di governo
non è più affidata all’ultimo risultato elettorale, ma all’ultimo sondaggio. E così la legittimità dei
governi sale e scende come la borsa, con due effetti negativi per la democrazia: primo, un’enfasi
“presentista” sul consenso immediato di chi c’è piuttosto che sulle future generazioni che non ci
sono; secondo, uno squilibrio nella divisione dei poteri, perché il rapporto tra le varie branche
cambia fortemente se il gradimento per l’esecutivo, ad esempio, supera il 70% o è in caduta libera
sotto il 30%».
Petrucciani «Direi che Sandro ha tracciato un panorama condivisibile, davvero molto accurato ed
esauriente. Aggiungerei soltanto che, se dovessi evidenziare due aspetti che ostacolano la buona
deliberazione democratica, forse i processi più eclatanti sono la ridefinizione delle scale politiche e
la spinta verso la verticalizzazione o, in termini più radicali, verso la “regressione oligarchica” della
democrazia. Di recente ne hanno parlato in molti, tra i quali Canfora e Zagrebelsky[xiv]. Del resto,
è un processo di cui è difficile sottovalutare la serietà. Proprio in questi giorni, per esempio, sono
apparsi sulla scena pubblica due indicatori di questa verticalizzazione della politica democratica.
Uno è il drammatico calo degli iscritti ai partiti. La partecipazione a un partito, che – senza alcuna
idealizzazione – poteva ancora e comunque rappresentare un momento di discussione più larga, è in
calo mostruoso. Ricordiamoci che nei loro periodi aurei partiti come la Democrazia cristiana o il
Partito comunista hanno raggiunto vette di circa due milioni o più di iscritti, e in questi giorni
abbiamo saputo che il Partito democratico è sceso al minimo storico di 100 mila iscritti. Potrà
piacere o no, ma la sostanza è che tende a morire – forse irreversibilmente – il ruolo del cittadino
che, iscrivendosi a un partito, diventa attivo e politicamente qualificato. L’altro aspetto molto
importante è il ruolo dei parlamentari. In Italia più che altrove, i parlamentari stanno perdendo del
tutto il potere di discutere effettivamente, di modificare le decisioni dei governi e quindi di
rispondere a coloro che li hanno eletti, instaurando una dialettica tra rappresentanti e rappresentati. I
parlamenti vengono ridotti a camere di registrazione della fiducia, nonostante volino i libri e gli
iPad come forma di protesta. I processi di verticalizzazione e il calo della partecipazione
camminano dunque a grandi passi, dando vita a una dinamica che si autoalimenta. Sì, perché quanto
meno la partecipazione conta qualcosa, tanto meno si è spinti a partecipare e quindi il disagio
accresce in qualche modo se stesso. E, a proposito di sondaggi, sappiamo che i dati sulla fiducia che
i cittadini ripongono nei partiti peggiorano costantemente di anno in anno».
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
La regressione oligarchica potrebbe considerarsi, d’altronde, come il rovescio della nuova
scalarità. Oggi è sempre più evidente come i processi di globalizzazione incidano profondamente
sulla resistenza dello storico “assemblaggio”, per dirla con Saskia Sassen, tra democrazia e Stato
nazional-territoriale. Senza entrare nel merito della questione su chi e cosa abbia avviato la
globalizzazione, si può pensare la democrazia oltre lo Stato? E, se sì, come?
Ferrara «Per chi fa filosofia politica, il fatto che la politica raggiunga efficacia solo sulla dimensione
continentale – che in Europa è necessariamente post-nazionale, mentre negli Stati uniti e in Cina è
ancora nazionale – pone prima di tutto la sfida di distinguere tra governo e governance. È vero che
quello di governance è un concetto slabbrato, confuso, usato spesso come sinonimo di
“coordinamento” e basta, però penso che sia assolutamente esagerata la critica di quei teorici
politici, come Claus Offe, che hanno sparato a zero sul concetto di governance come “significante
vuoto”[xv]. La chiave, secondo me, sta nella sanzione: il governo democratico prevede la capacità
di decidere sulla base di una legittimazione popolare, conservando il potere di sanzionare chi non si
adegua; governance, invece, significa coordinamento di attori diversi, senza la possibilità di
bacchettare coloro che non si adeguano. La differenza quindi è tra monopolio dell’uso legittimo
della forza nello Stato-nazione, nel caso del governo, e monopolio dell’attribuzione di legittimità
nelle strutture di governance, per cui è valida solo quell’azione che riceve l’“imprimatur” da parte
di tutta la struttura di governance. Posta tale differenza, rimane però da distinguere che cosa vuol
dire governance democratica e governance tecnocratica, che cos’è rappresentanza e che cos’è
accountability quando le strutture sono di governance. Mario Draghi, ad esempio, occupa una
posizione influentissima, che certamente non è al di sopra della legge, ma a chi risponde?».
Petrucciani «Replicare con delle proposte è molto difficile. Mi sembra possibile più che altro
scattare una fotografia della situazione, un’immagine in cui dimensione nazionale e dimensione
sovranazionale si tengano, siano in qualche modo co-implicate. Sul piano nazionale è evidente la
consunzione dei meccanismi rappresentativi, che in Italia è palese nello scontento sociale ed è stata
sicuramente al centro del grande successo del Movimento 5 Stelle. Certo, i meccanismi della
rappresentanza sono diventati meno importanti, sono stati per così dire “provincializzati” dal ruolo
acquisito da altre sedi, ma restano comunque una grande articolazione, che allo stato attuale è
assolutamente logora e andrebbe dunque ripensata con coraggio. A questo si lega il discorso sul
sovranazionale e qui sono d’accordo con Sandro e un po’ meno con tanti autori della democrazia
cosmopolitica, tra i quali Held[xvi] e Archibugi[xvii]: proprio perché il meccanismo rappresentativo
già sperimentato nello Stato-nazione è così logoro, non credo che sarebbe utile trasporlo
semplicemente su una scala molto più grande. Insomma, bisognerebbe fare innanzitutto una
diagnosi della situazione e poi, per studiare nuove vie democratiche, ci vorrebbe tanta inventiva
politica e fantasia istituzionale».
Passiamo dunque al “dover essere”. Entrambi i volumi propongono una teoria normativodeliberativa della democrazia: sulla scorta di Calogero e Apel, Petrucciani argomenta la
«giustificazione dialogica della democrazia»; nella sfida di rinnovare in senso universalista il
liberalismo politico rawlsiano, Ferrara lavora invece sulle fonti estetiche della normatività e, in
particolare, sulle idee di esemplarità, giudizio e immaginazione. Quali sono le ragioni di queste
prospettive?
Petrucciani «Ritorniamo un momento ai fondamenti, perché, come detto, la filosofia politica è un
processo in cui si torna costantemente ai fondamenti per poi muovere verso le dinamiche della
realtà. L’approccio che a me sembra più convincente rintraccia, in ultima istanza, una radice etica
nella democrazia. A mio modo di vedere, la democrazia poggia inevitabilmente su basi etiche
universalistiche. Dopodiché, bisogna discutere di quale sia l’etica adeguata alla democrazia e, dal
mio punto di vista, l’etica che maggiormente si inquadra con una visione democratica della politica
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
sta sulla linea delle etiche del dialogo e del discorso. I principi morali su cui si regge la democrazia
sarebbero, in particolare, il pari diritto di ciascuno a far sentire la propria voce e il rispetto di tutte le
persone. In questa prospettiva, dunque, l’enfasi non poggia tanto sul rispetto di leggi o regole
astratte, ma punta massimamente sull’interazione discorsiva tra le persone, sulla creazione di sfere
di confronto dialogico e di discorso pubblico. Tornando alla realtà, tutto ciò è naturalmente tanto un
ineludibile sfondo teorico della democrazia quanto qualcosa che si pone in forte attrito con i
processi reali, che in generale non sono caratterizzati da un ampio tasso di ragionevolezza,
discorsività e confronto, ma al contrario da irrazionalità e da grandi correnti di manipolazione
dell’opinione. Quindi, si può dire che la democrazia radicata in un’etica della discussione sia un
ideale molto esigente, un punto di riferimento teorico normativo con cui guardare criticamente ai
processi reali».
Ferrara «Riguardo alla teoria normativa della democrazia, penso anzitutto che, grazie al concetto
del “ragionevole”, il tema delle fonti estetiche della normatività fosse già ingranato nell’impianto
teorico rawlsiano. Oltre dieci anni prima di scrivere Liberalismo politico, infatti, Rawls non
qualificava la pretesa di validità della sua “giustizia come equità” in termini classici: la teoria della
giustizia non doveva cioè imporsi al consenso di una platea illimitata, ma doveva essere piuttosto la
teoria del “più ragionevole per noi”[xviii]. Ora, se non schiacciamo nuovamente quella frase – “più
ragionevole per noi” – su un’idea di normatività pratica universale, in senso kantiano o utilitarista
(che è opposto a quello di Kant ma egualmente astratto), allora il “più ragionevole per noi” può
derivare la sua normatività da chi noi siamo, da una certa idea di autenticità e, quindi, di
esemplarità. E il vantaggio della democrazia, in quest’ottica rawlsiana, è che in ultima analisi solo
in un contesto democratico possiamo soddisfare i nostri obblighi politici e abitare nelle istituzioni,
rimanendo noi stessi. È proprio di regimi variamente oppressivi, invece, costringerci a “non poter
essere noi stessi” se vogliamo obbedire alle leggi. Le due proposte del libro – l’idea di “regime
democratico multivariato” e di “democrazie multiple” – sono solo apparentemente più tecniche e
legate allo sviluppo del paradigma rawlsiano. In realtà, si collegano al tema dell’esemplarità e del
poter essere se stessi in un regime democratico. La proposta di un “regime democratico
multivariato” contempla fin dall’inizio l’ipotesi che gli elementi costituzionali essenziali, quelli che
formano il nucleo di un consenso che legittima l’intero regime democratico, non siano sottoscritti in
toto da sezioni importanti della cittadinanza. Potrebbe esserci o meno una ricaduta in termini di
pluralismo legale, ma in sostanza non si avrebbe la rigidità ancora presente in Liberalismo politico,
tale per cui se questo nucleo non è sottoscritto da tutti, se l’intersezione non è perfetta, allora ci
troviamo di fronte a un modus vivendi, un compromesso di fatto. Mentre l’idea di “democrazie
multiple”, di una pluralizzazione dell'ethos democratico, contribuisce proprio alla riflessione su che
cosa voglia dire “democratizzarsi” per uno dei cento Paesi che, secondo l’ultimo rapporto di
Freedom House, non sono ancora delle democrazie. La teoria politica non deve ripetere l’errore
della teoria della modernizzazione che, negli anni Sessanta, aveva in mente un unico percorso di
sviluppo che avrebbe trasformato le società tradizionali nella brutta copia delle società occidentali.
Sulla democrazia è una responsabilità di chi fa filosofia politica pensare in una chiave che disgiunga
democratizzazione e occidentalizzazione. E se rimaniamo fedeli all’idea che democrazia voglia dire
obbedire alla normatività di un ordinamento politico senza snaturarsi, democratizzarsi non potrà
significare occidentalizzarsi».
Petrucciani «Mi sembra un discorso molto interessante. Vedo soltanto un problema a margine. Tu
dici giustamente di non pensare la democratizzazione come occidentalizzazione però, guardando
alla vicenda tutto sommato fallimentare delle primavere arabe, secondo me si pone una questione:
ci sono dei presupposti perché una democratizzazione possa riuscire? Storicamente, in Occidente, la
democrazia è venuta dopo lo Stato di diritto, istauratosi sul principio dell’Habeas corpus, dopo una
cultura individualistica, che si afferma già nel Rinascimento, e dopo il pluralismo delle visioni
morali e religiose. Allora la domanda che ti pongo, senza conoscere la risposta, è questa: è possibile
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
una democratizzazione se prima non si sono in qualche modo assestate quelle che per il percorso
occidentale sono state le “precondizioni storiche” della democrazia? A me sembra abbastanza
difficile».
Ferrara «Io distinguerei prima di tutto due piani: uno riguarda la congiuntura storica in cui un Paese
si trova, che dipende dalle sue vicissitudini interne; un altro, invece, riguarda la presunta
refrattarietà alla democratizzazione di grandi visioni del mondo riconducibili in ultima analisi alle
religioni storiche. Ora, i limiti alla democratizzazione sono stati spesso ascritti ideologicamente ai
limiti delle visioni del mondo in quanto tali. Si è posta e si pone la questione, ad esempio, se una
popolazione islamica possa essere veramente democratica. E ricordiamo che meno di duecento anni
fa, negli Stati Uniti, la stessa domanda riguardava il cattolicesimo: può un cattolico essere
democratico? La prima cosa importante, quindi, è smontare questa costruzione. Anche perché
ritengo che le “precondizioni” della democrazia, come le hai chiamate tu, si possano sintetizzare in
tre elementi: una propensione alla priorità del bene comune rispetto ai beni particolari, un certo
valore dell’eguaglianza delle persone e un’idea del consenso come fattore legittimante. Io penso che
queste “precondizioni” siano tutte rinvenibili anche nelle religioni che a prima vista sembrano più
ostili alla cultura democratica. Nel confucianesimo, per esempio, una base di eguaglianza morale
c’è e deriva dalla convinzione che a nessun individuo è preclusa per principio la capacità di
acquisire perfezione morale. Secondo me, le peculiarità prettamente occidentali sono
essenzialmente due: la priorità dei diritti sui doveri e il valore del conflitto, del confronto,
dell’agonismo. Ma anche in questo caso nel libro cerco di dimostrare che la frattura non corre tra
Occidente e resto del mondo, perché la priorità dei diritti è stata fortemente contestata anche in
Occidente: pensa al tradizionalismo di Burke, pensa a Hegel, alla contrapposizione tra etica della
cura ed etica dei diritti nel femminismo, e, se non bastasse, all’utilitarismo, per il quale la fonte
primaria di normatività non sono i diritti ma l’utilità sociale».
Petrucciani «Ritieni però che ci siano degli stadi necessari per tutte le culture nel processo di
costruzione di una democrazia?».
Ferrara «È una questione aperta. L’India, ad esempio, ha raggiunto una democrazia pluralista senza
mai passare attraverso l’esperienza delle guerre di religione. Ovviamente ci sono state e continuano
a esserci violenze tra gruppi, ma non c’è mai stata una guerra di religione come la Guerra dei
trent’anni in Europa».
Finora abbiamo parlato dei presupposti culturali, storici e istituzionali della democrazia. Non
abbiamo ancora messo in luce, però, come uno dei presupposti della democrazia sia stata, di
fatto, la crescita capitalistica. Quando un Paese entra in recessione, non è forse inevitabile che lo
Stato non riesca a mantenere intatte le prestazioni di assistenza sociale? E, più radicalmente, non
è che forse il vero presupposto dello sviluppo della democrazia in Occidente si nascondesse
nell’egemonia di una parte del mondo sul resto?
Petrucciani «Il primo aspetto mi sembra lampante, almeno in Europa, perché forse per gli Stati
Uniti il discorso è un po’ diverso: la democrazia diventa l’ordine politico legittimo soltanto quando
dimostra la capacità di includere economicamente grandi strati sociali. Finché le contraddizioni
economiche della società sono troppo forti, come nel primo dopoguerra devastato da crisi
economiche e inflazioni catastrofiche, in Europa la democrazia non si assesta. La democrazia si
impone veramente nel secondo dopoguerra, quando bene o male entrano in sinergia due fonti di
legittimazione: da un lato, certo, l’eguaglianza dei diritti, l’autogoverno, la partecipazione aperta a
tutti, donne e uomini; dall’altro, però, la crescita del benessere. La legittimità dell’ordine
democratico, in altre parole, è data anche dal fatto che questo si dimostra capace di garantire una
graduale crescita del benessere. Allora la questione diventa: quanta crisi economica è in grado di
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
sopportare la democrazia senza collassare? Nonostante la crisi, la gente in Europa ancora mangia. Si
cominciano tuttavia a vedere forti segnali di risentimento e questo è un problema enorme, che
dovrebbe far riflettere anche gli apostoli dell’austerità e del rigore. Attenti, quindi, perché un ordine
troppo punitivo rischia di intaccare le condizioni stesse della democrazia. Non tanto perché la gente
in questo mondo opulento non abbia da abitare o da mangiare, quanto piuttosto perché così si
erodono le condizioni di legittimazione della democrazia: la gente rischia di non riconoscersi più in
questo assetto politico. Questo mi sembra il problema. Poi, certo, c’è anche l’altro aspetto che
dicevi tu, se e come il benessere dei Paesi avanzati sia compatibile con quello dei Paesi emergenti.
Però intanto bisogna stabilire quanta crisi economica la democrazia sia in grado di sopportare».
Ferrara «Il fatto stesso che si ragioni tanto sul costo della sanità, dell’istruzione, della ricerca, è
riflesso del pregiudizio per il quale i diritti sociali sarebbero “meno diritti” degli altri. Ma facevi
bene a reclamare un discorso diverso per gli Stati Uniti. Bisogna interrogarsi, infatti, se questa
equazione tra crisi economica e crisi della democrazia non sia una rappresentazione tutta europea.
Io non posso dimenticare di aver avuto la sfacciataggine, da giovane, di chiedere a un’anziana
signora tedesca come avesse votato nel ’33. Lei mi disse che sì, capiva la mia curiosità e
onestamente rispose di aver votato per Hitler. E alla domanda sul perché, disse: “guardi, non appena
ci riprendemmo dalla grande inflazione del ’23 arrivò la crisi del ’29, io mi dovetti trasferire per
cercare lavoro, c’era una fame nera e lui era l’unico a promettere di sistemare l’economia, di creare
posti di lavoro…”. Ebbene, dopo aver raccontato questo episodio a un amico americano, egli
commentò: “ma questa fu esattamente la stessa motivazione che negli Stati Uniti spinse l’elettore
medio a votare per Roosvelt!”. L’elemento su cui riflettere, dunque, è che la crisi del ’29 ha
prodotto il nazismo e rafforzato il fascismo di qua dell’oceano, mentre dall’altra parte ha portato il
New Deal e una grande fioritura democratica. E oggi, di fronte a una recessione di ben minore
entità, già recuperata negli Stati Uniti che sono di nuovo in crescita, questo storico contrasto è
riapparso: in Europa sono ricomparsi i populismi, la chiusura nazionalistica, la regressione
particolaristica con inclinazioni autoritarie, mentre sull’altra sponda dell’oceano Obama è stato
tranquillamente rieletto e il Partito Democratico si avvia con fiducia alle elezioni presidenziali del
2016».
Alessandro Ferrara, ordinario di Filosofia politica presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, è stato Presidente della
Società Italiana di Filosofia Politica dal 2005 al 2010 e dal 1993 è co-direttore della Conferenza annuale Philosophy
and Social Science di Praga. E’ co-fondatore e co-coordina il Seminario di Teoria Critica di Cortona. Autore di diversi
volumi, fra cui Reflective Authenticity (1998), Justice and Judgment (1999), The Force of the Example (2008), tutti
tradotti in italiano, nel 2011 ha pubblicato Democrazia e apertura.
Stefano Petrucciani è professore di Filosofia politica nell'Università di Roma La Sapienza. E' autore di numerosi libri
tra cui Introduzione a Habermas (Laterza 2000), Modelli di filosofia politica (Einaudi 2003), Introduzione a Adorno
(Laterza 2007), Marx (Carocci 2009), A lezione da Marx. Nuove interpretazioni, (Manifestolibri 2012).
NOTE
[i] S. Petrucciani, Introduzione a Habermas, Laterza, Roma-Bari 20113.
[ii] «L’idea (o meglio il termine) di consenso per intersezione», scrive John Rawls in nota a
Liberalismo politico (1993, nuova ed. ampliata nel 2005), Einaudi, Torino 2012, p. 16, «è stata
introdotta in Teoria della giustizia come strumento per indebolire le condizioni di ragionevolezza
della disobbedienza civile in una società democratica quasi giusta. In queste lezioni io la uso […] in
un senso diverso». Un senso cui Rawls accenna nel testo (ivi, pp. 15-16), quando scrive che il
consenso per intersezione «è formato da tutte le dottrine religiose, filosofiche e morali ragionevoli,
fra loro opposte, che hanno buone probabilità di durare di generazione in generazione e di
conquistarsi un seguito consistente in un regime costituzionale più o meno giusto nel quale il
criterio della giustizia sia quella stessa concezione politica».
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
[iii] «La ragione pubblica è tipica dei popoli democratici: è la ragione dei cittadini, di coloro che
hanno in comune lo stato di uguale cittadinanza. L’oggetto della loro ragione è il bene pubblico, è
ciò che la concezione politica della giustizia richiede riguardo alla struttura istituzionale di base
della società, nonché agli scopi e fini di cui essi, i cittadini, devono porsi al servizio» (ivi, p. 193).
[iv] Rawls definisce il discorso congetturale come segue: «ragioniamo sulla base di quelle che
crediamo siano, o ipotizziamo essere, le dottrine fondamentali, religiose o non religiose, delle altre
persone, e quindi cerchiamo di mostrare loro che, qualunque cosa pensino a questo proposito, esse
possono nondimeno sostenere una concezione politica ragionevole su cui fondare ragioni
pubbliche» (ivi, pp. 431-432).
[v] Ivi, pp. 116-119.
[vi] J. Quong, Liberalism without Perfection, Oxford University Press, Oxford 2011.
[vii] A. March, Islam and Liberal Citizenship: The Search for an Overlapping Consensus, Oxford
University Press, Oxford 2009.
[viii] N. Bobbio, Della libertà dei moderni comparata a quella dei posteri (1954) in Politica e
cultura, Einaudi, Torino 2005, pp. 132-162.
[ix] Id., Il futuro della democrazia. Una difesa delle regole del gioco, Einaudi, Torino 1984, pp. 328.
[x] L. Ferrajoli, La democrazia costituzionale e la sua crisi odierna, in «Parole chiave», n. 43,
giugno 2010 (fascicolo monografico dedicato a «Democrazia»), pp. 25-59.
[xi] F.I. Michelman, How Can the People Ever Make the Laws? A Critique of Deliberative
Democracy, in J. Bohman e W. Rehg (a cura di), Deliberative Democracy, MIT Press, Cambridge,
MA, 1997, pp. 145-171.
[xii] T. Piketty, Il capitale nel xxi secolo (2013), Bompiani, Milano 2014.
[xiii] B. Ackerman, The Decline and Fall of the American Republic, Harvard University Press,
Cambridge, MA, 2010, pp. 131-135.
[xiv] L. Canfora, G. Zagrebelsky, La maschera democratica dell’oligarchia. Un dialogo, a cura di
G. Preterossi, Laterza, Roma-Bari 2014.
[xv] C. Offe, An ‘Empty Signifier’?, in «Constellations», 2009, vol. 16, n. 4, pp. 550-562.
[xvi] D. Held, Governare la globalizzazione. Un’alternativa democratica al mondo unipolare
(2004), il Mulino, Bologna 2005.
[xvii] D. Archibugi, Cittadini del mondo. Verso una democrazia cosmopolitica, il Saggiatore,
Milano 2009.
[xviii] J. Rawls, Kantian Constructivism in Moral Theory, in «Journal of Philosophy», 1980, n. 88,
p. 519.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
Thelonious Monk. Ritratto di un eremita?
di GIACOMO FRONZI
Nel 1944, e cioè poco più di settant’anni fa, veniva pubblicato uno dei brani più noti ed eseguiti del
repertorio jazz, ’Round midnight, firmato da una figura considerata generalmente eccentrica,
“liminare”, ma che in realtà aveva piena consapevolezza del proprio posto nella società e di come
la musica potesse rappresentare un mezzo utile per migliorare il mondo: Thelonious Monk.
1. Musica e diritti civili
21 giugno 1969. Scoppia la prima rivolta gay, a seguito dell’ennesima retata della polizia. Dopo
anni di soprusi e provocazioni (queste ultime da ambo le parti, probabilmente), quella notte esplode
la rabbia, una rabbia incontenibile, premessa alla nascita del gay pride. Sempre quella notte,
all’Haven, un locale notturno illegale, si consuma un’altra rivoluzione, non civile, ma musicale, ad
opera di un dj italoamericano, Francis Grasso (1948-2001). Nasce la disco, la musica della libertà,
dell’emancipazione, dell’amore, sostenuta dai gruppi sociali fino ad allora vessati ed emarginati,
come i neri, gli ispanici, i gay, i bianchi proletari. «Le manipolazioni sonore e umorali di Grasso, i
sound system di Alex Rosner, le ricerche musicali e gli ideali di solidarietà di Mancuso sorsero tutti
sullo sfondo della nuova democrazia nera e gay che regnava nei locali newyorkesi e del potere
liberatorio dei cambiamenti sociali. Anche la musica stava cambiando. La ballabilità del funk si era
incrociata con la grazia del soul ed era emerso un nuovo sound»[i]. Era la nata la disco.
La disco music, al di là di quello che poi è diventata in anni successivi, ha fatto da sfondo a un’era
di drammatici cambiamenti sociali. È la colonna sonora della fuga da una realtà fatta di guerra
(quella del Vietnam), crisi petrolifera e profonda recessione economica. E a mano a mano che i
pregiudizi sui neri e gay iniziano ad attenuarsi, è anche la musica giusta per festeggiare nuove
libertà, con il suo straordinario e innovativo mix di R’n’B, ritmi latini e ritmi funk.
Ho fatto questo riferimento iniziale alla disco per due motivi. Il primo è sottolineare ulteriormente
quanto sia stretto il legame tra sviluppi musicali e dinamiche sociali. Ogni rivoluzione, ogni
rivendicazione di diritti ha la propria colonna sonora. Il secondo motivo è dimostrare come il jazz
possa essere considerato il genere musicale per eccellenza nel panorama della musica di protesta,
soprattutto perché storicamente è il primo grande genere musicale nato in un contesto di violazione
dei diritti.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
2. Alle origini del jazz
Sappiamo bene come alcuni tra i generi musicali extracolti più ascoltati al mondo (hip-hop, rap,
reggae, jazz o blues) trovino in Africa le proprie lontane radici storiche, culturali e, se vogliamo,
ideologiche. Il jazz nasce dalla convergenza di culture africane ed europee nelle colonie
nordamericane, in quell’oscuro e tragico processo che va dal xvi al xx sec. e che conosciamo come
«tratta degli schiavi»[ii]. Parliamo di circa venti milioni di persone. Questo immenso spostamento
di uomini ha comportato una convergenza tra culture come mai si era avuta fino ad allora, per
caratteristiche e modalità. Dal punto di vista musicale, approdano negli USA strumenti africani
(come il banjo), pratiche musicali legate sia alla danza che ai canti (come i canti di lavoro). Nelle
piantagioni risuonano i field hollers, un richiamo, una richiesta d’aiuto, un lamento solitario, un
«grido lungo, forte, musicale»[iii]. Il passaggio successivo sarà la trasformazione in canto sacro,
nello spiritual.
Questo accade nelle colonie inglesi (Virginia, Carolina, Georgia), ma non in Lousiana, a New
Orleans. Qui approdano gli schiavi africani provenienti dal sud del Marocco, quelli che poi saranno
chiamati “creoli”, riferendosi con questo termine ai neri di pelle chiara, nati da genitori bianchi e
neri, con nomi francesi. Come è stato scritto, la loro è una musica swingante, influenzata dalla
cantillazione coranica, che preferisce strumenti a corda portatili a scapito della trama
poliritmica[iv]. Negli anni Sessanta del Settecento i francesi cedono la Lousiana agli spagnoli, che
fanno di New Orleans una città danzante, peraltro è legata alla vicina Cuba da notevoli scambi
commerciali. Si crea allora una tale commistione da produrre una musica afro-mediterranea-cubana,
soprattutto in forma di danza, una danza che è una sorta di religione solidale, basata sull’assistenza
e la resistenza, fisica e culturale, degli schiavi.
Il passo successivo sarà la nascita di una nuova figura, quello dell’entertainer, l’intrattenitore, che
ingloba nel proprio repertorio canti delle piantagioni e composizioni originali dalle sonorità
nostalgiche e raffinate, affrontando, con la musica, una società antagonista che aveva relegato i neri
al ruolo di perdenti[v].
Alla fine dell’Ottocento ormai pianisti e compositori neri riescono a ritagliarsi un proprio spazio.
«Andava prendendo corpo una scuola pianistica costituita da compositori/improvvisatori che
cucivano insieme danze di provenienza orale, con un’abbondanza di sincopi afroamericane»[vi].
Questo stile, nel quale confluisce anche il ritmo di marcia per banda e il cakewalk (una danza che
risale alla schiavitù e che diventa, per i neri, la «parodia della cerimonialità dei padroni»[vii]),
prende il nome di ragtime (pensiamo a Scott Joplin, James Scott o Joseph Lamb), uno stile che
sprigiona un’irresistibile energia propulsiva, un’inesauribile invenzione melodica e una pervasiva
sicurezza ritmica, il tutto colmo di un potente ottimismo.
Nel frattempo, con la liberazione degli schiavi e il riconoscimento della cittadinanza americana
realizzato dal presidente Lincoln nel 1863, quegli uomini che erano vissuti in catene, dopo una
prima drammatica reazione di disorientamento e di disadattamento, si trovano a dover ridefinire il
loro nuovo ruolo, la loro nuova identità, le proprie ambizioni e le proprie speranze. In molti paesi
rurali del Sud, però, la situazione rimane ancora drammaticamente conflittuale, per la fortissima
opposizione al proclama di emancipazione dei neri, che si manifesta soprattutto con l’applicazione
di leggi discriminatorie e frequenti episodi di linciaggio. È in questo quadro che negli anni Novanta
dell’Ottocento, nella zona del Delta del Mississippi, nella zona tra la Georgia e il Texas orientale,
nasce una lirica musicale di ambiente rurale per voce solista e strumento accompagnatore, il blues,
«frutto culturale della prima generazione di neri contadini nati dopo la schiavitù, i quali si trovarono
ad affrontare nuovi problemi di indipendenza economica, adattamento sociale, organizzazione
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
familiare ed espressione individuale. Il blues scaturì così dalle nuove sfide che i giovani neri nati
liberi dovettero affrontare in una società sempre più ostile e violenta»[viii].
Intanto Chicago inizia a riempirsi di musicisti provenienti da New Orleans, in particolare bianchi,
che vanno ad esibirsi soprattutto nei cabaret. In questo contesto, siamo nel 1916, nasce la ODJB
(Original Dixieland Jass Band). “Dixieland” si riferisce geograficamente all’intero sud della
Louisiana. Ma ci sono già diverse forme di “jazz”. A San Francisco e Chicago il jazz indica la
musica polifonica e swingante dei neri provenienti da New Orleans; a New York indica la polifonia
frenetica della ODJB. Stiamo parlando, quindi, di jazz nero e di jazz bianco.
3. Jazz e impegno civile
La storia del jazz, naturalmente, continuerà arricchendosi di personaggi leggendari come Louis
Armstrong, Earl Hines, Bix Beiderbecker, Duke Ellington e tutti i grandi
strumentisti/improvvisatori/compositori che hanno reso sempre più complesso l’universo jazzistico.
Spostiamo però ora l’attenzione prima su alcune considerazioni generali e poi su una delle figure
più eccentriche della storia del jazz.
Va detto che la storia del jazz ci indica un percorso e uno sviluppo per nulla rigido e monolitico.
Questo genere musicale, pur essendo stato inevitabilmente travolto, al pari di qualsiasi altro, dalla
inarrestabile epidemia della standardizzazione e della commercializzazione, è sempre stato
fortemente condizionato dal contesto nel quale si è via via sviluppato, in quel tempo e in quel luogo,
pertanto sempre profondamente “attuale” e, per gli stessi motivi, sempre profondamente diverso. Il
jazz «va consumato caldo, con partecipazione di chi ascolta al momento creativo; deve maturare
nella realtà presente, riflettere tale realtà così intensamente come nessun’altra musica è stata mai
capace di fare, e quindi rinnovarsi incessantemente»[ix].
C’è chi però ritiene che questo incessante rinnovamento abbia subito un qualche rallentamento se,
all’inizio degli anni Novanta, Larry Kart ha sostenuto che lo stato del jazz in quel periodo poteva
essere ben riassunto dal detto «The old ones are going, and the young ones aren’t growing». Il jazz,
cresciuto a ritmi così rapidi da esprimere, nell’arco di una ventina d’anni dalla sua nascita, almeno
tre figure principali (Louis Armstrong, Sidney Bechet e Jelly Roll Morton) e una serie di capolavori
innegabili, con l’approssimarsi della fine del xx secolo, inizia a dare segni di “invecchiamento” –
per usare un lessico adorniano. Questa musica gloriosa inizia a perdere appeal, non per mancanza di
popolarità, quanto per la sua vitalità artistica, che pare essersi incrinata. Capace di rinnovarsi al
proprio interno, a un certo punto della sua storia il jazz sembra girare su se stesso, anche quando si
apre alla fusion o alla world music[x].
Ciononostante, gettando uno sguardo alla storia del jazz, potremmo dire che si sono sviluppate tante
forme di jazz per quanti contesti sociali e geografici ne hanno visto la nascita: jazz bianco, jazz
nero, jazz americano, jazz europeo, jazz italiano, ecc. L’espansione del jazz in tutto il mondo ha
comportato la modificazione del suo linguaggio originario, «grazie a una serie di
evoluzioni/rivoluzioni che [hanno palesato] la sua dirompente vitalità, tanto da far nascere non solo
stilemi rapportati al mutare delle situazioni sociali ed economiche americane prima e mondiali poi,
ma addirittura da coinvolgere anche jazzmen – soprattutto europei – che via via si [sono
appropriati] dei linguaggi jazzistici immettendo in essi elementi derivanti dal loro patrimonio etnico
così da creare altri linguaggi caratterizzati da una evidentissima originalità»[xi].
Il jazz ha sempre espresso sentimenti ambivalenti, ma sempre fortemente definiti: speranza, gioia,
disperazione e rabbia. Il jazz, insieme ad altri generi musicali, è il simbolo della libertà e del riscatto
dei neri e degli afroamericani. E la sua storia è stata costellata di personaggi leggendari vissuti come
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
simbolo di insubordinazione alla supremazia dei bianchi, ma anche di fratellanza, di uguaglianza
dei diritti, di rinnovamento culturale. Il jazz, il soul, il reggae, lo ska, costituiscono tutti dei modelli
musicali, ma anche e soprattutto dei modelli di cultura underground «nei quali i rapporti di genere,
di classe e generazionali si potrebbero attivamente rimodulare in senso più egualitario. In questo
momento hanno preso forma una nuova relazione con il mondo blackness e una nuova politica
razziale, che hanno resistito negli anni del dopoguerra»[xii].
Il jazz, nell’America della Guerra fredda, nell’America degli anni Sessanta, si presenta come il
megafono per le istanze emancipatrici soprattutto della comunità afro-americana. L’espansione del
jazz in quegli anni si accompagna alla convinzione ideologica di una sua presenta color blindness,
l’indifferenza del jazz al colore della pelle: poiché il jazz è ormai una musica di diffusione
universale, esso trascende le questioni razziali. Ma non è davvero così. Il sindacato dei jazzisti neri
è discriminato, i contratti con le case discografiche sono dei contratti capestro, il pubblico non è
integrato, le opportunità di lavoro sono limitate. Nell’immediato dopoguerra – lo sappiamo – uno
dei problemi più scottanti negli Stati Uniti è proprio quello della segregazione razziale. Bianchi e
neri sono divisi in ogni attività quotidiana della società civile. Intorno agli anni Sessanta l’esigenza
di far riconoscere i diritti civili di tutta la popolazione, senza discriminazioni, si fa sempre più
sentita. Cosa fanno i jazzisti in quel clima? Già dopo il 1955 vengono realizzati brani come la
Freedom Suite del grande sassofonista e compositore Sonny Rollins e Haitian Fight Song di
Charles Mingus, grandissimo contrabbassista, pianista e compositore. Nella seconda metà degli anni
Sessanta si fa sempre più assiduo e intenso l’impegno di jazzisti come Dizzy Gillespie, Count
Basie, Duke Ellington, Louis Armstrong o Abbey Lincoln, la quale, nel 1960, con il poeta Oscar
Brown Jr. e il marito Max Roach, batterista e compositore, mette a punto il disco-manifesto
Freedom Now Suite!, sulla cui copertina un gruppo di uomini bianchi e neri, seduti al bancone di un
bar, rivolgono allo spettatore un calmo sguardo di sfida. Il bancone del bar, ovviamente,
simboleggia il gesto di protesta di quattro studenti universitari del Greensboro che il primo febbraio
del 1960 s/i siedono, in un bar, nel posto riservato ai bianchi. Tra i jazzisti impegnati sul fronte della
difesa dei diritti dei neri, compare anche il “solitario” Thelonious Monk.
4. “Melodious Thunk” [xiii]
Thelonious Sphere Monk nasce il 10 ottobre 1917 a Rocky Mount, nella Carolina del Nord. A
quattro anni, con i genitori Barbara e Thelonious Sr., si trasferisce a New York, dove avrebbe
vissuto per i cinque anni successivi. Inizia lo studio del pianoforte classico attorno agli undici anni,
ma la sua predisposizione per quello strumento era emersa già da tempo, anche perché la musica, tra
i Monk, è di casa. «Thelonious Monk aveva una conoscenza e un gusto grandissimi per la musica
classica occidentale, per tacere della sua conoscenza enciclopedica degli inni, della musica gospel,
delle canzoni popolari americane e della quantità di arie poco note che sfuggono a una semplice
categorizzazione. Per lui, era tutta musica»[xiv].
A diciassette anni, Monk lascia il liceo Stuyvesant per proseguire la sua carriera musicale, che
inizialmente l’aveva visto impegnato come pianista e organista accompagnatore di songs gospel
nelle chiese e, successivamente, attivo nella sua prima band, a partire dal 1933, che gli consente di
muoversi nel Paese. Sono anni importantissimi per la formazione di Monk, che in questo suo
girovagare ha la possibilità di ascoltare i grandi pianisti della tradizione stride[xv], come Fats
Waller, Art Tatum o James P. Johnson. Nel 1941, inizia a lavorare al Minton’s club di Harlem, dove
continua a sviluppare uno stile che poi verrà conosciuto come “bebop”, stile che inizia ad arricchirsi
di un’accentuata tendenza alla riarmonizzazione e alla rimelodizzazione di canzoni standard.
Accanto a Charlie Parker e Dizzy Gillespie, Monk esplora nuove vie, privilegiando uno stile veloce
e altamente creativo, che avrebbe poi aperto le strade al jazz moderno. Monk inizia a incidere nel
1944, suonando insieme a Coleman Hawkins, che in quell’anno l’aveva invitato a suonare nel suo
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
quartetto, allo Yacht Club. Inizia così la sua carriera discografica, che dalla Prestige lo farà
approdare, all’inizio degli anni Sessanta, alla Columbia.
Nel 1951 viene arrestato insieme al pianista Bud Powell per possesso di stupefacenti. All’arresto
seguono sessanta giorni di galera e il ritiro (fino al 1957) della cabaret card, indispensabile per
potersi esibire nei club. Nel 1958 viene nuovamente arrestato, ingiustamente, per disturbo della
quiete pubblica, e la sua licenza viene revocata per la seconda volta, ma proprio verso la fine degli
anni Cinquanta Monk inizia a vedersi tributato il successo meritato e le incisioni fatte con l’etichetta
Riverside (ma anche con altre due etichette indipendenti, la Blue Note e la Prestige[xvi]) vanno così
bene da fruttargli, nel 1962, un contratto con la Columbia, label anche di Miles Davis, Dave
Brubeck e Duke Ellington. Il successo discografico va di pari passo con quello concertistico,
suggellato da una performance, nel dicembre del 1963, alla Philarmonic Hall di New York.
Nei primi anni Settanta, Monk è impegnato in alcune mostre personali e incisioni in trio per la
Black Lion di Londra, ma i concerti iniziano a essere sempre di meno. È il preludio a un graduale e
inesorabile isolamento, che porterà Monk al silenzio, non solo musicale. Dopo un concerto alla
Carnegie Hall, nel marzo 1976, Monk si ritira definitivamente dalle scene. Morirà il 17 febbraio
1982 all’ospedale di Englewood, nel New Jersey, a seguito di un ictus. Al suo fianco, ancora una
volta, la moglie Nellie, molto più che una compagna di vita. Si erano conosciuti quando lei aveva
appena dodici anni e lui quattro anni di più. Per mezzo secolo, questa donna è stata una figura
insostituibile, allo stesso tempo moglie, manager, madre, organizzatrice, contabile e musa
ispiratrice. È la seconda figura femminile che ha segnato la vita di Monk. L’altra è la ricca
ereditiera e mecenate Kathleen Annie Pannonica de Koenigswarter, la “baronessa del jazz” (nota
anche come “baronessa del be-bop”), donna che molto ha avuto a che fare con il sostegno a Monk e
alla sua musica. Sarà lei, nel 1957, a consentirgli di recuperare la cabaret card che gli era stata
ritirata nel 1951.
Proprio negli anni Cinquanta, come detto, la critica e il pubblico smettono di ignorare Monk,
probabilmente perché fino ad allora il più disteso e conciliante cool jazz aveva impedito
un’adeguata digestione del jazz monkiano, decisamente più dissonante, più rude e più trasgressivo.
A questo si aggiunge la “stranezza” dei suoi comportamenti: «i goffi balli che compie mentre il suo
gruppo sta suonando, i bizzarri cappelli che indossa in concerto, l’abitudine di girare in tondo e
naturalmente i lunghi silenzi»[xvii]. Eppure, Robin D. Kelley, uno dei principali studiosi del
pianista americano, è convinto che la solitudine e la stranezza di Monk non restituissero in toto le
caratteristiche di questa bizzarra figura. Secondo Kelley, una certa responsabilità nell’aver
cristallizzato nell’immaginario comune Monk come una persona timida e sfuggente, circondata da
un alone di mistero, è da attribuire alla campagna pubblicitaria di lancio di un album del 1948. In
verità, Monk, sì, era questo, ma non solo questo. Era anche un marito e un padre amorevole, un
vicino di casa allegro, un insegnante generoso. «Thelonious Monk – scrive Kelley – visse appieno
nel mondo, perlomeno finché il declino mentale e fisico non lo costrinse al ritiro, rendendo a quel
punto il suo mondo apparentemente molto più piccolo, chiuso in se stesso e a tratti impenetrabile.
Ma per la maggior parte della vita Monk interagì con il suo ambiente e ne fu affascinato. Politica,
arte, affari, natura, architettura, storia, non c’era argomento che considerasse estraneo, ed era il tipo
che amava le belle discussioni, a dispetto dei racconti sulla sua incapacità di comunicare»[xviii].
Monk è considerato il pianista jazz più innovativo e creativo dell’era Bepop. Nella sua ricchissima
biografia, R.D. Kelley traccia un percorso decisamente originale della vita e della carriera di Monk,
attraverso un approccio profondo e sofisticato, che potesse rendere giustizia del contributo offerto
da Monk alla musica americana e alla musica jazz internazionale. Come ha giustamente rilevato
Larry A. Greene, il sottotitolo del lavoro di Kelley, “Storia di un genio americano”, descrive con
precisione l’ampiezza e la profondità sia di questo lavoro di ricerca che, soprattutto, la collocazione
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
di Monk nel panorama musicale statunitense. Quello di Monk è un approccio al jazz fortemente
originale, che si allontana, pur non tradendolo mai del tutto, dal terreno swing delle big band degli
anni Trenta, dando l’avvio alla rivoluzione Bepop[xix].
La sua è una musica dai caratteri ambivalenti, oscillante tra assoluta libertà e ferreo rigore, tra
sperimentalismo e tradizione. Quando Monk è solo, il suo stream musicale scorre a tratti, in una
maniera che quasi potrebbe apparire stentata (Jürgen Arndt ha parlato di «poetica
dell’esitazione»[xx]), per via del suo essere spezzata, frammentata, “cubistica”. La discontinuità
propria del be-pop con Monk «arriva alle estreme conseguenze, rompendo l’ultimo legame tra una
frase e l’altra, sostituendovi l’irruzione dell’imprevisto, dell’inaudito»[xxi]. Quando, invece, il
pianista-compositore di Rocky Mount si esibisce in formazione, «la sua musica appare legata
ferreamente a un tema, a una scansione ritmica regolare»[xxii], dimostrando, con ciò, di tenere
comunque sempre aperto un canale di comunicazione con la tradizione. Come giustamente rilevano
Cappelletti e Franzoso, la musica afro-americana sperimentale non tende a innovare poggiando su
vezzi o atteggiamenti intellettuali (o intellettualistici), bensì elaborando una sorta di graduale
rivoluzione nella continuità. L’ambivalenza di Monk, allora, riesce a tenere insieme uno stretto
legame con la tradizione, pur aprendo a un universo armonico dissonante e indefinito.
L’ambivalenza diventa allora ambiguità, ambiguità che può arrivare a investire tutti i livelli:
strutturale, armonico, melodico, timbrico. Il risultato è una musica perennemente sghemba,
imprevedibile, pungente, per nulla rassicurante, fatta di cluster, cromatismi, dissonanze e
interruzioni improvvise, pur nel rigore della forma. È una musica “sbagliata”, che accoglie la nota
fuori posto, il dito che scivola erroneamente su un tasto («I made the wrong mistakes», sembra che
Monk abbia detto una volta), proprio perché questi elementi di fibrillazione rendono il risultato
finale imprevedibile, sintesi ed emblema della varietà e della ricchezza del mondo.
Molti artisti, nel mondo del jazz, hanno elaborato un proprio stile distintivo, una propria tecnica
strumentale, ma sono pochi quelli che hanno incarnato uno spirito nuovo e anticonvenzionale (o
non-convenzionale) come quello espresso da Monk. Un pianista spesso accusato di ineptitude,
soprattutto agli inizi della sua carriera, ma che poi è diventato – come ha sostenuto Givan – una
delle icone del jazz, venerato tanto come pianista quanto come compositore, entrato
nell’immaginario comune come l’archetipo dell’intellettuale modernista e dell’artista
anticonformista[xxiii]. L’errore, quindi, in Monk non è legato a una qualche forma di inettitudine o
alla mancanza di tecnica. È vero, l’approccio al pianoforte di Monk (il modo in cui utilizza
l’avambraccio, il polso, le mani, le dita), finanche la scelta della diteggiatura paiono elementi di un
tutto disorganico, quasi approssimativo, laddove invece sono il frutto di una scelta consapevole,
studiata in funzione di un universo espressivo[xxiv]. Si tratta quindi di componenti di un
«linguaggio che è gestuale prima che stilistico, o entrambe le cose allo stesso tempo, dato che
questa musica funziona come linguaggio sonoro in virtù del linguaggio gestuale che la supporta e la
fa vivere. […] Vedere Monk suonare è essere partecipi di un’esperienza sensoriale totale, che
collega gesto ed ascolto, suono e visione (e partecipazione cinestetica)»[xxv].
Le poche cose dette fin qui restituiscono – seppure parzialmente – il mosaico variopinto del
pianismo e della creatività musicale di Monk, un artista che non ha dato vita a una scuola. Non
volontariamente. Come tutti coloro che si caratterizzano in maniera geniale, anche Monk aveva un
linguaggio e uno stile così peculiari dall’essere di fatto inimitabili, pena lo scimmiottamento, la
caricatura. È quindi particolarmente difficile parlare di eredità di Monk[xxvi], quanto meno – per
come si è detto – se si utilizza il parametro della “scuola”. Al di là delle caratteristiche specifiche di
un lavoro o di un’attività a seguito del rapporto con il lavoro o l’attività di qualcun altro, in linea di
massima il risultato è sempre originale. E allora dovremmo parlare più correttamente di influenza,
un’influenza che Monk ha esercitato ben al di là delle proprie intenzioni, in parte contribuendo in
maniera decisiva allo sviluppo del be-pop, in parte liberando il jazz da quell’ombra di
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
“prevedibilità” che avrebbe potuto consumarne la carica creativa. Elaborando quella che potremmo
definire “poetica dell’imprevedibilità”, Monk ha rappresentato, per usare le parole di Zenni, il più
genuino e il più anomalo dei compositori bop: «anomalo per i tratti enigmatici e spiazzanti della sua
musica, genuino perché a volte questi stessi tratti ci appaiono come una sorta di iperbole del
bepop»[xxvii].
NOTE
[i] B. Brewster, F. Broughton, Last night a dj saved my life (1999), con un capitolo di P. Pacoda sul
dj style italiano, trad. it. di T. Benzi, Arcana, Roma 20072, p. 187.
[ii] Ed è proprio da qui che ha inizio la storia del jazz che Stefano Zenni formula, a partire da una
“prospettiva globale”: cfr. S. Zenni, Storia del jazz. Una prospettiva globale, Stampa Alternativa
Nuovi Equilibri, Viterbo 2012.
[iii] E. Southern, La musica dei neri americani. Dai canti degli schiavi ai Public Enemy (1997),
trad. it. di M. Mele, C. Baschirotto, S. Francescato, il Saggiatore, Milano 2007, p. 162.
[iv] Cfr. N. Sublette, The World that Made New Orleans. From Spanish Silver to Congo Square,
Lawrence Hills Books, Chicago 2008, p. 60.
[v] Cfr. S. Zenni, Storia del jazz, cit., p. 35 e R. Crawford, America’s Musical Life: A History,
Norton, New York 2001, p. 199.
[vi] S. Zenni, Storia del jazz, cit., p. 36.
[vii] Ibid.
[viii] Ivi, p. 43.
[ix] A. Polillo, Jazz. La vicenda e i protagonisti della musica afro-americana, Mondadori, Milano
19882, p. 664.
[x] Cfr. L. Kart, Provocative Opinion: The Death of Jazz, in «Black Music Research Journal», vol.
10, no. 1 (Spring 1990), pp. 76-81.
[xi] G.C. Roncaglia, Il jazz e il suo mondo, Einaudi, Torino 1998, p. 10.
[xii] P. Girloy, Could You Be Loved? Bob Marley, anti-politics and universal sufferation, in
«Critical Quarterly», vol. 47, nos. 1-2, pp. 226-45: 237.
[xiii] Una delle caratteristiche del pianismo di Monk è il tocco percussivo. Su questo aspetto, ha
scritto Stuart Isacoff: «Nellie, la moglie di Monk, descrisse la combinazione di ritmi dirompenti e di
attacchi pianistici decisamente percussivi con un anagramma onomatopeico del nome del marito,
“Melodious Thunk”» (S. Isacoff, Storia naturale del pianoforte. Lo strumento, la musica, i
musicisti: da Mozart al jazz, e oltre, edt, Torino 2012, p. 135.
[xiv] R.D.G. Kelley, Thelonious Monk. Storia di un genio americano, trad. it. di M. Bertoli,
minimum fax, Roma 2012, p. 14.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
[xv] Per stride dobbiamo intendere stride piano, vale a dire uno stile pianistico tipico di certo jazz
attorno agli anni Trenta, soprattutto ad Harlem, caratterizzato da un accompagnamento veloce della
mano sinistra che alterna bicordi di ottava (o decima) sui tempi pari e accordi sui tempi dispari
(battute in quattro tempi).
[xvi] Per una discografia essenziale e preliminare, cfr: Piano Solo, Disques Vogue – M. 33.342,
France 1954; Thelonious Monk Plays, Prestige – PRLP 189, US 1954, The Unique Thelonious
Monk, Riverside Records – RLP 12-209, US 1956; Round Midnight / In Walked Bud, Blue Note –
4 -1664, US 19 7; Columbia – CL 2038, US 1963; Misterioso (Recorded On Tour), Columbia –
CS 9216, UK 1966; Epistrophy, Affinity – L6-AF 11, Spain 1980; Blue Monk, Jazz MasterWorks –
CJZLP 8, Italy 1985.
[xvii] A. Cappelletti, G. Franzoso, La filosofia di Monk o l’incredibile ricchezza del mondo,
Mimesis, Milano 2014, p. 19.
[xviii] R.D.G. Kelley, Thelonious Monk, cit., p. 15.
[xix] Cfr. L.A. Greene, Thelonious Monk: “The high priest of bepop”, in «The Journal of African
American History», vol. 99, no. 1-2, special issue: “Rediscovering the Life and Times of Frederick
Douglass” (Winter-Spring 2014), pp. 119-22.
[xx] Cfr. J. Arndt, Thelonious Monk und der Free Jazz, ADEVA - Akademische Druck- u.
Verlagsanstalt Graz, Graz 2002, p. 274.
[xxi] A. Cappelletti, G. Franzoso, La filosofia di Monk o l’incredibile ricchezza del mondo, cit., p.
26.
[xxii] Ibid.
[xxiii] Cfr. B. Givan, Thelonious Monk’s Pianism, in «The Journal of Musicology», vol. 26, no. 3
(Summer 2009), pp. 404-42.
[xxiv] A. Cappelletti, G. Franzoso, La filosofia di Monk o l’incredibile ricchezza del mondo, cit., p.
52.
[xxv] Ivi, p. 54
[xxvi] Sull’eredità di Monk, cfr. G. Solis, Thelonious Monk and jazz history in the making,
University of California Press, Berkeley-London 2008.
[xxvii] S. Zenni, Storia del jazz, cit., p. 307.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
Crisi del lavoro e terremoti finanziari. Storia e tesi del Gruppo
Krisis
di RICCARDO FROLA
In quest'articolo si ripercorre il senso di una delle esperienze più originali della sinistra tedesca
degli ultimi anni, e cioè quella del Gruppo Krisis. Nell'analisi prodotta dai membri del gruppo la
superfetazione finanziaria è ricondotta immediatamente all'esaurimento della figura della forzalavoro come agente produttivo di merci.
«I nostri genitori ci hanno insegnato la religione del lavoro»
Mario Draghi[1]
La crisi, dal 2008, sembra aver messo tutti d'accordo, almeno sul piano psicologico: viviamo in un
periodo di rimpianti. Le nostalgie per un giardino dell'Eden incontaminato fatto di fabbriche, uffici,
lavoro full time, risparmi e seconde case al mare; si mescolano al rimpianto per la vecchia politica
attiva, le lotte sindacali, l'opinione pubblica e i valori illuministi perduti. Un arcadico ambiente
«naturale», costituito da un capitalismo sano e operoso, frutto supremo del progresso
dell’Occidente, che si sarebbe pervertito – secondo la vulgata ufficiale - a causa dell’avidità e della
corruzione delle élites politiche ed economiche. In questa narrazione biblica e larmoyante, le tesi
della corrente internazionale nota come «critica del valore», elaborate negli ultimi trent'anni
principalmente in Germania attorno alle riviste Krisis ed Exit! da R. Kurz, N. Trenkle, E. Lohoff, A.
Jappe, R. Scholz e altri autori meno noti in Italia, rappresentano l'unica eccezione rimasta
lucidamente a ciglio asciutto.
I titoli di alcuni degli scritti questi autori: «La fine della politica», «Manifesto contro il lavoro»,
«Denaro senza valore», suonano oggi come una bestemmia alle orecchie di un pubblico che,
stordito dalla crisi, non fa che chiedere lavoro, denaro e politica. Eppure, la figura di Krisis era
apparsa blasfema, ai suoi esordi, per ragioni contrarie, quando - unica eccezione nel contesto
eccitato degli anni’90 -, era stata la prima a segnalare proprio quella crisi che è oggi sotto gli occhi
di tutti.
Nel 1991, mentre le macerie del muro di Berlino venivano trasmesse in mondovisione e «l’euforia
della vittoria si diffondeva fra coloro che erano da sempre convinti […] che il libero mercato e la
democrazia occidentale rappresentassero l’ultima parola della storia»[2], Kurz pubblicava il suo
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
primo libro, Il collasso della modernizzazione[3], dove sosteneva « che, lungi dall’essere il segnale
del trionfo finale del capitalismo occidentale, la caduta dell’Europa dell’Est non era che una tappa
del crollo […] dell’economia mondiale basata sulla merce, sul valore, sul lavoro astratto e sulla
moneta»[4]. Un’ipotesi respinta tuttora persino dagli ambienti più radicali, e non solo per ragioni
corporative (il milieu intellettuale diffida di qualsiasi outsider che non sia «accademico, giornalista,
o intellettuale di professione», e Kurz, addirittura, «si guadagnava da vivere lavorando di notte nel
reparto di confezionamento di un giornale locale»[5]). Il rifiuto della «critica del valore» ha ben più
solide ragioni teoriche, dato che il suo corpus critico, basato sulla parte più vitale dell'opera di
Marx, porta necessariamente a liquidare, e una volta per tutte, le ultime, stantie repliche del
marxismo tradizionale.
Secondo Kurz e compagni, infatti, il capitalismo è una società primitiva, un’«universalità sociale»
feticista il cui nucleo, non diversamente da quello delle religioni premoderne, si è fatto indiscutibile
come una «seconda natura», anche per i suoi sedicenti «critici». Il feticcio mercantile, anzi, in
misura perfino maggiore di quelli arcaici, ingloba ogni aspetto della vita comune per sottometterlo
ad un «sistema di codificazioni simboliche ciecamente presupposto»[6]. Crea a sua immagine e
somiglianza tutte le diverse sfere sociali contemporanee (comprese quelle di «economia» e
«politica», per nulla autonome) e i diversi attori sociali che le agiscono come semplici burattini. A
tenere i fili, dietro le quinte, le anonime categorie del «valore» (l’unico vero «soggetto
automatico»): il «lavoro», la «merce», il «denaro», e le loro cieche leggi di accrescimento continuo.
«Il feticismo è una società dove gli uomini fanno la loro storia, ma senza saperlo»[7]. Tutti gli
uomini. Siano essi capi di partito, banchieri, intellettuali, occupanti di un centro sociale, operai o
imprenditori.
Una visione delle cose che, pur essendo di origine marxiana, è sempre stata inconciliabile con la
Weltanschauung «radicale», sempre schierata «dalla parte del lavoro», sempre alla ricerca di un
«soggetto» capace di ingaggiare una «lotta di classe» o un’«insurrezione» quale che sia.
Ma, come se non bastasse, gli autori della critica del valore ereditano da Marx anche quella teoria
del crollo che è sempre stata, per il marxismo tradizionale, un trauma da rimuovere.
Il capitalismo è in crisi, certamente; ma non a causa dell’opposizione militante dei suoi nemici.
La genesi del tracollo capitalista è piuttosto da ricercare nelle contraddizioni interne alla sua stessa
dinamica sociale. La «società del lavoro», che non permette a nessuno di vivere senza acquistare o
vendere quote di lavoro, sta eliminando proprio il lavoro da ogni ambito produttivo. A causa della
rivoluzione microelettronica ed informatica, avviate dalla concorrenza fra capitalisti, il lavoro vivo
è stato espulso dal processo di valorizzazione, che è rimasto così senza ossigeno.
Il capitalismo, dunque, sta per crollare, senza dubbio; ma all’orizzonte non si intravede ancora
nessun sole dell’avvenire.
Non si tratta di questioni astratte: senza la teoria del feticismo e del crollo, anche le migliori
intenzioni possono ruzzolare su versanti minacciosi. La attuale confusione teorica ha già creato
sinistre convergenze: le migliori aperture di emancipazione si mischiano ai peggiori incubi
reazionari e il guazzabuglio è divenuto un tratto tipico della nostra epoca.
E non è soltanto il caso di segnalare l’evidente avanzata di una nuova «destra dei valori che si
accompagna spesso a una certa dose di antisemitismo e che è in generale associata ad una postura
da “sinistra del lavoro”, ostile al liberalismo economico»[8], fenomeno spesso ripreso anche dalle
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
telecamere di certi Talk-show no-Euro nostrani. Quanto piuttosto di evidenziare come l'idea stessa
che alcuni soggetti privilegiati possano avere un ruolo nel determinare a tavolino l'andamento dei
mercati e i destini del mondo, non produca esclusivamente quell’innocua epica da Kriegsspiel
economico che apprezzano i clienti dei quotidiani.
Se i pochi lettori colti sopravvissuti, infatti, si appassionano ancora, sorseggiando un caffé, alla
«guerra delle valute», si esaltano a paragonare il Quantitative easing voluto da Draghi alla «vittoria
storica […] di Napoleone a Marengo nel 1800»[9], divorano le raffinate gesta di questo o quel
presidente di Banca Centrale che, agganciando all'Euro il tasso di cambio della propria moneta, o
sganciandolo, o creando inflazione con misure «non convenzionali», mette sotto scacco lo
sprovveduto presidente avversario; platee molto meno sofisticate aggiungono ai colori di questa
concezione, le tonalità, strutturalmente antisemite, del complotto. Trenkle e Lohoff hanno
sottolineato recentemente come per quasi tutti gli osservatori «La responsabilità» della «crisi
economica e sociale debba essere imputata ad “avidi investitori finanziari”»[10]. Non sfuggono a
questa rischiosa personificazione della crisi i vecchi baluardi della sinistra, che parlano da anni di
«rivoluzione dall’alto» ai danni dei subalterni; né i centri sociali, che in alcuni casi si sono spinti
fino ad appoggiare movimenti come i «Forconi» italiani, fra i quali l'antisemitismo, spesso, non era
soltanto metaforico.
Ma quali giustificazioni teoriche ha la «critica del valore» per ritenere che limitarsi a criticare solo il
capitale finanziario (per quanto sia da criticare anch'esso) significhi rovesciare pericolosamente la
«connessione di causa-effetto […] della logica capitalistica»[11]? E quali per sostenere che la stessa
enfatizzata sfera della «politica», alla quale si delega ogni soluzione, non sia altro che una
«funzione secondaria nell’incessante processo di automediazione della forma merce»[12]?
Per capirlo bisogna decifrare le categorie del capitalismo ritornando sulle pagine dell’«opera di
Marx» che, pur non essendo «un “testo sacro” […] resta l'analisi sociale più importante degli ultimi
centocinquanta anni»[13].
«Che cos'è una merce? sembra una domanda sciocca, alla quale chiunque saprebbe rispondere. Una
merce è un oggetto venduto o acquistato, che cambia di mano contro pagamento»[14]. Tuttavia,
come è possibile che merci così diverse come un iPhone e quattro paia di scarpe possano essere
scambiabili con la stessa quantità di denaro? Sembra, dice Marx, che ci sia una misteriosa
«sostanza», una «terza cosa» in comune fra due o più merci, in grado di renderle, al di là delle
apparenze, del tutto equivalenti qualitativamente, e diverse solo quantitativamente.
Secondo la teoria marxiana[15], il valore delle merci, la «terza cosa» misteriosa – e l’unica
ricchezza valida nella nostra società-, è dato dal tempo di lavoro speso per la loro produzione. Il
lavoro portatore di valore, che Marx chiamava lavoro astratto, non è però quell’attività che l’uomo
ha esercitato nei secoli per soddisfare i suoi bisogni; ma un'astrazione tipica del solo capitalismo, in
grado di ridurre tutti i differenti lavori umani concreti a «una mera quantità di tempo indifferenziato
speso per produrre una merce»[16]. Tutte le merci diventano così semplici espressioni di quote di
valore (di cui il denaro è la manifestazione superficiale) qualitativamente uguali.
Nella società del lavoro astratto, anche i lavoratori in carne ed ossa vengono privati delle loro
differenze concrete e ridotti a semplici portatori di «capacità di lavorare», una capacità qualsiasi da
riversare a piacere nelle diverse branche della produzione. Un operaio dell’industria telefonica può
essere rapidamente convertito in addetto all'imballaggio, purché lavori e produca nuovo valore da
immettere nel ciclo. In questo gioco sociale, la «capacità di lavorare» è a sua volta una merce (la
forza-lavoro, nel linguaggio di Marx), che viene venduta sul mercato ai capitalisti in cambio di un
salario.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
La ricchezza capitalista non è dunque altro, per Marx, che tempo di lavoro astratto umano speso,
che deve moltiplicarsi nel processo produttivo. Ma come? Durante la produzione i capitalisti
costringono i portatori di forza-lavoro a lavorare più tempo di quanto sia necessario a riprodurre il
salario che costeranno. Questo diktat della valorizzazione, che ha imposto un forte e distruttivo
dinamismo alla nostra società, fu storicamente gestito dai proprietari di capitale dapprima
aumentando il più possibile le ore di lavoro giornaliere dei loro operai; e poi, poiché la giornata
solare, le forze e la pazienza dei lavoratori non erano infinite come le esigenze del valore
imponevano, aumentando la produttività del lavoro tramite le tecnologie. La limitazione della
giornata lavorativa a sole otto ore, costrinse infatti i capitalisti ad applicare sfrenatamente la scienza
alla produzione mercantile dotandosi di macchine continuamente più efficienti e rapide per
diminuire la quota di tempo di lavoro astratto dedicata dal lavoratore a ripagare il suo valore.
Contrariamente a quanto si pensi, quindi, le rivendicazioni operaie e le lotte sindacali, che servirono
certamente a rendere meno brutale la vita dei lavoratori, ebbero anche il ruolo, ben poco
rivoluzionario, di aiutare il capitalismo ad assumere la sua vera fisionomia: industriale, tecnologica,
depurata da tutte le sue scorie premoderne. Questa rincorsa, però, generò la più grave
contraddizione della società capitalista. Le macchine, incapaci di generare valore perché in grado di
immettere nel ciclo solo il valore che «costano», e non un grammo di più, cominciarono a sostituirsi
in tutti gli ambiti produttivi, all’unica sostanza del valore: il lavoro vivo.
Secondo la critica del valore, l'evoluzione informatica e microelettronica portò negli anni '80 la
produttività ad un tale livello che la forza-lavoro umana nel processo di produzione divenne del
tutto superflua. Il capitalismo ha incontrato così, a causa delle sue stesse dinamiche, un limite
storico invalicabile. «Di fronte a questo sviluppo» tecnologico, dice Lohoff, «la teoria di Marx,
secondo la quale l'utilizzo delle conoscenze scientifiche nella produzione comporterà la distruzione
della società della merce, acquista un substrato empirico»[17].
La terza rivoluzione industriale, secondo Kurz, «fece sciogliere come neve al sole il nucleo
occupazionale nell’industria», una «diminuzione non [...] compensata […] dall’espansione fordista
in Asia e altrove, come invece crede un certo discorso […] del tutto ingenuo sul terreno della teoria
dell’accumulazione»[18].
Ma allora perché l'economia mondiale non è crollata già con l’esaurirsi del fordismo? Secondo i
nostri autori, proprio grazie alla stampella offerta dalla finanza e dal capitale fittizio.
Nella prima metà degli anni ’70, con l’esaurirsi delle possibilità di profitti industriali, «gli
investimenti in impianti di produzione […] vennero accantonati»[19]. Le enormi quote di capitale
così liberate, non potendo più essere reinvestite nel processo di valorizzazione, generarono una
«congestione» che avrebbe portato rapidamente l’economia mondiale all’asfissia, se non fosse stata
risolta dirottando i capitali sui mercati finanziari. Negli euforici anni ottanta, infatti,
l’accumulazione di capitale sembrò riprendere a ritmi elevati: «tale crescita, tuttavia – spiega
Lohoff –, non proveniva più dalla produzione di valore effettivo». Nella creazione dei prodotti
finanziari, infatti, il denaro venduto come merce ad un acquirente ritorna accresciuto, dando
l'impressione che si accresca anche la massa di valore a livello globale.
In realtà, il capitalismo finanziario era ed è soltanto una «capitalizzazione anticipata di valore
futuro», una scommessa sulla futura «reale» creazione, attraverso l’uso di lavoro vivo nel processo
di produzione, del valore anticipato con promesse di pagamento.
«Un valore non ancora esistente – e che probabilmente non potrà mai esistere – si trasforma in
capitale fittizio» e viene utilizzato fin da subito sul mercato come se fosse «reale». A livello
macroeconomico, però, con il tramite dei titoli di proprietà creati nella circolazione, nessun valore
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
«nuovo», viene generato. Le merci che sguazzano nel mercato finanziario(titoli, azioni,
obbligazioni), sono cioè in grado di accrescere il capitale senza aumentare la massa di valore
globale.
Presto o tardi, tuttavia, se il valore anticipato dai prodotti finanziari non viene realmente generato
nella produzione di merci tradizionali, il meccanismo crolla. Tutte le bolle finanziarie presentatesi
in ogni crisi capitalistica sono rapidamente scoppiate.
Il capitale fittizio è riuscito finora ad esercitare un lunghissimo differimento del crollo grazie alla
liberalizzazione dei mercati e all’abbandono dei vincoli del gold standard. Ma quanto più lungo è il
differimento, tanto più grande è la bolla, e tanto più fragorosa sarà la sua esplosione. Oggi «il 97 per
cento di tutti i flussi finanziari trasnazionali ha finalità meramente speculative», è dunque facile
farsi un’idea del gigantesco «potenziale di crisi che è stato accumulato».
La produzione reale, gli Stati, i Comuni, i partiti e le associazioni fanno quadrare i loro bilanci quasi
soltanto più reggendosi sui prodotti della sovrastruttura finanziaria. Aziende dal bilancio prospero
crollano a causa semplici speculazioni errate sui mercati finanziari. Il «denaro senza valore» si è
gonfiato a tal punto che «se […] l’intera montagna dei valori commerciali fittizi si mettesse oggi in
moto come reale domanda, ciò significherebbe l’iperinflazione immediata anche in Occidente […]
(e) la rapida bancarotta di un numero sorprendentemente alto di imprese in apparenza
“sanissime”[…]»[20].
Ma il valore basato sul lavoro, e il denaro che ne è la manifestazione superficiale, pur essendo
diventati obsoleti a causa delle contraddizioni del capitalismo, restano ancora solidamente a
fondamento della società: senza ottenere una quota di valore, senza vendere il proprio lavoro, non è
ancora possibile accedere a nessuna risorsa. Milioni di disoccupati cercano ogni giorno, per
sopravvivere, di interpretare un ruolo ormai storicamente superfluo, rischiando di morire di fame in
mezzo all’abbondanza.
Ha ancora senso, in questo contesto, richiedere una soluzione «politica», «statale»?
Secondo la critica del valore la politica e lo Stato sono anch’esse categorie secondarie della formamerce, del tutto interne al sistema che vorrebbero trascendere. Esortare ad un ritorno
dell’«autonomia del politico» non è soltanto un pio desiderio naïf; ma una contraddizione in
termini. «Tutto ciò che fa lo Stato tramite la politica – spiega infatti Kurz –, lo deve fare con il
mezzo del mercato, cioè nella forma-denaro […] la sfera politica e statale non può creare
autonomamente denaro. […] Solo da processi riusciti di valorizzazione, mediati dal mercato, lo
Stato può trarre il denaro per il “finanziamento” di tutte le sue misure […] tutte le sue decisioni,
risoluzioni e leggi, intorno a cui vertono le lotte politiche, rimangono completamente inefficaci, se
il loro funzionamento non è stato “guadagnato” regolarmente nel processo di mercato». La funzione
regolativa della politica quindi, nel tempo della crisi del capitalismo che l’ha generata, si «sfalda
insieme con il meccanismo funzionale economico».
Ma di questa consapevolezza teorica, non v’è traccia nel dibattito pubblico, meno che mai in quello
italiano: i cosiddetti «soggetti» critici hanno svolto fino in fondo il loro compito e hanno assunto la
forma tipica della società che abitano. Fin dall’illuminismo, la società capitalista e le sue
insufficienti critiche si sono adoperate per rendere «naturali» le forme di socializzazione mercantile.
I concetti base di «economia» e «politica» sono stati inconsciamente attribuiti, dalla coscienza
borghese, anche alle società premoderne che non li conoscevano, come se fossero stati da sempre
parte della stessa essenza umana. L’attuale dibattito tra austerity e ritorno al politico è un sintomo
evidente di questa cecità storica. Se le politiche di risanamento sono, secondo Trenkle e Lohoff, una
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
tragica fiction con la quale gli Stati chiedono «alla popolazione […] ogni possibile sacrificio» pur di
«conservare […] credibilità nei confronti dei mercati finanziari» e rimandare ancora di un poco il
crollo della montagna di promesse di pagamento ormai insolvibili; le soluzioni politiche, per quanto
in buona fede, di ritorno alle sovranità monetarie nazionali, di reddito di cittadinanza, di tagli al
debito pubblico; o quelle economiche, che si limitano ormai alle proposte di acquisto, da parte delle
banche centrali, di titoli di Stato tossici; sono destinate a naufragare sugli scogli dell’esaurimento
del valore.
«Oggi», scrive Jappe, «la sola “politica” possibile è la rottura radicale con il mondo della politica e
delle sue istituzioni, della rappresentanza e della delega, per inventare al loro posto delle nuove
forme di intervento diretto»[21]. Solo smascherando la falsa «naturalità» delle categorie profonde
del capitalismo – date per scontate sia dai suoi critici, che dai sostenitori – , sarà possibile
contestarle davvero e rivelarne la disumana nocività. Una nocività che non merita rimpianti o
nostalgie.
La «religione del lavoro», in fin dei conti, si è rivelata un oppio molto più stupefacente della sua
vecchia versione confinata nell’alto dei cieli: a quando una nuova emancipazione?
NOTE
[1] G. Di Lorenzo, la Repubblica, 15/01/2015.
[2] A. Jappe, Towards a History of the Critique of Value, traduzione mia.
[3] La cui traduzione giace già pronta in un cassetto da anni.
[4] Towards, cit.
[5] Towards, cit.
[6] R.Kurz, La fine della politica e l'apoteosi del denaro, Manifestolibri 1997, p.18
[7] A. Jappe-S. Latouche, Uscire dall'economia, Mimesis 2014, p.69
[8] J-L. Amselle, Les nouveaux rouges-bruns, Lignes 2014, traduzione mia.
[9] F. Forte, Il Foglio 23/01/2015.
[10] N. Trenkle, E. Lohoff, Terremoto nel mercato mondiale, Mimesis edizioni, 2013, p.27.
[11] Terremoto nel mercato mondiale, cit. p. 31.
[12] La fine della politica, cit.
[13] A.Jappe, Les aventures de la marchandise, traduzione mia.
[14] Les aventures, cit.
[15] Mi permetto di rinviare, per approfondimenti, alla mia postfazione di Crisi: nella discarica del
capitale, Trenkle-Lohoff, Mimesis 2014.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
[16] A. Jappe, postfazione a Manifesto contro il lavoro, DeriveApprodi, 2003, p. 126.
[17] Crisi: nella discarica del capitale, cit.
[18] La fine della politica, op. cit. p. 115
[19] Questa e seguenti Crisi: nella discarica del capitale, cit.
[20] R. Kurz, op. cit. p. 122.
[21] A.Jappe Crédit à mort, traduzione mia.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
Ontologia e metaontologia. Intervista a Francesco Berto
di CARLO CROSATO
Da qualche giorno è nelle librerie il nuovo libro di Francesco Berto e Matteo Plebani (edito da
Bloomsbury – dall’Italia acquistabile anche nelle librerie del web) su ontologia e metaontologia. In
questa intervista a Francesco Berto, proveremo a capire le questioni salienti contenute nel libro, e
le novità nell’ambito della filosofia analitica.
C.C.: La prima domanda è intorno al legame tra filosofia analitica e metafisica. Voi, già dalle
primissime pagine del libro dichiarate che questo è anche un libro di metafisica. Eppure
chiunque si accosti alla filosofia analitica da neofita penserebbe di avere a che fare non con un
materialismo sfrenato, ma di certo non con la parola metafisica. Cosa significa nel vostro
apparato categoriale “metafisica”?
F.B.: Metaphysics di Crane e Farkas e What Is This Thing Called Metaphysics? di Garrett sono
manuali di metafisica. Sostengono che la metafisica è una indagine intorno alle caratteristiche più
fondamentali e generali della realtà. Questo è ciò che “metafisica” significa anche per noi. Chi
approccia la filosofia analitica e pensa che non avrà a che fare con la metafisica probabilmente non
conosce la filosofia analitica, se non per qualche cosa che gli è stato detto da altri. Quello che gli è
stato detto è falso. I filosofi analitici pubblicano ogni anno migliaia di articoli di metafisica.
Si potrebbe intendere anche altro con “metafisica”; si potrebbe intendere qualcosa come
«un’indagine sulla realtà non-fisica». Ma anche quando si intendesse questo, ciò che è stato detto a
quel tizio resta falso. Buona parte di quelle migliaia di articoli pubblicati ogni anno riguarda la
realtà non fisica.
Questo è chiaro. E fa riferimento al senso più originario della metafisica. Può essere che quel
primo stupore riguardo il legame tra la metafisica e filosofia analitica sia dovuto al significato
che la metafisica ha assunto in epoca medievale, oltre che a una indubbia ignoranza della
filosofia analitica?
Se intende che i filosofi italiani non-analitici subiscono l’influenza della chiesa cattolica, questo
potrebbe spiegare il loro stupore.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
Il titolo dice che questa è una guida di ontologia. La domanda che solitamente viene attribuita
all’ontologia è quella relativa a ciò che c’è e all’essere in quanto tale. Nell’ambito della
filosofia analitica, quali sono le novità più interessanti in merito a domande e a risposte?
Rimane ancora imbattuta l’interrogazione aristotelica, o sono sorte nuove domande?
Con “interrogazione aristotelica” intende «Che cos’è l’essere?»? Sì, quella è ancora più o meno la
questione. La novità è che, mentre per qualche tempo si è avuta quasi esclusivamente una sola
risposta dominante, ora ci sono diverse risposte in giro.
La risposta dominante era dovuta a persone come Frege, Quine o van Inwagen. Diceva – per usare
un motto quineano –: «Essere è essere il valore di una variabile». Questo significava: la nozione di
essere è data dal quantificatore, le “variabili” in questione essendo per Quine variabili di
quantificazione. I quantificatori sono espressioni come “qualche” o “c’è” (nota: i linguisti non
chiamano “c’è” un quantificatore; logici e filosofi invece sì). Espressioni simili ci dicono di quante
cose si sta parlando. Per Quine o van Inwagen, x è significa che qualcosa è x, ossia che c’è una cosa
che è x. Niente di più e niente di meno. In particolare, “qualche” o “c’è” possono significare una
sola cosa (van Inwagen ha un argomento carino in proposito). Così anche “essere” deve significare
una sola cosa: essere è univoco. In più, naturalmente tutto è: non avrebbe senso affermare che ci
sono cose tali che non ci sono quelle cose. Kant avrebbe detto: essere non è una proprietà reale.
Questo significa: è una proprietà che non muove una virgola, dato che non separa la totalità delle
cose in quelle che hanno questa proprietà e quelle che non ce l’hanno. Essere non è come essere un
tavolo o correre, che separano il mondo in due: le cose che sono tavoli e quelle che non lo sono, o
le cose che corrono e quelle che non corrono.
Ora ci sono anche altre risposte in merito. Alcune persone, come Jason Turner o Kris McDaniel,
concordano sul fatto che la nozione di essere sia resa dal quantificatore, ma aggiungono che
“qualche” può significare anche cose differenti. In «qualche italiano è adorabile», «qualche numero
è primo», “qualche” significa cose diverse. E così, anche “essere” può avere diversi significati.
L’essere di cose concrete, come gli italiani, e l’essere di cose astratte, come i numeri, sono modi
d’essere differenti e irriducibili. Le persone che sostengono questo sono pluralisti ontologici.
Concordano, a loro modo, con il motto aristotelico che «L’essere si dice in molti modi». E
potrebbero anche pensare che l’essere sia detto in modi ancor più diversi di quanto Aristotele
avrebbe potuto immaginarsi. Diversi tanto quanto l’Essere di Heidegger è diverso dalle cose che
sono enti, per esempio.
Alcune persone, come Eli Hirsch, dicono che quando gli ontologi dissentono su ciò che c’è – A
afferma che ci sono cose del tipo K, B lo nega –, il loro disaccordo probabilmente è superficiale.
Sembra che riguardi com’è il mondo, ma non è veramente così. Ciò che succede in un simile
disaccordo è che essi intendono cose diverse con l’espressione “ci sono”, e sia A sia B hanno
ragione una volta ammesso ciò che rispettivamente intendono. I disaccordi ontologici, allora, sono
generalmente superficiali e accadono a persone che si fraintendono a vicenda: come quando io
affermo che il “football” si gioca in undici contro undici e tu lo neghi, ma io intendo parlare di
calcio mentre tu intendi parlare del football americano.
Altri, come Kit Fine e Jonathan Schaffer, affermano che ciò che davvero importa nella questione
dell’essere non è cosa ci sia, ma cosa fonda cosa – cos’è più fondamentale e se qualche cosa sia
assolutamente fondamentale. Questi sono chiamati grounding theorists, perché sono alla ricerca dei
fondamenti ultimi della realtà. Alcuni di loro sono anche chiamati neo-aristotelici e sono chiamati
così perché si avvicinano alla prospettiva aristotelica per cui, mentre l’essere ha molti sensi, uno è
più importante di tutti gli altri: l’essere come ousìa o sostanza (prima). L’ousìa è il fondamento
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
ultimo della realtà: se non ci fossero sostanze, dicono gli aristotelici, non ci sarebbe nulla. Cosa
significa qui “fondamento”? I grounding theorists danno risposte molto raffinate.
Altre persone ancora affermano che è falso che essere sia essere il valore di una variabile, dal
momento che alcune cose semplicemente sono prive di essere: certe cose non esistono, come la mia
sorella meramente possibile (in realtà non ho sorelle, ma naturalmente potrei averne avuta una),
oppure Sherlock Holmes, oppure l’unicorno che ho sognato la scorsa notte. Alcune di queste cose,
come un cerchio quadrato, non esistono e non potrebbero nemmeno esistere. La morale è: alcune
cose sono prive di essere, e così è falso che “qualche” catturi la nozione di essere. Chi afferma
queste cose è spesso chiamato meinonghiano, da Alexius Meinong, un filosofo austriaco che
credeva questo. Io sono un meinonghiano.
Come dichiara il titolo, poi, questa è una guida intorno alla metaontologia. Cosa significa che
la metaontologia è “il nuovo nero”?
“Metaontologia”, in un senso, si usa per intendere lo studio della metodologia dell’ontologia. Come
si deve fare ontologia? Alcuni dicono che andrebbe fatta per speculazioni apriori e a tavolino e con
esperimenti mentali. Per esempio, secondo The Philosophy of Philosophy di Timothy Williamson,
noi conosciamo le necessità metafisiche grazie a ragionamenti controfattuali (non chiamerebbe
questa procedura “a priori”, ma possiamo mettere questa questione fra parentesi – per lui,
comunque, è certamente filosofia a tavolino). Sappiamo che qualche affermazione, P, è necessaria
metafisicamente se supponiamo controfattualmente non-P, e sviluppando questa supposizione. Che
cosa accadrebbe se P fallisse? Se sviluppando controfattualmente questa supposizione otteniamo
una inconsistenza, allora sappiamo che P è metafisicamente necessaria.
Qualcun altro sostiene che si fa buona ontologia se si guarda alle nostre migliori scienze,
tipicamente le scienze naturali, specialmente la fisica fondamentale. James Ladyman e Don Ross
credono che non dovrebbe essere posta alcuna questione ontologica formulata in modo tale che la
scienza, e in ultima battuta la fisica, sia in principio incapace di risponderle (per esempio:
«Supponendo che il Big Bang sia una singolarità, che cosa c’era prima del Big Bang?»). Dovremmo
preferire il quietismo su simili questioni.
Alcuni sostengono che fare ontologia consista nel sistematizzare le nostre intuizioni. Un modo
semplice per capire che cosa intendano gli ontologi con “intuizioni” è considerare le intuizioni
come credenze comuni. Qualcun altro, invece, dice che non dovremmo curarci delle intuizioni. Per
esempio, secondo gli ontologi David Lewis o il mio amico Achille Varzi, la composizione
mereologica è non-ristretta. Questo vuol dire: ogni qual volta si abbiano cose x e y, si ha
automaticamente anche la loro “somma mereologica”, x+y. Quest’ultima è ciò le cui parli sono
esattamente tutto ciò che è parte di x e tutto ciò che è parte di y. Questo principio conduce a oggetti
spezzettati molto strani, per esempio quella cosa le cui parti sono esattamente il mio piede sinistro
più la punta della torre Eiffel. È di sicuro controintuitivo ammettere nella nostra ontologia una cosa
di questo tipo, ma Lewis e Varzi non se ne curano; credono che la composizione non-ristretta sia un
principio che fa parte della vera mereologia – la vera teoria generale della nozione di parte – e che
il principio possa essere indipendentemente motivato e giustificato. Si opporrà al senso comune, ma
è il senso comune a dover cedere il passo.
Tutte queste linee di pensiero sono metaontologiche: seguono dal fatto che ontologi come Varzi,
Ladyman, Williamson, ecc., hanno diverse visioni in merito alle massime e ai principi che
l’ontologia dovrebbe adottare. Che la metaontologia sia il nuovo nero (the new black), significa
semplicemente questo: un gran numero di filosofi presta attenzione a simili questioni, ovvero un
gran numero di ricerche innovative nell’ontologia del ventunesimo secolo sono focalizzate sulla
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
metaontologia. Se volete essere aggiornati sull’ontologia, fareste meglio a studiare la
metaontologia. Quindi leggete il nostro libro (non che io sia di parte).
Quali opportunità può fornire lo studio meta ontologico all’ontologia?
Beh, si suppone possa aiutare gli ontologi ad avere una migliore comprensione di ciò che stanno
facendo e di come dovrebbero farlo. Proprio come la metodologia delle scienze sperimentali si
suppone possa aiutare gli scienziati sperimentali ad avere una migliore comprensione di ciò che loro
stanno facendo e di come andrebbe fatto.
Quine è il filosofo che proponeva di stilare un inventario ideale di tutto ciò che c’è per
rispondere alla domanda ontologica. La metaontologia, invece, fa un passo indietro e tenta di
interrogare la stessa domanda ontologica. Nel vostro libro si tratta anche di chi propone di
distinguere tra essere e ciò che c’è: cosa significa, in termini metaontologici, che qualcosa c’è
sebbene sia privo di essere?
Chiariamoci. Quine ha sponsorizzato l’idea che il compito dell’ontologia sia stendere un inventario
di tutto ciò che c’è. Questo perché, per lui, ciò che c’è è ciò che ha essere: essere è essere il valore
di una variabile, così essere è reso dal quantificatore: “c’è”.
Ma persone come i summenzionati meinonghiani rifiutano che la nozione di essere sia resa dal
quantificatore, dal momento che ci sono cose, come Sherlock Holmes, che semplicemente non
esistono. Ci sono: ne parliamo e le pensiamo (l’ho appena fatto), e naturalmente c’è qualcosa di cui
stiamo parlando e pensando. Solo che queste cose sono prive di essere.
Come noi che parlavamo già di questo libro, quando ancora non esisteva nelle librerie.
“Libro” è ambiguo. Si può intendere l’oggetto astratto («Jurassic Park è stato un successo») o le
copie concrete («Per favore, mi prendi Jurassic Park dal comodino?»). Le copie concrete di
Ontology and Metaontology non esistono ancora (nel momento in cui dico questa frase), ma la cosa
astratta potrebbe esistere già da un poco. Altra questione è cosa significhi esistere per un oggetto
astratto, ma non credo che vogliamo inoltrarci in questa discussione.
La ringraziamo di questa anteprima.
No worries.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
Annuario di tassonomia critica 2014
di DIEGO FERRANTE e MARCO PIASENTIER
Per la conclusione del 2014, Critical Theory – blog-community che occupa uno degli spazi digitali
più noti della teoria critica anglofona – ha passato in rassegna i testi più dibattuti e influenti del
2014. In questo articolo, si prova a darne conto in modo ragionato.
* PREMESSA METODOLOGICA – Gli animali si dividono in: a) appartenenti all’Imperatore, b)
imbalsamati, c) addomesticati, d) maialini di latte, e) sirene, f) favolosi, g) cani in libertà, h) inclusi
nella presente classificazione, i) che si agitano follemente, j) innumerevoli, k) disegnati con un
pennello finissimo di peli di cammello, l) et caetera, m) che fanno l’amore, n) che da lontano
sembrano mosche. - (Jorge Luis Borges)
La scrittura rappresenta uno dei topos privilegiati della riflessione filosofica. Memoria,
estraniamento, desoggettivazione. Si scrive per fretta. Per essere più precisi. Si scrive l'urgenza. Per
sciogliere i nodi oppure osservarli con chiarezza maggiore. Dalla parte dell’autore, rimane in molti
casi un’esperienza individuale o ristretta che mette al centro ciò che viene avvertito come tale. Per
la conclusione del 2014, Critical Theory – blog-community che occupa uno degli spazi digitali più
noti della teoria critica anglofona – ha passato in rassegna i testi più dibattuti e influenti del 2014.
La successione di autori e titoli permette di affiancare alla scrittura il suo complemento più
immediato – la lettura, i lettori – per offrire un primo avvicinamento allo stato dell'arte.
L'intenzione di questa lettura incrociata non è di certificare o persino quantificare la qualità e
l'influenza di un approccio nel dibattito culturale, ma cerchiare in rosso quelle parole che paiono
ribollire e catturare con efficacia le domande che la teoria critica rivolge oggi a se stessa. La lettura,
allora, e i suoi numeri. Un filtro – benché parziale – di come il tempo tenti di leggere se stesso.
1. Truth / truːθ / noun – the quality or state of being true: he had to accept the truth of her
accusation. • (Also the truth) that which is true or in accordance with fact or reality: tell me the
truth | she found out the truth about him. • A fact or belief that is accepted as true: the emergence of
scientific truths.
Il post-strutturalismo francese continua a essere uno dei riferimenti più significativi dell’attuale
dibattito in teoria critica. Sebbene capiti di imbattersi in pubblicazioni ancora inedite, il corpus
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
principale è rappresentato da testi di letteratura secondaria, più o meno complessi a seconda del loro
scopo introduttivo o critico.
I filosofi a cui viene rivolta attenzione maggiore sono Derrida, Foucault, Deleuze e, in parte, Lacan.
Oltre a una nuova biografia scritta da Benoit Peeters, a Derrida sono dedicati nuovi testi volti a
introdurre alcuni dei suoi lavori più importanti, come se vi fosse ancora bisogno di cogliere in tutta
la sua complessità il significato e l’eredita della decostruzione. Ricordiamo Derrida’s Voice and
Phenomenom e il testo introduttivo The Politics of Deconstruction.
La decostruzione diventa oggetto di critica in un libro sul pensatore italiano vivente forte più
tradotto e dibattuto all’estero: Giorgio Agamben. Kevin Attell propone Giorgio Agamben: Beyond
the Threshold of Deconstruction, in cui sono sistematizzate le critiche che il filosofo romano rivolge
a Derrida nel corso del tempo. Secondo Agamben, la decostruzione è nullificazione e differimento
di se stessa e la traccia diviene la cifra di questo autoriferimento e infondatezza. Il pensiero che fa
proprio tale metodo è gettato di fronte all’oscuro presupposto dell’illatenza della verità. In altre
parole, nella decostruzione, “l’assenza di fondamento della verità – cioè la crisi radicale della
presupposizione – è pensata essa stessa nella forma del presupposto”.[1]
Ed è proprio sulla questione della verità che si gioca la battaglia più difficile per il poststrutturalismo francese. I diversi lavori su Deleuze, Foucault e Lacan sembrano tutti muoversi in
questa direzione. Cos’è la verità nel pensiero francese post-strutturalista? Come fare i conti con
quella rivoluzione copernicana di larga parte del pensiero contemporaneo che ha tentato di
neutralizzare la tradizione onto-teologica? Sono queste le domande che fanno da filo conduttore a
due testi dedicati a Deleuze Deleuze and the Naming of God e Iconoclastic Theology. Gilles
Deleuze and the Secretion of Atheism, i quali cercano di articolare la nozione di immanenza che sta
al centro del pensiero del filosofo francese e serve per pensare oltre la tradizione onto-teologica.
Interrogarsi sulla questione della “morte di Dio” non può che chiamare in causa un filosofo tedesco
a cui il post-strutturalismo francese ha largamente attinto: Heidegger. Segnaliamo due lavori che
cercano di ricostruire questa relazione. Il primo – Ontology in Heidegger and Deleuze A
Comparative Analysis – indaga il rapporto tra Deleuze ed Heidegger, il secondo – The World of
Freedom – usa la categoria di libertà come collante tra il pensiero del filosofo tedesco e Foucault.
Nonostante il valore di questi testi, che contribuiscono in modo decisivo a consolidare la tradizione
filosofica francese nel dibattito contemporaneo, rimane il sospetto che essi evitino un corpo a corpo
con le contraddizioni e i limiti del post-strutturalismo. La domanda che rimane spesso senza
risposta è se la tradizione post-strutturalista francese non abbia finito con il restaurare, sotto diversa
forma, l’onto-teologia che ha cercato con tanta energia di neutralizzare.
A mettere in discussione l’eredità del post-strutturalismo sono due movimenti filosofici. Il primo–
nato tra Francia ed Inghilterra – è il realismo speculativo proposto da Iain Grant, Graham Harman e
Quentin Meillassoux, a quest’ultimo viene dedicato un testo riservato solo ai grandi del pensiero
contemporaneo, The Meillassoux Dictionary, già redatto per alcuni dei più significativi tra i filosofi
francesi, tedeschi ed italiani. Meillassoux è allievo di Badiou, le cui obiezioni, ma anche punti di
contatto con il post-strutturalismo sono ben noti. Segnaliamo qui due volumi che ci sembrano
particolarmente significativi: Lacan Deleuze Badiou, edito da AJ Bartlett, Justin Clemens e Jon
Roffe e Controversies, dove Badiou and Milner si confrontano su politica e filosofia. Il secondo
movimento che tenta di far vacillare il post-strutturalismo, assieme anche alla filosofia di Badiou, è
la non-filosofia del pensatore francese François Laruelle, il quale si è inizialmente guadagnato
spazio nel dibattito anglofono proprio per le sue convincenti critiche sia al pensiero della differenza,
da un lato, e a quello di Badiou, dall’altro.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
2. Non- /nɒn/ prefix – Not doing; not involved with: nonaggression | nonrecognition. • Not of the
kind or class described: nonbeliever | nonconformist. • A lack of: nonsense. • (Added to adverbs)
Not in the way described: nonuniformly. • (Added to verbs to form adjectives) Not causing or
requiring: nonskid | noniron. • Expressing a neutral negative sense when a corresponding form
beginning with in- or un- has a special connotation (such as nonhuman compared with inhuman).
Secondo Laruelle tutte le forme di filosofia si costituiscono attorno a una decisione a priori, che
rimane costitutivamente “impensabile” dal quello stesso sistema di pensiero. L’essenza di questa
decisione risiede nella produzione di una frattura. Esempi più o meno recenti sono le categorie di
“ontico” e “ontologico” in Heidegger o di “differenza” e “presenza” in Derrida. Non vi è modo di
cogliere la decisione che determina questa frattura senza produrne un’ulteriore. Se questa è la
diagnosi, quale deve essere la cura? Il nome di questa pozione – forse taumaturgica – è la “nonfilosofia” che, secondo Laruelle stesso, sta alla filosofia come le recenti geometrie non euclidee
stanno alla millenaria geometria euclidea. Due sono i concetti fondamentali per cogliere la proposta
di Laruelle: soggetto come puro performativo e “immanenza radicale”. Se la filosofia tutta è
pensiero della frattura, allora solo una “non-filosofia” sarà davvero in grado di pensare
l’immanenza. La filosofia, infatti, non può che introdurre una dimensione trascendentale come
risultato del taglio che la fonda e costituisce. Alla luce di queste considerazioni sulla necessità di
una radicale immanenza, va pensato il soggetto della “non-filosofia”. Sebbene molte delle
contemporanee filosofie difendano l’essenza performativa del soggetto, secondo Laruelle, tale
performatività non si è mai data in tutta la sua pienezza, dal momento che il performativo può
essere articolato solo a partire da un piano di pura, radicale immanenza.
Il corpus di letteratura secondaria su questo autore cresce sempre più, contribuendo a situare il
pensiero di Laruelle nel dibattito contemporaneo. In particolare il testo di Katerina Kolozova, Cut of
the Real Subjectivity in Poststructuralist Philosophy, usa la filosofia di Laruelle per muovere una
critica a pensatrici quali Judith Butler, Drucilla Cornell, Luce Irigaray, and Rosi Braidotti. Esce
quest’anno anche la traduzione di Introduction au non-marxisme, dove Laruelle si propone di
investigare sia il fallimento che la forza ancora inesplorata del marxismo, proprio alla luce del suo
sistema filosofico. Un tema, quello del marxismo e del suo ruolo nell’odierna società neoliberale,
che rimane all’ordine del giorno.
3. Capital /‘ kapitl/ noun – Wealth in the form of money or other assets owned by a person or
organization or available or contributed for a particular purpose such as starting a company or
investing: the senior partner would provide the initial capital | rates of return on invested capital
were high. • The excess of a company's assets over its liabilities. • People who possess wealth and
use it to control a society's economic activity, considered collectively: a conflict of interest between
capital and labor. • [ With modifier ] A valuable resource of a particular kind: there is insufficient
investment in human capital.
In molti frangenti si fa fatica a sbarazzarsi di vecchie parole e ciò accade quando rimangono
dirimenti o si consolida una scollatura tra l’interpretazione e i dati concreti che continuano a
riproporsi. Il capitale, il capitalismo, esemplifica al meglio questo doppio versante e le increspature
polverose e quasi anacronistiche non intaccano una domanda che rimane assidua, “Come pensare
una via d’uscita?”. La ripetitività della questione è indice di un’impasse profonda per il pensiero
politico e la teoria critica; contrizione o stallo che non rimane meno complesso se problematizzato
per mezzo di analisi e metodi distinti. Nel segmentare le risposte e le interruzioni alla domanda
sulla natura, il fine, la fine del capitalismo, salta subito agli occhi la volontà o la tentazione di
recuperare analisi trascorse, presupponendo, in un certo modo, una continuità che resta inalterata.
La pubblicazione – per la prima volta completa – di On the reproduction of Capitalism di Althusser
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
o del lavoro di Lefevbre o, ancora, l’excursus genealogico del pensiero marxista – e soprattutto
francofortese – di Feenberg ben testimoniano questo lungo fermo immagine.
L’analisi dei meccanismi economici che sorreggono l’affermazione del tardo-capitalismo o la sua
ricostruzione storica (Vogl, The Spectre of Capital; Ole Bjerg, Making Money: the Philosophy of
Crisis Capitalism; Jonathan Crary, 24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep) ripropongono un
gesto consueto: la fiducia che il dispiegamento e la comprensione di un processo comportino poi
l’interruzione dello stesso, ma prima di tutto intendono offrire una prospettiva che sia diagnosi. La
ricezione dei testi di Sloterdijk si inserisce solo in parte lungo questa andatura, ponendo
l’attenzione su un difetto di prospettiva storica nella lettura delle condizioni presenti. In Globes:
Spheres Volume 2 (testo del 1999) il pensatore tedesco propone una metafisica della sfera e
descrive la storicizzazione della globalizzazione del capitale come episodio di un lungo processo
che attraversa la storia umana. Per Sloterdijk la globalizzazione nella sua ultima fase accentua
l’esternalità dell’uomo rispetto a se stesso, rendendo il disorientamento, la contingenza, il suo segno
caratterizzante.
La contingenza ha uno statuto ben distinto se ci si sposta nel campo post-strutturalista e partendo da
qui vale la pena soffermarsi di nuovo sulla via d’uscita, su come articolare l’analisi con l’efficacia
dei suoi effetti.
La riflessione di Badiou indica un punto significativo per avanzare nel dibattito. In un suo saggio
raccolto in Badiou and the Political Condition lo stallo del pensiero contemporaneo nel pensare il
politico è messo in relazione con una crisi del negativo, con il cedimento della sua logica, che ha
prodotto uno slittamento da una prospettiva dialettica a una non dialettica. La fase attuale del
capitalismo moderno attesta l’emersione di un discorso senza limiti, che cancella lo spazio esterno,
e appiattisce la negazione sul suo versante decostruttivo. Privato di un movimento dialettico, il
negativo corre il rischio di farsi funzione dell’antropologia capitalista e consolidarla nella sua
opposizione. Altrettanto insoddisfacente rimane il modello politico sviluppato da Negri (in questo
quadro di riferimento si inserisce, per esempio, il lavoro David Harvey, Seventeen Contradictions
and the End of Capitalism), che per Badiou ridurrebbe l’evento a momento strutturale interno alle
logiche di sviluppo del capitale.
La possibilità di un evento, di una rottura della struttura della situazione, richiede, invece, il
ripensamento del nesso tra negativo e creazione (l’argomento è trattato per esteso nel lungo dibattito
tra Milner e lo stesso Badiou in Controversies). La possibilità di articolare la negazione del presente
con la creazione del nuovo Stato, della nuova legge.
4. Life / laɪf / noun – The condition that distinguishes animals and plants from inorganic matter,
including the capacity for growth, reproduction, functional activity, and continual change preceding
death: the origins of life. • [With adj. or noun modifier] A particular type or aspect of people’s
existence: an experienced teacher will help you settle into school life | revelations about his private
life. • Vitality, vigor, or energy: she was beautiful and full of life. • The existence of an individual
human being or animal: a disaster that claimed the lives of 266 Americans | she didn't want to die;
she loved life. • A biography: a life of Shelley.
In molti cercano oggi la possibilità di questo evento nella riscoperta della forza vitale dell’essere
umano. Si distingue a tale proposito il “neo-vitalismo”, le cui origini vengono oggi fatte risalire già
a Spinoza e trovano un consistente sviluppo una certa interpretazione del pensiero di Nietzsche,
Simondon, Canguilhem, Deleuze, Foucault e nei pensatori biopolitici italiani come Agamben,
Esposito, Negri e Virno. Nonostante le dovute differenze – si pensi alla critica che Nietzsche muove
a Spinoza – a far da filo conduttore a queste diverse esperienze filosofiche è la comune convinzione
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
nell’esistenza di una forza che lavora al fondo di ogni vivente. Seguendo, ad esempio, la relazione
che Nietzsche istituisce tra dionisiaco ed apollineo, questa forza vitale, libera e creatrice è una forza
dionisiaca definita in antitesi alle maglie opprimenti di una cultura e una politica apollinea che
l’hanno soffocata ed annichilita. La politica a venire sarà, quindi, in grado di riappropriarsi
dell’essenza dionisiaca dell’essere umano, della forza de-soggettivante e ricreatrice della vita che,
fungendo da segreto motore del cambiamento e della trasformazione dell’essere umano, impedisce
all’identità di ciascun vivente di reificarsi in forme statiche e granitiche. La filosofia della vita è una
filosofia del viandante. Non a caso, il testo edito da Vanessa Lemm – Nietzsche and the Becoming
of Life – raccoglie saggi che, nel loro comune intento di esplorare la nozione di vita in Nietzsche,
rintracciano in termini quali nomadismo e metamorfosi le loro parole chiave. Il tentativo di
introdurre una semantica della vita nel dibattito critico è sicuramente operazione necessaria e
coraggiosa – forse tra le più rimarchevoli delle ultime decadi. Basti ricordare la famosa Lettera
sull’umanesimo scritta da uno dei padri della svolta linguistica e la fondamentale influenza che il
suo approccio anti-biologista ha giocato nella odierna riflessione critica. Heidegger, infatti, sostiene
che l’unico modo non metafisico di pensare l’umanità dell’uomo consiste nello svincolare la sua
essenza da ogni riferimento all’animalità. Eppure, il merito del recente interesse verso la nozione di
animalità deve essere letto alla luce della deriva prescrittiva che queste filosofia della vita sembrano
introdurre. Il passaggio immediato da cosa sia la vita a come debba essere la politica fa venire in
mente un celebre aforisma di Nietzsche, un altro Nietzsche, il quale ricorda i rischi di chi, come gli
stoici, fa proprio il motto “vivi secondo natura”:
“Secondo natura” volete vivere? O voi, nobili stoici, che impostura dalle parole! Immaginatevi un
essere come la natura, sperperatrice senza misura, indifferente senza misura, priva di fini e di
riguardi, senza pietà e giustizia, feconda e sterile e contemporaneamente insicura, pensate
l’indifferenza stessa come potenza – come potreste vivere conformemente a questa indifferenza?
[…] E nell’ipotesi che il vostro imperativo “vivere secondo natura” significhi in fondo lo stesso che
“vivere secondo la vita” – come potreste non vivere in questo modo? Perché fare un principio di ciò
che voi stessi siete e dovete essere?[2]
Il monito di Nietzsche non vuole avere il senso di un abbandono della questione dell’animalità
dell’uomo, ma piuttosto impone di riflettere – per dirla con un altro titolo della nostra raccolta – su
what animals teach us about politics. In altre parole, si tratta capire come la riflessione
sull’animalità possa arricchire e problematizzare, ma senza esaurire il dibattito sulla politica.
La questione della materialità dell’essere umano viene ripresa da altre due tradizioni di pensiero – la
fenomenologia e i gender studies – che la articolano in direzioni spesso tra loro non convergenti.
5. Body /ˈbädē/ noun – the physical structure of a person or an animal, including the bones, flesh,
and organs: it's important to keep your body in good condition • The trunk apart from the head and
the limbs: the blow almost severed his head from his body. • A corpse: they found his body washed
up on the beach. • The physical and mortal aspect of a person as opposed to the soul or spirit: a
duality of body and soul. • Informal a person's body regarded as an object of sexual desire: he was
just after her body.
La riflessione filosofica si è interrogata sin dalle sue origini sul corpo, sul suo statuto, su cosa lo
definisse tale, riscontrando in molti casi una generale e sorprendente concordanza. Il corpo è
individuato dalla sua solidità, dall’estensione, cui il moto è solo trasmesso, è corpo ciò che viene
percepito dai sensi. Nella filosofia aristotelica è strumento dell’anima che gli assegna una forma e
unità. Per Cartesio, in una linea immaginaria che per lunghi tratti assimila il pensiero classico e
quello moderno è res extensa, estensione materiale che può essere divisa e movimento meccanico.
Il paradigma meccanicistico che si intravede, verrà poi rafforzato e legato al discorso scientifico,
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
allo studio delle proprietà fisiche o biologiche. Come emerge controluce, il pensiero sul corpo, del
corpo, ha spesso assunto la forma di una dicotomia, che permettesse nel gesto divisorio di definire
un polo positivo e uno negativo, determinando così la stabilità di un piano e la frustrazione
dell’altro. Quali pensieri sono stati percorsi per mettere in crisi questa messa in parentesi che la
storia della filosofia ha spesso e volentieri riservato al corpo?
Una prima direttrice è individuata dalla fenomenologia. Husserl distingue tra “corpo vivente” (Leib)
e “corpo cosa” (Körper), su cui si basa per derivazione la distinzione tra le scienze umane e le
scienze naturali. Il corpo mantiene un aspetto ancipite, sta nel mezzo come raccordo tra il
soggettivo e l’oggettivo, è “la mia proprietà originaria, la mia proprietà duratura”. È la prima cosa
di cui ci si appropria. È lo strumento per appropriarsi di ciò che è all’esterno.
In The Far Reaches, muovendo dalla disamina di Husserl e Brentano, Michael Gubser ricostruisce
l’ombra lunga proiettata dalla fenomenologia sulle storia recente dell’Europa, e in particolare il
ruolo giocato per pensare il suo rinnovamento etico e sociale nel Novecento.
La fenomenologia francese manterrà la centralità del corpo assegnatagli da Husserl, indicando con
Merleau Ponty il corpo quale fondamento originario dell’esperienza per il suo carattere relazionale
di apertura al mondo. D’altro canto, sin dall’inizio la fenomenologia francese – e la sua eredità
intellettuale – è stata esposta a critiche di esoterismo e di irrazionalità. Il testo di Knox Peden
recupera le critiche alla fenomenologia per mostrare che molte delle obiezioni erano mosse a partire
dalla filosofia di Spinoza. Peden registra la dissimmetria tra la lettura razionalista di Spinoza, per
esempio da parte di Althusser, e le interpretazioni vitaliste divenute predominanti.[3]
In The Thing, Dylan Trigg utilizza le categorie fenomenologiche per passarne in rassegna le linee di
fuga: se il corpo è il centro di dell’esperienza, è anche il luogo di un passato che la precede sempre.
Attraverso il corpo, allora, si può leggere una forma di dis-possesso, di in-umanità che Trigg
formalizza mettendo in tensione Merleau Ponty, Husserl, Levinas con la letteratura e il cinema
horror. Ne emerge la materialità estraniata, estraniante della realtà, che si colloca di lato
all’esperienza e ai suoi limiti. Il riconoscimento di una realtà irriducibile che rimane estranea
permette di tornare alla struttura dicotomica che caratterizza molte letture del corpo e spostarci a
un’altra possibile risposta che assume il problema come presupposto per la sua riflessione.
6. Gender / ˈdʒen.dər / noun – Gender /ˈjendər/ noun – the state of being male or female (typically
used with reference to social and cultural differences rather than biological ones): traditional
concepts of gender | [As modifier]: gender roles.
• the members of one or other sex: differences between the genders are encouraged from an early
age. • Grammar (in languages such as Latin, Greek, Russian, and German) each of the classes
(typically masculine, feminine, common, neuter) of nouns and pronouns distinguished by the
different inflections that they have and require in words syntactically associated with them.
Grammatical gender is only very loosely associated with natural distinctions of sex.
All’origine dei gender studies si pone proprio il tratto binario ed escludente attraverso cui il Logos
ha costruito il suo discorso. La differenza sessuale esemplifica questa reductio ad unum: il
femminile è ridotto a funzione del maschile, una diade che barra uno dei suoi poli.
Il pensiero femminista italiano ha nella sua tradizione pensato la differenza sessuale come
ontologica, riconoscendo nel due la possibilità di affermare la singolarità del soggetto e non la sua
semplice moltiplicazione – molteplicità –. L’assunzione del genere come carattere biologico, nel
dibattito anglofono, ha mostrato il fianco ad accuse di essenzialismo (che non rendono conto del
rilievo della riflessione maturata in Italia). Questa trappola è stata elusa, per esempio, da Judith
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
Butler per cui la nozione di genere è un elemento storico-culturale su cui è possibile intervenire. Per
Butler si diventa soggetti perché interpellati all’interno di posizioni diversificate e contingenti. Nei
suoi testi combina la nozione foucaultiana di potere, come soggettivazione e assoggettamento, con
il lavoro di Arendt: il soggetto si posiziona in uno spazio pubblico e quindi politico, la tematica del
corpo assume un carattere preminente, che palesa l’intreccio tra il piano della riflessione filosofica,
quello giuridico e quello politico, anche sul terreno dei media.
Si inscrivono in questa direzione i tentativi di interpretare la fase attuale di recessione economica
attraverso le strategie comunicative, le mode, gli stili di vita che coinvolgono il discorso di genere
(Gendering the Recession, Diane Negra e Yvonne Tasker) o di formulare una nuova teoria nei
gender studies che tenga conto del legame tra l’esperienza singolare del soggetto e le aspirazioni
della nazione in una fase caratterizzata dalla paura del terrorismo e dalle reazioni che questa suscita
(Sovereign Masculinity, Bonnie Mann).[4] Una nota distinta è rappresentata da Kolozova (Cut of
the Real: Subjectivity in Poststructuralist Philosophy) che applica il lavoro di Laruelle per sostenere
che il pensiero femminista post-strutturalista ha reso il soggetto una categoria puramente linguistica
ed espressione di una discorsività senza limiti, producendo uno scollamento tra il soggetto e
l’istanza del reale.
La struttura cadenzata e discontinua dei paragrafi corrisponde alle premesse segnalate in apertura.
Gli scaffali non registrano tutte le combinazioni dei venticinque simboli ortografici, le migliaia e
migliaia di cataloghi falsi. Ogni elemento, piuttosto, rende visibili punti salienti e contraddizioni
che cedono poi il passo alle loro chiavi di problematizzazione. Da questa prospettiva volutamente
circoscritta, è necessario allora interrogarsi sulle omissioni o gli squilibri di una tradizione di
pensiero, di un lessico filosofico. Interrogare la preminenza di Zizek, capace di polarizzare il
dibattito della teoria critica. Analizzare il nesso sempre più consolidato tra democrazia e
liberalismo. Oppure scandagliare il pensiero e la tradizione italiana che, con poche eccezioni legate
per lo più al pensiero filosofico-politico, non riesce a interpretare con continuità un ruolo
sostanziale in questo dibattito.
NOTE
[1] Giorgio Agamben, La Potenza del Pensiero. Saggi e conferenze, Biblioteca Neri Pozza, 2005,
161.
[2] Friedrich Nietzsche, Al di là del bene e del male, Adelphi, 1977, 9.
[3] Il lavoro di Marder (Phenomena, Critique, Logos) cerca di risponde a questa obiezione
cercando un congiungimento tra i presupposti kantiani e l’insegnamento di Husserl per ricondurre il
senso dei fenomeni all’attività di senso della coscienza.
[4] Si veda anche il lavoro di Emanuela Bianchi (The Feminine Symptom) che analizza la capacità
del femminile di eccedere il discorso teleologico di Aristotele – per cui la donna si collocata sul
versante della materia, della passività –.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
Scienza della letteratura e critica della vita. Note su "The
Bourgeois" di Franco Moretti
di RAFFAELLO PALUMBO MOSCA
Uscito nel 2013, "The Bourgeois" di Franco Moretti non ha ricevuto in Italia tutta l'attenzione che
merita. Si tratta tuttavia di uno dei frutti più maturi delle digital humanities e del metodo del distant
reading. La riflessione su questo metodo porta inoltre a interrogativi ancora più generali sullo
statuto della critica letteraria.
Il libro
Pubblicato nel 2013 presso la casa editrice Verso e subito entusiasticamente recensito da tutte le
maggiori riviste americane e inglesi, The Bourgeois. Between History and Literature di Franco
Moretti non ha avuto, in Italia, l’attenzione che merita. Ed è stata un'occasione persa. Innanzi tutto
perché questo volume è, a oggi, il frutto più maturo e interessante delle digital humanities e in
particolare di quel metodo di distant reading i cui vantaggi Moretti illustrava già in Graphs, Maps,
Trees: Abstract Models for a Literary History del 2005. Ma The Bourgeois è anche ‒ forse
soprattutto ‒ uno studio nel quale la virtuosistica capacità dell’autore di bilanciare e perfettamente
intrecciare l’analisi storica e teorica, l’analisi dei dati e quella più propriamente critico-letteraria,
tocca il suo apice.
Il risultato, notevolissimo, è uno studio che, per quanto agile, non solo riscrive e analizza in modo
originale la storia e il declino della borghesia europea, ma ci consente anche di guardare da una
prospettiva nuova e diversa le tecniche letterarie di volta in volta utilizzate nel corso di due secoli.
Da una parte, quindi, Moretti rifiuta ‒ come vorrebbe una lettura ormai sclerotizzata di
Simmel, Weber, Sombart e altri ‒ di identificare borghesia e capitalismo come due facce della
stessa medaglia, o di ridurre il borghese all’etica del lavoro (come lo stesso Weber sembrava
inclinato a fare), per restituirci invece una storia più complessa e sfaccettata, in grado di illuminare
sia le contraddizioni interne alla borghesia stessa, sia l’ambiguo rapporto che essa intrattiene con lo
sviluppo del capitalismo europeo. Moretti riesce inoltre a stabilire una relazione sempre cogente tra
fenomeni extra-letterari e strategie retoriche perché ‒ come ricordava lui stesso in Segni e stili del
moderno del 1987 ‒ questi ultimi contano non tanto come possibili temi o oggetti di un testo, ma in
quanto capaci di suscitare «delle reazioni culturali, dei sistemi di valutazione che si traducono in
strategie retoriche».
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
L’assunto di partenza del libro è prettamente lukácsiano (il Lukács di Teoria del romanzo): «ogni
forma è la risoluzione di una fondamentale dissonanza dell’esistenza» e lo studio delle forme
letterarie come “fossili di quello che una volta è stato un vivo e problematico presente” serve quindi
a comprendere quale particolare dissonanza tali forme servissero ad armonizzare. Così, ad
esempio, Moretti è in grado di stabilire e chiarificare la relazione tra l'uso del past gerund
nel Robinson Crusoe di Defoe (1719) e la ragione strumentale tipica della mentalità capitalistica;
vale a dire: di riconoscere nella struttura e nel ritmo della prosa di Defoe l'‘incarnazione
del ‘metodo’ dell’accumulazione capitalistica che “rinnova senza sosta i risultati acquisiti in nuovi
inizi”. Già da questo primo esempio si sarà capito che, se Moretti guarda alla letteratura ‒ secondo
la sua felice definizione ‒ ‘da lontano’ (cioè: analizza e istituisce relazioni tra pochi dati
fondamentali e fondanti), la sua analisi si arricchisce e integra anche grazie a calibratissime
zoomate al livello della frase o del periodo. E la frase o il periodo sono presi come campioni in un
laboratorio per esemplificare lo stile di un autore (o di un'epoca) inteso come unione di ‘prosa’ (con
tutte le sue strategie retoriche) e, appunto, parole-chiave.
Non ho usato le parole ‘campioni’ e ‘laboratorio’ a caso, ma soprattutto per introdurre l’idea di una
critica letteraria, più volte ribadita e soprattutto praticata dall’autore, molto vicina alla scienza: una
critica le cui conclusioni e i cui giudizi sono fondati su fatti concreti e quindi anche,
popperianamente, falsificabili. Da qui l’importanza cruciale rivestita dalle ricerche ‒ sulle
occorrenze dei singoli termini da una prospettiva diacronica e su testi appartenenti a diverse
tradizioni, ad esempio ‒ condotte nel Literary Lab da Moretti stesso diretto presso la Stanford
University. Ma è chiaro: è l’interpretazione dei dati, la capacità di renderli significativi all’interno di
un progetto coerente ‒ lo sfruttare l’analisi quantitativa sempre in vista di un’analisi qualitativa ‒
ciò che più conta, e che Moretti riesce a fare in maniera non solo convincente, ma avvincente.
La struttura generale del libro è molto chiara: a un’introduzione nella quale si analizzano
criticamente quasi due secoli di teorie sulla borghesia (tra i più citati, e la cosa non sorprende,
Weber, Marx e Kocka) fanno seguito cinque capitoli, in ognuno dei quali Moretti analizza lo
slittamento semantico nel corso dei secoli di una parola-chiave (“utile”, “efficienza”, “comfort”,
“serio”, “influenza” e “onesto”) e lo stile di una serie di testi esemplari, sempre mettendoli in
relazione allo sviluppo della borghesia. Ogni capitolo sembra poi tripartito in un prima, durante e
dopo la rivoluzione industriale. In questo modo, Moretti analizza e mette in luce l’evoluzione e
della classe borghese e dei testi che ne sono l’espressione, evidenziando le contraddizioni interne ed
esterne di questo rapporto.
C’è però una domanda che risuona per tutto il libro, e che Moretti ripete esplicitamente e con
insistenza: qual è il lascito della cultura borghese? Dal punto di vista simbolico, il più grande
successo (“achievement”) della cultura borghese è senza dubbio la creazione di una cultura del
lavoro di cui Moretti non ignora, però, l’interna contraddizione. Anzi: l’analisi di Cuore di tenebra
di Conrad (1902) rivela come la devozione al lavoro in sé sia, nella cultura borghese, insieme
fondamento della dignità del soggetto e della sua infamia. Accostandosi al piano dell’analisi
letteraria, invece, Moretti enfatizza come nel corso di un secolo (dal 1800 al 1900) si assista a un
esponenziale aumento dei «riempitivi» (i “fillers”, contrapposti ai “turning points”, o ‘punti di
svolta’). “Unica invenzione narrativa del secolo”, i riempitivi portano lo sfondo in primo piano: non
modificano il senso della storia né le aggiungono alcunché di significativo, non sono semplicemente
‘effetti di realtà’ à la Barthes, e non servono ad introdurre nella trama le ‘realtà’ borghesi. Perché,
allora, Moretti ne parla come dell’invenzione narrativa borghese per eccellenza? Perché ‒ e si
ricordi il passo di Segni e stili del moderno già citato ‒ essi “offrono quel tipo di piacere narrativo
compatibile con la regolarità della vita borghese” e attraverso di essi la logica della
razionalizzazione “pervade il ritmo stesso del romanzo”. Potrei continuare a lungo con esempi di
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
questo fine intrecciarsi di storia sociale e teoria letteraria all’interno del libro di Moretti, ma rinvio
senz’altro al piacere di scoprirli nel volume.
Da ultimo, vorrei solo citare l’analisi che Moretti fa dell’evoluzione nell'uso degli aggettivi tra 1700
e l’epoca vittoriana: se l’analisi quantitativa non mostra variazioni significative, l’analisi qualitativa
rivela come la loro funzione cambi invece in maniera radicale. Se, nota Moretti, in Robinson Crusoe
(e negli altri romanzi del periodo) gli aggettivi servivano a indicare qualità fisiche delle cose e
contribuivano alla “accuratezza letterale” della prosa, nei romanzi vittoriani gli stessi aggettivi
indicano invece qualità morali. Vale a dire: contengono un «giudizio in miniatura»; è così che il
romanzo vittoriano nasconde la propria vocazione moralistica dietro una solo apparente
‘oggettività’; i giudizi sono, nel testo, continuamente offerti, ma sempre in modo indiretto. Gli
aggettivi usati nel romanzo vittoriano, conclude Moretti, “non offrono precisamente un giudizio, ma
presentano una data qualità come inerente all’oggetto in sé”. La sfida di The Bourgeois è
ambiziosissima: non solo restituire un’interpretazione originale di due secoli di storia sociale e
letteraria, ma anche fondare questa interpretazione attraverso un’analisi che sia in senso proprio
scientifica. È una sfida che Moretti senza dubbio vince; e non è davvero cosa da poco.
Brevi riflessioni a margine
Eppure The Bourgeois, e soprattutto il metodo del distant reading, portano anche a interrogativi più
generali sulla critica letteraria in sé: da una parte sul posto e il ruolo che essa occupa all’interno dei
saperi, ma anche all’interno della società e, più modestamente, all’interno dell’università (ad
esempio, cosa faranno quegli studiosi ‒ ovvero tutti quelli che non sono a Stanford ‒ che non hanno
a disposizione un literary lab?). Ma andiamo con ordine. Se il tentativo di avvicinare, almeno
metodologicamente, lo studio della letteratura a quello propriamente scientifico non è nuovo (nuovi
sono il modo e gli strumenti utilizzati da Moretti) esso corre anche un rischio consueto: perdere di
vista il singolare e considerare tutti i testi, indipendentemente dal loro valore, solo come sintomi di
un qualcosa d’altro (società, politica, classe).
Mi spiego meglio, contrapponendo quelli che a mio parere sono oggi i due metodi critici più nuovi e
fecondi (e tra loro i più differenti): il distant reading di Moretti, appunto, e la ‘critica della vita’ ‒ la
definizione è di Massimo Onofri ‒ recentemente proposta e studiata in un convegno all’Università
di Sassari. La differenza è evidente: se il distant reading vuole riscrivere la storia della letteratura
come “sociologia delle forme simboliche” (Moretti in Segni e stili del moderno), la critica della vita
vuole riscriversi come letteratura (Berardinelli) e per questo il suo punto di vista è sempre
particolare e situato, e adotta le forme retoriche e i metodi che di volta in volta ritiene più
appropriati, dall’autobiografia alla satira alla critica filosofica; se il distant reading parla di
significatività storica e di costanti stilistiche, la critica della vita non può prescindere dal giudizio di
valore su ogni singolo testo. E infine: se il distant reading si rivolge soprattutto agli studiosi ‒ e
spesso agli studiosi di altre discipline ‒, la critica della vita considera sempre suo compito mediare
tra il testo e il lettore comune. Anzi, come ha affermato Berardinelli al convegno di Sassari, nel
critico della vita si percepisce il punto di contatto tra lo studioso e il lettore comune.
A costo di apparire salomonico, vorrei dire che questi due approcci sono in contrapposizione come
le due facce di una moneta, e quindi entrambi necessari. Scegliere l’uno o l’altro dipenderà più da
una predisposizione personale che da una scelta di principio; più difficile sarebbe invece
immaginare un’alternanza dello stesso studioso tra i due poli (quell’alternanza che invece è
utilissima al lettore). Entrambi i metodi possono avere delle derive pericolose: se l’idea di una
scienza della letteratura può degenerare e, di fatto, negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso
con gli epigoni dello strutturalismo, è degenerata in un concettismo che esclude il pubblico dei non
specialisti, anche la critica della vita corre il rischio di diventare critica impressionistica. Vale a
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
dire: una critica che si nasconde dietro affermazioni di gusto non sufficientemente motivate. Non è
certo il caso né di Moretti, la cui analisi è sempre coinvolgente e variata, né dei maestri della critica
della vita come, per fare solo qualche nome, Onofri, Berardinelli, Nigro e Ficara.
Questo breve elenco mi conferma in una mia idée fixe: la critica sono i critici e, al di là dei metodi e
delle scuole, a contare sono soprattutto le intuizioni personali e i particolari modi in cui ogni
metodo è declinato di volta in volta. Ha certo ragione Berardinelli quando scrive che la critica
letteraria è “oggi più che mai un’attività da inventare”; sempre, naturalmente, che si abbia “la forza
e la voglia di farlo”. Moretti è convinto che lo studioso della letteratura possa e debba imparare dal
rigore dello scienziato e che il dialogo tra la letteratura e le scienze dure debba sempre rimanere
aperto. Non potrei essere più d’accordo. Ma sono anche convinto che non si debba mai dimenticare
che il dialogo della letteratura ‒ e quindi anche della critica ‒ è sempre anche con un lettore che,
come ha scritto Onofri, “ha a cuore la sua esistenza”; un lettore che nel testo cerca “un
crittogramma del suo destino”, ed è proprio questo destino che la critica della vita indaga e mette in
luce. Di fronte alla progressiva marginalizzazione del discorso letterario nella società
contemporanea abbiamo bisogno di tutte le bocche da fuoco disponibili.
Opere citate e di riferimento:
Berardinelli, Alfonso. La forma del saggio. Marsilio, Venezia, 2008.
Moretti, Franco. The Bourgeois. Between History and Literature. Verso, New York, 2013
Moretti, Franco. Segni e stili del moderno. Einuadi, Torino, 1987.
Onofri, Massimo. La ragione in contumacia. La critica militante ai tempi del fondamentalismo.
Donzelli, Roma, 2007.
Palumbo Mosca, Raffaello. L’invenzione del vero. Romanzi ibridi e discorso etico nell’Italia
contemporanea. Gaffi, Roma, 2014.
Il convegno La critica come critica della vita. Alle radici antropologiche e filosofiche della critica
letteraria si è tenuto nei giorni 12 e 13 febbraio 201 presso l’Università di Sassari. È prevista la
pubblicazione degli atti. Il programma è visibile sul sito dell’università a questo indirizzo:
http://www.uniss.it/php/proiettoreTesti.php?cat=204&xml=/xml/bacheca/bacheca15235.xml
Raffaello Palumbo Mosca è ricercatore di letteratura italiana presso la University of Kent in
Inghilterra e si occupa prevalentemente del romanzo europeo contemporaneo e dei rapporti tra
romanzo, etica e politica. Ha pubblicato saggi e articoli in riviste italiane ed estere (“Lettere
italiane”, “Studi Novecenteschi”, “Nuovi Argomenti”, “Raison Publique”, “Modern Language
Notes” etc.). Con L’invenzione del vero. Romanzi ibridi e discorso etico nell’Italia contemporanea
(Gaffi, Roma, 2014) ha vinto il premio Tarquinia-Cardarelli per l’opera prima di critica letteraria.
Dirige con Lorenzo Chiesa la Genoa School of Humanities (www.gsh-education.com). Collabora
con “L’Indice dei libri del mese”, con il progetto Books in Italy (www.booksinitaly.it) e con la casa
editrice Zanichelli.
www.raffaellopalumbomosca.com - [email protected]
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
Heidegger: l’olocausto come atto di autoannientamento
ebraico
di RICHARD WOLIN *
In questo articolo pubblicato qualche settimana fa su “The Chronicle of Higher Education”,
ampliato e rivisto per la presente traduzione italiana, Richard Wolin prosegue la sua riflessione sul
valore e il significato dei "Quaderni neri" di Heidegger; riflessione di cui il lettore può già
osservare il precipitato nel suo saggio tradotto nell'ultimo Almanacco di Filosofia di “MicroMega”
e che diventa tanto più importante alla luce della recentissima pubblicazione dei "Quaderni Neri"
relativi agli anni 1942-1948. Ringraziamo l'autore per aver concesso al “Rasoio di Occam” la
possibilità di tradurre il testo.
La scorsa primavera, l’editore francofortese Vittorio Klostermann ha pubblicato i primi tre volumi
(dei nove previsti) dei Quaderni Neri di Martin Heidegger: un diario filosofico che il saggio di
Friburgo tenne coscenziosamente, a partire dai primi anni Trenta per quattro decenni. Per molti
versi, i Quaderni offrono un accesso diretto ai pensieri filosofici e alle convinzioni più profonde di
Heidegger. Allora la loro pubblicazione ha scatenato un’importante controversia internazionale, in
quanto è emersa la piena portata del fanatismo nazionalsocialista di Heidegger. Fra le altre
rivelazioni, i Quaderni Neri hanno tradito l’identificazione senza soluzione di continuità con
l’ideologia dell’antisemitismo eliminazionista, che del Terzo Reich costituì il principio e la fine.
Quindi Heidegger aderiva, senza riserve, all’idea di un complotto ebraico mondiale, ritenendo il
“giudaismo mondiale” responsabile della degradazione tecnologica della totalità dell’Essere (Sein).
Come osserva in un testo correlato: “sarebbe importante interrogarsi sulle basi della particolare
predisposizione della comunità giudaica alla criminalità planetaria”.
Il quarto volume dei Quaderni Neri (Riflessioni I-IV), comprendente gli anni 1942-48, apparirà a
breve [è già apparso, n.d.r.]. Le anteprime dimostrano che, dopo la guerra, non solo l’antisemitismo
di Heidegger persisteva ininterrotto; esso giungeva ad altezze qualitativamente nuove. Pertanto
l’ultima parte mostra come il pensiero di Heidegger si adattasse all’ideologia della negazione
dell’olocausto. La sua affermazione forse più inquietante al riguardo è che lo sterminio degli ebrei
europei vada compreso come atto di “autoannientamento” ebraico (Selbstvernichtung). In particolar
modo, offensive come possono essere, tali affermazioni sono del tutto coerenti con la struttura
teorica della “critica della tecnica” che Heidegger aveva sviluppato nel corso degli anni Trenta.
Perciò il danno di affermazioni del genere alla credibilità di Heidegger come pensatore è
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
sistematico piuttosto che fortuito. Compromette il nucleo autentico della sua filosofia successiva,
incentrato sull’eterea dottrina della “storia dell’Essere”.
Come fu quindi possibile, per un uomo che alcuni considerano il più grande filosofo del ventesimo
secolo, giungere a un tale ripugnante verdetto, ritenendo in sostanza gli ebrei responsabili per la
loro morte in massa? Per rispondere a questa domanda, si deve sospendere temporaneamente
l’incredulità e pensare come un heideggeriano.
Nel corso degli anni Trenta, Heidegger aveva individuato nel “giudaismo mondiale” il vettore
fondamentale della modernità occidentale – una formazione culturale che, sulla scorta di Oswald
Spengler, egli considerava come un continuum di irreversibile declino (Untergang). Il termine
impiegato per descrivere questo processo di catastrofico declino culturale era “macchinazione”; e, a
un certo punto nel suo ragionamento, “giudaismo mondiale” e “macchinazione” diventarono
sinonimi. Già nei primi volumi, questo modo di procedere aveva conseguenze che possono essere
descritte solo come perverse e contorte. Per esempio, Heidegger asseriva che, nella misura in cui la
“macchinazione” minacciava di impedire alla Germania nazista di realizzare il suo massimo
potenziale storico, e poiché gli ebrei erano i suoi esponenti fondamentali, il nazismo stesso si era in
parte arreso alla “giudaizzazione” (Verjudung).
Tali argomenti costituiscono antisemitismo allo stato puro. L’incriminazione del “giudaismo
mondiale” da parte di Heidegger non aveva nulla a che vedere con la realtà dei costumi o condotte
di vita ebraiche. Piuttosto, si basava sull’attribuzione agli ebrei – che, durante gli anni Trenta, nel
periodo precedente all’olocausto, furono perseguitati e oppressi come mai prima – di una capacità
fantasmagorica di influenzare la politica mondiale da dietro le quinte. Attribuendo al “nemico
ebraico” poteri e abilità soprannaturali, Heidegger forniva al contempo una giustificazione per
combattere l’influenza ebraica con ogni mezzo necessario – sterminio compreso. Ovvero, come
Heidegger osserva nel 1942: “Il genere più alto e l’atto più alto della politica consiste nel porre il
proprio oppositore in una situazione in cui è costretto a prendere parte al suo stesso
autoannientamento”[1].
Secondo Heidegger, l’olocausto era un atto di “autoannientamento” ebraico nella misura in cui, ad
Auschwitz e negli altri campi di morte, gli ebrei stessi – come principali promotori della
“macchinazione” quale devastazione tecnologica di tutto l’Essere –avevano ceduto alle forze
dell’omicidio di massa industrializzato. In questo modo, gli ebrei d’Europa avevano semplicemente
aderito alle forze ed energie tecnologiche che essi stessi avevano originariamente scatenato. Come
afferma Heidegger: “Quando l’essenzialmente ‘ebraico’, in senso metafisico, lotta [kämpft] contro
ciò che è ebraico [das Jüdische], viene raggiunto il culmine dell’autoannientamento nella storia”.
Nell’opinione di Heidegger, dunque, la Shoah significava un po’ più che un esempio imponente e
sanguinario di ritorsione contro se stessi. In modo più serio, per Heidegger la transizione verso un
nuovo “inizio” non può verificarsi finché lo spirito ebraico non è sconfitto.
Naturalmente, questa spiegazione estremamente falsa rappresentava al contempo il modo di
Heidegger di preservare la Germania e i tedeschi dalla responsabilità storica – oltre che dalla
colpevolezza – per aver lanciato nel 1939 (secondo l’accusa del Tribunale per i crimini di guerra di
Norimberga) una “guerra imperiale di aggressione”. Seguendo la guerra, per tutta la Germania
occupata, gli Alleati avevano affisso dei cartelli in campi di concentramento e luoghi dell’orrore che
affermavano: “Sie sind schuldig daran!” (“L’avete fatto voi!”). La teoria della “storia dell’Essere”
(Seinsgeschichte) di Heidegger offriva un potente contrappeso intellettuale: una comoda
razionalizzazione per la non responsabilità tedesca. Come dice nella “Lettera sull’umanismo” del
1947 (il testo canonico di Heidegger del periodo del dopoguerra): “Se e come esso [l’ente] appaia,
se e come Dio e gli dèi, la storia e la natura entrino nella radura dell’Essere, si presentino e si
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
assentino, non è l’uomo a deciderlo. L’avvento dell’ente riposa nel destino dell’essere”[2].
Quest’affermazione rappresenta una deliberata accettazione del fatalismo storico e dell’eteronomia
umana: un’acquiescenza passiva di fronte ai “decreti” (Schickungen) imperscrutabili di poteri più
alti senza nome. Dando la colpa della catastrofe europea a pompose astrazioni quali la “tecnica
planetaria” o il “destino dell’essere”, Heidegger cercava di scaricare la responsabilità per uno dei
più eclatanti esempi storici di omicidio premeditato di massa.
A questo punto, vale la pena ricordare che uno degli interventi più influenti del dopoguerra
sull’argomento della responsabilità tedesca fu il saggio pionieristico di Karl Jaspers del 1946, La
questione della colpa (Die Schuldfrage). In questo pamphlet ampiamente dibattuto, Jaspers
sosteneva che solo assumendosi attivamente la responsabilità per le atrocità e i misfatti del Terzo
Reich i tedeschi come popolo potevano avviare il necessario processo di rigenerazione morale.
(Sotto i nazisti, Jaspers era stato espulso dall’insegnamento a partire dalla metà degli anni Trenta
per via della moglie ebrea. Nelle ultime fasi della guerra, la coppia visse nella costante paura di
essere deportata). Nel corso degli anni Venti, Jaspers e Heidegger erano stati intellettualmente
vicini, pensando a se stessi come pionieri nello sviluppo dell’esistenzialismo come alternativa al
compassato razionalismo neokantiano. Perciò la sprezzante caratterizzazione da parte di Heidegger
della Shoah come esempio di “autoannientamento” ebraico voleva essere anche una replica
ideologica agli appelli diretti, etici di Jaspers al pentimento nazionale. Come uomo e come filosofo,
Heidegger possedeva molti talenti. Basti questo per dire che integrità intellettuale e rettitudine
morale non erano tra quelli.
Una caratteristica parimenti inquietante dei Commenti I-V è che, nonostante la devastazione
ampiamente diffusa della guerra, Heidegger insiste nel dire che i tedeschi, e loro soltanto, hanno la
capacità di redimere l’Occidente dalla sua condizione di incontrollata degenerazione nichilistica.
Heidegger porta questo ragionamento un ripugnante passo più in là, sostenendo che la sconfitta
degli alleati della Germania era un crimine di gran lunga superiore allo sterminio degli ebrei
europei. Cerca di capovolgere la situazione a danno dei conquistatori della Germania. Essi sono,
nell’opinione di Heidegger, “più colpevoli” dei tedeschi. Li accusa di “colpa collettiva” e di aver
trasformato la Germania occupata in un “KZ” (campo di concentramento)[3]. A questo punto, si
può solo indietreggiare con stupore di fronte alla sua sbalorditiva miopia di giudizio.
Evidentemente, se vi fu una nazione responsabile per la frenesia distruttiva senza precedenti della
Seconda guerra mondiale, è stata la Germania. Per tanti aspetti, l’ottuso germanocentrismo di
Heidegger – che egli indossava come un distintivo d’onore – contribuiva decisamente alla sua
rovina.
Una lettura dei Commenti I-V rivela quanto poco Heidegger avesse imparato dalla guerra.
Diversamente da Jaspers, egli ha fallito nell’utilizzare il Götzendämmerung del dominio nazista
come un’esperienza di apprendimento o come una spinta verso il miglioramento morale. Piuttosto,
Heidegger ha continuamente cercato rifugio in logore razionalizzazioni ed esercizi di autoinganno.
Liquidava altezzosamente critici e dubbiosi affermando, “non possono attaccare la filosofia quindi
attaccano il filosofo”. Ma questo atteggiamento tradisce soltanto la sua straordinaria mancanza di
conoscenza di sé.
In Germania, le conseguenze di queste ultime rivelazioni sulle indifendibili posizioni ideologiche di
Heidegger si sono già ampiamente diffuse. A gennaio, il presidente dell’International Heidegger
Society, Günter Figal, si è dimesso sostenendo che non poteva più rappresentare in buona fede la
filosofia di Heidegger in una veste ufficiale. Il mese scorso, il curatore dei Quaderni Neri, Peter
Trawny, ha rilasciato un’intervista esplicita al magazine tedesco di filosofia, Hohe Luft, in cui ha
criticato i suoi soci heideggeriani per la loro servile disonestà: cioè per essersi comportati per
decenni come vigliacchi apologeti di tutte le cose heideggeriane. Poco dopo, l’Università di
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
Friburgo ha annunciato le sue intenzioni di chiudere il cosiddetto “Heidegger Lehrstuhl” in
fenomenologia, che è attualmente occupato da Figal, e di sostituirlo con una posizione meno
controversa in filosofia analitica. Ma benché questo cambiamento possa avere un “senso
amministrativo” dal punto di vista dei funzionari universitari, intenzionati a sbarazzarsi della cattiva
pubblicità, da una prospettiva intellettuale è limitato e controproducente. In primo luogo, il
Lehrstuhl in questione è stato precedentemente occupato dal mentore e predecessore di Heidegger,
il fenomenologo Edmund Husserl, che era, per di più, ebreo. Perciò, una soluzione più giusta e
imparziale sarebbe quella di ribattezzare la posizione “cattedra di Husserl” e in tal modo continuare
a onorare la ricca eredità filosofica della fenomenologia.
Il più recente atto di malafede da parte dei difensori di Heidegger è stato di affermare che elementi
antiebraici sono presenti anche nell’opera di pensatori tedeschi precedenti, quali Kant e Hegel,
insinuando così che sarebbe ingiusto prendere di mira Heidegger per aver nutrito convinzioni
antisemite, le quali, nella storia della filosofia, erano ampiamente diffuse. Ad ogni modo, asserzioni
del genere sono fallaci e fuorvianti per molti aspetti cruciali.
Perché in primo luogo (e solo per affermare quel che è ovvio): segnalare che commenti antisemiti
possono essere trovati nell’opera di pensatori tedeschi precedenti (qui si può anche menzionare il
saggio di Marx del 1843, “Sulla questione ebraica”) non torna in alcun modo a credito di
Heidegger. Ma in modo più significativo, sono il contenuto e il tenore di simili esempi di
antisemitismo che, soprattutto, meritano la nostra attenzione. Le tracce di antisemitismo (un termine
che fu coniato per la prima volta negli anni Settanta dell’Ottocento) che si trovano nelle opere di
Kant e Hegel sono di quel genere che si può chiamare episodico o occasionale. Per tale ragione, non
influiscono in modo sfavorevole sulla nostra considerazione finale del valore della loro filosofia.
Al contrario, nel caso di Heidegger la questione è ben diversa. I Quaderni Neri rendono
inequivocabile che l’antisemitismo occupa un ruolo sistematico nell’ultimo pensiero di Heidegger.
Inoltre, per tornare momentaneamente agli idealisti tedeschi predecessori di Heidegger, Kant e
Hegel: gli esempi di antisemitismo che si trovano nelle loro opere sono, per lo più, della variante
tradizionale, religiosa. Possono condurre a discriminazione e persecuzione, ma non erano, di regola,
di carattere annientatore. Al contrario: obiettivo primario della cristianità era di convertire gli ebrei
piuttosto che distruggerli in massa. Infine, le filosofie di Kant e Hegel si basavano sull’idea di
“autonomia della ragione”. Come tale, in contrasto con la filosofia di Heidegger, il loro pensiero si
dimostrava inconciliabile con l’ideologia dell’“antisemitismo redentore” fatta propria dai nazisti.
Com’è noto, il filosofo politico tedesco, Carl Schmitt, ha riconosciuto questa fondamentale
incongruenza osservando che, il 30 gennaio 1933 (la data della presa del potere nazista), “Hegel è
morto”.
L’antisemitismo che si trova nei Quaderni neri è di un genere e una portata qualitativamente
differenti. Come a questo punto dovrebbe essere chiaro, Heidegger si identifica senza difficoltà con
l’“antisemitismo eliminazionista” che è diventato il pilastro centrale del nazionalismo culturale
tedesco negli ultimi decenni del diciannovesimo secolo. Così già nella frase conclusiva del suo
famoso saggio “Das Judentum in der Musik” (18 1), Wagner gioca con l’idea di Untergang
(distruzione, perire) come “soluzione” desiderabile alla questione ebraica. Dal momento che
Heidegger crede che le tendenze disgregatrici della modernità siano guidate dalla propensione
ebraica al “calcolo” e alla “computazione”, come i Quaderni Neri affermano più volte, solo una
Endlösung o Soluzione Finale della Questione Ebraica le risolverà.
In Germania, dopo la guerra, la riammissione nella famiglia delle nazioni è dipesa da un sincero
riconoscimento delle violazioni e malefatte storiche precedenti. Ora è tempo per gli heideggeriani
che si trovano altrove di seguire la guida tedesca assumendo una posizione di critica esplicita e
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
spietata. Solo così possono ripristinare la loro reputazione seriamente compromessa come
intellettuali e studiosi.
* History and Political Science, The Graduate Center della City University of New York
(traduzione di Denise Celentano)
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
L’Essere in guerra con l’ente. Heidegger, la questione dei
“Quaderni neri” e la cosiddetta “Italian Theory”
di ROBERTA DE MONTICELLI
Perché la maggior parte della intelligentsia italiana di sinistra continua a considerare Heidegger
come il principale crocevia per comprendere la modernità? La compromissione di Heidegger con il
nazismo non affonda le radici nel suo pensiero filosofico? Perché il profondo antiliberalismo del
pensiero heideggeriano continua ad affascinare i maggiori rappresentanti di ciò che è stato
chiamato “Italian Theory”? La pubblicazione dei "Quaderni neri" e le più recenti ricerche a
riguardo aiutano a rispondere a questi quesiti.
La pubblicazione, ancora in corso, dei Quaderni neri continua ad alimentare in tutta Europa un
dibattito forse non solo mediatico sulla questione del nesso fra il pensiero di Heidegger e la sua
adesione, mai revocata né da lui commentata, al nazismo. Una questione che sopravvive ai fiumi di
inchiostro versati, per una ragione molto semplice: non è soltanto Heidegger in questione, né
soltanto la sua eredità, con cinquant’anni di dominio quasi incontrastato nell’accademia e perfino
nell’insegnamento scolastico della filosofia nell’Europa continentale, soprattutto neolatina.
In questione è la natura stessa della filosofia, se possiamo assumerne a paradigma Socrate e
contemporaneamente chiamare “filosofia” la più esplicita negazione dello spirito socratico, fino
all’ultima conseguenza, che è l’indifferenza alle distinzioni (fra il vero e il falso, il nobile e
l’ignobile, la vittima e il carnefice). Un’indifferenza in cui molti, specie fra i più giovani, vedono
invece una “filosofica” impassibilità. Abituati come sono dai loro maestri a chiamare “moralismo”
le distinzioni morali, e “violenza” quelle logiche.
Questa riflessione prende le mosse dal recente libro – esso stesso al centro di molte polemiche – di
Donatella Di Cesare[1], e può considerarsi un commento carico di interrogativi alla frase che ne
condensa la tesi centrale e il senso ultimo:
“Il pensiero più elevato si è prestato all’orrore più abissale” (2014, 3)
Questa riflessione si articola in tre punti. Il primo e il secondo si riferiscono rispettivamente
all’accezione più ristretta de “il pensiero più elevato” (che sarebbe quello Heidegger) e a quella più
lata (la tradizione filosofica occidentale), sollevando rispettivamente la questione I) di questa
“elevatezza” e II) della legittimità di una chiamata di correo della tradizione filosofica (antica e)
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
moderna. Il terzo, la pars construens, fornisce un criterio di distinzione della filosofia dalla sofistica
e argomenta che Heidegger è – dal punto di vista della filosofia – peggio che un nazista o un
antisemita: è un sofista.
I. Nazismo e antisemitismo. I tre moduli dello heideggerese
In un suo articolo del 1988[2] Jeanne Hersch, la cui analisi del nazismo di Heidegger in quanto
radicato nel suo pensiero è ancora la più limpida e articolata che io conosca, aveva relativizzato
l’antisemitismo di Heidegger.
La sua tesi è infatti che l’antisemitismo non sarebbe di per sé ragione sufficiente di adesione al
nazismo, in quanto: 1) il nazismo non si riduce all’antisemitismo 2) ci sono nel pensiero di H.
ragioni ancora più consistenti di adesione al nazismo.
Su entrambi i punti 1) e 2) si può continuare a concordare con Hersch – e vedremo quali sono le
ragioni più consistenti, radicate nel pensiero di Heidegger; ricordiamo che circa quarant’anni fa
Hersch aveva definito il pensiero di Heidegger “dittatoriale” (come Löwith) e “irresponsabile”.
Ma Hersch ha un secondo punto: e cioè che sull’antisemitismo di Heidegger si può anche dar
ragione alla pletora dei suoi difensori, che pretendevano Heidegger non fosse personalmente
antisemita. E’ vero che Hersch ricorda che
“Heidegger non è stato antisemita come non lo sono molti non-ebrei di stampo corrente che tuttavia
non sono neppure anti-antisemiti. Heidegger non è stato abbastanza anti-antisemita perché
l’antisemitismo del nazional-socialismo costituisse un ostacolo sufficiente alla sua adesione; e non
lo è stato neppure abbastanza da impedirgli – quando le persecuzioni erano in corso - di affibbiare il
termine “ebreo” a questo o quel collega, al quale voleva nuocere” (2004, 2)
Fu anche un miserabile delatore, Heidegger, e si sa quale era il rischio cui mise alcune vite, a parte
il famoso tradimento di Husserl. A questo proposito ci sarebbero da ricordare parecchi nomi:
Baumgarten, Hönigswald, Marck, Heinemann[3]…..
Ma sul secondo punto Donatella Di Cesare e i Quaderni neri hanno definitivamente dimostrato che
Jeanne Hersch era stata eccessivamente indulgente. Altro che non anti-antisemitismo!
Partiamo quindi dalla questione dell’antisemitismo. Donatella Di Cesare ha dimostrato due cose:
1) Che certamente un anti-semitismo, non biologico-razziale ma “metafisico”, è essenziale al
pensiero heideggeriano;
2) Che questo anti-semitismo metafisico è inscindibile dalla lettura heideggeriana della
modernità (gli ebrei sono infatti “gli agenti della modernità”).
Nel seguito di questa sezione estrarrò da alcune citazioni dai Quaderni neri tre moduli di linguaggio
heideggeriano, che riassumono il suo pensiero (o per lo meno la sua parte più nota e divulgata nei
cinquant’anni successivi al ’4 ).
Primo modulo: lo sradicamento
Ecco uno dei passaggi dei Quaderni neri che Donatella Di Cesare ha reso più famosi:
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
“La questione riguardante il ruolo dell’ebraismo mondiale [Weltjudentum] non è una questione
razziale [rassisch], bensì la questione metafisica [metaphysisch] su quella specie di umanità che,
essendo per eccellenza svincolata, potrà fare dello sradicamento di ogni ente dall’essere il proprio
“compito” nella storia del mondo»[4].
Il primo modulo dunque è “lo sradicamento di ogni ente dall’essere”.
Ora, Heidegger ha ragione: prendiamo un bel caso di ebreo sradicatore, Edmund Husserl. E’ una
pagina da Tipi ideali di cultura, (1923), tr. it. L’idea d’Europa)[5].
Il contesto è quello di una riflessione sull’universalità dei giudizi ben fondati – anche quelli di
semplice esperienza – che costituiscono acquisizioni per tutti:
“I giudizi motivati sulla base delle cose hanno validità oggettiva, ossia intersoggettiva, nel senso
che quello che vedo io può vederlo chiunque; al di là di tutte le differenze fra individui, nazioni,
tradizioni, quali che siano, in vigore e profondamente radicate, stanno le comunanze, che sono il
titolo di un mondo comune di cose, che è costituito da esperienze interscambiabili, così che tutti
possono intendersi con tutti, possono ricorrere alle stesse cose vedute. E dapprima riferito a queste e
poi proseguendo oltre si schiude un regno di verità, che ognuno può portare alla propria vista, che
ognuno vedendolo può realizzare in sé, da qualsiasi cerchia culturale provenga, amico o nemico,
greco o barbaro, figlio del popolo di Dio o Dio dei popoli nemici”[6].
Ecco qui all’opera l’ebreo errante che sradica.
Traduciamo ora queste piane parole husserliane in heideggerese – la stessa Donatella Di Cesare ci
aiuta egregiamente a farlo.
Questa pagina è indubbiamente una descrizione e un elogio dell’evidenza, della “oggettualità” di
ciò che è dato e universalmente accessibile.
Ecco qui, colto in flagrante, il peccato di oblio dell’Essere, l’elogio dell’evidenza, “il predominio
dell’ente che sbarra l’accesso all’essere, ridotto a “semplice presenza”, “sprecato in una quantità di
concetti privi di radici”[7].
2. Secondo modulo: l’oblio dell’Essere
La riduzione dell’Essere all’ente, ovvero l’oblio dell’Essere, questo è il secondo modulo
heideggerese.
Qui però c’è un’altra cosa che non deve sfuggire. Husserl insiste sullo sradicamento, non solo e non
tanto in relazione all’evidenza universale dei giudizi di fatto, ma anche e soprattutto in relazione
alla ricerca di evidenza per i giudizi di valore: perché accade che, continua,
“le motivazioni provenienti dall’esperienza e in generale dall’evidenza della cosa si mescolano con
motivazioni di minor valore, con quelle che sono così profondamente radicate nella personalità che
già il loro metterle in dubbio minaccia di “sradicare” la personalità stessa, la quale ritiene di non
poter rinunciare a loro senza rinunciare a se stessa – cosa che può portare a violente reazioni
d’animo”[8].
Il bello è che Husserl sta parlando di qualunque tipo di ricerca cognitiva, compresa quella morale,
giuridica, politica: sta semplicemente variando sul tema del “sapere aude”- con una nuova e
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
sofferta consapevolezza di quanto sia difficile il passaggio alla maggiore età: dalle care certezze
della comunità d’appartenenza all’autonomia del pensiero adulto, quando uno scopre il “minor
valore” delle motivazioni cui aderiva con tutto il cuore, ma che non sono giuste.
Ecco come Husserl ribadisce il concetto dello sradicamento:
“Il pensiero non è giusto perché io o noi, per come siamo, non possiamo non pensare in questo
modo; semmai, solo se un pensiero è giusto, è giusto anche il nostro pensare, e noi stessi siamo
giusti”[9].
Insiste, dunque, spietato:
“E non importa che piaccia o meno a me o ai miei compagni, che ci colpisca tutti “alla radice”: la
radice non serve”[10].
Terzo modulo: la macchinazione
Ora che sappiamo in cosa consiste la “malessenza” dello “sradicamento” (anzi del giudeo errante e
sradicante) possiamo ritrovare dentro un altro grumo di fango nero il terzo moduletto di questo
linguaggio: la macchinazione. Ecco:
“Il mio “attacco” a Husserl è diretto non solo contro di lui, il che lo renderebbe inessenziale –
l’attacco è diretto contro l’omissione della questione dell’Essere, cioè contro l’essenza della
metafisica come tale, sulla cui base la macchinazione dell’ente riesce a determinare la storia”[11].
“La Machenschft, il Wesen, l’essenza della metafisica”, ci ricorda Donatella Di Cesare:
“la macchinazione che tenta di occultare il corso della storia imponendo il predominio dell’ente e
occultando l’Essere”[12].
Questo è veramente, di tutti i moduletti, il più passepartout che ci sia, anche perché dà espressione a
una nostra pulsione profonda, sempre latente anche quando evita l’esplosione paranoica: c’è una
potenza “macchinatrice” che ha colpa di tutto, e più genericamente è descritta, più tranquilli siamo
noi, amici dell’Essere, filosofi che contemplano l’Essenza del Nichilismo, il Destino dell’Occidente
o della Necessità, la Tecnica, il Capitalismo o la Finanza, tutti i volti della Metafisica, insomma, e
qualcuno ce ne sarà sfuggito. Il Neoliberismo, forse.
Quella volta, però, il pastore dell’Essere non rimase tranquillo, e andò all’appuntamento col Destino
dell’Occidente (o meglio, specificamente, con “l’intima grandezza del Nazionalsocialismo”, pronto
all’“incontro tra la tecnica planetaria e l’uomo moderno”[13]), a braccetto di Hitler, contro il
Nemico che è “la malessenza dell’ente”.
Come ci spiega la nostra guida:
“La guerra mondiale viene letta attraverso la differenza ontologica e si rivela, perciò, la guerra
dell’Essere contro l’ente”[14].
Cosa possiamo ricavare da questo delirio? Non c’è dubbio: i tre moduli ricombinati insieme danno
l’essenziale del “pensiero” di Heidegger. O per lo meno, questa è la nostra tesi. Come scrive un
altro studioso:
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
“Ma in verità tutti i tratti fondamentali ascritti al giudaismo si attagliano perfettamente al processo
di oblio dell’essere, così come tratteggiato da Heidegger in celebri analisi. Lo sradicamento, la
mancanza di fondamento e l’atteggiamento strumentale nei confronti di ogni cosa sono tratti
essenziali dell’oblio dell’essere a favore dell’ente, ovvero della riduzione di tutto ciò che è a mero
oggetto scientifico o cosa disponibile”[15].
Questa analisi mostra quali sono i riferimenti intuitivi di questo linguaggio, che da allora infiniti
epigoni ripetono, con i tre moduli: lo sradicamento dall’Essere, l’oggettivazione (la metafisica e la
sua storia!) con relativa disponibilità di ogni cosa ottenuta attraverso la scienza-tecnica, la
macchinazione in cui la modernità si dispiega (per mano del capitalismo giudaico internazionale, i
banchieri etc.).
Alla nostra tesi segue una prima domanda per Donatella Di Cesare, ricordando la frase citata: “Il
pensiero più elevato si è prestato all’orrore più abissale”.
Ma che cosa ci sarà di “elevato”?
Perché: come si può considerare “elevata” l’idiozia etno-metafisica dell’ebraismo sradicatore?
Come risulta bene dal passaggio di Husserl, Heidegger imputa a questo “sradicatore” quella che è
per Husserl la gloria di Socrate: la vita esaminata, il vaglio critico delle tradizioni e culture
d’appartenenza.
Ma non sembra molto più elevata l’idea di incolpare l’Ebreo Metafisico di essere l’agente della
modernità, che è il bersaglio di tutt’e tre i moduletti: e modernità – in filosofia - vuol dire
l’Illuminismo, il principio kantiano di autonomia morale della persona, l’universalismo morale, il
cosmopolitismo politico, la scienza e la democrazia.
Qui viene opportuna la pagina di Hersch che riassume l’altra lettura del nazismo di Heidegger. Una
lettura che distingue, anzi fortemente separa, la “modernità” e il “destino dell’Occidente”, la ragion
pratica e Auschwitz, l’Illuminismo e il nazismo. Con buona pace di Adorno-Horkheimer, e della
loro oscura Dialettica del’Illuminismo.
Nel cuore del pensiero di H., scrive J. Hersch, troviamo
“Un disprezzo ardente, appassionato, ossessivo, per tutto ciò che è comune, medio e generalmente
ammesso; per il senso comune, per la razionalità, per le istituzioni, per le regole, per il diritto, per
tutto quello che gli uomini hanno inventato, nello spazio in cui devono convivere, al fine di
confrontare i loro pensieri e le loro volontà, di dominare la loro natura selvaggia, di attenuare il
regno della forza. Assoluto disprezzo dunque, per la civiltà occidentale, cristallizzata in tre
direzioni: la democrazia, la scienza, la tecnica; - per tutto ciò che, generato dallo spirito
dell’Illuminismo, fa assegnamento su ciò che può esserci di universale nel senso di Cartesio, in tutti
gli esseri umani. Tutto questo è vuoto. La democrazia è vuota”. (Hersch 2004, 3)
II. Antisemitismo e filosofia. La chiamata di correo della “metafisica”
“Il pensiero più elevato si è prestato all’orrore più abissale”.
La portata della tesi di Donatella Di Cesare vuol essere enormemente più vasta. E’ tutta la
tradizione filosofica “occidentale”, è appunto ciò che Heidegger chiama “la metafisica”, che deve
venir coinvolta insieme con Heidegger in una riflessione sulla Shoah.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
“Perché la Shoah non è solo una questione storica, ma è una questione filosofica che coinvolge
direttamente la filosofia. Le responsabilità di una lunga tradizione di pensiero devono essere ancora
accertate e discusse”[16].
Immediate sono le questioni che si pongono:
1. Su quale base possiamo dire che questa “lunga tradizione di pensiero” è in qualche senso
connessa al nazismo? Non era Heidegger, il nazista, e non era Husserl, l’ebreo sradicatore, culmine
del pensiero della metafisica? Questi due non erano in guerra?
2. Una risposta è: possiamo dirlo appunto perché Husserl e la metafisica sono la modernità, cioè
perché leggiamo la filosofia pre-heideggeriana con gli occhi di Heidegger.
3. Ma qui c’è un buco: perché per Heidegger metafisica implica Oblio dell’Essere, Ente,
modernità; ma Hitler non era l’Essere in guerra con l’Ente, contro la modernità?
Quindi occorre un altro passaggio per riempire il gap: e cioè
4. Modernità, Illuminismo, Ragione, significano Scienza, Tecnica, Industria. E “dunque”
conducono all’industria della morte, alla scienza dello sterminio, alla tecnica dell’erogazione di gas.
Per l’ultimo passo (di stringente consequenzialità logica, come si può vedere) dobbiamo in effetti
saltare dallo Heidegger di prima a quello di dopo la sconfitta nazista. Che non rinnega il nazismo,
ma adesso dice che è colpa della modernità, dell’industria, della tecnica! Che era il nazismo, il
destino della modernità!
Nel ’4 infatti Heidegger, che aveva pur cantato le lodi dell’attacco motorizzato alla Francia, cioè
dello slancio metafisico della nuova umanità capace di coltivare la propria razza con la tecnica,
improvvisamente paragona l’agricoltura meccanizzata industriale con la fabbricazione di cadaveri
nei campi di concentramento[17].
Di Cesare quasi-cita Heidegger:
“Ma lo sterminio è stato senza precedenti anche perché non era mai avvenuto che si uccidesse in
una catena di montaggio. Il processo di industrializzazione della morte, che assunse la precisione
quasi rituale della tecnica, trovò nell’uso del gas un cambiamento di qualità”[18].
Ma qual è il senso di questo ultimo punto – l’equazione di Illuminismo/nazismo o Modernità
/sterminio? Esattamente quello enucleato dalla tesi più scioccante di Heidegger: gli ebrei – gli
agenti della Modernità si sono auto-annientati!
“Selbstvernichtung, autoannientamento, è la parola chiave: gli ebrei si sarebbero autoannientati.
Nessuno potrebbe allora essere chiamato in causa, se non gli ebrei stessi. Già nei quaderni del 1940
e del 1941, quando viene avanzata l’esigenza di una “purificazione dell’Essere”, fa la sua
inquietante comparsa il termine ‘autoannientamento’” [19].
Ho riletto più e più volte quel passo, apparso su un grande quotidiano, nella speranza che mi fosse
sfuggito un commento non assolutorio, almeno su questo. Macché.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
“Rigoroso e coerente, Heidegger non fa che trarre la conclusione di ciò che ha detto in precedenza.
Gli ebrei sono agenti della modernità: hanno diffuso i mali…complici della Metafisica, hanno
portato ovunque l’accelerazione della tecnica. L’accusa non potrebbe essere più grave”.
Qui le cose però si fanno serie. Se avessimo un po’ di sense of humour ci verrebbe da commentare
che in tempi di patti e compromessi fra ex avversari politici, perché no: immaginare una specie di
kafkiana chiamata di correo, da parte del carnefice e calunniatore della ragione etica e di quella
logica, delle sue vittime già calunniate, è una trovata.
E invece non lo trovo umoristico, questo, ma rivoltante. La domanda per Donatella Di Cesare è
dunque: E’ antisemita e nazista o non lo è, Heidegger?
Se non lo è, non sappiamo di cosa si stia parlando.
Ma se lo è, nel senso preciso che i suoi moduli di pensiero sono inseparabili da questo
antisemitismo metafisico e da questo nazismo, come è possibile utilizzare esattamente la stessa
“logica” senza consegnarsi appunto a un pensiero capace di legittimare la più orrenda nefandezza?
Non c’è verso: se sono loro gli agenti della modernità, e se la modernità conduce ai campi di
sterminio, allora gli ebrei si sono auto-annientati.
In conclusione: come è possibile unirsi a Heidegger proprio nel gesto più osceno, che è quello di
rigettare la colpa di Hitler e propria sulle sue vittime?
Ma se di questo gesto osceno si prova orrore più ancora che del nazismo e dell’antisemitismo, c’è
forse ragione, dopo aver dimostrato l’intrinsecità del’antisemitismo e del nazismo al pensiero di
Heidegger, di chiamare “giustizialista” e “totalitario”[20] chi invece si rifiuta di equiparare Kant e
Husserl a Heidegger? Infine, resta qualche ragione per non “prendere posizione”? Tutta la vita è
prendere posizione – ma si può farlo in modo più o meno fondato. Davvero non ci sono buone
ragioni per giudicare moralmente ignobile e intellettualmente ridicola la posizione di Heidegger?
Ma soprattutto, come si fa, infine, a giudicare Heidegger
“un naufrago che attraversa la notte del mondo, rischiarata da profondi sguardi filosofici e potenti
visioni escatologiche”?[21].
Un naufrago! Non l’ignobile delatore che fu[22], non colui che mise a rischio la vita di alcuni, non
il traditore della fiducia dell’antico maestro, e neppure l’autore della vergognosa uscita (che egli
stesso ha deciso di rendere pubblica, offrendola dunque al nostro giudizio) sugli ebrei che “si sono
auto-annientati”. E i profondi sguardi filosofici quali sono? E quali le visioni escatologiche?
Dobbiamo dunque credere che è vero, gli ebrei sono il popolo eletto a svelare la loro propria
essenza che è insieme quella di homo sacer sottratto alla protezione della legge e quella di
modernità sradicante-calcolante-reificante che nel campo di concentramento svela la natura ultima
del potere, come potere della ragione sulla nuda vita? Sarebbe questo il profondo sguardo
filosofico? E’ un riassunto (sgangherato, lo riconosco) delle idee fondamentali di quella che
chiamano oggi Italian Theory)[23]. Sia come sia, certo nessuna prosopopea, o personificazione
mitica, come quella ultra-indeterminata del “Potere” che si aggira in libri molto popolari di autori
contemporanei – da Michel Foucault a Giorgio Agamben a Slavoj Žižek sembra meglio
impersonare l’idea (o – mi si perdoni – il delirio) della Machenschaft, della macchinazione
universale.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
III. Pars construens: il criterio di distinzione fra filosofia e sofistica, ovvero Heidegger sofista
prima che nazista.
La mia pars construens offre un criterio di distinzione fra filosofia e sofistica, da usarsi come
argomento contro la chiamata di correo della tradizione filosofica.
Accettiamo anzitutto le premesse più atte a screditare questa tradizione.
1. Platone con la sua ricerca di verità in materia di giustizia “fonda” una distopia totalitaria;
2. Kant ha espressioni antisemite, anche forti (non più di quelle anticattoliche, naturalmente, ma che
importa).
3. Frege nutre convinzioni razziste.
Fra i critici della distopia platonica ci sono i più profondi estimatori di Socrate – cioè della veglia
critica e della costante richiesta di evidenza e buone ragioni per le proprie asserzioni, come Karl
Popper e Isaiah Berlin.
Kant, nella sua Religione nei limiti della semplice ragione, dispone le religioni in ordine di
lontananza dall’ideale dell’autonomia morale. Inoltre, come tutto il cristianesimo paolino, oppone la
legge interiore al comando sacerdotale e alla precettistica rituale, e con Grozio oppone la legge
dello Stato a quella di Dio. Può essere giusto metterlo nel calderone delle responsabilità “della”
filosofia per la Shoah[24]? Kant, il più strenuo difensore filosofico dell’universalismo morale e di
quello cosmopolitico? Non lo crediamo, ma per quali ragioni?
Può essere giusto mettere in questo stesso calderone Gottlob Frege, morto nel 1925, di cui sappiamo
da un Nachlass mai pubblicato dall’autore in vita che nutriva opinioni razziste, e suggerire
addirittura l’esistenza di un nesso fra il suo “terzo regno” platonico dei pensieri e il Terzo
Reich[25]? Anche in questo caso, crediamo di no, ma perché?
Cominciamo dall’ultimo. Frege è il filosofo la cui teoria del significato come peso di verità delle
espressioni, cioè contributo di ogni espressione alle condizioni di verità dell’enunciato in cui
compare, getta le basi di una nuova dimensione della nostra responsabilità: quella delle parole.
Offre a Husserl (che ne fa la base delle sue Ricerche logiche) l’idea prima e centrale del socratismo
fenomenologico: la logica è l’ideale del parlare onesto, è l’etica del pensare. Per merito di Frege la
logica potrebbe e dovrebbe diventare il cuore dell’educazione umanistica: infatti ci insegna il peso
o valore semantico delle parole, il loro ruolo o contributo di verità (o falsità), e ci educa a una
responsabilità nell’uso del linguaggio, la cui mancanza finisce invece per distruggere il più
prezioso bene comune che abbiamo: la luce delle parole.
Frege è anche l’autore di una formula lapidaria – “il pensiero non ha padrone”.
E’ il pensiero di un filosofo che – come nel caso di Platone, nel caso di Kant, nel caso di Frege – ci
dà occhi per vedere i suoi errori, e perfino giudicare le sue opinioni. E’ con lo standard
dell’universalismo kantiano che giudichiamo stridenti le espressioni che lo tradiscono, come è con
lo standard socratico della vita esaminata che giudichiamo inaccettabile la società chiusa di Platone.
E’ con lo standard fregeano del peso di verità delle parole che giudichiamo non solo obiettivamente
falso, ma per questa ragione anche obiettivamente infame qualunque giudizio di inferiorità razziale
di un uomo rispetto ad un altro.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
Ma con lo standard di Heidegger è impossibile vedere la nefandezza di molti giudizi pubblici e
privati di Heidegger, è impossibile giudicarli bassi e anche stupidi quanto veramente sono. Questa è
la differenza fra filosofo e sofista.
E’ questo il criterio della differenza fra un filosofo e un sofista, e mi sembra un criterio abbastanza
chiaro. Che sia applicabile al caso di Heidegger è altrettanto chiaro, se non altro perché il sistema di
un autore il cui motto è “tanto peggio per la logica” contiene la negazione di ogni sua proposizione,
ovvero dice tutto e il contrario di tutto. Come strumento di giudizio non vale un granché, qualunque
sia l’argomento.
Risale al 1929 il testo forse più letto di Heidegger, Che cos’è la metafisica? - fra gli scritti di
Heidegger, quello che ebbe più immediato successo, e che lo rese da subito famoso (ne dipende fra
l’altro la maggior parte delle letture “di prima generazione” di Sein und Zeit, che era uscito nel
1927. Ne dipende pesantemente il trattato di Sartre del 1943, L’essere e il nulla).
Risale al 1932 il trattatello logico di Rudolf Carnap, Il superamento della metafisica attraverso
l’analisi logica del linguaggio, in cui si mostra entro che ristretti limiti si può parlare dell’essere e
del nulla – senza parlar di nulla. In quegli anni le due vie del pensiero si separano. Resta ben poco
oggi di vivo di quel piccolo manifesto carnapiano del verificazionismo: ben poco, perché Carnap
stesso fornì ai suoi successori – a Popper, a Quine – gli strumenti per contestare con successo la
parte insostenibile delle sue teorie (secondo il nostro criterio, Carnap era certamente un filosofo e
non un sofista). Eppure quel poco è essenziale a mettere in luce la natura sofistica del dire
heideggeriano[26]. Tanto peggio per la logica, sussurra il pastore dell’Essere – con un po’ più di
pathos:
“E se, così, vien fiaccata la potenza dell’intelletto nell’ambito della questione intorno al niente e
all’essere, allora si decide con ciò anche il destino della signoria della “logica” dentro la filosofia.
L’idea della “logica” si risolve nel vortice di un interrogare più originario”[27]
Ma in questo “vortice” si dissolve anche quel fondamento etico del dire che è, ripetiamolo ancora
una volta, la responsabilità nell’uso delle parole. Vale a dire, la capacità e volontà di rispondere
delle nostre singole affermazioni, in primo luogo costruendole in modo che abbiano la possibilità di
essere vere, o anche, perché no, di essere false. Un sofista è chi oscura il nesso necessario fra la
nostra disponibilità a prendere sul serio ciò che un altro dice e la pretesa di verità implicita in ogni
asserzione. Se dissolviamo la logica in un interrogare più originario la pretesa di verità delle
asserzioni perderà ogni senso. E con essa svanirà la possibilità che abbiamo di esprimere pensieri
definiti, e di attribuirceli gli uni agli altri come credenze, convinzioni, tesi che abbiamo espresso.
Parliamo, parliamo, e non diciamo nulla.
IV. Conclusioni retrospettive – per l’oggi.
Nei primi 7 paragrafi della Crisi delle scienze europee Husserl presenta il suo pensiero in diretta
continuità con quello illuministico, in quanto speranza di dare un fondamento di conoscenza,
ragionevolezza e autonomia al pensiero pratico (etica, diritto, politica) e non solo a quello
scientifico. In questo contesto espone due principi, che già in altri scritti aveva presentato come
costitutivi dell’Idea di Europa, questa sempre rinascente eccedenza dell’ideale sul reale, della norma
sul fatto, del diritto sul potere. Furono anche i due pilastri di un’Europa a venire. E cioè il principio
di personalità – col suo corollario di (pari) dignità e diritti di tutte le persone; e l’universalismo della
legge (di quella morale, certo – ma in linea di principio anche del diritto, sovra statuale e
sovranazionale). Sono i due principi che dopo la guerra ponemmo a fondamento della Dichiarazione
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
Universale dei Diritti dell’Essere Umano, e delle costituzioni delle Repubbliche rifondate, compresa
la nostra. E naturalmente anche alla base dell’Unione Europea.
Heidegger costruì il suo pensiero sulla negazione di questi due principi, e sulla loro sostituzione con
due principi opposti: la concezione destinale della storia, con la rimozione dell’autonomia e della
responsabilità morale degli individui; e l’adozione di un principio di comunità, radice e destino
come esplicitamente più fondamentale di quello di personalità, e sulla base del quale gli fu possibile
esaltare il Führerprinzip e i legami della terra e del sangue, salutando “l’intima grandezza del
Nazionalsocialismo”.
Dopo il ’4 , Heidegger fu sdoganato, prima in Francia e poi in Italia, e il suo pensiero sofistico
dominò sul continente per mezzo secolo ancora. Come fu possibile?
Ora abbiamo forse una risposta, a questa domanda. Fu possibile perché il sofista vinse purtroppo in
larga misura anche nella mente di chi per sentimenti, storia personale, adesioni profonde si situava
su un altro fronte politico.
Molto peggio della rimozione del suo nazismo fu ed è l’indifferenza, anzi la stessa cancellazione
mnestica della differenza fra esserlo e non esserlo, fra vittime e carnefici, fra Illuminismo e
Auschwitz, fra ragione e delirio, nel “vortice” dell’interrogare originario, nella sua “profondità
abissale”. E questa è opera della sofistica, come opera sua è l’indistinzione fra sofistica e filosofia.
La cosa – per la mente – peggiore.
Ognuno degli innumerevoli ripetitori delle formule del massimo sofista del Novecento ha
contribuito a diffondere quell’indifferenza e quell’indistinzione. Con i risultati che si sono visti,
quanto alla presenza al nostro tempo dei filosofi della mia generazione, al nostro ruolo di coscienza
critica e ragione indipendente nello spazio pubblico delle ragioni, di sentinelle della democrazia e di
ispiratori di vera ricerca.
Abstract
Why does such a relevant part of the Italian Left Wing intelligentsia keep regarding Heidegger’s
legacy as a necessary key to understanding Modernity, in spite of more and more indisputable
proofs of Heidegger’s involvement in Nazism, and of the roots of this involvement in Heidegger’s
philosophical thought? Why does the deeply illiberal root of Heidegger thought still captivate some
of the best known representatives of what has been called “Italian Theory”? The ongoing
publication of Heidegger’s Schwarze Hefte, and a recent book by D. Di Cesare on them, tracing
back the responsibility for totalitarianism to the whole philosophical tradition, yield the topics for
an analysis aiming at an answer to these questions.
NOTE
[1] D. Di Cesare (2014) Heidegger e gli ebrei. I «Quaderni neri», Bollati Boringhieri 2014. Se ne
veda un’ ampia recensione a cura di Stefano Cardini: L’antisemitismo metafisico nell’ombra
dell’Essere. Heidegger e gli ebrei alla luce dei Quaderni neri,
http://www.phenomenologylab.eu/index.php/2014/11/heidegger-quaderni-neri-di-cesare/. La stessa
Di Cesare, forse anche in qualità di vice-presidente della “Martin Heidegger Gesellschaft”, è tornata
a più riprese in interventi pubblici sul tema di un antisemitismo metafisico che lungi dall’essere una
peculiarità di Heidegger sarebbe il basso continuo dell’intera filosofia tedesca (e non solo di quella,
l’autrice non dimentica naturalmente di ricordarci Shakespeare e Lutero), e in particolare di quella
kantiana.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
[2] J. Hersch (1988), tr. it. (2004), Il dibattito su Heidegger: la posta in gioco, in R. Ascarelli, ed.,
Oltre la persecuzione, Carocci, Roma, ora reperibile anche su
http://www.phenomenologylab.eu/index.php/2015/03/heidegger-hersch/. Da vedere anche R.
Klibansky (1991), L’Université allemande dans les années trente (Notes autobiographiques), in
« Revue de la société de philosophie du Québec », pp. 139-158. Ho riassunto e ripreso le tesi di
questi due testimoni oculari in De Monticelli (2004), Il vuoto dentro. Jeanne Hersch e il dibattito su
Heidegger e il nazismo, in: R. Ascarelli (a c.di) Donne, memoria, ebraismo, Carocci, Roma, ora
disponibile online su Academia.edu.
[3] Ne parla E. Faye (2012), Heidegger - L’introduzione del nazismo nella filosofia, L’Asino d’oro,
pp. 52, 67, 465. Si veda anche G. Piana, citato in
http://www.phenomenologylab.eu/index.php/2014/01/heidegger-il-vate-delatore/ (Il volume di
Giovanni Piana, Conversazioni su “La crisi delle scienze europee” di Husserl, è reperibile
presso Lulu.com all’indirizzo:
http://www.lulu.com/shop/giovanni-piana/...)
[4] QN Riflessioni XIV, all’indomani dell’offensiva tedesca a est, annunciata da Hitler il 22 giugno
1941; DDC 101.
[5] E. Husserl (1923), tr. it. L’idea di Europa (Cinque saggi sul rinnovamento), trad. it. C.
Sinigaglia, Cortina, Milano 1999, pp. 71-110
[6] Husserl (1923), trad. it. L’idea d’Europa, cit., p. 91, corsivo nostro.
[7] Di Cesare (2014), p. 100
[8] Ibid., p.92, corsivo nostro.
[9] Ibid., p. 92
[10] Ibid., p. 92, corsivo nostro.
[11] Heidegger (1939-41), Ueberlegungen XII-XV, Schwartze Hefte pp. 46-47, cit. da Di Cersare
(2014), cit., p. 154
[12] Ibid., p. 154
[13] L’espressione si trova (fra l’altro) nei Seminari ’34-’3 , che hanno dato nuovo materiale alla
ricerca di E. Faye, (2007) Heidegger. L’introduzione del nazismo nella filosofia, L’asino d’oro.
L’abbiamo ritrovata nel delizioso romanzo di Josè Pablo Feinmann, L’ombra di Heidegger, Neri
Pozza Editore 2007, p. 99.
[14] Di Cesare (2014), p. 98
[15] Zhock (2014), La deludente verità dell’antisemitismo di Heidegger, http://mimesisscenari.it/2015/01/09/la-deludente-verita-dellantisemitismo-di-heidegger/
[16] Di Cesare, “Shoah, ecco l’anno nero di Heidegger”, “Corriere della Sera”, 9/02/201
[17] Faye (2012), 79, 27.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
[18] “Corriere della sera” 9/02/201 , art. cit.
[19] Di Cesare, “Heidegger: ‘Gli ebrei si sono auto-annientati’”, “Corriere della Sera”, 8/02/201 . E
infatti, nell’articolo già citato del giorno successivo, l’autrice non lesina critiche al povero Günter
Figal, che sotto lo choc della pubblicazione dei Quaderni neri, si è dimesso dalla carica di
Presidente della Società Martin Heidegger.
[20] Di Cesare (2014): si può essere presi “dalla pulsione giustizialista” (p. 17); oppure da “un
mediocre revanscismo e una forte pulsione reazionaria” (p.18) : in tal modo si “depotenzia la
filosofia di Heidegger nella sua carica rivoluzionaria” (p. 28), e ci si attesta “integralisti”, sia pure
del “liberalismo”.
[21] Di Cesare (2014), p. vii
[22] Numerosi documenti sulla sua attività in questo senso si trovano in Faye (2007); da Di Cesare
(2014) possiamo citarne uno, la lettera di denuncia di Richard Hönigswald, “che ha sostenuto una
filosofia tagliata su misura per il liberalismo”, con il quale “l’attenzione viene sviata dall’uomo nel
suo radicamento storico e in quella sua tradizione di popolo che proviene da suolo e sangue. A ciò
si è accompagnato un consapevole rifiuto di ogni interrogare metafisico” (ibid. p. 9 ). Pare, ci fa
notare l’autrice, che Heidegger stesso aspirasse a quella cattedra a Monaco, “per avvicinarsi a
Hitler”. In ogni caso Hönigswald ne fu rimosso nel ’33, per essere poi, durante la Notte dei cristalli
del ’38, preso e internato a Dachau.
[23] Cf. un’intervista di D. Gentili a R. Esposito, G. Marramao su questa
nozione, http://www.losguardo.net/public/archivio...
[24] Cosa che D. Di Cesare fa citando (p. 42) una non felice frase kantiana sull’”eutanasia
dell’ebraismo”, senza però metterla nel suo contesto, che è quello della previsione di una
spiritualizzazione progressiva di una religione ancora lontana dallo status di “pura religione
morale”, come lo è del resto il cattolicesimo romano. Ringrazio Stefano Bacin per la segnalazione:
Cf. Marcus Willaschek, Jürgen Stolzenberg, Georg Mohr, Stefano Bacin (Hg.), Kant-Lexikon,
Berlin–Boston, De Gruyter, 2015
[25] Ci perdoni l’autrice, ma questa frase è di un’arbitrarietà inaccettabile: “Certo, per leggere un
trattato di logica non è necessario occuparsi dell’antisemitismo dell’autore, sebbene in Frege
sussista più di un nesso fra il Reich logico, quello teologico e quello politico” (Di Cesare 2014, p.
8).
[26] Per una esposizione elementare dell’analisi carnapiana del linguaggio di Heidegger si può
vedere De Monticelli (2006), Esercizi di pensiero per apprendisti filosofi, Bollati Boringhieri,
Torino, Parte prima L’Essere, il Nulla e la logica.
[27] Ibid., p. 26, corsivo nostro.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
L’estetica aujourd’hui. Conversazione con Elio Franzini
di GIACOMO FRONZI
Lo scorso 27 marzo, a Milano, si è tenuto il XIII Convegno della Società Italiana d’Estetica (SIE),
durante il quale è stato eletto il nuovo presidente, Elio Franzini, Professore di Estetica alla Statale
di Milano, filosofo che, in particolare, ha orientato le proprie ricerche verso la fenomenologia,
indagandola però in connessione con temi di carattere propriamente estetico, come la costruzione
artistica, l’immagine, il simbolo, la visione. Abbiamo colto questa occasione per invitare Franzini a
discutere con noi dell’estetica al giorno d’oggi, estetica intesa tanto come disciplina teorica quanto
come termine che sintetizza un diffuso e condiviso modo d’essere dell’uomo contemporaneo.
Professor Franzini, innanzitutto, auguri per questo nuovo importante incarico. Lei è stato di
recente eletto nuovo presidente della Società Italiana d’Estetica, raccogliendo l’eredità del
presidente emerito, Luigi Russo, Ordinario di Estetica a Palermo. A questo proposito, trovo
giusto ringraziare il prof. Russo che, in più di dieci anni, molto ha fatto affinché la SIE e la
ricerca estetologica potessero rafforzarsi in termini organizzativi e scientifici, tanto a livello
nazionale quanto a livello internazionale. Potremmo partire proprio da qui: professore, come
immagina i prossimi anni di impegno come presidente della Società Italiana d’Estetica? E
quali priorità dovrebbe darsi la Società?
La ringrazio molto. Mi associo al più vivo ringraziamento, per nulla formale, nei confronti del Prof.
Russo. Si deve a lui se l’estetica è in Italia una disciplina unita sul piano istituzionale e forte su
quello dei contenuti. Credo dunque che la continuità negli intenti e nelle azioni sia una necessità
dettata dagli eventi: quando le cose funzionano è assurdo volerle cambiare. Certo, gli eventi esterni
imporranno nuovi comportamenti, come è ovvio. Ma il futuro è abbastanza imprevedibile, se non su
due questioni. In primo luogo, la SIE, come tutte le altre Società scientifiche, dovrà svolgere un
ruolo di attiva consulenza e collaborazione nei confronti di Anvur e CUN. Negli ultimi anni questa
funzione si è accentuata e ritengo sia importante proseguirla, in modo da mantenere viva la sinergia
tra il mondo della ricerca e gli organismi istituzionali che se ne occupano. In secondo luogo, ritengo
sia doveroso cercare di mettere in atto un ricambio generazionale, in primo luogo nell’Università.
La ASN ha senza dubbio mutato i meccanismi di reclutamento: ma, in assenza di risorse, i suoi esiti
rischiano di non essere visibili. L’Estetica, come tutta la ricerca scientifica in Italia, ha bisogno di
nuove idee, e queste possono essere offerte solo dalle nuove generazioni. Io spero di essere soltanto
il “traghettatore”.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
La riflessione estetica, anche sull’onda del dibattito innescatosi negli ultimi decenni a partire
dalla rimodulazione, ad opera dell’estetica analitica, di alcuni temi tipici dell’estetica
“tradizionale”, si è orientata verso i più diversi campi del “sentire” e le più diverse sfere
dell’attività e della speculazione umane, attivando un serrato dialogo anche con discipline che
hanno molto più a che fare con il sapere scientifico che con quello umanistico-filosofico:
penso, ad esempio, alle neuroscienze. Si tratta, in qualche modo, della proposta avanzata da
diversi filosofi, come Mario Perniola, secondo il quale una riflessione può dirsi estetica solo se
il termine viene preso nel pieno senso etimologico, come una “filosofia del sentire”, giacché, se
la nostra epoca è un’epoca “estetica”, ciò accade «non perché essa ha una relazione
privilegiata e diretta con le arti, ma più essenzialmente perché il suo campo strategico non è
quello conoscitivo, né quello pratico, ma quello del sentire, dell’aisthesis», giungendo così
anche ad affrontare temi quali i rapporti tra filosofia, gusto e alimentazione. Crede che questo
ampiamento illimitato del proprio campo d’azione possa nuocere alla specificità e
all’autonomia epistemologica della disciplina?
Non credo che l’estetica rischi la dispersione, anche perché, pur avendo una propria tradizione e una
propria storia, non è, come avrebbe detto Emilio Garroni, una “filosofia speciale”. È un campo
aperto, dove la varietà dei temi e degli orizzonti non significa di necessità dispersione. L’estetica
forse può apparire soltanto all’interno di una dimensione complessa e articolata. La confusione
stessa che si è verificata nella sua storia tra teoria della sensibilità e filosofia dell’arte è indicativa
delle origini della disciplina, il cui campo di applicazione, le cui “ontologie regionali”, si rivolgono
a oggetti, a orizzonti dove il giudizio sembra connettersi alla specificità intuitiva delle cose stesse,
senza perdersi in definizioni capziose o in fattualismi sterili. La confusione, il senso di incertezza,
sono anche l’eredità di un percorso dell’arte che si confronta con le dimensioni del concetto, della
sensibilità e delle loro tormentate unioni. Questa intrinseca varietà dell’estetica, peraltro, è connessa
alla sua stessa definizione storica, dove già si sono incontrati momenti in cui, nelle medesime
epoche, si è verificata una coesistenza di linguaggi diversi, e in apparenza talmente irriducibili da
generare confusione e dubbio (si pensi alla secentesca Querelle tra Antichi e Moderni).
Per cui, se si volessero seguire le “piste” che corrono oggi per i territori dell’estetica, si
ritroverebbero problemi non nuovi, forse solo più confusamente impostati, o che tali appaiono in
virtù della vicinanza all’occhio, sempre però testimonianza di una verità dove si è consapevoli che
l’estetica ha, come scrive Fabrizio Desideri, «una decisiva rilevanza per la definizione di una
generica identità umana, anziché un valore puramente accessorio o residuale». In sintesi, lo sforzo,
in questa densità di percorsi dialogici, è quello di comprendere le loro interazioni, i loro legami con
il nostro “mondo della vita”, con quelle strutture di senso precategoriali che sono il fondamento di
ogni conoscenza possibile e reale. Nulla di “mitico”: solo la possibilità di giudicare il senso delle
cose con una ragione intuitiva, attenta alle loro specificità, nella consapevolezza che tale ricchezza
di senso estetico è profonda dove le particolarità spirituali delle cose, con le loro stratificazioni
culturali, sono irriducibili a dimensioni solo linguistiche. Principio che si può riassumere con una
frase di Flaubert citata da Kundera: «mi sono sempre sforzato di andare all’anima delle cose».
L’estetica è questo tentativo, che non “definisce” le cose, ma cerca di comprenderne la
stratificazione di senso, prendendo avvio dall’originario livello intuitivo, da quella dimensione di
esperienza soggettiva e intersoggettiva che le recepisce, comunica, esprime per risalire a tutta la
loro complessità di livelli, senza dimenticare che di “cose” si tratta, cioè di realtà che appartengono
al nostro comune e condiviso mondo della vita. Un mondo che è fatto di tante ontologie, cioè di
tanti modi per “coniugare” l’essere, senza che nessuno escluda o neghi il senso possibile di un altro,
cercandone ragioni che non sono esclusive, bensì, come avrebbe detto Bachtin, voci del medesimo
dialogo. In cui le dimensioni della storia, culturali e spirituali, e quelle dell’immediato giudizio
estetico, che si dà con il darsi della cosa stessa, non sono tra loro contrapposte, ma fanno invece
comprendere come, nei percorsi generali della conoscenza, intuizione estetica ed elaborazione
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
riflessiva e intellettuale collaborano al medesimo processo, e sono la specificità delle varie anime
della disciplina.
Storia, cultura e spirito, dunque, rientrano pienamente nel discorso estetico, al di là delle sue
specificazioni e precisazioni. A questo proposito, una delle declinazioni più dibattute (e forse
controverse) negli ultimi anni mi pare essere stato il cosiddetto processo di estetizzazione
diffusa, tipico della contemporaneità. Tale processo mi sembra rinviare a una doppia possibile
interpretazione, ciascuna della quali conduce a esiti opposti, che potremmo definire
genericamente negativo e positivo. Una distinzione utile a chiarire la differenza delle due
interpretazioni è legata all’attribuzione, in relazione agli sviluppi della società
contemporanea, di una diversa connotazione che si può assegnare alla bellezza:
funzione/finzione o qualità. Nel primo caso, il bisogno ineliminabile di bellezza tende a
configurarsi come una sovrastruttura prodotta dai nuovi modelli sociali di comportamento,
orientata verso l’accettazione di se stessi da parte degli altri membri della comunità. Essere
belli diventa funzionale al riconoscimento che l’individuo riceve dagli altri: si è riconosciuti
sulla base del dato apparente, sulla base di un giudizio primariamente e, talvolta,
esclusivamente estetico. Nel secondo caso, invece, la bellezza si presenterebbe come un
elemento non già funzionale, bensì opzionale rispetto ad altri attributi, ad altre qualità, vissuti
come scelta consapevole e non come una passiva imposizione di una società che tende a
sopravvalutare la bellezza e sottovalutare altre dimensioni (ad esempio, detto banalmente,
l’apparenza sull’essenza). La bellezza come opzione, oltre che rappresentare una scelta
consapevole, rinvia, proprio in virtù della consapevolezza che manifesta, a una dimensione
“interiore” ed essenziale, contrapposta, dunque, all’esteriorità dell’apparenza. A questo
livello d’analisi, estetica ed etica tendono a incrociarsi, dal momento che la bellezza interiore
rappresenta la positività dei princîpi, la genuinità dei comportamenti, l’autenticità e la bontà
dei rapporti intersoggettivi. Proseguendo con questo ragionamento, si giunge inevitabilmente
a sostenere l’“esteticità” e l’“eticità” delle relazioni intersoggettive?
La bellezza è sempre stata legata a una dimensione etica. Anche in questo caso si tratta, a mio
parere, di cogliere la densità dei concetti – in questo caso del concetto di bellezza – dimostrando
ancora una volta la centralità sociale e culturale dell’estetica. Quando Paul Valéry definisce il
piacere estetico, il piacere di fronte al bello, come una serie di azioni reazioni, eccitazioni sensibili
che non hanno una funzione fisiologica uniforme e ben definita, costruisce una geniale formula, che
mostra la strada: la definizione del bello conduce su epoche storiche, mentre per comprenderlo
bisogna descriverne funzioni, effetti, contraddizioni, aporie, tutto ciò che lo rende nozione aperta e
progressiva, non formula vuota e ripetitiva. La bellezza, osserva ancora Valéry, non può essere
considerata una “nozione pura”, anche se tale nozione è stata essenziale nel divenire della
spiritualità occidentale, e ha segnato una metafisica che è alla base del pensiero filosofico. Platone,
volendo sintetizzare, e con tutti i rischi della sintesi, opera proprio ciò che, a parere di Valéry, non
andrebbe fatto, cioè separa il Bello dalle cose belle. Questa “formula”, come la Scuola d’Atene di
Raffaello, con Platone che volge il dito verso l’alto e Aristotele che lo pone verso il basso, segno
della dualità che corre attraverso la metafisica (come studio della trascendenza, da un lato, e come
fondamento sensibile, dall’altro), vale anche per il bello “estetico”: può essere nei cieli, come
“idea” non sensibile, ma può anche essere idea “estetica”, che si frantuma nelle cose. Al tempo
stesso, nulla vieta di cercare, ed eventualmente trovare, l’universale nel particolare, operando una
sintesi felice.
È su questi assi che si è sviluppata l’idea di bellezza, e ognuno di essi porta con sé i pericoli di
definizioni di ambiti difficilmente definibili. L’idea metafisica della bellezza, come ancora osserva
Valéry, dispensa dalla reale percezione delle cose belle, e quindi presenta un uomo privato di una
sua concreta possibilità di vivere il mondo e gli oggetti. D’altra parte, una visione “naturalistica” del
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
bello lo conduce verso una varietà infinita, che rischia lo scetticismo più estremo e il soggettivismo
più esasperato; esattamente come una volontà sintetica inevitabilmente si conclude in una forme di
canonizzato classicismo.
Dal momento che dai pericoli non si esce, proprio perché i dualismi del pensiero filosofico vanno
accettati come sue caratteristiche intrinseche e ineliminabili, l’idea di bello si muove tra le nozioni
di necessità e arbitrarietà. Necessità perché la bellezza è così, e non potrebbe essere altrimenti. Ma,
al tempo stesso, si è consapevoli che avrebbe potuto essere altra, o non essere affatto. Situazione del
tutto aporetica, che rende il bello un crocevia di senso tra la metafisica, la logica, la teoria della
sensibilità e dell’arte, ma anche il senso comune e i giudizi quotidiani che ne conseguono, in cui la
parola bellezza è mischiata al gradevole, al piacevole, al grazioso, a uno spettro di significati e
sfumature che non coinvolgono solo i grandi concetti – la Natura e l’Arte – ma il senso con cui le
cose si svolgono nel mondo. Il bello può scoprire il suo senso composito anche oggi, proprio
tornando a quella che Freud chiama la sua “caducità”: tale caducità del bello non implica un suo
svilimento, ma, al contrario, ne aumenta il valore, dal momento che «il valore della caducità è un
valore di rarità nel tempo» e «la limitazione della possibilità di godimento aumenta il suo pregio». Il
lutto che la scomparsa, l’indefinibilità della bellezza, l’indeterminazione spazio-temporale porta in
sé, è un grande enigma: ma è un enigma che non uccide la bellezza, bensì ne fa sentire l’esigenza di
ricostruire un rapporto con le cose, forse caduco e mortale, ma di cui proviamo profondo e autentico
bisogno.
In sintesi, l’orizzonte in cui la bellezza appare e si staglia, anche per il filosofo, non è quello del
pensiero puro, e dei suoi raffinati apparati categoriali, ma di un precategoriale sentimento, passivo e
legato alla passionalità del nostro essere nel mondo. Di conseguenza la bellezza, essenziale,
naturale, empirica o spirituale che sia, se anche fosse un “grande paradigma”, non è indifferente alla
storia e alla molteplicità delle sue forme. L’affacciarsi di nuove classi sociali da un lato, ben
evidente sin dal Settecento, e lo sconvolgimento che attraversa l’Europa dalla Rivoluzione francese
alla caduta di Napoleone, sono essenziali come la caduta della polis greca o la Riforma Protestante.
Quando è stato notato che alcune pagine di Marx e di Baudelaire che descrivono la società borghese
sembrano in sintonia, non è perché i due si conoscessero né per un generico “spirito dei tempi”, ma
in quanto entrambi colgono come una rovina sociale imponga nuovi modi per analizzare il presente.
Andando alla ricerca di un’epica anche per la vita moderna, e i suoi motivi sublimi, Baudelaire
ricorda nel Salon del 1846, che «siccome ogni secolo e ogni popolo ha avuto la propria bellezza, noi
dobbiamo avere per forza la nostra. E ciò è nell’ordine delle cose».
Dalle Sue parole emerge chiaramente come la bellezza si presenti, tanto per il filosofo quanto
per il non-filosofo, come una dimensione che è al tempo stesso esistenziale, spirituale,
empirica, storica. Mi viene in mente, allora, la prospettiva di György Lukács, il quale, in
Storia e coscienza di classe, pone il principio estetico come un luogo in cui poter individuare la
«chiave per risolvere il problema del senso dell’esistenza sociale dell’uomo». Quanto siamo
lontani (o vicini) da una prospettiva di questo tipo?
È una questione decisiva, una domanda molto importante. Non credo che l’estetica possa
“risolvere” il problema dell’esistenza sociale dell’uomo, ma può certo aiutare ad affrontarlo.
L’estetica è in definitiva un modello epistemologico, che non spiega contenuti specifici, ma descrive
le possibilità che sono nell’esperienza, che ne costituiscono l’essenza, che rifiuta un’ontologia
separata da una fenomenologia, cioè da una capacità di costante indagine sul visibile e
sull’invisibile, sui lati nascosti delle cose. «Penso con angoscia al giorno – scrive Kundera – in cui
l’arte cesserà di cercare il mai detto e, docile, si rimetterà al servizio della vita collettiva, che esigerà
da lei che abbellisca la ripetizione e aiuti l’individuo a confondersi, felice e in pace, con l’unità
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
dell’essere». Un modello epistemologico che lavora attraverso balbettii, interrogazioni e descrizioni
e non definizioni e spiegazioni, non è un metodo specifico, canonizzato e immobilizzato, bensì la
consapevolezza di un’indagine dialogica che, nella varietà dei modelli, la modernità ha
progressivamente conquistato. L’estetica mostra davvero che, come scrive Habermas, la modernità
è un progetto incompiuto: «da questa visuale, una modernizzazione sociale che prosegue in modo
autosufficiente il suo cammino si è separata dalle spinte di una modernità culturale che in
apparenza è divenuta obsoleta; essa attua soltanto le leggi funzionali dell’economia e dello Stato,
della tecnica e della scienza, che, secondo quanto si dice, si sarebbero unite in sistema sul quale non
si può esercitare alcun influsso». Proprio perché l’estetica non è figlia di una modernità “sociale”,
deve attingere da se stessa i propri contenuti, cercandoli in primo luogo nella tradizione filosofica,
nella contaminazione che ha generato con altri saperi come le retoriche, le critiche, le dimensioni
dell’arte, che l’hanno interrogata senza in esse definirla, forse con il solo fine di evidenziarne la
specificità e le differenze. Questi nessi implicano una azione, una capacità di interpretare e
trasformare il mondo che si vive, di coglierne il senso profondo, attento al divenire della storia, al
“gioco eterno” tra quel che permane e l’attimo che fugge, tra la stabilità delle cose e la loro
contingenza. Faust ha incarnato questo “spirito attivo” della modernità, che ha in sé la capacità di
mutare le proprie forme, di mostrarne la dinamicità. Il Faust di Goethe può trasformarsi nel Faust di
Valéry, che non ha in sé, come scrive, alcuna ansia di nessun’altra avventura, «in me che ho saputo
vincere l’angelo e tradire il demone», senza per questo essere meno Faust, ma solo comprendendo
che ora Faust può apparire anche come polivalenza e pluralità, figura infinitamente moltiplicata il
cui destino, e il cui tormento, è quello di ricominciare senza mai esaurire né la durata né il possibile.
In questo modo può essere forse sintetizzato il percorso dell’estetica, in tutta la sua pluralità
semantica: è dialogo tra il sapere e il potere, mostrando la possibilità costruttiva del molteplice, il
desiderio di unità che è in esso, la stabilità e l’arbitrio di un’unità posta in essere da un movimento
aporetico, cioè in una dialettica qualitativa, priva di sintesi, che è la dialettica polifonica di cui
parlava Bachtin, in cui ogni voce ha in sé le altre, ma mantiene la propria specificità e appartenenza,
senza alcuna volontà di prevaricare. Perché ciò sia possibile, l’estetica non solo non può rifiutare la
propria tradizione, ma deve anzi sempre di nuovo esibirla, mantenendo il peso della propria
memoria, anche nel momento in cui, come nella nostra contemporaneità, sembra vi sia, come
ancora scrive Valéry, una «libera coesistenza in tutti gli spiriti colti delle idee più dissimili, dei
principi di vita e di conoscenza più opposti».
Rispetto alla propria memoria e alla propria tradizione, non possiamo negare come
storicamente una delle relazioni privilegiate, più strette e più durature nel tempo che l’estetica
ha avuto è stata quella con l’arte e con il suo (eventuale) contenuto di verità. Hans-Georg
Gadamer, in Verità e metodo, scriveva: «[…] noi non chiediamo all’esperienza dell’arte come
essa stessa si pensi, ma che cosa essa in verità sia e che cosa sia la sua verità, anche se essa non
sa che cos’è e non sa dire quel che sa […]. Nell’esperienza dell’arte vediamo attuarsi
un’esperienza che modifica realmente chi la fa, e poniamo il problema dell’essere proprio di
ciò che viene in tal modo esperito. Così possiamo sperare di comprendere meglio che verità sia
quella che qui ci viene incontro». Alla luce delle più recenti correnti di ricerca estetologica,
crede che queste parole di Gadamer possano trovare oggi motivo di interesse per un’estetica
contemporanea che sembra aver abbandonato la via della ricerca della verità nell’arte?
Credo che Gadamer, pro domo sua, enfatizzi un poco questo problema. Ho in mente un passo di
Verità e metodo in cui contrappone Kant e Hegel, attribuendo al secondo una volontà di far
partecipare l’arte al movimento della verità, che sarebbe precluso al primo, il quale misurerebbe «la
verità della conoscenza in base al concetto di conoscenza e di realtà proprio delle scienze della
natura». A mio parere si tratta invece di due modi diversi per affrontare il problema della verità in
genere e della verità dell’arte in specifico: da un lato, l’arte è vista come uno dei momenti critici del
rapporto estetico tra esperienza e ragione, dall’altro, si incarna invece in forme storiche concrete,
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
ciascuna delle quali ha una sua specificità spirituale che si deve “interpretare”. In definitiva
l’estetica, prima ancora del suo battesimo, ha sempre indagato questi temi, cercando di rispondere
alla domanda: «quale è l’atto, o la serie di atti, che fonda ciò che viene chiamato arte?». Mi sembra
dunque, in sintesi, che l’estetica, ripercorrendo la sua storia, continui ad avere al centro la
definizione dell’arte come problema connesso alla sua “verità”, dimostrando che l’espressione
artistica non è il gioco presentativo di una variegata “domenica della vita” – sempre tramata da una
dimensione di un inganno travestito da ripetitivo e raffinato stilema – bensì il lavoro di un percorso
che attraverso le forme manifesta un sapere che interpreta, in dimensioni sensibili, la verità della
presenza mondana e dei sentimenti a essa correlati, e che la “giudicano”. L’arte insegna quella che
Pavel Florenskij, nella Prospettiva rovesciata, chiamava policentricità della rappresentazione.
Policentricità di cui l’arte stessa è il simbolo perché, come scrive, l’arte “è, o per lo meno vuole
essere, innanzi tutto, verità della vita, che non sostituisce la vita, ma si limita ad indicarla
simbolicamente nella sua più profonda realtà”. L’espressività artistica è la capacità di cogliere gli
oggetti estetici come “catene immaginative”, che non si esauriscono nella “referenzialità” del primo
sguardo, rivelando invece una ricchezza interiore, radicata nella specificità del materiale stesso che
le costituisce. Questo orizzonte conduce a sottolineare che sono i materiali stessi, nella sintesi
formale che costituisce l’opera, a esporre i loro nessi sensibili di unità, sottoponendoli a quello
sguardo “simbolizzante” che è a mio parere l’essenza veritativa dell’espressione artistica. L’estetica
può così far comprendere che la storia stessa delle arti non esibisce il gioco delle forme con se
stesse, rinchiuse in un contingente esibirsi, ma una forma estetica strutturata nel proprio materiale e
fondata nel nostro riconoscimento empatico, conoscitivo e storico. L’arte funge non solo da
esemplificazione, ma da costante attestazione di un processo intenzionale operativo, la cui
“espressività” si rinnova nel rinnovarsi degli atti esperienziali che ne esibiscono il senso veritativo e
fondativo, i nessi intrinseci che costituiscono tale senso, offrendolo allo sguardo empatico di
comunità intersoggettive. Franz Marc afferma che il senso dell’arte è forse riassumibile in un solo,
metafisico, aforisma: «Dio creò il mondo e lo mise in discussione». Ebbene, se “mettere in
discussione” il mondo è il compito espressivo dell’arte, mettere in discussione l’arte è compito che
non si può lasciare solo alle “critiche”, e che dunque la filosofia deve sempre di nuovo affrontare.
Se l’arte è uno dei temi principali dell’estetica è perché, nel rinnovarsi del sentire, ne cerca sempre
la profondità qualitativa che ne esalta il potere di differenza, che non “accresce” né il nostro sapere
né la spiegazione delle cose del mondo, ma permette tuttavia di guardare a questo mondo
cercandone le radici, la profondità, il mistero, ampliando lo spettro del visibile, approfondendone i
sensi simbolici, che nutrono l’interrogazione che è la base epistemologica di ogni sapere reale e
possibile.
Spostando ora il focus di questa conversazione sulla contemporaneità, tra le varie e più
recenti ricerche in campo estetologico, una tra quelle che maggiormente sembra suscitare un
interesse planetario è quella del filosofo americano Richard Shusterman, il quale – detto
sinteticamente – ha inteso attualizzare l’estetica proponendo un progetto teorico da lui
definito somaestetica, che, anziché «rivangare insolubili dibattiti ontologici sul rapporto
corpo-mente», sostenendo filosoficamente la necessità di una nuova coscienza del corpo, punta
a «reindirizzare lo studio filosofico di questo nesso cruciale verso una più feconda direzione
pragmatica, che rafforza importanti ma trascurate connessioni tra filosofia della mente, etica,
teoria politica e le pervasive dimensioni estetiche della vita quotidiana». Cosa pensa della
proposta teorica di Shusterman?
Shusterman è figlio di una tradizione che ha nel pragmatismo, e in Dewey, i suoi punti di
riferimento. Una tradizione senza dubbio interessante e importante. Ritengo, essendo “figlio” della
tradizione fenomenologica, che i concetti che egli esprime, nel loro indubbio interesse, possano
essere manifestati anche attraverso altri linguaggi, come, per esempio, dimostra Merleau-Ponty.
Superare i dualismi significa appunto accedere ai molteplici modi con cui si manifesta il mondo
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
della vita. L’estetica, nella sua storia, ha forse insegnato che dalla dicotomia, o meglio dalle sue
forme, raffinate o ingenue, bisogna uscire, assumendo i modelli all’interno della loro epoca e non
universalizzandone il paradigma, e comunque scorgendo entrambi i lati della dicotomia. Bisogna
così constatare che i piani della descrizione di processi naturali e culturali non sono astratti, e non
sono degli “abiti” preconfezionati, bensì si adattano a ciò che le cose sono, ai punti di vista possibili
che essi richiedono per poter essere afferrati in tutti i loro strati di senso. In sintesi, respingere le
dicotomie, le chiusure, non deve annullare, bensì al contrario potenziare, il valore epistemologico
delle differenze e dei differenti modelli di analisi connessi alle specificità degli oggetti. Senza una
consapevolezza dei processi genetici attraverso i quali si determinano gli orizzonti e i modi della
conoscenza, non può esservi una reale comprensione degli oggetti che si analizzano e dei metodi
che ne svelano le specificità. Per superare il dualismo, la contrapposte forme di “obiettivizzazione”,
le riduzioni metodiche di certa filosofia analitica, si deve quindi essere consapevoli che la realtà può
essere esplorata attraverso modi diversi, ma l’importante è continuare a cercare, in questa diversità,
le strutture trascendentali che attraversano il loro orizzonte di esperienza. Ad ogni monismo
falsificante, come a contrapposti obiettivismi, va così opposta la consapevolezza teorica che, come
ricorda Giulio Preti, In principio era la carne: recuperare il mondo della vita, il legame tra la
razionalità e le operazioni conoscitive, il tentativo di cogliere i nessi “legali” tra antropologia e
scienze naturali, la continuità, o le analogie, tra intelletto e sensibilità, significa introdurre
nell’argomentazione un atteggiamento antidogmatico che impone di “andare a vedere” qualità e
significato delle cose, che costituiscono il piano di sviluppo originario del pensiero e delle sue
dinamiche. Uno dei risultati più rilevanti della vicenda storica dell’estetica è stato dunque quello di
cogliere il valore conoscitivo generale del sensibile, recuperando una dimensione originaria che
opera a contatto con il senso “carnale” delle cose. Come si è più volte sottolineato, evidenziando la
centralità, anche simbolica, di Goethe, l’estetica insegna a discendere nel “regno delle Madri”: un
territorio di schemi “concreti”, di forme simboliche delle cose, di radici del senso, un territorio che
Husserl definisce «disperatamente multiforme e in una continua differenziazione». Se il pensiero
oggettivo «ignora il soggetto della percezione», come osserva Merleau-Ponty, la vita che esperisce
il mondo ha questo soggetto al suo centro, un corpo proprio, un corpo estetico che fonda, nelle sue
sintesi e nella sua dinamicità attiva, l’oggettività stessa. Il giudizio estetico non è una proposizione
inguaribilmente individuale, bensì un modello – l’idea estetica – per un sapere antropologico che
scaturisce da una relazione originaria tra una comunità di senso e il mondo della vita: la conoscenza
viaggia attraverso variazioni e modificazioni, nell’incessante movimento del moderno, sempre alla
ricerca di un suo “oltre”, così come la molteplicità degli sguardi si offre soltanto con il sentire
comune dei soggetti corporei di fronte alle circostanze in cui le cose appaiono. Il senso del mondo,
tuttavia, quello in cui si vive e si pensa, è in una genesi inseparabile dalle qualità estetiche delle
cose così come esse sono per noi. Una genesi in cui alcuni oggetti – forse quegli oggetti estetici che
chiamiamo opere d’arte – esibiscono nel loro darsi estetico il senso simbolico di un sapere dove il
legame tra rappresentazione e concetto mantiene sempre un fondo di anonimia, che non è colmato
né da norme assolute né dalle rappresentazioni affini, dove l’intenzione dei soggetti è nella sua
storicità sempre “fungente” e mai esaurisce la tematizzazione del senso del fenomeno.
Vorrei concludere questa conversazione con una questione più generale, che tocca non
specificamente l’estetica ma, più in generale, il ruolo della filosofia e della pratica filosofica
nel nostro difficile presente. Da un Suo recente volume, Non sparate sull’umanista, mi pare
che emerga la volontà di rilanciare l’utilità sociale della riflessione filosofica, soprattutto in un
tempo di crisi profonda, diffusa, radicale. Riferirsi all’uccisione, con arma da fuoco,
dell’umanista, mi fa tornare alla mente le parole di Jean-Fronçois Lyotard che, nel suo Perché
la filosofia è necessaria, scrive che oggi non si uccidono più i filosofi, «ma si può uccidere la
filosofia senza bisogno di uccidere il filosofo. Si può impedire al filosofo di esserci, di essere
presente con la sua mancanza nella società». Ciononostante, la domanda «perché filosofare?»
rimane, trasformandosi, in Lyotard, nella domanda conclusiva: «in realtà, come non
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
filosofare?». Come pensa che si possa configurare, oggi, il dibattito sull’utilità della filosofia e
sulle sue possibili ricadute pratiche?
La domanda più difficile è sempre l’ultima. È noto che si parla molto, negli ultimi anni, a partire dai
paesi anglosassoni di “filosofia in azienda” o di “consulenza filosofica”. Sono senza dubbio
orizzonti da esplorare, dal momento che non devono esistere ambiti da cui la filosofia sia a priori
esclusa. Dobbiamo d’altra parte riflettere ancora sull’episodio narrato da Platone relativo alla
servetta tracia che ride di Talete, interrogandoci sul fatto che, anche quando sembra non “servire a
nulla”, la filosofia riveste un’essenziale funzione sociale, che comunque accresce la consapevolezza
critica di un Paese.
Difficile peraltro ignorare che siamo in un momento in cui abbondano le riflessioni dei filosofi su se
stessi e, di conseguenza, sulla filosofia. È sempre il segno di una crisi, che periodicamente si
rinnova e che assale quando a una funzione “tradizionale”, che si svolge in prevalenza nelle
università e nell’editoria specialistica, se ne affianca un’altra, che cerca la sua visibilità sulle pagine
culturali dei giornali. Non è una tendenza nuova dal momento che ne parlava anche Leopardi (la
filosofia dei gazzettieri): ma si è sviluppata negli ultimi cinquant’anni sino a creare quasi una
dicotomia sociale, tra ciò che è chiuso in un ambiente ristretto e ciò che, invece, affronta la vita, con
differenze di linguaggio che non possono non incidere né sulla tradizione né sulla storia. Tutto ciò
che segnala una crisi del proprio orizzonte di ricerca non può essere ignorato: ma, tuttavia, neppure
enfatizzato, dal momento che di enfasi vive. Incarna, molto semplicemente, un’esigenza sempre più
forte di “divulgazione”, che a volte sfiora la banalizzazione, l’eccitazione per il “nuovo”, sia esso un
paradigma, un “ismo”, un metodo, un nesso con altre discipline, un prefisso, un suffisso e via
dicendo. Un’esigenza che la diffusione della comunicazione e dei mezzi di trasmissione del sapere
non può non generare e che, tuttavia, non muta i termini generali in cui si muove la disciplina. Nella
filosofia non esiste un vero e proprio “progresso”: la storicità degli elementi di pensiero non supera
né annulla i precedenti. Con essi, piuttosto, si stratifica, aprendo punti di vista diversi su problemi
antichi, che spesso ne ricalcano altri, semplicemente ignorati, dimenticati o sconosciuti a chi scrive.
In sintesi: la filosofia è costituita da “punti di vista” e dunque poco importa se essi trovano spazio in
un’aula o su un quotidiano, dal momento che la funzione della filosofia è, è sempre stata, sociale,
pubblica, politica, intersoggettiva. Il male eventuale non è generato dal “mezzo” che accoglie le
riflessioni dei filosofi, bensì dalla loro volontà, spesso narcisistica, di semplificare quel che non solo
è complesso, ma anche storicamente articolato e stratificato. La filosofia, per essere “utile”, deve
dunque guardare alla sua storia, alle funzioni che ha in essa rivestito. Perché la filosofia, piaccia o
meno, è una disciplina storica: non vi è nulla di eterno in essa dal momento che i concetti che la
costituiscono si sono formati nel tempo e attraverso il tempo. Neppure i concetti di logos e di
episteme, di ragione e di scienza, sono sempre stati uguali a se stessi, al di là dei miti delle origini.
Tutto ciò che è storico può essere, per sua stessa natura, messo in discussione, argomentato,
criticato.
Non per tale motivo, tuttavia, deve venire catturato dallo scetticismo o dal relativismo. I concetti,
infatti, non si riferiscono a se stessi – non dovrebbero – bensì alle cose, al mondo, al mondo della
nostra vita: qui sono radicati e da qui prende avvio la loro genesi storica. Una genesi le cui
articolazioni, dalla nascita nell’antichità greca sino a oggi, è impossibile seguire, tantomeno
ricostruire, ma che prende avvio da due punti fermi: la filosofia ha uno stile, che è qualcosa di più di
un metodo; la filosofia ha un significato, che è qualcosa di più delle sue articolazioni. Stile è, per
riprendere una definizione di Goethe, una caratteristica, intrinseca sia ai metodi sia agli oggetti, che
si basa sui fondamenti più profondi della conoscenza, andando alla ricerca dell’essenza delle cose,
che sono figure visibili e tangibili. Le cose hanno un significato inseparabile dal nostro dirigersi
verso di esse: la filosofia cerca il significato oggettivo dei vari modi con cui esse si esprimono in un
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
percorso dove i concetti sono i momenti costitutivi nella verità di un campo di ricerca. Gli oggetti
non sono i loro significati, anche se loro tramite sono conosciuti, appresi, tematizzati: il significato
“si riferisce” a un oggetto, ma certo non si identifica con esso. Un oggetto ha una pluralità di
significati possibili: indagarli, interrogarli è lo stile della ricerca, il suo modo di chiarificare,
cercandone l’essenza, i concetti intorno ai quali, in questa interrogazione, si è storicamente formata
la filosofia.
Per porre in atto tale genesi è necessario un atteggiamento critico: un atteggiamento che non solo
comprende il senso più profondo della crisi – sociale, culturale e dunque filosofica – che attraversa
il pensiero moderno e contemporaneo, ma che espliciti come sia in tale funzione che si delinea il
concetto di ragione come strumento essenziale per il pensiero. Una ragione che non è vuota, bensì
esercizio che si manifesta attraverso giudizi, correlati a rappresentazioni sensibili. Introdurre la
filosofia significa esibire – esprimere – i modi con cui i concetti manifestano i loro significati in
quanto nessi storicamente determinati tra cose e idee, che si rincorrono vicendevolmente in un
reciproco e costante processo di simbolizzazione.
Nel 1953, introducendo il corso al Collège de France, dal titolo «Mondo sensibile e mondo
dell’espressione», Merleau-Ponty ne delineò lo scopo generale, definendone i temi. In primo luogo,
dunque, il mondo sensibile, le “cose”. Poi il mondo dell’espressione, cioè le cose culturali, gli
oggetti d’uso, i simboli. Il fine, come è ovvio, è quello di «approfondire l’analisi del mondo
percepito mostrando che esso già suppone la funzione espressiva». Esplicitando questa analisi si
sviluppa una «teoria concreta dello spirito», il cui fine è quello stesso della filosofia: «ristabilire
l’unità e nello stesso tempo la differenza del mondo percepito e del mondo intellegibile attraverso
una ridefinizione della coscienza e del senso». In questa ridefinizione bisogna essere consapevoli
che non si deve solo parlare dei luoghi della confusione, «ma anche della regione delle questioni
fondamentali, delle questioni di principio»: «di questioni – come scrive Giovanni Piana – che
vengono per prime, e proprio per questo possono essere dette questioni ultime». Questioni che
tuttavia non devono portare in cime tempestose, ma guardare alle cose che sono intorno a noi, alle
loro intrinseche possibilità, alle immagini con cui si presentano: guardare al loro senso metafisico,
dove metafisica è «tacita esortazione» e «profonda saggezza». In uno dei suoi ultimi scritti, dedicato
a Seneca, Diderot si pone la domanda su quale sia l’oggetto della filosofia, offrendo una risposta
che ne delinea stile e significato: «Legare gli uomini attraverso un commercio di idee e l’esercizio
di una mutua beneficienza», tenendo presente che essa «non ci ordina di tormentarci». Il filosofo,
continua, si sosterrà soltanto «attraverso la grandezza delle cose». Mi sembra un messaggio ancora
attuale.
La ringrazio molto e Le auguro ancora buon lavoro.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
Löwith: il sì di Heidegger al nazismo
di GIORGIO FAZIO
È recentemente uscito, esito di una lunga e complessa ricerca, "Il tempo della secolarizzazione.
Karl Löwith e la modernità" (Mimesis) di Giorgio Fazio. Ne pubblichiamo, per gentile concessione
dell'autore, un estratto, relativo al rapporto di Löwith con Schmitt e Heidegger.
La soluzione nazista alla questione ebraico-tedesca
(...) Löwith non dedicò mai nei suoi scritti dell’esilio una discussione specifica alla dottrina della
razza propagandata dal nazionalsocialismo. In ciò trovò espressione il suo convincimento di fondo
che questa dottrina non fosse altro che una semplice facciata ideologica, funzionale alla «radicale
riorganizzazione» conservatrice e autoritaria attuata dal nuovo regime, che si serviva dei prodotti
razzisti di una rozza zoologia politica per offrire ad una piccola borghesia proletarizzata dalla crisi
economica un surrogato proiettivo della propria perdita di status sociale. Del resto, come osservò
con amara ironia in una lettera a Strauss, il «novum della razza» che il nazionalsocialismo
aggiungeva all’ideologia völkisch-nazionalistica tedesca era «un’idea che si deve a un francese e a
un inglese: Gobineau e Chamberlain!».[1] Nella “soluzione” nazista al problema ebraico-tedesco
Löwith riconobbe essenzialmente «il lato più manifesto della barbarie di principio che sanziona
qualsiasi brutalità al servizio di un mostruoso apparato statale».[2] Il segno di una
«disumanizzazione dell’uomo»: una negazione del fatto elementare e fondamentale che l’uomo è
anzitutto un uomo, nonostante le diversità di razza, di nazionalità, di fede, di classe e di professione,
e che questa sua semplice realtà non è una qualità «piatta e astratta». Da qui il rifiuto che egli
oppose fino all’ultimo a quanti lo sollecitarono a un ritorno all’ebraismo o al sionismo. Già come
tale questa scelta, in quel preciso momento storico, gli apparve l’espressione, simmetricamente
rovesciata, dello stesso disconoscimento perpetuato dall’antisemitismo nazista nei confronti del
«problema naturale della politica», con cui qualsiasi regime politico è costretto a misurarsi: il
problema dell’irriducibilità dell’individualità personale, nelle sue concrete dimensioni di vita e nelle
sue plurali e differenti appartenenze sociali e comunitarie, a qualsiasi unità politica fondata su una
presunta sostanza omogenea del popolo. Non è errato affermare quindi che Löwith rivendicò, dopo
il ’33, una sorta di fedeltà alla tradizione liberale dell’ebraismo assimilato, scorgendo in essa il
presupposto per difendere un punto di vista liberale tout court, fondato sul principio dell’irriducibile
differenza tra vita politica e vita privata e sul richiamo ai diritti universali dell’uomo, in quanto
distinti e irriducibili a quelli del cittadino. «La “e” tra l’essere tedesco e ebreo – come aveva detto
Franz Rosenzweig, un autore scoperto proprio durante l’esilio e divenuto un termine di riferimento
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
molto importante per riflettere sul senso della sua stessa appartenenza all’ebraismo – è una
questione di cadenza: non esistono, su questo, norme generali. Dove debba trovarsi un baricentro e
non due, e come possano distribuirsi i pesi tra questi due baricentri – sono tutte questioni che
ciascun individuo deve decidere per sé e con se stesso. Ma deve poter decidere. Bisogna dargliene
la facoltà. Io non oserei mai regolamentare la vita. Sarebbe in contraddizione con la realtà non
scritta dell’“e”, che per me è addirittura una necessità di fede».[3]
Tutto ciò non vuol dire, però, che la “soluzione” nazista alla questione ebraico-tedesca e la stessa
nuova condizione “estraniata” di ebreo discriminato per motivi razziali non incisero sul
riorientamento che Löwith impresse alla sua ricerca in seguito alla Machtergreifung nazista. Questa
nuova condizione gli offrì senza dubbio un punto di vista conoscitivamente “privilegiato” per
ragionare sulle logiche e sui dispositivi del nuovo stato totalitario ma, al di là di ciò, anche per
riflettere sul peso di una dinamica che non a caso, soltanto dopo il ‘33, iniziò a conquistare il
proscenio della sua produzione filosofica: la questione della secolarizzazione del cristianesimo.
Non diversamente da altri esponenti della diaspora filosofica ebraica tra le due guerre – come
Adorno, Horkheimer, Arendt, Plessner, per citare soltanto alcuni di coloro con i quali entrò in
contatto durante gli anni dell’esilio – anche per Löwith la partenza dalla Germania coincise con
l’interruzione delle linee di ricerca che stava seguendo fino a quel momento e con il loro
dirottamento su un’unica questione fondamentale: quella della genesi e delle radici della “catastrofe
tedesca”. Le domande di Löwith non furono diverse da quelle che si posero molti altri intellettuali,
non solo ebrei, in tutta Europa: come era stato possibile che nel paese in cui erano germogliate,
negli anni della klassische Zeit di Weimar, alcune tra le forme più elevate dell’umanesimo europeo,
si era potuto affermare un movimento politico di massa che operava una soluzione di continuità
senza precedenti nei confronti del continuum di valori della civiltà europea? E come era stato
possibile soprattutto che ampi settori della cultura e dell’intellettualità tedesca non ebraica si erano
allineati entusiasti a questo tipo di soluzione politica alla crisi della Germania del primo dopoguerra
e più in generale alla crisi del mondo liberale?
Per tentare di dare una risposta a questi interrogativi, Löwith si vide costretto a tornare sulle
posizioni radicali del dibattito filosofico tedesco con le quali si era confrontato negli scritti
precedenti, individuando ora in esse una sorta di lontana responsabilità nella genesi delle premesse
“spirituali” e ideologiche della catastrofe che si era consumata con la Machtergreifung nazista. Si
era trattato, come Löwith chiarirà negli scritti dell’esilio, di un tipo di responsabilità “indiretta”, che
non era stata quella di chi compie le azioni politiche, magari volgendo in prassi le dottrine
ideologiche altrui, ma piuttosto quella di chi, con le proprie visioni e con le proprie idee, aveva
preparato un clima intellettuale in cui certe cose si sono rese possibili. Proprio la tendenza a
consumare ogni margine di differenziazione tra filosofia e prassi, tra riflessione teorica e richiamo
all’azione diretta, e a radicalizzare la critica agli istituti e alla cultura del mondo borghese-cristiano,
in un nome di un’ultima verità fondamentale, finalmente riappropriabile nella crisi definitiva del
vecchio mondo – questa sarà la tesi di Löwith – ha contribuito in maniera decisiva alla progressiva
degenerazione della cultura politica, all’erosione di ogni terreno d’intesa condiviso, preparando la
disponibilità di molti esponenti degli stessi ceti borghesi e intellettuali a soluzioni politiche estreme.
Soluzioni che non sono state la diretta conseguenza di quelle filosofie radicali, ma che tuttavia ne
hanno svelato l’intrinseca equivocità e pericolosità.
La tesi di una “responsabilità indiretta” del radicalismo filosofico tedesco costituì però soltanto il
primo passo di una ricerca genealogica che ampliò progressivamente il proprio raggio di analisi,
risalendo indietro nel passato e individuando le radici del radicalismo teorico post-hegeliano nella
stessa filosofia di Hegel: più determinatamente, nel modo con cui l’ultimo rappresentante della
filosofia classica tedesca aveva compreso filosoficamente, in un ultimo e grandioso affresco di
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
filosofia della storia, gli eventi che avevano definito il profilo della modernità politica europea. La
comprensione filosofica di questi eventi – la Rivoluzione Francese e il dominio napoleonico – si era
risolta in una mondanizzazione della visione escatologica cristiana della storia, ossia nella
«trasformazione della storia cristiana della salvezza in una teodicea mondana, per la quale lo spirito
divino è immanente al mondo, lo Stato è un Dio terreno e la storia in genere rappresenta qualcosa di
divino».[4] La tesi di Löwith sarà che precisamente questa tendenza, specificamente tedesca, perché
radicata nella storia del protestantesimo luterano, a trasformare la filosofia in una teologia
razionalizzata, che rifunzionalizza le categorie e gli schemi concettuali della fede in una visione
filosofica capace di mediare in sé i contrasti e le contraddizioni della società moderna, ha costituito
l’origine del divenire spirituale della filosofia successiva. Il radicalismo filosofico post-hegeliano è
stato messo in moto da una doppia tendenza, come metterà in luce Löwith: da una parte dalla
volontà di smascherare il carattere ideologico della onto-teo-logia hegeliana, emancipandosi
compiutamente dal cristianesimo e dalle sue forme secolarizzate, dall’altra però di dare una
soluzione definitiva alle scissioni della società borghese che proprio Hegel aveva riconosciuto e
mediato nella sua filosofia. Proprio quest’ultima tendenza ha tradito il perpetuarsi di una meccanica
di sostituzioni e di trasferimenti di funzioni e di concetti della tradizione cristiana, che alla fine si è
risolta nella dismissione delle funzioni della filosofia e nella sua capitolazione rispetto a una storia e
a una politica investita di un’aspettativa escatologica di salvezza. E proprio questo radicalismo ed
estremismo filosofico post-hegeliano hanno costituito l’antefatto filosofico di una politica come
religione che, investendosi del compito “salvifico” di risolvere definitivamente il problema della
società borghese e della modernità, corrispondendo ai presunti bisogni del tempo e alle necessità del
destino, ha dato vita a mostruosi apparati statali totalitari che hanno disumanizzato gli uomini
concreti.
La chiave di lettura genealogica della secolarizzazione, quale strumento di comprensione della
genesi dei totalitarismi novecenteschi, entrò quindi stabilmente nel repertorio di temi della
riflessione di Löwith soltanto dopo il ‘33. Ed è difficile non cogliere come un ruolo decisivo
nell’acquisizione di questa prospettiva lo giocò la nuova condizione di ebreo discriminato e il nuovo
punto di osservazione “privilegiato” che questa condizione gli offrì per riflettere sul ruolo della
dinamica della secolarizzazione del cristianesimo, in particolare nella cultura “protestante”, nel
preparare i presupposti ideologici della protesta della Germania nei confronti dell’umanesimo
europeo.
Nel corso degli scritti dell’esilio, la chiave di lettura della secolarizzazione verrà progressivamente
dilatata nel suo campo di applicazione. Già nell’opera successiva a Da Hegel a Nietzsche, Meaning
in History, scritta durante il suo esilio negli Stati Uniti, Löwith punterà a mostrare come la
secolarizzazione dell’escatologia cristiana abbia attraversato longitudinal- mente l’intera storia del
pensiero occidentale e sia stata alle origini delle sue più profonde patologie culturali. Patologie che
quindi hanno trovato nella storia dello spirito tedesco da Hegel a Nietzsche, e nelle conseguenze
non volute e non intenzionali che ne sono seguite, soltanto il loro ultimo terreno di radicalizzazione
e di estremizzazione. (...)
Il decisionismo politico di Carl Schmitt e la guerra civile europea
La tesi di un nesso genetico tra giacobinismo e stato totalitario novecentesco viene ripresa più volte
da Löwith negli scritti dell’esilio e viene formulata anche nel carteggio con Leo Strauss, dove egli
osserva, sempre rispondendo alle prese di posizioni politica del suo interlocutore, che «il fascismo è
senz’altro un’escrescenza della democrazia».[5]Al fondo di questa affermazione sta la tesi,
condivisa da Löwith con molti altri critici liberali della democrazia, che lo stato moderno europeo,
uscito dalla Rivoluzione francese e dal dominio napoleonico, ospita al proprio interno la
compresenza di due forze tra loro contrastanti – uguaglianza e libertà, rispetto dei diritti del
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
cittadino e rispetto dei diritti dell’uomo – ma tende a risolvere questa difficile tensione a vantaggio
del primo elemento.[6] Questa tendenza scaturisce dall’assunto, proprio del modello roussovianogiacobino di democrazia, che l’unità di una repubblica debba poggiare sul fondamento di
un’omogeneità del popolo. In Rousseau, questo principio era legato al progetto “pedagogico” di
formare l’uomo come cittadino e di elevarlo all’interesse universale della democrazia,
recuperandolo dalla sua alienazione borghese e agendo con ciò sulle origini morali della
disuguaglianza. Nelle dottrine dello stato totalitario fascista e nazista, la pretesa alla formazione
dell’uomo rinviava invece ormai a nozioni programmaticamente non universalistiche e non
ugualitarie di ciò in cui consiste l’autenticità del popolo e la corrispondente omogeneità che deve
essere salvaguardata e prodotta. Tuttavia, tra l’uno e l’altro modello esiste comunque un nesso, notò
Löwith, che sta nell’investire la politica della funzione “salvifica” di risolvere la differenza tra
homme-bourgeois e citoyen forgiando un uomo identificato senza residui con i valori omogenei
della comunità politica, quale fondamento dell’unità dello Stato.
«Gli stati totalitari dei nostri giorni sono quindi il tentativo di dare una risposta alla domanda di
Rousseau: come è possibile fare accordare l’uomo, che già nello stato naturale rappresenta in certo
modo una totalità, con la totalità completamente differente della société politique?».[7] Per
realizzare la pretesa alla formazione dell’uomo «lo stato totalitario deve logicamente combattere
assieme ai diritti dell’uomo anche il cristianesimo, poiché questo costituisce un ostacolo alla fusione
dell’homme con il citoyen». Proprio questa lotta alla religione cristiana esprime un processo di
trasferimento di prerogative sacrali sulla idea di sovranità politica, che si traduce nell’eliminazione
del pluralismo interno allo Stato, nella negazione della differenza tra pubblico e privato, quindi
delle prerogative di libertà privata del singolo, e nell’inversione della differenza tra sacro e profano
contro chi, in quanto non appartenente ai criteri politici stabiliti dalla sovranità politica, è
disconosciuto della stessa qualità di uomo e in quanto tale sacrificabile.[8]
Alla luce di queste riflessioni, si comprende perché il secondo grande confronto cui Löwith si
dedicò subito dopo la Machtergreifung nazista fu con il pensiero politico di Carl Schmitt. A Schmitt
Löwith dedicò il suo ultimo seminario tenuto all’università di Marburgo nel semestre invernale ‘33’34. Dalla rielaborazione dei materiali di questo corso ricavò poi il saggio Decisionismo politico,
pubblicato nel 1935 presso la rivista giuridica «Revue internationale de la théorie du
droit/Internationale Zeitschrift für Theorie des Rechts”, sotto la firma pseudonima di Hugo Fiala,
presunto professore dell’università di Madrid. Sul pensiero di Schmitt Löwith ritornò poi nel saggio
Max Weber und seine Nachfolger, ma la presenza del pensiero del giurista è visibile in molti testi
dell’esilio e, come si vedrà, è rinvenibile al fondo della stessa struttura concettuale di Da Hegel a
Nietzsche.
Per Löwith fu senz’altro significativo scoprire che già nel testo del 1921 La dittatura Schmitt
avesse rivendicato esplicitamente una continuità tra il principio democratico della sovranità
popolare, nella sua specifica declina- zione giacobina, e il concetto di dittatura autoritaria.
Richiamandosi direttamente a Il contratto sociale di Rousseau, in questo testo il giurista aveva
difeso la tesi che «la dittatura non sta in alcun contrasto necessario con la democrazia, ma può
congiungersi con essa. Infatti, alla sua essenza appar- tiene solo l’accordo della volonté générale
con la volonté de tous, l’identità di governanti e governati, di popolo e stato, di volontà popolare e
Legge, di massa e guida. La volontà del popolo non ha bisogno però di essere raggiunta tramite
elezione segreta e per il numero di voti: essa può venire espressa, perfino in modo più originario e
più credibile, per acclamazione. Gli stessi metodi dittatoriali possono direttamente essere
espressione di una sostanza democratica». Una democrazia, aveva affermato Schmitt, «può essere
mi- litarista o pacifista, assolutista o liberale, progressiva o reazionaria, senza per questo smettere di
rimanere di principio una democrazia, di riconoscere l’uguaglianza politica dei cittadini».[9]
Schmitt era potuto giungere così alla conclusione che la rivoluzione fascista e quella russa, avendo
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
prodotto un’o- mogeneità democratica e con ciò i fondamenti per una volonté générale sono
antiliberali ma non antidemocratiche. Queste tesi erano state riprese nel testo del 1927 Dottrina
della costituzione, dove Schmitt aveva compiutamente articolato la propria concezione identitaria di
democrazia di massa, fondata su una popolazione omogenea e guidata da un leader carismatico. Qui
la tesi dell’identità tra democrazia e dittatura era stata ulteriormente affermata rinviando al principio
dell’identità tra eguaglianza democratica e uguaglianza sostanziale. L’uguaglianza politica non
andava intesa nel senso dell’uguaglianza impolitica di tutti gli uomini dell’umanità sommata in
termini individualistici – aveva affermato il giurista - ma come una sostanza concreta,
un’omogeneità o un’uguaglianza di stirpe: l’appartenenza a una determinata razza comune, a
credenze, a un destino comune e a una tradizione. Laddove questa uguaglianza politica, a differenza
dell’idea liberale di uguaglianza umanitaria, ha sempre come correlato una possibile
disuguaglianza, quindi un’esclusione, come nell’antichità l’essere-greco si differenziava dall’essere
barbaro e l’essere liberi dall’essere schiavi.
Schmitt aveva inscritto queste tesi sulla democrazia in una ben determinata lettura del processo di
secolarizzazione, che puntava a riabilitare deliberatamente la teologia politica. Nel testo del 1922
Teologia politica, il giurista aveva sostenuto la tesi che tutti i concetti giuridici che sono espressione di una decisione sovrana, del potere e del dominio, sono concetti secolarizzati, che non solo
linguisticamente richiamano le idee teologiche, ma che sono anche sostanzialmente provenienti da
esse.[10] Secondo la sua lettura genealogica della modernità, agli albori della modernità, il nuovo
Stato moderno ha potuto garantire legittimità all’ordine sociale e spegnere il conflitto confessionale
religioso, solo in quanto ha riprodotto e trasferito le funzioni di legittimazione dell’ordine politico,
assolte in precedenza dal fondamento cristiano, all’interno dei propri apparati istituzionali. I
concetti e le procedure giuridiche moderne devono il loro funzionamento normale all’esistenza di
un’istanza decidente, da essi non ricavabile e pure di essi fondante, che fa sporgere l’ordinamento
giuridico sull’eccezione: un’istanza che, in analogia al ruolo che il miracolo ha nella teologia,
coincide con la prerogativa ultima di dichiarare lo stato di eccezione e di ristabilire, attraverso
l’espulsione del nemico che mette in pericolo l’unità dell’ordine, le condizioni di normalità sulla
base delle quali soltanto possono funzionare e attivarsi le procedure giuridiche e istituzionali. Il
sovrano politico si rivela quindi esclusivamente nel momento in cui decide, in una situazione data,
quale sia l’effettiva unità sostanziale del popolo, impegnandosi a respingere come nemico chiunque
minacci l’unità che si è affermata in questo modo. Ma proprio questa verità, questa la diagnosi
critica di Schmitt, era stata cancellata e rimossa nell’epoca del predominio della democrazia
liberale, del pensiero naturalistico e di un’economia costituita su concetti naturalistici.[11]
Nel saggio del ’3 Decisionismo politico, Löwith non manca di evidenziare come la teoria
schmittiana della secolarizzazione costituiva anche lo sfondo su cui prendeva forma una critica
“morale” all’uomo della società borghese, che attingeva al repertorio di temi classici della
Kulturkritik del pensiero conservatore europeo. Nelle forme di vita borghesi, Schmitt aveva additato
la manifestazione di una vita spogliata di ogni virtù pubblica, limitata in un orizzonte privato che si
esaurisce nel ciclo della produzione e del consumo e trova la propria auto-realizzazione nella
sicurezza degli agi e dei comforts, nell’intrattenimento e nel godimento estetici, smarrendo il senso
della virtù politica come ardimento e coraggio, come disponibilità al sacrificio fino alla morte per i
valori della propria comunità politica. Prendendo posizione contro la decadenza e la corruzione
dell’elemento serio della vita umana nella società borghese, Schmitt si opponeva quindi anche
“moralmente” allo status quo liberale, invocando un ritorno dal «niente culturale e sociale» dell’età
della spoliticizzazione liberale ad una «natura integra e non corrotta» dell’uomo, dalla cui forza far
scaturire nuovamente un «ordine delle cose umane».[12]
Si può dire quindi che Löwith ebbe effettivamente la conferma nel confronto con Schmitt di una
serie di nessi concettuali già colti in Rousseau e in particolare del connubio tra critica secolarizzata
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
dell’alienazione dell’uomo borghese e teologia politica. Rispetto a Rousseau, a mutare in Schmitt,
oltre all’assenza di uno «sviluppo onesto» delle contraddizioni tra homme-bourgeois e citoyen ossia la mancanza di una chiara visione delle aporie intrinseche al tentativo di eliminare del tutto i
diritti dell’uomo in funzione di quelli del cittadino - era l’orientamento politico. E l’espressione di
ciò è che, accanto alla lotta contro il liberalismo, Schmitt si era richiamato per fondare il proprio
attacco alla società borghese alla teologia politica dei pensatori controrivoluzionari: De Maistre, de
Bonald, e soprattutto Donoso Cortès. (...)
La critica che Löwith sviluppa nel suo saggio del ‘3 contro questo intero impianto teorico ruota
attorno a due temi fondamentali: in primo luogo, il tratto occasionalistico del concetto radicalmente
decisionistico della politica di Schmitt e in secondo luogo le aporie della sua critica alla distinzione
“liberale” tra pubblico e privato, compiuta in nome di un concetto totalitario della politica.
In realtà, osserva Löwith in questo saggio, dietro il richiamo all’identità comune del politico, non vi
è in Schmitt alcuna credenza in identità ascrittive, fondate sull’esistenza di caratteri comuni per
tradizione, linguaggio e razza. Allo stesso modo, alla base della sua critica teologico-politica alla
forma dello Stato liberale non vi è alcuna reale credenza religiosa in un fondamento teologico dello
Stato politico. Lo stesso richiamo alla teologia politica dei pensatori della controrivoluzione «non è
impegnativo»: Schmitt attribuisce a Donoso Cortés posizioni che non erano proprie del pensatore
cattolico, il quale lungi dal credere che l’essenza dello Stato si riduce a una decisione assoluta e
creata dal nulla del tutto ingiustificabile, «era un buon cristiano e credeva che solo Dio possa creare
qualcosa dal nulla, non l’uomo».[13] L’idea di una decisione sovrana creata dal nulla è peculiare di
Schmitt, che reinterpreta in questo modo il principio moderno della sovranità popolare, non invece
di Donoso Cortès, ai cui occhi la Rivoluzione francese, che dichiarava sovrani l’uomo e il popolo,
era apparsa come una ribellione contro l’ordinamento della creazione e pertanto «avrebbe veduta in
una decisione creata dal nulla qualcosa di non meno grottesco che nell’e- terno dialogo del
romanticismo».[14]
Il concetto del politico di Schmitt è in realtà un concetto radicalmente decisionistico, argomenta
Löwith: esso ha una natura totalmente formaliz- zata ed esistenziale, che è diretta conseguenza
dell’annuncio nietzscheano del nichilismo europeo. Lo stesso Schmitt ne Il concetto del politico,
pone in evidenza Löwith, aveva affermato che «il politico non ha alcuna sostanza propria» e alcun
ambito oggettivo di riferimento: esso «può trarre la sua forza dai più diversi settori della vita
umana, da contrapposizioni religiose, economiche, morali o di altro tipo; esso infatti non indica un
settore concreto particolare ma solo il grado di intensità di un’associazione o di una dissociazione di
uomini, i motivi della quale possono essere di natura religiosa, nazionale (in senso etnico o
culturale), economica o di altro tipo e possono causare, in tempi diversi, differenti unioni e
separazioni».[15] Proprio perché manca di un contenuto proprio, questo era il senso dell’argomento
di Schmitt, il sovrano politico si rivela esclusivamente nel momento in cui decide, in una situazione
data, quale sia l’effettiva unità sostanziale del popolo, impegnandosi a respingere come nemico
chiunque minacci l’unità che si è affermata in questo modo. Sul piano teorico, però, la distinzione
politica alla quale è possibile ricondurre le azioni e i motivi politici è esclusivamente «la distinzione
di amico (Freund) e nemico (Feind)», al di là dei contenuti di questa contrapposizione. Posta questa
definizione del politico, però, è strutturalmente indifferente, nel quadro teorico di Schmitt, su quali
forze e su quali contenuti lo Stato ripone la sua determinata peculiarità. Ciò che importa non è se lo
Stato sia fatto o ordinato in questo o in un altro modo: «ciò che conta è solo che esso sia un’unità
politica che dà la norma, che decide sovranamente sopra la vita degli uomini». I possibili contenuti
dell’essenza dello stato si riducono al fatto che in generale questo status in quanto tale esiste ed è
capace di decidere sul suo essere e sul suo non essere, con la conseguenza che ogni contenuto è
indifferente rispetto all’affermazione dell’unità sovrana come tale. L’unico presupposto
“normativo” di questa concezione è la negazione dello stato pluripartitico liberale.[16]
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
La stessa distinzione amico-nemico quale criterio del politico, osserva Löwith, non ha alla propria
base alcun fondamento di giustificazione, razionale o sostanziale. Schmitt dà l’impressione di
riferirsi a caratteristiche inscritte nella diversa natura delle comunità politiche ma, in realtà, questa
stessa distinzione «non ha nulla di specifico in sé e viene intesa puramente o solamente in senso
esistentivo». Se si assume che è il sovrano a decidere caso per caso se è dato il pericolo di unità
dello stato in presenza di un nemico reale, risulta impossibile affermare che il nemico come tale
neghi la propria concreta «forma di esistenza» o il proprio concreto «modo» di essere. Di un altro
determinato come estraneo o nemico non può dirsi nulla di più e nulla di meno che esso neghi «il
factum brutum dell’esserci pubblico-politico, al di qua di ogni più particolare determinazione
secondo i differenti tipi dell’essere etnico e razziale, religioso e morale, civilizza- torio ed
economico», e di «tutte le distinzioni e le profonde somiglianze specifiche dell’essenza degli
uomini».[17]
Com’è possibile riconoscere “giustamente” la situazione politica nella sua totalità e distinguere
“giustamente” tra nemico e amico, se questo riconosci- mento si restringe di fatto allo stabilire che,
in caso di emergenza, tanto l’una che l’altra parte deve decidere con piena sovranità, se questo caso
di emergenza è veramente dato, o no, e chi, “dato il caso”, nega il proprio modo di esistenza
politica.[18]
Löwith può concludere quindi su questo punto: posto che la teoria del politico di Schmitt non
afferma una decisione politica piuttosto che un’altra, sulla base di presupposti oggettivi e normativi
fissi, ma l’anormale diritto della decisione sovrana in quanto tale, il decisionismo politico ha un
tratto irriducibilmente occasionalistico e quindi ideologico, ossia teso a giustificare qualsiasi energia
politica sovrana, purché antiliberale e anticomunista. La teoria politica di Schmitt, quindi, non fa
che riesibire, in termini simmetricamente rovesciati - decisionistici e non estetici - quella stessa
passività dell’esistenza romantica rispetto alle forze politiche domi- nanti, in cui Schmitt stesso, nel
suo testo giovanile Romanticismo politico, aveva individuato il contrappasso di un’esistenza
romantica che insegue il miraggio di una piena sovranità sulla propria società e sul proprio tempo,
divenendo in realtà funzione di decisioni prese da altre.[19]
Per Löwith la dimostrazione più eloquente dell’occasionalismo della teoria politica di Schmitt era
stata data da lui stesso nel momento in cui, in seguito alla presa del potere nazista, egli aveva
abbandonato, con precisa puntualità, lo stesso apparato teorico del decisionismo difeso fino a quel
momento, facendosi interprete di un «pensiero politico tedesco e ordinativo», e garantendosi in
questo modo una piena sintonia con il nuovo corso politico-ideologico nazista. In altre parole:
quando il caso d’eccezione politico era stato di fatto eliminato da una Decisione sovrana, il pericolo
comunista sventato e la crisi della democrazia liberale risolta in termini autoritari, anche la teoria
politica del decisionismo era stata superata dalla realtà. Con questo abbandono del decisionismo
politico Schmitt, però, osserva Löwith, si era tradito solo in apparenza: poiché il suo pensiero, se
mai, era rimasto “fedele” a se stesso proprio in questo, svolgendosi «da un normativismo estremo
(nello scritto sul Wert des Staates, 1927), al concetto decisionistico della politicità (1927) fino al
pensiero ordinativo (del 1934), ripensando fedelmente quello che più lo aveva colpito volta per
volta, nelle situazioni politiche».46 Ma anche questo pensiero «specificamente tedesco» e
«ordinativo» non era altro che un’ulteriore cornice ideologica, dietro la quale si nascondeva la
verità ultimo del suo pensiero politico: l’essere espressione di un nichilismo passato all’azione.
Nel saggio Decisionismo politico, Löwith si sofferma, come si è detto, anche su quello che può
essere considerato il rovescio interno dell’idea di una totale omogeneità del demos quale base
dell’unità politica: la negazione del pluralismo interno allo stato e la critica dei diritti universali
dell’uomo.[20] Per mostrare le aporie cui va incontro questo secondo versante della teoria del
giurista, Löwith pone in evidenza come, in realtà, neppure Schmitt ha mai potuto sottrarsi «alla
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
distinzione di pubblico e privato» e di conseguenza neanche al problema della loro connessione.[21]
A veder bene, infatti, questo problema si ripresenta nello stesso stato di eccezione della guerra, dove
pure, secondo la teoria di Schmitt, l’esercizio assoluto della sovranità dovrebbe far assumere
definitivamente allo status politico «de facto valore normativo su tutti gli obblighi ad esso
subordinati», rendendo ineffettuale la stessa distin- zione pubblico-privato.[22] La dimensione del
politico non è totale nemmeno nello stato di eccezione della guerra: anche qui non si diventa
senz’altro e semplicemente nemico del nemico, ma si conserva tanto dall’una che dall’al- tra parte
qualità “private” apolitiche che rinviano alla «durevole e insopprimibile esistenza» di forme di
obbligazione impolitica e universalmente uma- na, capaci di trascendere i confini delle
appartenenze politiche secondo la logica amico-nemico.[23] La stessa possibilità di compiere
suicidio in guerra, di lasciarsi uccidere così che «la propria volontà di morire dia l’impressione di
un eroico sacrificio per la comunità», nota Löwith, è un caso limite che testimonia il residuo
margine di libertà di movimento - e di dissenso - che il singolo può far valere anche in uno stato
totale, contravvenendo alla pretesa riduzione della vita umana alla logica del politico.
Ribadendo le insormontabili contraddizioni che nascono da ogni tentativo di superare la differenza
tra homme-bourgois e citoyen, tra diritti universali dell’uomo e diritti del cittadino, Löwith conclude
su questo punto notando come una teoria che non rinunci a «comprendere che cosa sia la politica» e
si concentri sui problemi posti dal «caso normale» della convivenza umana in un ordinamento
comune», non può in alcun modo limitarsi a fondare l’unità dello stato astraendo dal pluralismo e
dall’irriducibilità dell’uomo alla quali- tà di cittadino. Schmitt non si avvede, osserva Löwith, come
sia sempre esi- stita una risposta ed una proposta politica incentrata sul dialogo che non sia la
«cosiddetta discussione» liberale: quella per esempio che si è data «nella comunità pubblica della
polis greca e nel dialogo platonico».[24] Ciò rimanda al fatto che un ordine politico può attingere
un fondamento di legittimità solo se si mostra in grado di ancorare la «base dell’esistenza politica
comune» su un vincolo che obblighi al riconoscimento delle prerogative di autonomia individuale
piuttosto che negarle, e che accolga le differenze e il pluralismo piuttosto che espellerli come dati
inconciliabili con l’unità politica. [25] Queste forme di riconoscimento sono esplicitamente negate
dalla dottrina totalitaria dello Stato di Schmitt, e tuttavia, osserva Löwith, egli è comunque costretto
a porsi il problema di stabilire «una qualche uguaglianza che sostenga e garantisca umanamente
l’unità politica fra colui che guida e coloro che gli ubbidiscono». Fino a quando rimaneva un puro
decisionista, egli poteva non determinare in cosa consista questa sostanza omogenea della
democrazia dit- tatoriale. Dopo il ’33, egli risolve questo problema abbracciando la dottrina
antisemita della razza propugnata dal regime nazista. Qui la sostanza dello stato totale diventa
«l’uguaglianza di stirpe degli appartenenti al popolo», ossia «l’uguaglianza etnica nel senso della
razza» ariana, quanto ora doveva assicurare l’uguaglianza democratica del Führer con la sua
Gefolgschaft».[26] Una prova ulteriore, per Löwith, del fatto che l’antisemitismo, tanto in Schmitt
quanto nel nazismo, è l’espressione ultima di una violenta rimozione del problema umano e
naturale della politica. (...)
Il Sì di Heidegger a Hitler
Prima di verificare il modo in cui i confronti con Rousseau e con Schmitt costituirono per Löwith
due stazioni fondamentali nel percorso di definizione della sua genealogia filosofica della catastrofe
tedesca ed europea, è necessario soffermarsi sul modo in cui, proprio la categoria di occasionalismo decisionistico, utilizzata nella critica a Schmitt, costituì lo strumento di cui egli si servì anche
per interpretare l’adesione di Heidegger al nazismo. Löwith fu uno dei primi a riconoscere nel corto
circuito tra filosofia e politica, tra attività intellettuale e propaganda politico-ideologica, che prese
corpo nei testi e negli interventi in cui si consumò il breve periodo d’impegno pubblico di
Heidegger in favore del regime nazista in qualità di rettore dell’università di Friburgo, ben più che
un semplice sviamento personale, dettato magari dall’ambizione umana-troppo umana di porsi alla
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
guida filosofica del nuovo corso storico della Germania. Piuttosto, che Heidegger non fosse riuscito
ad attingere dalla sua filosofia strumento teorico alcuno capace di metterlo nelle condizioni di
distanziare criticamente la sequenza di eventi che avevano portato alla presa del potere di Hitler e
che, proprio come Schmitt, avesse potuto riformulare concetti e categorie filosofiche fino a renderli
possibili strumenti di legittimazione ideologica del nuovo regime, costituì la prova, agli occhi di
Löwith, dell’orizzonte politico della sua filosofia. Rappresentò la dimostrazione in altre parole della
«sostanziale omogeneità della filosofia di Heidegger con l’atmosfera e la mentalità
nazionalsocialiste».[27]
Löwith verificò queste tesi attraverso una particolareggiata analisi della famigerata Prolusione di
rettorato che Heidegger tenne a Friburgo pochi mesi dopo la presa del potere di Hitler e che, per un
dubbio senso di cortesia, il filosofo stesso aveva avuto la “premura” di recapitare personalmente a
Löwith, con l’accompagnamento di «amichevoli saluti».[28]Una volta ricevutolo, Löwith riconobbe
da subito in questo testo un valore filosofico che lo distaccava dagli innumerevoli libelli e discorsi
che i professori allineati avevano prodotto dopo il rivolgimento nazista. Per questa ragione lo trasformò nell’oggetto di un’attenta considerazione filosofica.
A colpirlo fu innanzitutto l’ambiguità della sua trama argomentativa. Heidegger era riuscito infatti
ad adattare in questo testo le categorie onto- logico-esistenziali di Essere e tempo così
sapientemente all’«istante storico» da dare l’impressione che «intenzioni filosofiche e situazione
politica, libertà della ricerca e coercizione statuale potessero e dovessero coincidere a priori».[29]
Attraverso questa operazione egli aveva potuto dare un fondamento filosofico tanto alla
Machtergreifung nazista quanto alla propria presa di posizione in suo favore, al prezzo però di
un’indistinzione di piani tra filosofia e politica, tra «servizio del sapere», «servizio del lavoro» e
«servizio militare», che metteva capo alla «quintessenza dell’ambiguità», per cui alla fine non si
sapeva se si doveva mettere mano ai Vorsokratiker di Diels o marciare con le SA.[30]
Il tema fondamentale di questo Discorso era quello dell’«autoaffermazione dell’università». Questo
tema era svolto in esplicito contrasto con «la forma liberale della libertà accademica e
dell’autonomia amministrativa» e inquadrato interamente «nello schema nazionalosocialista della
“guida” e dei “seguaci”». Heidegger proclamava che «il rettore ha il dovere di guidare
spiritualmente gli insegnanti e gli studenti, tuttavia anch’egli – il Führer – è a sua volta guidato dalla
“missione spirituale del suo popolo” ». Il destino del popolo veniva legato quindi alle sorti delle
università, per cui la missione dell’università era identica a quella che concerneva il popolo: scienza
tedesca e destino tedesco dovevano conseguire potenza in un’unica «volontà essenziale». Senza
chiarire i contenuti e le forme di legittimazione di questo compito storico del popolo tedesco,
Heidegger si appellava quindi al «destino che bisogna volere» e alla fine era proprio esso che
giustificava qualsiasi volere, «ammantandolo di filosofia della storia».[31]
Apparentemente, notò Löwith, proprio il concetto di destino storico, che svolgeva la funzione di
legittimazione ultima della scelta in favore di Hitler, esibiva una differenza radicale rispetto al
concetto di storicità autentica messo a punto nelle ultime pagine di Essere e tempo. Nell’opera del
’27, la storicità era stata ancorata infatti alla temporalità esistenziale di un’esistenza risoluta,
rinviata alle possibilità autentiche della propria fatticità dall’anticipazione della morte. Negli ultimi
paragrafi di Essere e tempo, Heidegger aveva affermato esplicitamente che «la storicità autentica
deve essere compresa come l’attimo estatico sgorgante dal futuro, e solo rispetto al futuro autentico
anche la storia passata può essere compresa autenticamente»: l’autentica storicità «comprende la
storia come il ritorno del possibile e sa che la possibilità si ripete solo se l’esistenza è aperta nella
ripetizione risoluta in modo destinale-attimale».[32]Nel Discorso di rettorato, questo impianto
concettuale sembrava capovolgersi: Heidegger concepiva ora la storicità autentica come la
ripetizione di un passato sostanziale, proprio di una comunità di destino etnicamente omogenea -
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
quella tedesca – che doveva «trovare e conservare la grandezza della sua destinazione», come
qualcosa di sostanziale, quindi, a cui lo stesso Führer era soggetto, nel suo esserne ultimo interprete
e profeta. D’altra parte questa autoaffermazione veniva parimenti concepita come una missione di
portata storico-spirituale, perché ad essa era demandato il compito di interrompere, con un nuovo
inizio della storia, la degradazione prodotte dalla Zivilisation moderna, facendo rivivere nel presente
l’idea di spirito e di Kultur, rivelatisi originariamente agli albori della civiltà europea nella Grecia
classica. In realtà, come notò Löwith, al fon- do di questa discontinuità con Essere e tempo si
nascondeva una chiara continuità: il movente ultimo tanto dell’appello a decidersi risolutamente per
se stessi trasmesso implicitamente da Essere e tempo quanto della volontà politica di
autoaffermazione del popolo tedesco era «la coscienza della decadenza e del trapasso, ossia il
nichilismo europeo». Era la risoluta convinzione che tutti i valori, gli ordinamenti, i fini essenziali e
i criteri tradizionali si erano interamente vanificati nel mondo della progressiva oggettivazione
razionale dell’uomo e del suo mondo, indotta dall’avanzamento del dominio tecnico-capitalistico.
Una convinzione, questa, che in Heidegger, come Löwith aveva già messo in evidenza, aveva la
propria segreta fonte d’ispirazione nell’attacco di Kierkegaard contro il suo tempo e nella sua lettura
“protestante” della vita pubblica moderna e della generalità pubblica. Heidegger aveva reso profano
il paradosso della fede di Kierkegaard e trasformato la dialettica cristiana tra peccato e salvezza nel
movimento di un’esistenza che deve riprendersi da sé stessa dalla sua deiezione nella sfera
pubblica, appropriandosi delle possibilità più au- tentiche inscritte nella propria effettività. Questa
effettività, intesa come «ciò che resta della vita una volta scarnificata da ogni contenuto e da ogni
determinazione di essenza», era qualcosa di costitutivamente indeterminato. L’appello a decidersi
per se stessi e per la propria fatticità era privo di criteri atti a orientare un processo di effettiva
individualizzazione e di responsabilizzazione del singolo, perché mancante del riferimento a un
sistema di vincoli e di norme intersoggettivamente condivise e universali, tutte interpretate, in
ultima istanza, come fattori di allontanamento e di dispersione del singolo dalla propria stessa
autenticità. L’appello a decidersi per se stessi era quindi il rimando a una decisione per il nulla, che
invece di illuminare le condizioni di una libera ricerca della propria peculiare forma di vita, sulla
base del riconoscimento del pluralismo dei modi di vivere, garantito da una sfera pubblica fondata
sulla condivisione di norme astratte e di orientamenti universali, si risolveva in un vuoto
decisionismo, in cui l’unico punto certo era la polemica contro la sfera pubblica moderna. Proprio
questo decisionismo aveva perciò in sé tutti i tratti dell’occasionalismo rilevati da Schmitt nella sua
critica del romanticismo politico, e riconosciuti da Löwith alla base del suo stesso decisionismo
politico antiromantico e secolarizzato. Anche quella di Heidegger, in altre parole, era la filosofia di
una borghesia in lotta con se stessa: una filosofia che celebrava l’autenticità del singolo e la sua
decisione per se stesso contro la sfera pubblica moderna, ma che era pronta a ribaltarsi in
giustificazione di qualsiasi rivolgimento e di qualsiasi rottura politica autoritaria e reazionaria,
purchè capace di interrompere il declino liberale, bloccare ogni reale trasformazione sociale e
purchè capace offrire a esistenze decise a tutto come a nulla contenuti con cui determinare il senso
di un’autentica esistenza tedesca. Da ciò, per Löwith, il nascosto orizzonte politico della filosofia di
Heidegger. Ma da ciò anche l’omogeneità spirituale di Heidegger con l’atmosfera e la mentalità
naziste: «lo spirito del nazionalsocialismo aveva a che fare non tanto con il nazionale e con il
sociale, quanto piuttosto con quel radicale decisionismo e dinamismo che rifiutano qualsiasi
discussione e intesa, perché contano unicamente ed esclusivamente su se stessi – sul poter-essere
(tedesco) sempre proprio di ciascuno. Sono sempre espressioni di violenza quelle che definiscono il
vocabolario della politica nazionalsocialista e della filosofia di Heidegger». I loro concetti e le sue
parole sono «l’espressione della dura e spietata risolutezza di una volontà che si afferma di fronte al
nulla, di un esistere senza pace e senza gioia, orgoglioso del suo disprezzo per la felicità e per
qualsiasi umanità».[33]
Giorgio Fazio ha studiato all’Università di Roma “La Sapienza”. È stato fellow della Alexander
von Humboldt-Stiftung presso l’Università di Potsdam, dove ha svolto attività di ricerca sui temi
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
dell’antropologia filosofica e della secolarizzazione. Ha scritto numerosi saggi su Karl Löwith e
altre figura del pensiero filosofico tedesco del XX secolo.
NOTE
[1]
[1] Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933. Ein Bericht (1940), Metzler, Stuttgart 2007,
trad. it. di E. Grillo, La mia vita in Germania prima e dopo il 1933, Il Saggiatore, Milano 1988,
(d´ora in poi MVG) p. 78.
[2]
[2] Ivi, p. 183.
[3]
[3] Ivi, p. 173.
[4]
[4] K. Löwith, Von Hegel zu Nietzsche. Der revolutionäre Bruch im Denken des 19. Jahrunderts.
Marx und Kierkegaard (1941/1949), in SS, vol. IV, cit., pp. 1-490, trad. it. di G. Colli, Da Hegel a
Nietzsche, Einaudi, Torino 1993, (d’ora in poi HN), p. 326.
[5]
[5] L. Strauss, K. Löwith, Oltre Itaca, cit., p. 77.
[6]
[6] Cfr. per esempio il classico Jacob L. Talmon, Le origini della democrazia totalitaria, Il Mulino,
Bologna 2000.
[7]
[7] Ivi, p. 355.
[8]
[8] Cfr. G. Agamben, Homo sacer, Einaudi, Torino 2005.
[9]
[9] Cfr. K. Löwith, Max Weber und seine Nachfolger (1939), in SS, vol. V, cit., pp. 408-18, qui p.
417; trad. it. di O. Franceschelli in „“Micromega”“, 2, 1987, pp. 197-205. C. Schmitt, Die Diktatur:
von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf.
Duncker & Humblot, Leipzig-München 1921, trad. it. di A. Caracciolo, La dittatura, Settimo
Sigillo, Roma 2006.
[10]
[10] C. Schmitt, Politische Theologie, Duncker & Humblot, Leipzig-München 1922, trad. it. in Le
categorie del politico, cit., pp. 27-86.
[11]
[11] Cfr. su questo C. Galli, Genealogia della politica, Il Mulino, Bologna 1996.
[12]
[12] Questa linea del pensiero era stata valorizzata da Leo Strauss nel suo saggio del ‘32
Anmerkung zu Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, tenuto in attenta considerazione da Löwith
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
nella stesura del suo saggio. Cfr. L. Strauss, Gesammelte Schriften, vol. III, Metzler StuttgartWeimar 2001, pp. 217-238, trad. it. di R. Esposito, in: Gerusalemme e Atene. Studi sul pensiero
politico dell’Occidente, Einaudi, Torino, 1998, pp. 379-399. Sul rapporto di contiguità e diradicale
differenza tra le due critiche a Schmitt di Strauss e di Löwith cfr. G. Fazio, La critica di Karl
Löwith al decisionismo politico di Carl Schmitt e il suo rapporto con “Note sul concetto del politico
di Carl Schmitt” di Leo Strauss, in “La Cultura”, 48, 2, 2010, pp. 263-302.
[13]
[13] DP, p. 136.
[14]
[14] Ivi, p. 136-7.
[15]
[15] C. Schmitt, Der Begriff des Politischen, Duncker & Humblot, München-Leipzig 1932, trad. it.
in Le categorie del politico, cit., pp. 87-165, qui pp. 120-1. 41 K. Löwith, Max Weber und seine
Nachfolger, cit., p. 416.
[16]
[16] Per Schmitt «il senso positivo dello Stato assoluto sorge solo dalla negazione polemica dello
Stato neutrale ossia liberale. E quindi esso non abbraccia universalmente, come lo Stato hegeliano, i
momenti concreti della società borghese, ma rende totale tanto lo Stato che la società, sempre dal
punto di vista del caso di emergenza». DP, p. 137.
[17]
[17] Ivi, p. 139.
[18]
[18] Ivi, p. 141-142.
[19]
[19] Nel saggio giovanile Romanticismo politico Schmitt aveva individuato nell’occasionalismo il
trait d’union di tutti i fenomeni romantici. Facendo ricorso a questa categoria «altamente
dissolvitrice», coniata dalla corrente filosofica barocca del XVII secolo, egli si era riferito ad un
atteggiamento che respinge «ogni casualità necessaria e chiaramente calcolabile, come anche ogni
solido legame ad una forma fissa». «Tutto ciò che può fornire un ordine consequenziale alla vita e
ai fatti storici, sia una causalità meccanicamente calcolabile, sia un rapporto finalistico o normativo
– aveva affermato Schmitt - è assolutamente incompatibile con la rappresentazione della mera
occasionalità: chi eleva a principio l’occasionale o il casuale viene a trovarsi in una posizione di
grande superiorità rispetto alla normalità e a tutti i suoi limiti». C. Schmitt, Politische Romantik,
Duncker & Humblot 1998, trad. it. a cura di C. Galli, Romanticismo politico, Giuffrè Milano 1981,
p. 39. Nell’astensione ironica dal mondo fondata sulla tensione inconcludente a vedere una “vera
realtà” dietro l’apparenza delle cose e nella produttività puramente estetica che si esaurisce nella
costruzione di un mondo meramente soggettivo, formato con materiali attinti casualmente dalla
realtà e uniti sulla spinta di un’«emozione di accompagnamento», l’esistenza romantica, scriveva
Schmitt, sostituisce in termini secolarizzati l’idea di Dio come ultima ed assoluta istanza di un
mondo ridotto «a pura occasione della sua unica e sola attività». Il romantico si vuole mantenere
nella posa occasionale e geniale, non può legarsi, perdersi in una realtà determinata, perché in
questa determinazione si sottoporrebbe a una pienezza di legami e di riferimenti, che lo
costringerebbe a rinunciare alla sua soggettiva sovranità. Egli fugge dalla fissazione in una
decisione contenutisticamente determinata che lo costringerebbe a confrontarsi con una realtà
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
limitata e limitante, ed eleva la categoria di possibilità sopra ogni altra categoria di realtà. Osservata
sociologicamente, concludeva Schmitt, questa attitudine non è altro che una forma di sublimazione
dell’esistenza borghese. Il romantico proviene dalla società borghese ma si ritrae da essa e la vuole
contraddire. Egli odia il filisteo inserito nei vincoli, nei ruoli e nelle funzioni sociali della società,
ma d’altra parte il suo gesto di sottrazione rimane puramente nominale. Egli vuole essere produttivo
senza essere realmente attivo. Egli è quindi in se stesso l’espressione dell’odio contro se stessa della
borghesia, che finisce per dar luogo a un’inevitabile autocontraddizione. La sua superiorità sopra il
presente assunto come mera occasione patisce un rovesciamento altamente ironico: tutto ciò che è
romantico sta al servizio di energie altre, non romantiche, e la superiorità sopra definizioni e
decisioni si rovescia in servizievole accompagnamento di forze estranee e di decisioni estranee. In
ogni epoca, infatti, sono gli uomini decisi a decidere il corso delle cose umane e perché una
decisione sia concreta e libera, bisogna decidersi per qualcosa di determinato, sapendosi vincolati
per sempre alla decisione una volta presa. Sullo sfondo di questa lettura, nel suo saggio del ’3 ,
Löwith mette in luce quindi come, allo stesso modo dell’esistenza romantica, anche il concetto
secolarizzato di decisione politica sovrana di Schmitt non ha alla base alcun riferimento fisso in
Dio, in una trascendenza che può fungere da sostanza fondativa: è solo un analogo di Dio,
secolarizzato per “svuotamento”. Da qui la tesi che la lotta di Schmitt contro il carattere privato
dell’esistenza borghese e correlativamente del suo Gegenpol - la sfera pubblica moderna - sia essa
stessa una forma romantica di rifiuto della modernità, svolta in una direzione opposta a quella
estetica ma convergente negli esiti occasionalistici. In altre parole, nell’ondivaga e opportunistica
attività politica del consigliere di stato Adam Müller, additata da Schmitt come l’espressione più
rappresentativa degli esiti del romanticismo politico, questi non aveva fatto altro che attaccare la
sua stessa ombra, con una virulenza direttamente proporzionale alla sua rimozione. Su questi temi si
veda in particolare C. Graf von Krockow, Die Entscheidung. Eine Untersuchung über Enrst Jünger,
Carl Schmitt, Martin Heidegger, Enke, Stuttgart 1958.
[20]
[20] La critica di Schmitt all’appello ai diritti umani era stata duplice. Da una parte, dietro questo
appello, egli aveva additato l’espansione della spoliticizzazione economico-liberale e tecnica, nel
significato di minaccia arrecata alle stesse possibilità politiche della comunità politica. Da un’altra
parte, in questo appello egli aveva ravvisato il travestimento ideologico con cui una politica
determinata si arroga il diritto di dominare le altre, affermando i propri interessi economici e
conducendo, in nome dell’umanità, guerre di espansione imperialistica, come nel caso del
liberalismo anglosassone. Da qui la sentenza: «chi dice umanità, vuole trarre in inganno». Per una
rilettura di questa critica schmittiana, che si avvale esplicitamente di un’impostazione filosoficoantropologica, si veda M. De Carolis, Il paradosso antropologico, Quodlibet, Macerata 2008.
[21]
[21] DP, p. 154.
[22]
[22] Ibidem.
[23]
[23] Rifacendosi alla propria esperienza nelle trincee, Löwith ricorda come nella stessa prima
guerra mondiale «gli stessi uomini pronti a uccidersi l’un l’altro potevano diventare pacifici
camerati che trattavano gli uni con gli altri e conversano, e pure rimanevano nemici politici». DP, p.
154.
[24]
[24] Ivi, p. 135.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 1 – marzo 2015
[25]
[25] Ivi, p.135.
[26]
[26] Ivi, p. 149.
[27]
[27] MVG, p. 66.
[28]
[28] Ivi, p. 57. Cfr. M. Heidegger, Die Selbstbehauptung der deutschen Universität. Das Rektorat
1933-34, in Gesamtausgabe, vol. XVI, Klostermann, Frankfurt a.M. 2000, pp. 107-117, trad. it.
L’autoaffermazione dell’università tedesca. Il rettorato 1933-34, Il melangolo, Genova 1988.
[29]
[29] MVG, p. 57.
[30]
[30] Ibidem.
[31]
[31] MVG, p. 58.
[32]
[32] M. Heidegger, Essere e tempo, cit., pp. 554.
[33]
[33] MVG, pp. 60-61.