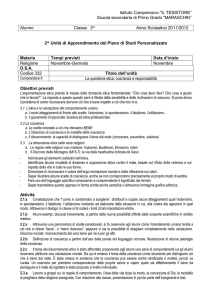Riflessioni
sull’etica
A cura del Dipartimento di
filosofia
Liceo scientifico E.Majorana
Scordia - 2006
Introduzione
Quest’anno, all’interno del Dipartimento di filosofia del nostro Liceo, è maturata un’idea che,
all’inizio timida, è apparsa come una vera “sfida” in un ambiente come quello scolastico e giovanile
tradizionalmente presentato come demotivato e in genere poco interessato a tematiche
extracurriculari ma di interesse decisivo nella società di oggi. Si è voluto offrire la possibilità, a chi
interessato, di partecipare ad una serie di incontri per approfondire alcune tematiche di attualità
inerenti alle problematiche suscitate dallo studio della storia della filosofia. Gli incontri sono stati
curati da alcuni docenti di filosofia del liceo e si sono tenuti nelle ore pomeridiane per due ore alla
settimana. Dopo aver somministrato un questionario per capire quale tematica privilegiare, si è
deciso di incentrare il seminario su tematiche inerenti l’etica. Alla fine sono stati quattro gli
interventi sull’argomento (in ordine cronologico):
1.
2.
3.
4.
Nietzsche: nichilismo e volontà di potenza (prof. Cataldo)
L’etica della responsabilità di Weber e Jonas (prof.ssa Cariola)
Etica per un figlio di Ferdinando Savater (prof. Garufi)
Vocazione alla politica e responsabilità collettiva (prof. Interi)
E’ doveroso ringraziare gli studenti, una trentina, i quali, superando non poche difficoltà, hanno
preso parte ai vari incontri. Ringraziamo in particolare alcuni di loro che, attraverso i loro appunti,
hanno reso possibile la pubblicazione del seguente lavoro. Un ringraziamento speciale va infine al
Preside prof. Moncada per aver sostenuto l’iniziativa.
Nichilismo e volontà di potenza
«Che cosa significa NICHILISMO?
Significa che i valori supremi si svalutano. Manca lo scopo: manca la risposta al “perché?”»
( F.Nietzsche, La volontà di potenza, brano 2 ).
In altre parole, il nichilismo è un processo attraverso il quale si svolge la caduta dei valori supremi;
è l’ospite più inquietante che bussa alla porta, una minaccia misteriosa e oscura, impalpabile,
diffusa. Questo processo è in pieno svolgimento
Il valore è tutto ciò che per noi è un bene, il risultato del nostro stimare, è un qualcosa che ci importa, ovvero ci mette in movimento verso di sè diventando la meta del nostro muoverci. Una volta
caduti i valori vengono a mancare gli scopi e le mete.
La risposta al “perché” non è più una semplice richiesta ma muta in una vera e propria necessità.
Per la comprensione del concetto di nichilismo come svalutazione dei valori supremi è necessario
individuare cosa Nietzsche intende per valori supremi.
Nietzsche, riprendendo il concetto di valore supremo di Platone, considera i valori supremi
atemporali, non soggetti al divenire e quindi eterni, ed inoltre fa coincidere questi con i valori
cosmologici, cioè relativi all’ ente nel suo insieme. Tali valori nel contesto sociale dell’ottocento
perdono la loro atemporalità e sono soggetti alla caducità.
Seguiamo la via di delucidazione del concetto di nichilismo tracciata da Nietzsche:
«Il Nichilismo come stato psicologico subentrerà di necessità, in primo luogo, se abbiamo cercato
in tutto l’accadere un “senso” che in esso non c’è;sicché alla fine chi cerca perde il coraggio.
Il nichilismo è allora l’acquistare coscienza del lungo spreco di forze, il tormento dell’ “invano”,
l’insicurezza, la mancanza dell’occasione di riposarsi in qualche modo, di tranquillizzarsi ancora
su qualcosa, la vergogna di fronte a se stessi, come se ci si fosse troppo a lungo ingannati…».
(Nietzsche, La volontà di potenza, brano 12, sez. A ).
Dall’ analisi di questa sezione il nichilismo si configura come coincidente con il senso di
frustrazione che subentra quando si è a lungo supposto che ci fosse un fine al divenire storico e poi
si capisce che dietro di esso c’è solo il nulla. Esso porta con sé il tormento dell’invano e la
consapevolezza dell’inutilità di tutto quello che è stato fatto. Dunque l’uomo diventa cosciente che i
valori a cui aveva dato un senso in realtà non ce l’hanno cadendo così nell’insicurezza.
«Quel senso potrebbe essere stato: l’ “adempimento” di un supremo canone morale in tutto
l’accadere, l’ordine morale del mondo; o l’accrescimento dell’amore e dell’armonia nei rapporti
fra gli esseri; o l’avvicinamento a uno stato universale di felicità; o anche il dirigersi verso uno
stato universale del nulla…una meta è ancor sempre un senso. Ciò che è comune a tutte queste
rappresentazioni è che si debba raggiungere qualcosa attraverso il processo stesso, e poi si capisce
che col divenire non si mira a nulla, non si raggiunge nulla…». ( ibidem ).
Questi aspetti hanno in comune il fatto che si debba raggiungere qualcosa col processo stesso, si
mira a qualcosa, e alla fine si arriva al nulla e quindi al nichilismo, cioè la delusione devastante che
subentra quando si è a lungo supposto e si scopre che alla fine non c’è niente.
«Il nichilismo come stato psicologico subentra, in secondo luogo, quando si è postulata una
totalità, una sistematizzazione e addirittura un’organizzazione in tutto l’accadere e alla sua base:
sicché l’anima assetata di ammirazione e venerazione gozzoviglia nella rappresentazione generale
di una suprema forma di dominio e amministrazione ( se si tratta dell’anima di un logico, basta già
l’assoluta consequenzialità e dialettica reale per riconciliare con tutto..).
Una specie di unità, una qualunque forma di “monismo”: e in conseguenza di questa credenza
l’uomo ha un profondo sentimento della connessione e della dipendenza da un tutto a lui
infinitamente superiore, è un modus della divinità…”Il bene dell’universale esige l’abbandonarsi
del singolo” … ma, guarda un po’, un siffatto universale non c’è! In fondo l’uomo ha perduto la
fede nel suo valore se attraverso di lui non opera un tutto di valore infinito; egli cioè ha concepito
un tale tutto per poter credere nel proprio valore». ( ibidem ).
Il nichilismo come stato psicologico subentra, in secondo luogo, nel momento in cui, dopo aver
considerato il mondo dell’accadere come organizzato, poi scopriamo essere in balia del caos : “il
mondo danza sui piedi del caso”. A tale stato psicologico segue la consapevolezza che si è postulata
una realtà organica perché la si riteneva necessaria a dare un senso, quindi un valore, all’esistenza
facendoci sentire parte di un tutto significativo e organizzato secondo unità, scopo ed essere; ma
quando si scopre che non c’e connessione tra la realtà e tali principi subentra lo sconforto. Tale
sconforto deriva dal fatto che il mondo appare ora disordinato e perciò dal fallimento di una
concezione che dava senso all’esistenza dell’uomo stesso in quanto lo faceva vivere sentendosi
parte di qualcosa di più grande che deve realizzarsi.
«Il nichilismo come stato psicologico ha ancora una terza e ultima forma. Date queste cognizioni,
che col divenire non si deve raggiungere niente, e che sotto ogni divenire non si ritrova per nulla
una grande unità, nella quale l’individuo possa totalmente immergersi come in un elemento di
supremo valore: non resta come scappatoia che condannare come illusione tutto questo mondo del
divenire e inventare un mondo che sia al di là di esso, come mondo vero. Ma appena l’uomo si
accorge che questo mondo è stato fabbricato solo in base a bisogni psicologici, e che in nessun
modo egli ha diritto a far ciò,, sorge l’ultima forma del nichilismo, che racchiude in se l’incredulità
per un mondo metafisico – che proibisce a se stessa di credere in un mondo vero. In questa
posizione si ammette la realtà del divenire come unica realtà, ci si vieta ogni sorta di via traversa
per giungere a mondi dietro i mondi e a false divinità – ma non si sopporta questo mondo che pure
non si vuole negare…
Che cos’è accaduto in fondo? Si raggiunse il sentimento della mancanza di valore quando si
comprese che non è lecito interpretare il carattere generale dell’esistenza né col concetto di
“scopo”, né col concetto di “unità”, né col concetto di “verità”. Con ciò non si ottiene e raggiunge
niente; nella molteplicità dell’accadere manca l’unità che permei tutto: il carattere dell’esistenza
non è “vero”, è falso…, non si ha assolutamente più ragione di mettersi in testa un mondo
vero…Insomma: le categoria “scopo”, “unità”, “essere”, con le quali avevamo introdotto un
valore nel mondo, ne vengono da noi nuovamente estratte – e ora il mondo appare privo di
valore…» ( ibidem ).
Di fronte ai primi due fallimenti, per cui col divenire non si raggiunge nulla e dietro il divenire non
c’è alcuna supposta unità, resta una sola scappatoia: condannare come illusorio questo mondo e
postularne un altro al di là di esso, perfetto, incorruttibile, eterno: il mondo vero (concezione
platonico – cristiana). Ma quando l’uomo si accorge che questo mondo è stato creato in base a
bisogni psicologici (dare senso alla vita dell’uomo), sorge l’ultima fase del nichilismo, fortemente
pessimistico.
L’uomo ha sempre fatto coincidere i valori supremi con caratteristiche ontologiche dell’essere, ma a
questo punto prende coscienza del fatto che tali valori sono pure invenzioni umane. Il risultato è un
mondo privo di senso.
«Ammesso che ci siamo resi conto del fatto che non è più lecito interpretare il mondo con queste tre
categorie, e che dopo tale riconoscimento il mondo comincia a divenire per noi privo di valore:
dobbiamo allora domandarci da dove provenga la nostra fede in queste tre categorie. Proviamo a
vedere se non sia possibile rifiutare loro questa credenza. Una volta che abbiamo svalutato queste
tre categorie la prova della loro inapplicabilità all’universo non è più una ragione per svalutare
l’universo.
Risultato: il credere nelle categorie di ragione è la causa del nichilismo – abbiamo misurato il
valore del mondo in base a categorie che si riferiscono a un mondo puramente fittizio.
Risultato conclusivo: tutti i valori con cui abbiamo finora cercato dapprima di rendere per noi
apprezzabile il mondo, e con cui l’abbiamo poi, appunto perciò, svalutato, quando essi si sono
dimostrati inapplicabili – tutti questi valori sono, ricalcolati dal punto di vista psicologico, risultati
di determinate prospettive di utilità per il mantenimento e il potenziamento di forme di dominio
umane: e solo falsamente sono proiettati nell’essenza delle cose. L’iperbolica ingenuità dell’uomo
è ancor sempre il postulare se stesso come senso e misura del valore delle cose…».
( Nietzsche, La volontà di potenza, brano 12, sez. B ).
Per millenni l’uomo ha quindi interpretato il mondo attraverso queste tre categorie (scopo, unità,
essere). La domanda sorge spontanea: da dove deriva la fede dell’uomo in queste tre categorie?
L’uomo, seguendo l’ideologia platonico–cristiana, ha attribuito valore ad un mondo trascendente
che è al di là di quello reale; tale processo non deriva da un ragionamento oggettivo ma da un
bisogno vitale che di logico non ha nulla.
L’uomo svaluta il mondo: ciò significa che estrae da questo quei valori che prima ha introdotto ma
che adesso ritiene inutili. Ma nichilismo non è solo svalutazione ed estrazione ma anche
introduzione stessa dei valori.
Si arriva alla conclusione che le tre categorie non sono applicabili al mondo e all’universo ma si
riferiscono ad un mondo illusorio, falso e irreale.
Nietzsche sostiene inoltre che oltre ai vecchi valori deve venire meno anche il principio che opera la
posizione dei valori, il luogo oltre questo mondo.
E’ necessario un nuovo principio che attui la nuova posizione di valori: tale principio è la volontà di
potenza quale si esprime nell’ uomo che ha da venire, l’ oltre-uomo.
«Il punto di vista del valore è il punto di vista di condizioni di conservazione, di
potenziamento rispetto a forme complesse di relativa durata di vita entro il divenire».
( Nietzsche, La volontà di potenza, brano 715 ).
La posizione di valori e, in ultima analisi, i valori stessi sono la manifestazione della volontà di
potenza.
I valori ripensati dal punto di vista della volontà di potenza sono il risultato di determinate
prospettive di utilità connesse al potenziamento e al mantenimento di forme di dominio. I valori
devono assicurare all’uomo il dominio, quindi la volontà di potenza non è desiderio di qualcosa che
manca ma desiderio di avere più potenza (per sua essenza è potenza di potenza). Il fine di porre
valori è quindi il mantenimento e il potenziamento della potenza stessa.
E’ attraverso il processo di transvalutazione che si pongono i nuovi valori: vengono meno i vecchi
valori, il luogo cui rimandano i vecchi valori e si pone il nuovo principio per la posizione dei valori,
la volontà di potenza.
I valori nel loro insieme costituiscono la morale. Ma che cosa significa morale per Nietzsche?
Nietzsche si definisce un immoralista perché riguardo al problema della morale,così come era stato
posto fino a quel momento, quindi all’ interno di un suo ambito specifico, si pone fuori. Le sue
concezioni morali non hanno a che fare con la definizione di “bene” e di “male” relativa all’ ambito
di quella morale che Nietzsche considera nella sua origine platonico-cristiana.
Secondo Nietzsche la morale è un sistema di giudizi di valore i quali trovano fondamentale
l’esistenza di un altro mondo al di fuori di quello sensibile e questi stessi valori, provenienti
dall’esterno, danno valore e significato all’esistenza umana. Gli uomini non riescono ad assegnare
un valore alla propria vita se non credono che esiste qualcosa nell’aldilà, dopo la vita terrena. La
morale finora descritta è anch’ essa espressione della volontà di potenza, un suo caso specifico: è la
morale voluta da una categoria di persone malriuscite, gli schiavi, che pongono come validi valori
più favorevoli a loro stessi. Tale morale trova espressione nella figura dell’uomo “buono”.
A questa morale si contrappone la morale dei signori.
SCHIAVI
↓
Umiltà
Rinuncia a se stessi
Sottomissione
Mediocrità
Esaltazione della spiritualità
↓
Mistificazione della vita
SIGNORI
↓
Forza
Gioia
Violenza
Orgoglio
Ebrezza
Esaltazione della sessualità e della fisicità
↓
Esaltazione della vita
Il signore pone i valori e li pone come una responsabile creazione generata dalla propria forza.
La morale dello schiavo invece deriva dal risentimento e dalla percezione della propria debolezza
ed inferiorità nei confronti del signore. Lo schiavo pone dei valori antitetici a quelli del signore e lo
fa nel tentativo di imporli agli altri; così le loro debolezze si tramutano in valori.
In “Al di là del bene e del male”, all’aforisma 19, troviamo: «Morale, cioè intesa come dottrina di
rapporti di potere sotto i quali prende origine il fenomeno vita».
Qui Nietzsche non pensa più alla morale che condiziona il platonismo. E’ vero però che anche in
questo aforisma la morale è pensata come un sistema di giudizi di valore che valgono per tutto l’
ente nel suo insieme e lo determinano nell’ ambito di complessi rapporti di potere. In questo ambito
assai ampio trovano posto anche le nuove posizioni di valori che possono definirsi morali in quanto
hanno a che fare con supposte condizioni di vita.
In conclusione possiamo dire che l’uomo è vittima di una iperbolica ingenuità in quanto prima pone
i valori e poi li percepisce come esterni, provenienti da lontano e con un’esistenza autonoma.
L’uomo è ingenuo perché si pone come misura e fonte dei valori ma lo fa senza sapere di esserlo.
Il Nichilismo è dunque la presa di coscienza che nella cosa non c’è valore: non esistono valori
esterni e autonomi ma ne è l’uomo il vero principio e il vero artefice; di conseguenza deve assumere
su di sè in maniera consapevole la responsabilità di ogni sua donazione di senso.
L'etica della responsabilità di Weber e Jonas
La riflessione sull'etica della responsabilità è partita da un testo di Weber, "IL LAVORO
INTELLETTUALE COME PROFESSIONE" , dove il termine professione è sinonimo di
vocazione, dedizione ad una causa. Servizio alla causa vuol dire competenza, capacità intellettuale
che si chiama coraggio delle conseguenze e consapevolezza delle azioni che si compiono, come
infatti lo stesso Weber afferma "Sono pronto a lavorare con qualunque partito, meno che mai con
quello degli stupidi".
Quali sono le caratteristiche dell'uomo di scienza?
Passione,ispirazione,dedizione verso ciò che si insegna, non deve mai esprimere giudizi di valore,
né dare bella e pronta la verità. Il professore non è un capo, ma un maestro ed in quanto tale deve
riuscire a comunicare i metodi del pensare,gli strumenti e la preparazione a quello scopo, e la
chiarezza in modo da "rendersi conto del significato ultimo del suo proprio operare". Dice Weber "
di un insegnante che riesce in questo compito sono tentato di dire che si è messo al servizio di
potenze etiche per promuovere il dovere , la chiarezza e il senso di responsabilità e credo che se
sarà tanto più capace quanto più coscienziosamente eviterà di formare bella e pronta e di suggerire
per proprio conto ai suoi ascoltatori la posizione da prendere". Qual’ è allora l'atteggiamento
interiore dell'uomo di scienza di fronte alla propria vocazione e professione? "La scienza << per
amore della scienza>> e non per consentire ad altri di raggiungere successi nel campo tecnico,
industriale o di potersi meglio nutrire,vestire,illuminare e governare". L'uomo di scienza deve agire
per il bene comune e riuscire ad esporre i problemi scientifici in modo semplice, così da poterli
rendere accessibili ad una mente incolta. Solo colui che agisce per vocazione può riuscire in questo
intento. " La cattedra non è per i profeti e i demagoghi, a loro il compito di parlare dove è possibile
la critica, mentre nell'aula, dove si sta seduti di faccia ai propri ascoltatori, non è possibile inculcare
le proprie opinioni politiche, in quanto si deve recar loro giovamento, trasmettendogli le proprie
conoscenze ed esperienze scientifiche. E' troppo comodo far prova del proprio coraggio di
confessore della fede là dove gli astanti e forse anche quelli di diversa opinione sono condannati al
silenzio!". Tra le pareti dell'aula d'insegnamento una sola virtù ha valore: la semplice probità
intellettuale che significa mettersi al lavoro, adempire al compito quotidiano nella nostra qualità di
uomini e nella nostra attività professionale. " Ciò è semplice e facile, quando ognuno abbia trovato
e segua il demone che tiene i fili della sua vita" - cioè a dire la propria vocazione e quindi si assume
la responsabilità di agire conseguentemente.
Nel secondo incontro, oggetto d'analisi è stata "LA POLITICA COME PROFESSIONE" tratta
anch'essa dal libro sopra citato."Ma, che uomo deve essere colui al quale è consentito di mettere le
mani negli ingranaggi della storia? Quale etica deve seguire? L'uomo politico deve possedere tre
qualità, che non devono assolutamente mancare e sono: la passione, il senso di responsabilità e la
lungimiranza. Senza tali qualità verrebbe a mancare inevitabilmente l'uomo politico". " Passione,
vuol dire sentirsi disposto a sacrificarsi per una causa. Evidentemente, però, non basta solo la
semplice passione, per quanto sinceramente sentita. Essa non crea l'uomo politico, se non
mettendolo al servizio di una causa e quindi facendo della responsabilità la guida determinante
dell'azione. Un grande politico, infine, deve disporre di lungimiranza, cioè deve essere appassionato
nelle sue azioni, responsabile, ma distaccato. La mancanza di << distacco>> è uno dei peccati
mortali che condannerà l'uomo politico all' inettitudine". Un nemico assai frequente e con cui
convive l'uomo politico è la "vanità". "La vanità è un difetto assai diffuso e forse nessuno ne và del
tutto esente, è una sorta di malattia professionale". La vanità, ossia il bisogno di porre in primo
piano la propria persona induce l'uomo politico alla tentazione di commettere i peccati mortali, sul
terreno della politica, che sono : mancanza di una causa giustificatrice e mancanza di responsabilità.
Non c'è aberrazione più deleteria dello sfoggio pacchiano del potere e del vanaglorioso compiacersi
del sentimento di potenza. " Il mero politico della potenza quale cerca di glorificarlo un culto
ardentemente professato anche da noi, può esercitare una forte influenza, ma opera di fatto nel
vuoto e nell'assurdo". Ma qual è il rapporto reale tra l'etica e la politica? Sono estranee o la
medesima etica vale per d’azione politica come per tutte le altre? Dobbiamo renderci conto che ogni
agire in senso etico può oscillare tra due massime radicalmente diverse, può essere orientato
secondo "l'etica della convinzione" oppure secondo "l'etica della responsabilità". L'etica che l'uomo
politico deve seguire è quella della responsabilità, differente da quella della convinzione. " Non che
l'etica dell'intenzione coincida con la mancanza di convinzione", ma l'etica della responsabilità è
quella di chi prima di agire valuta le conseguenze delle proprie azioni . Il comportamento non è
valutato in base alla sua rispondenza e volere, ma in relazione alle sue conseguenze, la
considerazione etica punta più sui nessi che sui valori. L'etica della convinzione è quella di chi
opera sulla base delle intenzioni, cioè di scopi aderenti alle proprie convinzioni e ai quali attribuisce
un valore, indipendentemente da quello che sarà l'esito dell'azione senza dubbio, poi l'uomo politico
non è un "santo", non può certo porgere l'altra guancia ad uno sgarbo, quindi il mezzo che egli
adopera e di conseguenza la " forza ". " Chi anela alla salute della propria anima e alla salvezza di
quella altrui non le cerca attraverso la politica, la quale si propone compiti del tutto diversi e tali che
possono essere risolti solo con la violenza. Il genio della politica e il dio dell'amore vivono in un
intimo reciproco "contrasto". Concludendo, " la politica consiste in un lento e tenace superamento
di dure difficoltà, da compiersi con passione e discernimento". Solo chi è sicuro di non venir meno
anche se il modo, considerato dal suo punto di vista è troppo stupido o volgare per ciò che egli
vuole offrirgli, e di poter ancora dire di fronte a tutto ciò: "Non importa continuiamo", solo un
uomo siffatto ha la "vocazione" per la politica. Pertanto l'etica della convinzione e quella della
responsabilità non sono assolutamente antitetiche, ma si completano a vicende e solo congiunte
formano il vero uomo, quello che può avere la "vocazione politica".
Nel terzo ed ultimo incontro, abbiamo preso in esame un capitolo del libro di Hans Jonas " Il
principio responsabilità". La predominanza della tecnica è dovuta alla scomparsa del legame di
armonia tra il mondo e l'uomo esistito sino a quando l'uomo ha conosciuto un fine superiore.
L'abuso della tecnica produce un sottocosmo, sempre più terreno e legato ad interessi
esclusivamente economici, che fanno perdere all'uomo il senso della propria centralità e lo fa
credere un essere che si è fatto da sé. Nella società tecnologica la dignità umana sembra non avere
più nessun ruolo. L'uomo s'illude di essere dotato d’autosufficienza e il progresso tecnico ha lo
scopo di favorire lo sviluppo. Quando più le tecniche offrono la loro egemonia, tanto più l'uomo
rischierà l'alienazione. Sul piano pratico l'uomo diventa una funzione e quando non svolge più la
funzione, diventa legittimo la sua eliminazione, siamo di fronte alla spersonalizzazione della vita
umana. Il mondo della tecnica è un mondo arido, privo di creatività il cui valore assoluto è la
produttività, l’ inautenticità viene eretta a sistema di vita.
Il perfezionamento della tecnica è connesso ad un impoverimento massimo delle vite interiori.
Crisi d’identità e crisi metafisica dell’ uomo
L’uomo non più considerato nella sua spiritualità che lo fa essere unico, diviene un numero insieme
a, tutti gli altri. La civiltà occidentale non conosce l’uomo in tutte le sue dimensioni, ma l’uomo
macchina – monade isolata,ossessionata dal predominare sugli altri – l’uomo perde la sua emotività,
diventando un semplice esecutore. Guarda tutto con distacco, senza partecipazione avvolto in una
solitudine che lo uccide. Nel vedere la realtà come spettacolo, dove l’uomo assiste senza
partecipare, nasce nell’uomo la disperazione.
“La tecnica costituiva allora un ben dosato tributo alla necessità e non la via verso la meta prescelta
dall’umanità,un mezzo dotato di limitata adeguatezza nei confronti di fini prossimi e ben definiti;
oggi invece la tecnica si è trasformata in un illimitato impulso progressivo della specie”. In tal
modo il trionfo dell’ homo faber sul suo oggetto esterno significa nel contempo il suo trionfo nella
costituzione interna dell’ homo sapiens, di cui un tempo non era altro che una parte ausiliaria.
Mentre il mondo della tecnologia tende a migliorare, l’uomo perde la propria identità e cade in una
crisi interiore non sentendosi più partecipe del proprio lavoro. “ Come si esce dalla crisi del
soggetto?” L’uomo deve riaffermare la propria identità, la propria dignità, così da poter governare
la tecnologia. Di fronte agli scenari riguardanti della civiltà odierna l’uomo non può più rifarsi alle
etiche tradizionali di matrice ellenistica ed ebraico-cristiane, la nuova etica deve tenere conto del
mondo extra-umano e delle generazioni future quella che Jonas chiama “etica della responsabilità”,
infatti, al vecchio imperativo Kantiano l’autore contrappone il nuovo imperativo che suona così :
“agisci in modo che le conseguenze della tua azione non distruggano le possibilità future della vita”
. Ma perché sacrificarsi per le generazioni future? Perché vi è un dover essere intrinseco all’essere,
cioè un finalismo interno all’ordine delle cose il quale fa sì che la vita esiga la conservazione della
vita. “ Non siamo responsabili verso gli uomini del futuro, bensì verso l’idea dell’uomo, tale da
esigere la sua incarnazione nel mondo. E’ un’idea ontologica che sostiene però che una tale
presenza deve essere tutelata, facendone un dovere per noi che la possiamo mettere in pericolo.
Solo questa idea dell’uomo dicendoci perché debbano esserci gli uomini, ci dice come essi debbano
essere. Da ciò l’avvento di un imperativo categorico ontologicamente fondato : “il primo imperativo
categorico è che ci sia un’ umanità”.
“Etica per un figlio” di Fernando Savater
L’etica non è una materia opzionale ma la materia più diffusa nel mondo poiché riguarda tutti.
“L’inventore” dell’etica fu Socrate che si scagliò contro i sofisti. Non c’è nessuna comunità che non
abbia alla base delle regole di comportamento. L’etica cosi come l’arte, la letteratura e l’estetica è
rappresentativa di un’epoca; inoltre il cambiare dell’etica con il cambiare delle epoche ci indica che
essa è riferita anche alla libertà; quest’ultima intesa come l’essere diverso da qualcosa che è. Così la
storia viene concepita come un continuo variare di etica e mentalità.
Savater afferma che la libertà sta alla base dell’etica e che varia con la convenienza. Il problema
dell’etica contemporanea è quello di avere un’eccessiva tolleranza a far diventare culture diverse
come culture di pari dignità.
Oggi l’etica sembra quasi non esistere in quanto siamo in un’epoca in cui i bambini sono “drogati”
di principi sin dalla nascita.
In quest’opera non si trattano argomenti “scottanti” della nostra epoca, come possono essere la
droga, la violenza o la clonazione, ma il padre vuol semplicemente dare al figlio delle istruzioni utili
che gli potranno servire per la sua vita futura, indipendentemente dal fatto che il ragazzo possa
essere d’accordo o No.
Savater definisce l’etica come una materia molto importante, poiché grazie ad essa si è in grado di
comprendere che cosa sia giusto o sbagliato non solo per i nostri interessi personali, ma anche per
gli interessi della collettività.
Per argomentare e spiegare le sue teorie egli usa una vastissima gamma di esempi tratti dalla vita di
tutti i giorni, evitando di ricorrere a termini troppo specifici e quindi di annoiare suo figlio (e i
lettori) con un linguaggio poco comprensibile.
Fernando Savater fa netto riferimento a Nietzsche. Egli definisce l’etica come arte del sopravvivere
affiancandola alla libertà, non come diritto ma come conquista.
Il senso di convenienza comporta una scelta, poiché si sceglie ciò che conviene. Ciò su cui è
importante porre l'accento, è proprio la capacità di Savater di parlare di argomenti forti usando un
linguaggio semplice e quotidiano.
Un esempio da cui possiamo partire è quello del paragone fatto tra Ettore e le termiti. Quando il
termitaio viene attaccato da un’inondazione o da un elefante le termiti-soldato rimangono a
difendere il termitaio mentre quelle operaie vanno a chiudere il loro rifugio lasciando le altre fuori.
Anche Ettore rimane fuori dal suo “rifugio” per salvare Troia ma a differenza delle termiti egli
rimane nella storia come un grande eroe. Anche le formiche si sono sacrificate per la propria
“comunità, ma a differenza di Ettore non vengono ricordate nella storia. Savater spiega tutto ciò
affermando che le termiti agiscono perché programmate biologicamente e non perché come Ettore
sono mosse da sentimenti di patria e famiglia. Infatti, Ettore avrebbe potuto ritirarsi perché sapeva
di perdere contro Achille, ma non lo fece perché sarebbe apparso vigliacco di fronte ai costumi e ai
valori della sua società. Da ciò si arriva ad accostare l’etica ad una scelta e quindi con la libertà.
Essa, infatti, è strettamente legata alla larghezza di cultura e del linguaggio. La libertà deriva
dal dare una risposta all’ambiente. A ciò Savater apporta un esempio ripeso da Aristotele: un
marinaio sta per naufragare e deve decidere se buttare in mare il carico che sta trasportando o
l’equipaggio. Ciò ci porta a concludere affermando che noi non siamo liberi di scegliere le
condizioni in cui viviamo ma le risposte agli eventi.
La libertà è la nostra forza, è la capacita di esprimere noi stessi ed esiste solo quando c’è
relazione con gli altri esseri umani. Da ciò nasce la netta differenza che Savater fa tra ordine,
capriccio e abitudine. Egli afferma:
<<….ordini, abitudini e capricci possono essere a volte motivi adeguati per agire, ma in altri casi
non c’è ragione perché sia così. Sarebbe un po’ idiota volere disubbidire a tutti gli ordini, agire
contro tutte le abitudini e opporsi a tutti i capricci, perché a volte risulteranno convenienti e
gradevoli. Però l’azione non è mai giusta solo in quanto è un ordine, un’abitudine o un
capriccio>>.
Il capriccio come la libertà viene dal nostro interno. Da qui deriva la libertà vista come logica che
facciamo per la nostra interiorità. La libertà diventa cosi definizione di identità.
Savater fa una netta distinzione tra morale ed etica affermando:
<<… le parole “morale”ed “etica” non hanno lo stesso significato. “Morale” è l’insieme di
comportamenti e norme che tu, io e alcuni di coloro che ci circondano consideriamo in genere
validi; “etica” è la riflessione sul perché li consideriamo validi e il paragone con le altre “morali”
di altre persone diverse>>.
Egli stesso però userà i due termini allo stesso modo (per non confondere le idee al figlio) e
affermerà l’esistenza di 4 principi di morale:
1.
2.
3.
4.
Filosofico, fai del bene per il bene stesso;
Religioso, fallo perché è la volontà del Signore,
Umano, fallo perché aumenta la felicità;
Politico, fallo per amore della società in cui vivi.
Dopo aver fatto la distinzione tra ordine, abitudine e obbligo Savater sembra cadere in
contraddizione con ciò che aveva affermato prima in quanto dice al figlio << fai quello che vuoi>>
come nel passo riportato qui di seguito:
<<Se ti dico “fa ciò che vuoi” sembra in qualche modo ti stia dando un ordine, “fai questo e non
altro” anche se ti impongo di agire liberamente. Che ordine complicato se lo esaminiamo da
vicino! Se obbedisci lo disobbedisci (perché non fai quello che vuoi, ma quello che voglio io ti do
l’ordine); se disobbedisci obbedisci (perché fai quello che vuoi invece di fare quello che io ti
ordino… ma è esattamente questo che ti sto ordinando!) >>.
Tutto questo serve per affermare che alla base della libertà sta la contraddizione. La libertà non è
agire nel vuoto ma rispondere in maniera differente alle provocazioni dell’ambiente poiché è esso
che decide le situazioni. L’uomo non agisce nel vuoto, ma nel contesto che purtroppo non si sceglie
liberamente. Il vero obiettivo dell’etica è rendere l’uomo capace di costruire la propria identità,
quindi essere se stessi.
Un esempio di ciò Savater, pur essendo laico, lo riprende dalla Bibbia. La vicenda è quella di Esaù
e Giacobbe. Il primo per un piatto di lenticchie, cucinato dal fratello, cedette l’eredità che gli
spettava in quanto primogenito, al secondo. Per Savater, Esaù peccò di mentalità tattica ovvero agì
con interesse immediato. La mentalità tattica è quella del furbo che ha sempre l’impressione di
morire il giorno dopo. Opposta a quella tattica c’è la mentalità strategica che è quella
dell’intelligente che sa reprimere gli istinti. Il reprimere gli istinti è inteso come la strategia migliore
per raggiungere la felicità mettendo cosi alla base dell’etica la mentalità strategica. Per essere felici
bisogna privarsi dei pregiudizi. La libertà è un dovere a cui tendere, anche se si è coscienti di non
arrivarci. Non esiste libertà senza il rapporto con gli altri. Il primo compito che ogni uomo dovrebbe
svolgere, è capire gerarchicamente i valori e non fare alla stessa maniera di Esaù che mise l’eredità
e le lenticchie sullo stesso piano.
Savater tratta, per concludere, la figura dell’imbecille visto come colui che “zoppica nell’animo, che
ha bisogno del bastone per camminare”. A proposito di ciò, egli individua tre tipi di imbecilli:
a) Colui che non ha ambizioni e scopi;
b) Colui che dice una cosa un secondo prima ed un’altra un secondo dopo senza alcun modo di
discutere: questa imbecillità è dovuta alla scarsa attenzione infatti egli è incapace di creare
delle strategie;
c) Colui che sostiene le stesse idee del gruppo a cui appartiene perché il gruppo le sostiene
oppure colui che contraddice solo per atteggiamento e non per ragionamento.
La soluzione per non cadere in una di queste tra categorie è conquistare la coscienza e rimanere se
stessi.
L’unico imperativo morale che dobbiamo avere è che se esisto sono felice, ma io esisto se c’è una
relazione con gli altri. E’ la coscienza che dà l’esistenza. Dice Savater che si deve coltivare
l’egoismo inteso come egoismo strategico della persona che sa dare una gerarchia ai valori. Savater
vuole arrivare all’anticretinismo dicendo che l’uomo di coscienza sa assumere le proprie
responsabilità senza cadere nell’errore di non voler pagare i propri errori di persona.
Da qui l’ultimo consiglio che Savater dà al figlio ma rivolto a tutti i suoi lettori:
<<Dato che si tratta di scegliere, cerca di fare sempre quelle scelte che ti apriranno poi un
maggior numero di altre opzioni possibili e non quelle che ti mettono con la faccia al muro. Scegli
quello che ti apre: agli altri, a nuove esperienze, a diversi modi di essere felice. Evita quello che ti
chiude e ti sotterra. Per il resto, buona fortuna! E quell’altra cosa che una voce che sembrava la
mia ti gridò quel giorno nel sogno quando il vortice minacciava di trascinarti via: abbia
fiducia!>>
Vocazione alla politica e responsabilità collettiva
L’argomento su cui ci siamo soffermati in particolare nel nostro incontro potrebbe apparire
poco consono ai temi finora trattati e alla finalità del seminario; appare invece, per alcuni aspetti,
fondamentale per riscoprire il senso di qualunque azione che voglia veramente essere significativa
per l’agire umano. Si è partiti dal significato e delle implicazioni della vocazione, intesa come
impegno e anche come “chiamata” che è necessaria per chi voglia operare in azioni dotate di senso.
Intanto, il termine deriva dal latino, che lo utilizza in due accezioni: quello, allegro e gioviale,
dell’invito a pranzo, per esempio è il modo in cui Cicerone usa questo termine; e quello di citazione
in giudizio che è una cosa molto più seria e che troviamo frequentemente in Varrone. Si tratta, in
sostanza, di un termine dalle diverse facce perché anche l’invito a pranzo non è una cosa
secondaria: alcune tra le cose più importanti della storia dell’umanità avvengono durante conviti
(Platone), ultime cene (cristianesimo), pranzi di diverso tipo. Qui dà già il senso di qualche cosa
che viene fatta insieme. Una chiamata è sempre una chiamata di qualcun altro – questo è il primo
elemento – e poi, questa chiamata è una chiamata a fare qualcosa di comune. Nello stesso tempo,
però, questo termine, passando nella storia, ha dentro di sé anche l’idea che una chiamata comporta
un rendere conto: è quindi una chiamata di responsabilità. Dunque c’è qualcun altro che chiama o
che invita; anche qui vocazione ha assunto spesso significati religiosi: chi crede attribuisce
spontaneamente la voce di questo “qualcun altro” che chiama a Dio stesso; però nella storia ci sono
tanti esempi di persone che hanno parlato di una propria vocazione pur non avendo la fede,
attribuendola dunque ad una sorta di voce interiore, a una chiamata che sentivano, con la stessa
chiarezza con cui il credente ha sentito la chiamata da parte di un altro al quale dava il nome di Dio.
L’uomo, indipendentemente dalla fede, si accorge di avere dentro una realtà così profonda e
complessa che lo costringe a mettersi sempre in rapporto comunque con se stesso: è la voce della
coscienza che è in grado di giudicarci e di spingerci.
Esempi di vocazioni religiose
Alcuni esempi storici di vocazione – non tutti però – sono presi dal contesto della cultura ebraica, in
essi la vocazione è riferita a un Dio che chiama; altri esempi, invece, sono riconducibili ad una voce
interiore, non necessariamente Dio, ma non per questo meno fortemente dotate delle caratteristiche
di “chiamata”.
Nella Bibbia c’è un episodio in cui c’è un giovane, Samuele, che dorme al Tempio e che a un certo
punto sente una voce – è la voce di Dio – che lo chiama:
Il giovane Samuele continuava a servire il Signore sotto la guida di Eli. La parola del Signore era
rara in quei giorni, le visioni non erano frequenti. In quel tempo Eli stava riposando in casa,
perché i suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere. La lampada di Dio non
era ancora spenta e Samuele era coricato nel tempio del Signore, dove si trovava l’arca di Dio.
Allora il Signore chiamò: “Samuele! ” e quegli rispose: “Eccomi”, poi corse da Eli e gli disse:
“Mi hai chiamato, eccomi! ”. Egli rispose: “Non ti ho chiamato, torna a dormire! ”. Tornò e si
mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo: “Samuele! ” e Samuele, alzatosi, corse da Eli
dicendo: “Mi hai chiamato, eccomi! ”. Ma quegli rispose di nuovo: “Non ti ho chiamato, figlio
mio, torna a dormire! ”. In realtà Samuele fino allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né
gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare: “Samuele! ” per
la terza volta; questi si alzò ancora e corse da Eli dicendo: “Mi hai chiamato, eccomi! ”. Allora Eli
comprese che il Signore chiamava il giovinetto. li disse a Samuele: “Vattene a dormire e, se ti si
chiamerà ancora, dirai: Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta”. Samuele andò a coricarsi al
suo posto. Ma il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo chiamò ancora come le altre volte:
“Samuele, Samuele! ”. Samuele rispose subito: “Parla, perché il tuo servo ti ascolta”. Allora il
Signore disse a Samuele: “Ecco io sto per fare in Israele una cosa tale che chiunque udirà ne avrà
storditi gli orecchi. In quel giorno attuerò contro Eli quanto ho pronunziato riguardo alla sua
casa, da cima a fondo. Gli ho annunziato che io avrei fatto vendetta della casa di lui per sempre,
perché sapeva che i suoi figli disonoravano Dio e non li ha puniti. Per questo io giuro contro la
casa di Eli: non sarà mai espiata l’iniquità della casa di Eli né con i sacrifici né con le offerte! ”.
Samuele si coricò fino al mattino, poi aprì i battenti della casa del Signore. Samuele però non
osava manifestare la visione a Eli. Eli chiamò Samuele e gli disse: “Samuele, figlio mio”. Rispose:
“Eccomi”. Proseguì: “Che discorso ti ha fatto? Non tenermi nascosto nulla. Così Dio agisca con
te e anche peggio, se mi nasconderai una sola parola di quanto ti ha detto”. Allora Samuele gli
svelò tutto e non tenne nascosto nulla. Eli disse: “Egli è il Signore! Faccia ciò che a lui pare
bene”.
Samuele acquistò autorità poiché il Signore era con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle
sue parole. ( Libro di Samuele, capitolo 3)
Quello che in questo brano colpisce è che il maestro non dice a Samuele chi è quella voce, ma lo
rimanda alla sua solitudine e gli dice: “Ascolta, quando senti di nuovo questa chiamata devi
rivolgerti alla voce stessa che ti ha chiamato”. Questo è un episodio importante anche perché il
ragazzo non riconosce la voce, è una cosa del tutto nuova nella sua vita, e, come farebbe ognuno di
noi, va dalla persona o dalle cose che già conosce, di cui già è sicuro, per avere conferme. Solo che
qui c’è un rischio, quello di non rispondere a questa chiamata perché andiamo dagli altri e, in fondo,
già non vogliamo affrontare il nuovo; andiamo verso gli altri che già conosciamo perché con il loro
buon senso ci confermino i nostri dubbi. Samuele è fortunato perché anche il suo maestro aveva
sentito la voce e può capire che anche Samuele ha un destino simile al suo: lo rimanda così alla sua
solitudine perché intuisce che Samuele deve trovare il coraggio di rivolgersi all’ignoto e di chiedere
a quella voce che cosa vuole. Qui c’è un punto importante perché io devo chiedere alla voce che
cosa vuole da me. E’ la voce, non “le voci”, che mi dice ciò che devo fare, cioè mi dice quello che
io sono – almeno secondo lei –; gli altri non possono saperlo. Il maestro, infatti, non dice a
Samuele: “Guarda, ti spiego io, è così così e così”. No, lo rimanda alla voce perché nessun altro può
sapere chi sono io: questa è una cosa che io devo scoprire, che ognuno di noi deve scoprire, e gli
altri non possono darci informazioni su questo. Soltanto andando verso questo ignoto, quindi, io
saprò di me. In questo senso la vocazione è l’inizio della conoscenza. Conosciamo tante cose, ma la
conoscenza vera, ad un certo punto, comincia con un salto: quando io accetto di inoltrarmi in ciò
che nessun altro può dirmi di me.
Un altro brano che abbiamo esaminato, tratto sempre dall’Antico testamento è la vocazione di
Ezechiele:
Il cinque del quarto mese dell’anno trentesimo, mentre mi trovavo fra i deportati sulle rive del
canale Chebàr, i cieli si aprirono ed ebbi visioni divine. Il cinque del mese - era l’anno quinto
della deportazione del re Ioiachìn - 3 la parola del Signore fu rivolta al sacerdote Ezechiele figlio
di Buzì, nel paese dei Caldei, lungo il canale Chebàr. Qui fu sopra di lui la mano del Signore.
Capitolo 2
Visione del libro
Mi disse: “Figlio dell’uomo, alzati, ti voglio parlare”. 2 Ciò detto, uno spirito entrò in me, mi fece
alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava.
Mi disse: “Figlio dell’uomo, io ti mando agli Israeliti, a un popolo di ribelli, che si sono rivoltati
contro di me. Essi e i loro padri hanno peccato contro di me fino ad oggi. Quelli ai quali ti mando
sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro: Dice il Signore Dio. Ascoltino o non ascoltino
- perché sono una genìa di ribelli - sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro.
Ma tu, figlio dell’uomo non li temere, non aver paura delle loro parole; saranno per te come cardi
e spine e ti troverai in mezzo a scorpioni; ma tu non temere le loro parole, non t’impressionino le
loro facce, sono una genìa di ribelli. Tu riferirai loro le mie parole, ascoltino o no, perché sono
una genìa di ribelli.
E tu, figlio dell’uomo, ascolta ciò che ti dico e non esser ribelle come questa genìa di ribelli; apri la
bocca e mangia ciò che io ti do”. Io guardai ed ecco, una mano tesa verso di me teneva un rotolo.
Lo spiegò davanti a me; era scritto all’interno e all’esterno e vi erano scritti lamenti, pianti e guai.
[…]
Capitolo 3
Mi disse: “Figlio dell’uomo, mangia ciò che hai davanti, mangia questo rotolo, poi và e parla alla
casa d’Israele”. Io aprii la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo, dicendomi: “Figlio
dell’uomo, nutrisci il ventre e riempi le viscere con questo rotolo che ti porgo”. Io lo mangiai e fu
per la mia bocca dolce come il miele.[…]
Quando Ezechiele sente la voce quando si trova in una situazione difficilissima. Lo si capisce dal
modo dettagliato in cui racconta il fatto. In questo caso la chiamata vuol dire: “Alza la testa!”. La
vocazione, per Ezechiele, ha prima di tutto il significato di uscire dal servaggio, uscire dalla
sottomissione. Ezechiele ci dice che la chiamata è una liberazione. Quello che prima abbiamo
incontrato come l’ignoto, come la non conoscenza, come il rischio, in realtà è un’uscita dalla
situazione negativa in cui ci si trova. Ci sono, dunque, due aspetti: uno è quello della liberazione, il
secondo è quello dell’emancipazione perché Ezechiele è tirato fuori e gli viene consegnato un
compito; la voce gli dice: “Va nella terra dei Caldei e fa…”. Per Ezechiele, infine, questa parola –
quella della voce che chiama, della vocazione – è una parola che nutre, dice che noi dobbiamo
mangiarla. Questo vuol dire che dopo che uno è stato chiamato ad una cosa non puoi più nutrirsi di
altre cose: bisogna mangiare della propria chiamata. Se uno ha una vocazione, e se l’ha accettata,
non può più saltare; diventa prigioniero, per così dire, di questa vocazione; ma è una prigionia nella
quale si trova la libertà, perché si diventa veramente se stessi. Un’ultima annotazione a questo
brano: cosa vuol dire “mangiare” la parola con la quale si è chiamati? Il Signore, questa voce che lo
chiama, gli dice: “Adesso io ti do un rotolo – un libro –; tu lo devi mangiare; ti do il libro dei dolori,
delle lamentazioni, dello strazio, delle disgrazie; ti do il libro del dolore dell’uomo; mangialo”.
Ezechiele inghiotte il rotolo e dice: “Al mio palato fu dolce”. Questo episodio ci colpisce! Perché?
Ma se conteneva tutto ciò che c’era di più amaro nell’umanità? E’ dolce perché il modo in cui Dio
si manifesta è la liberazione e l’affermazione di chi è Ezechiele: “Tu, Ezechiele, sei quello che deve
inghiottire le amarezze dell’umanità e andare all’umanità a spiegare le cose che io ti dico”. Colui
che è chiamato ha solo questa possibilità: possono esserci cibi più raffinati, possono esserci destini
di ricchezza, di successo o altre professioni o altre cose, bellissime! Ma non sono lui. Lui troverà il
“dolce” dell’esistenza soltanto nella fedeltà a quella parola che lo ha chiamato.
La parola che chiama non la si sente con le orecchie: è parola interiore; dunque ci appartiene, c’è
una identità un’unità tra la parola che chiama e il chiamato. Il chiamato e il chiamante, dunque,
sono “uno”. “Uno” l’amato e l’amante, come sperimentiamo nell’innamoramento, nel matrimonio,
in cui si diventa una cosa sola
Esempi di vocazione non religiosa
Ci sono tante vocazioni anche non religiose. Ne abbiamo citato due. Un caso di queste vocazioni è
raccontato da Jean Guéhennon, un ragazzo il cui padre era spesso licenziato per attività sindacali
che vive molto giovane il suo primo sciopero. Quello sciopero ha come scopo l’esistenza stessa del
sindacato operaio che il padronato vuole impedire; la lotta è ineguale perché è chiaro che chi ha una
riserva di denaro è più potente. Gli operai sono alle prese con la fame, mandano i propri figli in
altre città, presso altre famiglie operaie, perché glieli tengano e possano mangiare. Alla fine la
resistenza di questo sciopero diventa un “caso” tanto che arriva nel paese, per parlare agli operai, il
grande Jean Jaurés, uno dei fondatori del socialismo francese.
“[…] Parlava sotto il mercato coperto, tutta la città era venuta ad ascoltarlo…Ci parla appena
delle nostre prove, ma ci dice che non avevamo il diritto di essere vinti, perché la nostra lotta non
era soltanto nostra, ma di tutti. Si rivolse esclusivamente alla nostra fierezza. Ci dipinse il mondo
che portavamo in noi e noi piangevamo nel riconoscerlo, e poi la sua voce divenne più grave.
Evocò tutti i dolori che subivano in quel momento gli uomini; le terre insanguinate, la guerra che,
come una nuvola, saliva all’orizzonte e calava verso di noi, un universo furioso che solo il nostro
buon senso e la nostra volontà potevano esorcizzare. Allora soltanto, verso la fine del suo discorso,
ci chiamò con questo nome più carico di tenerezza: “Compagni”, e per la prima volta ebbi il
presentimento del nostro destino[…]”
Il ragazzo Guéhennon racconta così, vent’anni dopo, le emozioni dell’incontro. Jean Jaurés, a suo
modo, era un “chiamato”. La caratteristica di chi ha una vocazione è di vedere, indipendentemente
dalla foschia delle difficoltà, esattamente l’obiettivo della sua vocazione. Infatti i dolori al
“chiamato” vengono quando lui non distingue più l’obiettivo, non quando gli altri gli fanno
difficoltà. E Jean Jaurés non sottolinea nel suo discorso il negativo, l’oscuro di quello che stava
accadendo in quel momento, sottolinea lo scopo. “… ma ci dice che non avevamo il diritto di essere
vinti, perché la nostra lotta non era soltanto nostra, ma di tutti. Si rivolse esclusivamente alla
nostra fierezza. Ci dipinse il mondo che portavamo in noi e noi piangevamo nel riconoscerlo”.
Tre considerazioni conclusive su questo esempio. Primo: la vocazione può essere suscitata anche da
un esempio, da un uomo, non soltanto da una voce che si ritiene divina. Secondo: la vocazione, che
è una vocazione “a me”, ha un valore universale; infatti Jaurés parla di tutti i dolori del mondo –
come i dolori del rotolo di Ezechiele – e dice: “C’è bisogno di te non per una cosa che riguarda solo
te, ma per una missione universale”. Questo, però avviene in un compito specifico: cioè si
raggiunge lo scopo universale se ci si dona in un particolare, in un compito preciso. Non esiste una
vocazione generale: la vocazione è sempre ad una persona e ad una cosa. A volte ci si perde con
l’idea di fare una cosa troppo piccola o si spreca tempo cercando di dedicarsi a una cosa grande: la
strada per l’infinito è l’infinitamente piccolo; la strada per il “grande” è l’umile, è il modesto.
Terzo: rispondendo ad una vocazione si prende non una via individuale, ma si entra a far parte di
una comunità: la comunità di coloro che hanno risposto. Quel “compagni” è il segno del fatto che la
vocazione immette in una comunità, in un gruppo.
Un altro esempio che abbiamo citato è quello di Marx. Indipendentemente dal giudizio sul suo
pensiero, quello che colpisce della sua persona è la straordinaria capacità di voler andare avanti
nonostante le difficoltà, anzi, proprio per le difficoltà.
Durante il periodo di esilio londinese, la famiglia Marx era attanagliata dalle ristrettezze
economiche: nel 1855 morì il figlio di Marx, il piccolo Edgard, detto Musch, di 9 anni; ce n’era
abbastanza perché Marx abbandonasse la partita e rinunziasse all’attività rivoluzionaria, accettando
un impiego se non altro per porre fine agli stenti dei propri cari. Ecco come dà notizia della morte
del figlio ad Engels in una lettera del 6 aprile 1855:
“Caro Engels, il povero Musch non è più. Si è addormentato (nel vero senso della parola) tra le
mie braccia oggi tra le 5 e le 6. Non dimenticherò mai come la tua amicizia ci ha reso più leggero
questo terribile periodo. Il mio dolore per il bambino tu lo capisci…” (6 aprile 1855)
Ma perché Marx non si ritira? In una lettera di una settimana dopo, scrive:
“La casa è naturalmente del tutto desolata e vuota dopo la morte del caro bambino che ne era
l’anima. Non si può dire come il bambino ci manche ad ogni istante. Ho già sofferto ogni sorta di
guai, ma solo ora so che cosa sia una vera sventura. Mi sento broken down (spezzato). Per fortuna
dal giorno del funerale ho avuto dei mal di testa così tremendi che non ho più avuto né modo né
voglia di pensare a nulla. Tra tutte le pene terribili che ho passato in questi giorni, il pensiero di te
e della tua amicizia, e la speranza che noi abbiamo ancora da fare insieme al mondo qualche cosa
di intelligente, mi hanno tenuto su” (12 aprile 1855)
E’ l’essere amico di qualcuno e con qualcuno, la “speranza collettiva”, che dà la forza di continuare
e di andare avanti, nonostante le difficoltà.