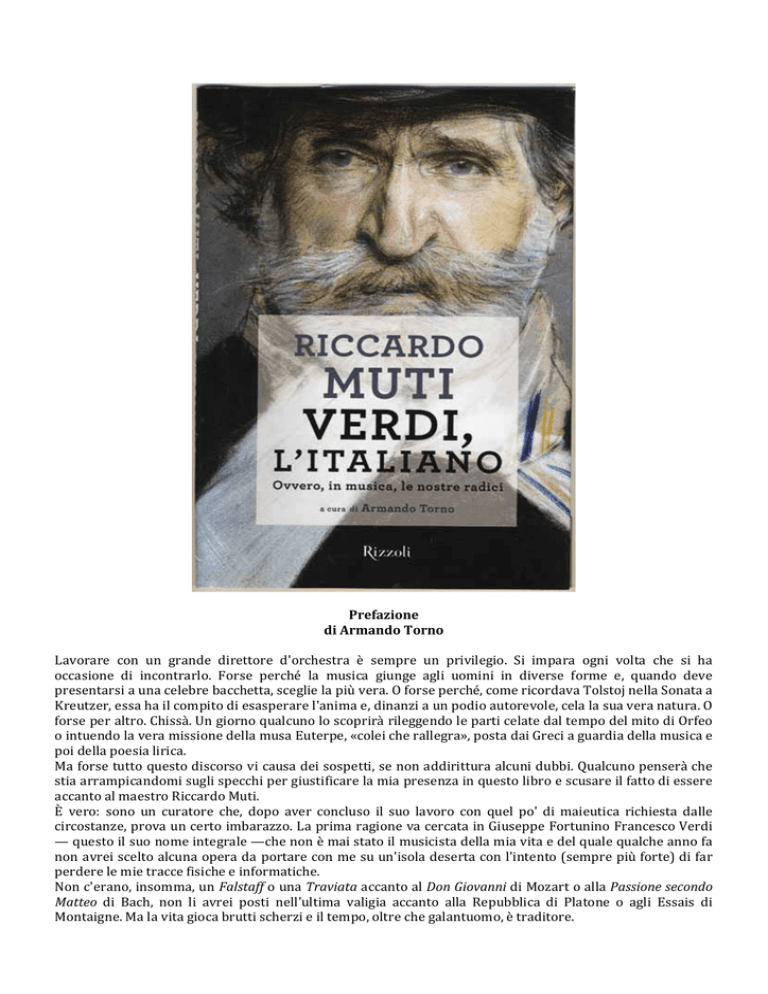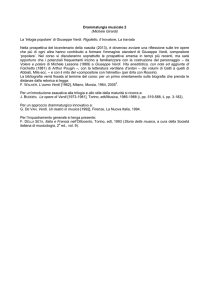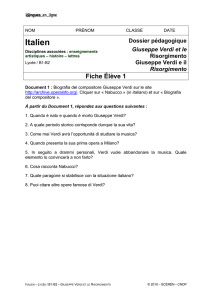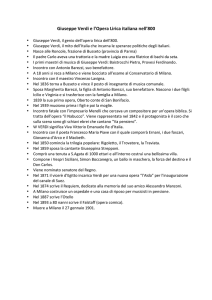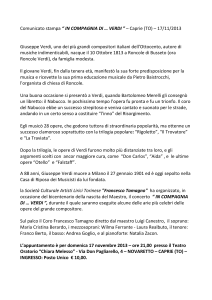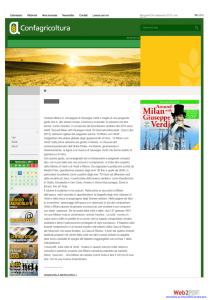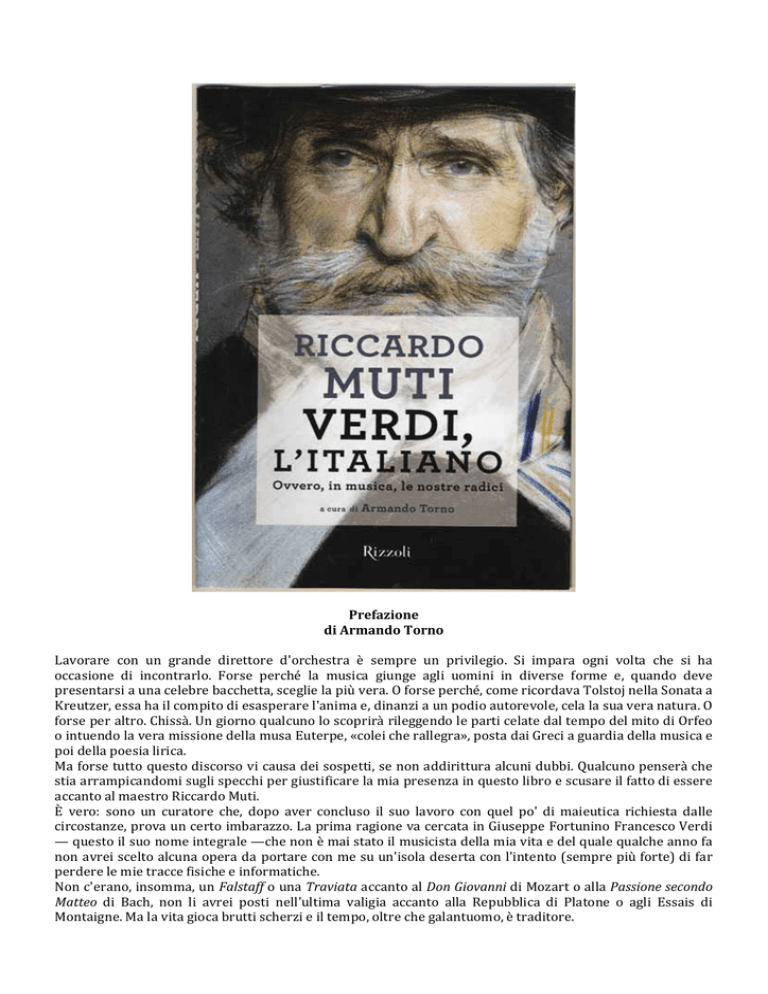
Prefazione
di Armando Torno
Lavorare con un grande direttore d'orchestra è sempre un privilegio. Si impara ogni volta che si ha
occasione di incontrarlo. Forse perché la musica giunge agli uomini in diverse forme e, quando deve
presentarsi a una celebre bacchetta, sceglie la più vera. O forse perché, come ricordava Tolstoj nella Sonata a
Kreutzer, essa ha il compito di esasperare l'anima e, dinanzi a un podio autorevole, cela la sua vera natura. O
forse per altro. Chissà. Un giorno qualcuno lo scoprirà rileggendo le parti celate dal tempo del mito di Orfeo
o intuendo la vera missione della musa Euterpe, «colei che rallegra», posta dai Greci a guardia della musica e
poi della poesia lirica.
Ma forse tutto questo discorso vi causa dei sospetti, se non addirittura alcuni dubbi. Qualcuno penserà che
stia arrampicandomi sugli specchi per giustificare la mia presenza in questo libro e scusare il fatto di essere
accanto al maestro Riccardo Muti.
È vero: sono un curatore che, dopo aver concluso il suo lavoro con quel po' di maieutica richiesta dalle
circostanze, prova un certo imbarazzo. La prima ragione va cercata in Giuseppe Fortunino Francesco Verdi
— questo il suo nome integrale —che non è mai stato il musicista della mia vita e del quale qualche anno fa
non avrei scelto alcuna opera da portare con me su un'isola deserta con l'intento (sempre più forte) di far
perdere le mie tracce fisiche e informatiche.
Non c'erano, insomma, un Falstaff o una Traviata accanto al Don Giovanni di Mozart o alla Passione secondo
Matteo di Bach, non li avrei posti nell'ultima valigia accanto alla Repubblica di Platone o agli Essais di
Montaigne. Ma la vita gioca brutti scherzi e il tempo, oltre che galantuomo, è traditore.
Da quando, nel 2000, ho smesso di occuparmi di musica come critico (vent'anni e qualche mese mi avevano
provato spiritualmente, mettendo a dura prova il sistema nervoso), sono riuscito ad avvicinarmi sempre più
a Verdi. E oggi non me la sentirei di fuggire senza qualcosa di lui. Il guaio è che, man mano che passano i
mesi, rischio di aggiungere anche delle lettere alle partiture e a eventuali registrazioni da spedire con le
salmerie per quella progettata fuga. Insomma, sono un pentito della musica e mi sono avvicinato all'opera
del Maestro di Busseto.
I miei rapporti con Riccardo Muti in questi anni sono continuati al di là delle esecuzioni musicali, delle
critiche, di quel grande gioco delle umanità che gravita attorno alle stagioni e ai teatri; si sono stabilizzati,
come dire?, in quello spazio che ogni esistenza riesce a trovare tra quel che fa e quel che è. E quando una sera
a cena mi ha chiesto di occuparmi del «suo» Verdi, ovvero di un libro che raccontasse esperienze e
interpretazioni di una bacchetta par suo, ho risposto meccanicamente di sì.
Il lavoro con Muti è materia non facile da descrivere. Non perché il Maestro sia esigente o caratteriale,
tutt'altro. Lui possiede ancora il dono della meraviglia quando parla di musica, anche se è la sua vita, e a essa
ha dedicato ogni energia, oltre che sentimenti e passioni. Si innamora di un passaggio, di una soluzione
vocale o strumentale, riflette sul testo del libretto o consulta il copia lettere di Verdi prima di operare le
scelte. Prova senza stancarsi, così come hanno fatto i direttori che l'hanno preceduto e che sono ormai
modelli ideali. Sente e risente una voce, corregge anche le minuzie, chiede di ricominciare, cita direttamente
le volontà di Verdi o del musicista in questione sulla partitura. So che passa intere ore su una pagina e, se ha
qualche dubbio, non lo nasconde. Insomma, Muti fa parte di quella razza in estinzione di signori del podio
che prova e riprova ogni rigo di una certa opera, condividendo con gli interpreti e i professori d'orchestra le
soluzioni scelte. È esigentissimo, ma anche i cantanti e i musicisti lo sono con lui. Intendo dire che se Muti è il
direttore, tutti sanno che devono dare il massimo ma, allo stesso tempo, si aspettano da lui altrettanto.
Scrivo codesti particolari per ricordare ai lettori il suo metodo di lavoro. Questo libro è nato tra una prova e
una prima, accanto a un'audizione oppure in un momento di una giornata dedicata allo studio. Nella sua casa
di Ravenna o in uno spazio trovato al Teatro dell'Opera di Roma.
I ricordi del Maestro sono stati registrati e trascritti; poi, ovviamente, riletti e sistemati, sino a diventare un
vero e proprio libro. L'unico artificio che le pagine contengono è il collegamento fatto tra discorsi relativi a
una certa opera o a un determinato argomento. Per spiegarlo con un semplice esempio, dirò che poteva
capitare, mentre si stava esaminando Aida, che il Maestro facesse una precisazione su Traviata: e allora
quest'ultima parte veniva ricollegata a quella dove si parlava di tale opera.
Non si sono voluti inserimenti a prescindere dai ricordi, giacché quanto si legge in questo libro è quello che
Riccardo Muti ha desiderato conservare del «suo» Verdi in particolari momenti del 2011 2012. Avrebbe
potuto aggiungere molto di più, soffermarsi su altri mille aspetti, aprire la scatola degli infiniti episodi noti o
meno noti, ma ha scelto queste parti: e fedelmente chi scrive ha cercato di cucirle con un lungo filo rosso che
attraversa la sua vita.
Verdi, del resto, è il compositore con cui si è misurato più a lungo, quello con il quale ha condiviso speranze e
trionfi ininterrottamente. Non che Muti sia lontano dagli incanti di Mozart o da Cherubini o che, come
direttore, non rappresenti la migliore interpretazione per taluni grandi della scuola napoletana, ma Verdi è
stato il suo spirito guida. E questo anche se qualcuno in futuro lo ricorderà (con Strehler) per il Don Giovanni
del 1987 alla Scala, in un'esecuzione che lasciò all'epoca a bocca aperta; o altri si aggrapperanno alle sue
direzioni di Beethoven, a quelle nove sinfonie che entrarono anche nei muri oltre che nell'anima del teatro
del Piermarini.
Muti deve molto a Verdi, ma questa frase va sempre letta al contrario: Verdi deve molto a Muti in questi
ultimi decenni. Le pagine che vi apprestate a leggere ricorderanno le sue scelte, soprattutto metteranno in
luce la capacità di un direttore di essere fedele a un compositore sfidando le mode e i vezzi del momento.
A volte egli ha tolto le «aggiunte», le licenze di questo o quel cantante, persino taluni atteggiamenti che erano
diventati consuetudine di un baritono (si pensi alla mano sul cuore e allo sguardo rivolto al loggione in cerca
dell'applauso) o ha fermato il soprano che tendeva a bamboleggiare. Insomma, ha restituito Verdi così come
doveva essere, anche se il musicista in questione era stato coperto da oltre un secolo di licenze e di varianti a
cui non aveva mai pensato.
Se l'Ottocento ebbe la pessima mania delle arie di baule, ovvero di quei brani che avevano reso celebre un
cantante e venivano cantati indipendentemente dall'opera che si stava eseguendo al solo fine di suscitare
entusiasmo nel pubblico, il Novecento e questi primi anni del secolo XXI non sono riusciti a liberarsi delle
superfetazioni musicali (dal latino medievale «superfetatio, superfetationis», da «super-fetare», vale a dire
«concepire sopra») che si annidano in ogni esecuzione. Muti ritorna sempre a Verdi e toglie senza
tentennamenti tutto quello che si è aggiunto alla sua arte, ai desideri che ha espresso, agli ordini che sovente
impartiva.
Ho imparato molte cose in questi incontri, e soprattutto ho capito che in musica lo studio, le prove, il lavoro
assiduo non si possono sostituire. L'arte della musa Euterpe, in altri termini, è un percorso che si deve
compiere con dura disciplina e non ammette deroghe. Tutto il tempo che un musicista spende per
l'esecuzione di una certa musica è sempre restituito dalle note sotto varie forme. È qualcosa che non va
confuso con gli applausi, anche se ne fanno parte, ma rappresenta la realtà più intima, una sorta di
ricompensa metafisica. Gli ascoltatori prima o poi se ne accorgono, anche se oggi c'è una distrazione
maggiore rispetto a qualche decennio fa. Ma, come si suole dire, ogni epoca sente quello che può e capisce
quanto le è necessario per vivere. O per sopravvivere, che è un verbo più adatto ai nostri giorni.
Va da sé che se in questo libro scoprirete cose buone, il ringraziamento va al maestro Muti, che è il vero
autore; se, al contrario, vi imbatterete in qualche menda («Nessuno nasce imparato», soleva ripetere
Benedetto Croce) la colpa è di chi l'ha curato. E l'ha curato senza cambiare la sintassi originale e senza
tradire lo spirito che faceva parte del parlato.
Un ringraziamento va anche alla redazione Rizzoli, a Lydia Salerno e a Caterina Soresina Stoppani, angeli
custodi di questa iniziativa.
Premessa
Il musicista della vita
Ti serba alla grand'opra tu la dovrai
[compir...
Un nuovo secol d'br rinascer tu farai
RODRIGO, IN DON CARLO,
ATTO III, PARTE II, SCENA I
Verdi è il musicista della Vita, e certo è stato il musicista della mia vita. È un compositore talmente capace di
mettere a nudo e trattare le nostre passioni e i nostri dolori, i nostri pregi e i nostri difetti, che noi ci
riconosciamo in essi, e questo è uno dei motivi della sua universalità: sarà sempre attuale. Fino a quando
l'uomo resterà tale, con le sembianze di oggi, e non avrà come in Star Trek le orecchie lunghe, la testa a fungo
e le gambe rattrappite, ogni generazione troverà nella sua musica una parola di conforto.
Verdi, infatti, non ti stravolge mai: ti fa sempre sentire che ti è vicino e ti comprende. Entrando in contatto
con la sua musica e il suo teatro, hai la netta sensazione di un musicista che parla all'uomo dell'uomo,
vivendo tutti i sentimenti in prima persona. Studiando sempre di più questo autore, sono convinto infatti che
i personaggi siano per lui un mezzo per esprimere molti dei suoi stati d'animo e in ogni opera ce n'è almeno
uno che rappresenta una trasposizione del compositore.
La sua vita fu contraddistinta da un'amarezza continua — si parla spesso infatti di «pessimismo verdiano»
— ed essa traspare nelle sue opere. Non solo nel finale del Falstaaf; dove Verdi anche scherza e, con un
sorriso amaro, dà l'addio a tutto, ma i suoi personaggi più tristi e più desolanti sono quelli che
rappresentano la sua autobiografia.
Fiesco, nel Simon Boccanegra, è certamente una espressione di Verdi nel suo dolore, nel suo pessimismo,
nella sua tragedia (e pensiamo in quest'opera alla frase, pronunciata dal Doge: «Perfin l'acqua del fonte è
amara al labbro dell'uom che regna»), ma lo è anche Riccardo, in questo caso baldanzoso, nel Ballo in
maschera. L'amore di Luisa Miller verso la figlia è un sentimento paterno, come quello di Verdi che ha
perduto i figli molto presto; l'innamoramento, il senso della gelosia, il tradimento dei vari personaggi sono i
suoi; La Traviata è la sua risposta alle critiche dei «benpensanti» di Parma e di Busseto per il fatto che, da
vedovo, convivesse con Giuseppina Strepponi e, sempre nella Traviata, papà Germont, il padre di Alfredo
che induce Violetta a lasciare il figlio, non è altri che papà Barezzi, padre di sua moglie Margherita,
naturalmente visto sotto una luce più aspra.
Ma bisogna anche aggiungere che, superando l'aspetto autobiografico, i suoi personaggi finiscono poi per
essere prototipo di un modo di essere universale. Un esempio per tutti: Desdemona. Rappresenta le
Desdemone di tutto il mondo, comprensive, oneste, innamorate dell'amore per i loro uomini come lei è
innamorata dell'amore per Otello.
Per questo, assistendo a un'opera di Verdi, ognuno trova sul palcoscenico il proprio scrigno
sentimenti realizzato in maniera sublime, e ciò rende Verdi imperituro, in grado di essere compresa da
cinesi, australiani, peruviani... perché il suo è un messaggio che viene dal profondo di un cuore grande,
capace di riscaldare. Non a caso, per la morte di Giuseppe Verdi, D'Annunzio scrisse nell'Elettra i famosi
versi: «Diede una voce alle speranze e ai lutti. / Pianse ed amò per tutti».
Questa capacità di comunicare e di toccare direttamente le corde più profonde dell'ascoltatore, senza orpelli,
senza bisogno di traduzioni, non significa però né superficialità, né leggerezza. Molti lo considerano un
musicista sanguigno. Certo, neppure io dico che non sia passionale, ma lo è nella cornice di una grande
nobiltà e aristocrazia delle espressioni, come ho cercato di rendere nel mio modo di dirigere le sue opere e
come spiegherò approfonditamente nelle prossime pagine, tentando di capire chi realmente fosse Verdi e
quali indicazioni desse per l'esecuzione della sua musica.
Verdi, come dicevo, è il musicista della mia vita, nel senso che mi ha sempre accompagnato, sin da bambino.
A tre anni mi portarono al teatro Petruzzelli di Bari a vedere un'Aida. Stavo in braccio al nostro autista e
sembra che non abbia dato segni di stanchezza, ascoltando l'opera in assoluto silenzio. O forse dormivo, non
lo so.
Mio padre, che era un medico, aveva la voce di tenore e in casa spesso cantava, accennava delle arie. Quando
ho iniziato a studiare il pianoforte, a lui non è sembrato vero di poter cantare avendo finalmente uno che lo
accompagnava, e così le arie di Verdi mi sono divenute familiari.
Ascoltavo però le stesse arie anche nelle feste patronali, dove le bande — che ancora oggi io ammiro e
proteggo — suonavano le fantasie delle opere di Verdi più che di qualsiasi altro autore: i vari duetti tra
baritono e tenore, baritono e soprano, tenore e soprano. La parte del soprano veniva fatta dalla cornetta,
cioè la tromba, e la parte del baritono dal bombardino e dal flicorno tenore, strumenti che avevano un
vibrato che sembrava addirittura riprodurre la voce umana. Quindi, anche se non frequentavo il teatro,
avevo dimestichezza con questi motivi.
La prima vera opera che ricordo è stata al teatro Piccinni di Bari, quando avevo dodici o tredici anni: un
Otello, diretto da Napoleone Annovazzi. Il tenore era l'argentino Carlos Guichandut, certo non era al livello di
Mario Del Monaco, però per me fu molto importante. Ricordo che mio padre, quando iniziò l' Otello, con la
tempesta — «Una vela! Un vessillo!», «È la nave del duce...» — mi disse: «'Uagliò, sta' attento: adesso arriva
l'Esultate!», perché era, ed è, di prammatica che l'Esultate fosse il banco di prova del tenore: se è bocciato nel
momento dell'Esultate, è condannato per l'intera opera, ma di questo parleremo più avanti.
Bisogna dire che ho subito avvertito Verdi come un musicista a me molto affine, con cui sentivo un rapporto
diretto. Uno dei momenti in cui ne presi a quell'epoca consapevolezza fu quando seguii le prove alla Scala del
mio maestro, Antonino Votto. Ne ricordo due in particolare: il Falstaaf e Un Ballo in maschera. Votto aveva
una conoscenza del Falstaaf miracolosa: sarebbe stato in grado di riscrivere la partitura nota per nota. Si
recava alla Scala per le prove ed entrava da via Verdi col suo cappottino grigio; un usciere gli toglieva il
cappottino dalle spalle, lui passava dai sotterranei e andava direttamente in orchestra. Senza partitura:
dirigeva a memoria. Non voglio dire che chi dirige con la partitura sia meno bravo di chi dirige senza, però
dirigere a memoria è un conto, provare tutto a memoria è un altro. Fare le prove di Falstaaf senza avere una
partitura davanti, senza portarla proprio in teatro, neanche in camerino, è notevole. Ma Votto era così: si
comportava come se andasse a un ritrovo con amici. Un giorno, avevo venti-ventidue anni, gli chiesi:
«Maestro, ma come fa?». Lui mi rispose con molta semplicità: «Se avessi lavorato con lui, sarebbe lo stesso
anche per te». «Lui» era Toscanini: non c'era altro lui.
Era un mondo fantastico, cui ripenso con malinconia...
Nel 1968 fui nominato direttore del Maggio Musicale Fiorentino. La prima grande opera dell'Ottocento in
forma scenica che diressi, in un teatro vasto, con un palcoscenico grande, fu I masnadieri, nel 1969: anche la
mia carriera comincia quindi con Verdi.
Ero pieno di entusiasmo, quasi di spirito garibaldino nell'affrontare quest'opera. La regia era di Erwin
Piscator, realizzata per l'esecuzione di qualche anno prima con Gianandrea Gavazzeni: una regia a
quell'epoca estremamente moderna e intelligente.
Fu un periodo bellissimo. Non avvenne nulla che potesse turbare la preparazione dell'opera. Durante le
prove di scena, dove ero sempre presente (come ancora oggi quando non sono impegnato in altre prove),
c'era un momento in cui il coro era in una posizione da cui non poteva vedermi, allora mi misi a dirigere il
coro in piedi su una sedia di paglia.
Poi avrei capito che i conti in un teatro sono ben diversi, ma nel 1968-69 si era ancora sull'onda di uno
slancio postbellico, c'era un'atmosfera febbrile in tutto il Paese. Era anche un periodo di contestazione, di
rivoluzioni giovanili, che hanno portato poi a una crisi, con tante cose buone e altre meno buone. Firenze è
sempre stata una delle città più combattive dal punto di vista dialettico e si sentiva, nel bene e nel male,
un'aria molto frizzante, che investiva anche il teatro. Quindi il titolo deI masnadieri si confaceva anche a un
atto d'accusa rivolto da parte della popolazione a certi vertici. Quel titolo, nella situazione di oggi, forse
sarebbe di attualità.
Nel 2013 cade il bicentenario della nascita di Verdi. Il miglior modo per celebrare questo anniversario non è
a mio parere quello di riproporre le sue opere, perché Verdi è già il compositore più eseguito al mondo,
bensì di approfondirne lo studio. Il problema è che non si può continuare a interpretare la sua musica
rispettando una inviolabile tradizione, perché dicendo «si è fatto sempre così e bisogna continuare a far così»
non si va avanti: occorre cogliere l'occasione per ristudiarlo.
Qualcuno potrebbe considerarmi arrogante, ma non Credo affatto di possedere la verità assoluta su Verdi. Si
è scritto molto su Bach, Mozart, Rossini, sullo stile, sugli strumenti, ma cosa si sa di Verdi?
Innanzi tutto si commettono molti errori, non rispettando le sue disposizioni; in secondo luogo si dimentica
che, vista la longevità del compositore, le sue opere sono nate in epoche differenti. La sua prima opera è
Oberto, del 1839, l'ultima è Falstaff del 1893.
Al tempo delle prime creazioni di Verdi, le orchestre erano composte da strumenti costruiti in modo diverso
rispetto a quelli di cinquant'anni dopo: gli ottoni non avevano pistoni, gli archi erano differenti, inoltre la
buca non esisteva e i teatri erano sempre illuminati. Lo stile dell'orchestra che suona in palcoscenico allo
stesso livello dei cantanti è certo dissimile dallo stile dell'orchestra dell'Otello o del Falstaafl decenni più
tardi, quando l'orchestra viene fatta mettere nella buca e alla Scala il giovane Toscanini suona il violoncello
diretto da Verdi. Quindi il vero suono filologico di Otello e Falstaaf è quello di Toscanini, quello che lui
ricordava avendo ascoltato di persona le indicazioni di Verdi, diversamente il suono di Oberto o Nabucco è
quasi settecentesco, esile piuttosto che robusto.
Per cui, chi è Verdi?
L'opera è un fatto culturale, oggi più che mai. Io Credo che, anziché concentrarci sulla singola nota o sulla
durata del fiato di un cantante, dovremmo cercare di sviscerare con sempre maggiore attenzione il
messaggio artistico-culturale dell'autore. Davvero vorrei che l'opera tornasse a rappresentare la cultura del
nostro Paese, non come esibizione da circo di questo o quel cantante. Oggi tutto sembra diventato più facile,
più superficiale e più immediato e, attraverso la televisione e il cinema, la società è diventata abile a
guardare, ma meno ad ascoltare.
I nostri musicisti del passato hanno creato un grande patrimonio, che ora è proprietà del mondo intero.
Anche cogliendo l'occasione dell'anno verdiano, noi dobbiamo restituire a Verdi, il patriarca, la dignità e il
rispetto che desiderava, e che merita. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il compositore d'opera
più amato è ancora ben lontano dall'essere conosciuto a fondo. L'opera di Verdi è ancora da venire: in questo
senso Verdi è l'autore del futuro.
1
Esattamente quello che è scritto
... il male sta che non si eseguisce
mai quello che è scritto; ... Io non ammetto,
né ai Cantanti, né ai Direttori
la facoltà di creare.
LETTERA DI VERDI A GIULIO RICORDI
I I APRILE 1871
Spesso mi domandano quale sia il segreto per accostarsi a una partitura. Io Credo che i direttori d'orchestra,
ma anche i cantanti, dovrebbero avvicinarsi a ogni partitura, e a quelle di Verdi in particolare, non solo con
estrema semplicità, ma anche con estrema umiltà, e soprattutto senza essere condizionati da quello che già
si è fatto.
Sarebbe il caso di tenere sempre a mente le parole che Verdi scrive a Giulio Ricordi l' 11 aprile 1871,
lamentando il fatto che i direttori «interpretano» e i cantanti «creano», per cui le esecuzioni non
corrispondono alle sue intenzioni:
Sulla divinazione dei Direttori ... e sulla creazione ad ogni rappresentazione ... È la
strada che condusse al barocco ed al falso l'arte musicale alla fine del secolo passato, e
nei primi di questo, quando i Cantanti si permettevano creare (come dicono ancora i
Francesi) le loro parti, e farvi in conseguenza ogni sorta di pasticci e controsensi. No: io
voglio un solo creatore, e mi accontento che si eseguisca semplicemente ed esattamente
quello che è scritto; il male sta che non si eseguisce mai quello che è scritto. ... Io non
ammetto, né ai Cantanti, né ai direttori la facoltà di creare, che, come dissi prima, è un
principio che conduce all'abisso.
Ora, è chiaro che quando Verdi chiede di eseguire «esattamente quello che è scritto» non intende che
l'interprete, con i suoni, faccia una specie di fotocopia della partitura, perché questo è impossibile. La
valutazione della lunghezza di una nota è sempre un fatto aleatorio, nessuno è in grado di battere quattro
quarti sempre nello stesso modo. E una nota, nelle mani di un direttore, non può che avere una durata, un
peso, un colore, un timbro diversi da quella di un altro.
Le parole di Verdi significano allora: «Cercate di capire quello che io intendo dire e che è dietro le note, ma
leggendolo attraverso le note, non cambiandole a capriccio, creando». È un po' come dicevano i Sufi con la
massima: «Se vedi lo zero non vedi nulla, ma se guardi attraverso lo zero vedi l'infinito»; tradotto in musica: se
vedi una nota non vedi nulla, ma se guardi attraverso la nota vedi l'infinito.
Pensiamo che a quell'epoca non esisteva la Siae, per cui, una volta che l'autore aveva dato la partitura in
mano all'impresario, quest'ultimo e gli esecutori potevano fare ciò che volevano.
In una locandina del Trovatore della Scala, del 1854, anno immediatamente successivo alla prima di Roma,
ho potuto leggere il programma di una di quelle serate tipiche dei teatri italiani, dove c'era un pot-pourri di
tante cose: si rappresentava il primo atto, poi c'era un balletto, quindi il secondo atto seguito da
intrattenimenti vari. Il terzo atto (quello con la cabaletta «Di quella pira l'orrendo foco») non era stato
assolutamente eseguito, il che significa che, all'epoca, non era il punto di riferimento del Trovatore.
Verdi, così attento alla drammaturgia delle proprie composizioni, non poteva certo essere contento
dell'amputazione di un atto intero della sua opera.
Il rispetto della partitura è stato il principio che ha improntato il mio lavoro, sin da I masnadieri a Firenze.
Quella era la prima volta in cui mi confrontavo con il mondo strano dei cantanti, lo stesso che, senza alcuna
remora, prende una partitura e la adatta alle proprie esigenze: «Questo è troppo pesante e lo tolgo, questo
sarebbe meglio portarlo mezzo tono sotto...». Tutto in virtù, poi, della nota finale (una volta mi fu detto
addirittura: «Quella nota è importante perché è il goal!»).
Personalmente trovavo che fosse un insulto alla grandezza del compositore e, quasi con una sorta di
ribellione, cominciai a interessarmi sempre più a che cosa Verdi aveva scritto (anche alle sue lettere), a che
cosa voleva, a che cosa avrebbe detto.
Devo dire che in Italia vivevamo un periodo straordinario per quanto riguarda la musicologia e la critica
musicale. C'erano dei grandi personaggi con cui un giovane direttore d'orchestra poteva approfondire questi
argomenti, penso a Vittorio Gui, al mio maestro Votto, a Franco Ferrara. Però mi ero accorto che, tranne i
grandissimi direttori, il modo di andare avanti, di capire e di interpretare le opere verdiane da parte degli
altri era basato sulla consuetudine, con alcune parti che erano state chiuse tra graffette e mai più eseguite.
Spesso ripeto la famosa frase del grande direttore d'orchestra Furtgler: «La tradizione è l'ultimo sbiadito
ricordo dell'ultima cattiva esecuzione». È proprio così. Nei primissimi tempi, quando chiedevo consigli, mi
dicevano: «Qui si taglia, qui si abbassa...» e quasi ero tentato anch'io di seguire tali indicazioni. Poi, col tempo,
ho assunto sempre più un atteggiamento critico, ho cominciato a rileggere molte pagine ormai dimenticate e
a pormi problemi e domande che mi portarono, nel 1972, al Guglielmo Tell in edizione integrale, che fece un
grande scalpore.
D'altra parte, come in un museo il direttore ha l'obbligo di mostrare al pubblico l'intero suo patrimonio, lo
stesso vale per la musica. Chi mi autorizza a non eseguire alcune parti? Ricordo che, quando feci La Traviata
ed eseguii alcune cabalette sconosciute ai più — per esempio, nella scena ottava, dopo l'aria di Germont Di
Provenza il mar, il suol, la cabaletta «No, non udrai rimproveri, copriam d'oblio il passato...» —, un giornalista
mi rimproverò, sottolineando inoltre che, laddove la partitura indicava il da capo, avevo persino fatto
cantare due volte la stessa cabaletta, con qualche variazione e abbellimento. Io rimasi molto offeso: perché
accusarmi di aver portato in scena ciò che Verdi aveva scritto? Perché io dovrei, come ancora oggi si fa,
abolire una cabaletta in quanto brutta? In realtà non è brutta: lo è se viene eseguita in una maniera volgare.
Oltre ad abolire determinate parti ritenute meno belle, un altro «trucco» spesso in voga, abbastanza infame,
è quello di abbassare le tonalità per preservare il cosiddetto acuto finale (in genere neanche voluto
dall'autore). Come si usa dire: «Fessi e contenti».
Per esempio, «Di quella pira», nel Trovatore, scritta in Do maggiore, molto spesso si fa in Si maggiore: mezzo
tono sotto o, ancora più spesso, in Si bemolle maggiore, cioè un tono sotto. Questo perché alla fine il tenore
vuol fare quel famigerato acuto che deve durare mezz'ora. Però Verdi teneva molto ai rapporti fra le tonalità:
non si può cambiare il colore di un'intera cabaletta solo perché si vuole cantare un acuto. È un delitto.
D'altra parte, in tutta la letteratura operistica è molto raro trovare arie che terminano con acuti: ne possono
contenere tanti, ma la risoluzione della frase è sempre in basso. Perfino Rossini, in tutte le sue cadenze,
spinge la voce in alto, ma nel finale la riporta giù. Gli stessi castrati, quando si cimentavano nelle grandi
improvvisazioni virtuosistiche, facevano salire la voce fino ad altezze inimmaginabili, con trilli, gruppetti,
scale e gorgheggi, ma la conclusione era sempre in basso, perché così è il cammino della vita...
In Verdi c'è il Si bemolle acuto in chiusura di Celeste Aida, però si tratta di una scelta d'effetto: non è un acuto
vigoroso, è segnato pianissimo, morendo, e la partitura orchestrale è molto delicata (è però raro sentirlo
eseguire così, solitamente il tenore spara l'acuto).
«Di quella pira» è un po' l'emblema della mia intenzione di rimuovere consuetudini esecutive che si sono
sedimentate nel tempo, ma che considero sbagliate. Di certo ho rotto un tabù, e questo non può che essere
positivo per direttori e cantanti in futuro.
Molti tenori non eseguono particolarmente bene l'aria che precede la cabaletta ma, se alla fine cantano
l'acuto, il pubblico dimentica tutto il resto e applaude. Quell'acuto in realtà è sbagliato, è proprio sbagliato
musicalmente: Verdi non ha scritto un Do, bensì un Sol; infatti non può essere che l'aria si chiuda con un
acuto e poi il coro improvvisamente ricominci con «All'armi!». Anche dal punto di vista drammaturgico non
ha senso: è contrario alle intenzioni di un grande musicista e uomo di teatro qual era lui. Volendo rispettare
l'arcata drammatica, quell'acuto è inconcepibile.
Quando Verdi ha riscritto Il Trovatore per Parigi, Le trouvère, ha cambiato tante cose, ma quella nota è
rimasta Sol naturale, non il Do naturale che già viaggiava ampiamente nei teatri. Verdi infatti ne era
consapevole, ma non poteva certo passare il tempo a dare bacchettate a quelli che cantavano note che lui
non aveva scritto.
Per fare quell'acuto bisogna riarrangiare completamente la parte del coro perché, mentre il coro canta
«All'armi, all'armi» (Sol-Do), in quel momento il tenore dovrebbe tener ferma una nota (il Sol naturale),
«All'aaarmi!». Secondo Verdi, poi, dovrebbero finire insieme, come sarebbe logico: quando si va all'attacco,
parte il generale con tutto l'esercito; invece, di solito, per fare quella nota acuta l'esercito parte e il generale
rimane sulla scena, con la spada in aria, con l'urlo non scritto da Verdi, secondo il famoso detto «Armiamoci
e partite».
Un altro grave errore che si commette spesse eseguendo Il Trovatore è alla fine del secondo atto, quando di
colpo compare Manrico: è una delle cose più stupefacenti che Verdi abbia scritto, di una modernità
incredibile. Leonora canta, incredula, perché pensava che Manrico fosse morto: «Sei tu dal ciel disceso o in
ciel son io con te?».
È una delle frasi più sorprendenti dell'opera, in cui Verdi ferma momentaneamente la battaglia e, come un
grande regista moderno, sposta lo zoom direttamente sulla cantante. Sta finendo il secondo atto e,
attenendosi allo spartito, dovrebbe cantare solo il soprano. La brutta e orrenda tradizione, invece, fa sì che,
in maniera demenziale, il tenore — desiderando mantenere il proprio ruolo di protagonista — si unisca al
soprano e domandi a se stesso: "Son io dal ciel disceso o in ciel son io con te?".
Un uomo di teatro come Verdi avrebbe mai potuto accettare tutte queste cose?
In qualche caso, invece, fu lo stesso Verdi a dare indicazioni precise sul diapason: per esempio, pretese che l'
Otello venisse fatto con un diapason basso (non il 443-44-45 che era in uso, ma addirittura il 432-33-34), per
avere un suono scuro.
Essere fedeli alla partitura non significa però non essere liberi nell'interpretazione. Se si ascoltano le mie
esecuzioni, che piacciano o no, avendo sott'occhio la partitura, si nota che alcuni miei tempi sono molto
tradizionali, talora invece ho tempi sostenuti. Dagli scritti di Verdi risulta che preferiva i tempi veloci, perché
non amava che la musica subisse rallentamenti, a favore di un cantante o per l'indolenza di un direttore.
Voleva che non si perdesse mai la tensione drammatica; lo vediamo per esempio nella scena del gioco a
carte, nel secondo atto della Traviata, con l'arrivo di Violetta: «Ah, perché venni, incauta! Pietà di me, gran
Dio!».
L'accompagnamento orchestrale è febbrile, ma quando il soprano canta queste parole la maggior parte dei
direttori rallenta. Io, invece, lo eseguo in modo più compatto, più a tempo, meno rallentato. Fu Votto a
insegnarmi così, mi spiegò che non bisogna rallentare, perché il ritmo dell'intera scena non deve cambiare, è
sempre agitato; Verdi scrive la frase tra parentesi, intendendo quindi che è un pensiero di Violetta. Il fatto
che la melodia sia bella non implica che tutti debbano rallentare, è assurdo e anche sbagliato dal punto di
vista drammatico, non semplicemente musicale: i suoi pensieri devono risultare parte di quell'inferno, è
essenziale. Rallentare qui è una delle prassi tradizionali, però. Certo, è molto più facile e si fa contento il
pubblico, ma nella partitura quella frase è tra parentesi.
Un caso opposto, in cui invece mi discosto dalla partitura, è nel secondo atto del Luisa Miller, «Cortigiani, vil
razza dannata». Io lo dirigo in modo quasi violento, fortissimo, concitato, non mezzoforte com'è scritto, che
potrebbe farlo sembrare un Concerto grosso di Corelli. Se si aggiungono potenza, volume e intensità,
l'orchestra diventa romantica, impetuosa: questa è la nostra tradizione. Per essere fedele alla partitura,
dovrei eseguirlo in modo più controllato, più classico.
Pensiamo infine al duetto tra Riccardo e Amelia nel secondo atto del Ballo in maschera; le parole sono: «Ah,
qual soave brivido l'acceso petto irrora!». Toscanini lo eseguì con la Nbc Orchestra in modo irruente: voleva
eccitazione. In realtà nella partitura è segnato ppp, leggerissimo. Io cerco di trovare un compromesso; con
tutto il rispetto per il grande Maestro, Credo che esagerasse: quel ppp è un ideale, ci aiuta a capire quali
sonorità Verdi desiderasse, qualcosa di onirico, di etereo. Ma seguirlo alla lettera al giorno d'oggi risulta
impossibile: i teatri d'opera sono grandi e i cantanti tendono piuttosto a sovraesporre la voce.
Da questi esempi risulterà chiaro il motivo per cui sostengo che il problema dell'interpretazione verdiana
perdurerà nei prossimi decenni. Negli anni Quaranta e Cinquanta Verdi veniva eseguito in maniera verista, i
cantanti ricorrevano alle urla, le orchestre mancavano di raffinatezza, ed è sbagliato: Verdi è uno dei
compositori più raffinati ed eloquenti. Il dubbio che rimane aperto però è: evidenziando l'eleganza, in quale
misura si priva Verdi dell'accento verdiano?
Questo mio riallacciarmi al rigore di Verdi mi ha attirato purtroppo delle antipatie: sono spesso stato
accusato di essere il direttore che vuole sottomettere i cantanti e non permettere loro di brillare. Ma Verdi
non scriveva per far brillare il tenore o il soprano: scriveva unicamente perché voleva esprimere attraverso
le loro voci i suoi sentimenti.
Alla fine della mia vita Credo che questa sarà una lotta persa, però sono contento di averla condotta, perché
nel mio concetto di orgoglio di essere italiano, e nel credere in quest'Italia, ho sempre pensato che la nostra
produzione operistica non sia inferiore a quella di Mozart o di Wagner, il cui ascolto viene fatto con estremo
e sacerdotale ossequio e riverenza: nessuno oserebbe cambiare le loro pagine.
I tedeschi, peraltro, ci hanno spesso accusato di essere in musica il popolo dello zumpappà. Ma io ripeto
sempre che i cosiddetti accompagnamenti verdiani (che a volte risuonano come «musica da banda», per
intenderci e senza nulla togliere alle bande) non sono «accompagnamenti», bensì note che, attraverso una
pulsazione ritmica, devono creare attorno alla voce l'evocazione di una situazione drammatica interiore.
Non si può considerare solo la voce il veicolo dell'espressività e, sotto, fare una specie di rustico
accompagnamento. Tuttavia è così che spesso viene eseguita l'opera italiana. Mi capita alle volte di leggere
nelle critiche frasi come: «Il direttore ha cercato di nobilitare la partitura verdiana». Ma l'Attila, per fare un
esempio, ha forse bisogno di essere nobilitato? Attila è opera nobile! Io non conosco una sola battuta di Verdi
in cui ci sia un elemento di volgarità (a meno che non sia intenzionale).
Quindi non è che uno nobilita ciò che prima non era nobile: è che prima era eseguito in maniera ignobile.
Questa è una battaglia che continuerò a fare.
Anche se mi sono sempre interessato a studiare storicamente ciò che interpreto (dove è avvenuto, come è
avvenuto, qual era il clima), voglio precisare che non sono uno schiavo della filologia fine a se stessa, come
quella spesso applicata al mondo barocco e al primo classicismo, che prescrive il non vibrato, la voce fissa,
eccetera.
Se volessimo essere davvero filologici, dovremmo vestirci in modo diverso, perché i vestiti erano diversi e
assorbivano in maniera diversa il suono, dovremmo abolire le macchine e gli aerei, mangiare in un altro
modo, mettere la parrucca... Non è che, se io non vibro o uso le corde di budello o tengo l'arco in un certo
modo, ho ricreato filologicamente un mondo.
Per esempio, chi di noi sa come veramente cantavano i più famosi cantanti evirati del XVIII secolo, come
Farinelli o Caffarelli? Nello stesso secolo, il bambino Pergolesi, a Napoli, allievo di uno dei collegi musicali
della città, cantava filologicamente? Gli Angeli musicanti dei Musei Vaticani dipinti da Melozzo da Forlì, che
cantano con le bocche spalancate, cantano «all'italiana»: senza tecnica, ma con passione e slancio.
Sicuramente non corrispondono alla tecnica filologica che si vorrebbe applicare oggi: tutte le nostre teorie
moderne crollano di fronte a quei quadri.
È chiaro che all'epoca gli strumenti avevano un altro suono, perché erano diversi: oggi sono più generosi,
nella dimensione e nella sonorità. Negli ottoni, per esempio, non abbiamo l'oficleide bensì la tuba (che certe
volte sostituisce erroneamente il trombone basso o il cimbasso). Tuttavia, non è usando il cimbasso invece
della tuba che si risolve il problema filologico verdiano.
La filologia di Verdi è semplicemente nell'approccio da parte degli interpreti, basato sull'individuazione del
dramma: perché quella nota è sotto quella parola? Perché quella parola è sopra quella nota? Questo è un
concetto che approfondiremo nel capitolo Il perfetto accordo tra musica e parola.
Il suono verdiano è quello che ci ha lasciato Toscanini, perché ha suonato il violoncello diretto da Verdi e il
suono che ha creato è sicuramente quello che poi ha adoperato, in maniera più moderna e più brillante,
come interprete in tutta la sua vita.
Si narra a questo proposito un aneddoto divertente: un giorno Toscanini era al secondo leggio alla Scala,
giovanissimo, nel famoso assolo del gruppo dei violoncelli alla fine del primo atto dell'Otello e si beccò una
sgridata terribile da Verdi perché suonava troppo forte. Toscanini allora avrebbe risposto al grande e
venerabile Maestro: «Non sono io che suono troppo forte: è il primo che suona troppo piano!». In ogni caso, il
suono toscaniniano è certamente più vicino alle intenzioni di Verdi rispetto a quello di certi direttori filologi
di oggi, che magari non parlano neanche l'italiano e non sanno che cos'è l'italianità, nel senso nobile della
parola.
Bisogna ammettere tuttavia che Verdi è molto esigente: richiede all'esecutore un virtuosismo non solamente
di velocità delle note, ma anche nel suono, nel fraseggio, aggiungendo anche indicazioni di sonorità vocale:
già in Nabucco il compositore prova nuovi timbri, in Macbeth sottolinea le situazioni drammatiche creando
sonorità impensabili a quell'epoca. Nel Macbeth, e ricordiamo che è del 1847, Verdi chiede all'orchestra un
suono muto, al cantante una voce soffocata, che sembrano una contradictio in terminis: «muto» significa
«silenzio». Suono muto significa «suono che non è suono». Questo è virtuosismo, perché richiede allo
strumentista non solamente l'esercizio e l'esperienza di ciò che ha studiato in conservatorio, ma anche il
contrario: e cioè di emettere un suono... non emettendolo.
Su questo suono muto, vi è poi l'indicazione diminuendo. Come si può diminuire un suono che è già un non
suono?
È questa la grandezza di Verdi. Ha un concetto del suono e della sua emissione che non appartiene a quello
nostro, «normale». Verdi è molto più moderno di quello che noi pensiamo, e qui è davvero proiettato molti
decenni in avanti: indicava sonorità pressoché espressionistiche, ben prima che l'espressionismo diventasse
una scuola di composizione o di pittura. Suono muto, suono soffocato, senza suono, con voce oscillante, sono
tutti termini che non si troveranno neppure nelle partiture di Aleksandr Scrjabin, che sono ricche di
prescrizioni ben precise.
Già all'inizio del suo percorso creativo Verdi si rivela un compositore «del futuro» e intende usare
l'orchestra e la voce, specialmente la voce, in un modo ben diverso da quello atletico oggi in voga, quando si
richiedono ai cantanti prestazioni di virtuosismo e potenza. Per lui la voce era davvero veicolo di
espressione, ma un'espressione di tale modernità che, se cercassimo di realizzarla nei nostri teatri
tradizionali, saremmo presi per matti.
Un chiaro esempio di questo è il ruolo di Lady Macbeth. Non Credo che oggi il pubblico accetterebbe una
Lady Macbeth con una voce rauca, una «voce che avesse del diabolico», ma è così che Verdi la voleva.
Solitamente Verdi scriveva tenendo presenti le caratteristiche dei cantanti che aveva a disposizione e spesso
apponeva modifiche se un cantante non riusciva a eseguire la propria parte come scritta; teneva molto
all'accuratezza, dal punto di vista sia vocale che strumentale, ma dava la massima importanza
all'espressione.
Io invece non ho mai potuto scritturare un'interprete con una voce rauca per Lady Macbeth, sia perché a un
certo punto ci sono note che richiedono un suono potente, sia perché il pubblico protesterebbe. Sarebbe
splendido però poter eseguire un Macbeth con un soprano e un baritono che cantino con una certa asprezza;
Verdi spiegò ben chiaramente perché non voleva Eugenia Tadolini come Lady Macbeth: «La Tadolini ha una
voce stupenda, chiara, limpida, potente e io vorrei in Lady una voce aspra, soffocata, cupa».
Carlos Kleiber, il grande direttore d'orchestra che ci ha lasciati nel 2004, mi disse un giorno: «Ci sono delle
musiche che funzionano bene solamente sulla carta, cioè guardandole. Perché, quando le si porta in vita, il
risultato è di gran lunga inferiore a quello che immaginavamo».
Ogni buon musicista, aprendo la pagina di una partitura, legge e immagina, crea dentro di sé la partitura
stessa. È come quando uno legge la Divina Commedia: non ha bisogno di declamarla ad alta voce, perché le
parole entrano nella testa e possono anche creare un effetto recitato estremamente poetico, che si perde
però nel momento in cui vengono pronunciate e nascono a vita concreta.
Lo stesso vale per la musica: io posso immaginare un suono, ma dovrò poi fare i conti con le difficoltà
tecniche dei diversi strumenti; pensiamo per esempio all'oboe che, essendo uno strumento ad ancia doppia,
non può scendere sotto una certa sonorità.
Il momento dell'esecuzione allora non è altro che il momento della concretizzazione di giorni e giorni di
lavoro, con gli strumenti e con i cantanti. Il rapporto palcoscenico-buca è strettissimo. Ogni tanto si legge da
parte di certi critici musicali: «Il direttore ha seguito bene i cantanti, ha aiutato i cantanti», ma è una frase
completamente sbagliata. Il direttore non deve seguire il cantante: deve far musica con il cantante. È chiaro
che non deve mettergli la camicia di forza, ma neanche essere schiavo di una serie di cantanti che, se lasciati
al loro arbitrio e non incanalati in un comune flusso interpretativo, creerebbero il caos.
Uno dei problemi fondamentali in Verdi, ma in tutta l'opera italiana, è il legato. Noi abbiamo la più bella
lingua del mondo, perché è come un fiume che scorre: il legato nella musica deriva infatti dal legato nella
nostra lingua parlata.. Purtroppo però oggi, quando si canta, molto spesso si spezzano le parole. Si racconta
di un corista che un giorno, cantando il Macbeth, chiese al maestro del coro: «Scusi, che cos'è il galempio?».
Aveva infatti interpretato le parole "Colga l'empio!" spezzando il verbo "col-ga".
Parte integrante dello stile è quindi il modo di pronunciare le parole, perché in Verdi sono molto più
importanti che non in Bellini o in Donizetti. In Verdi ogni parola è come una scultura di Michelangelo, questa
è la differenza maggiore tra lui e i compositori suoi contemporanei o di poco precedenti.
La chiave per una buona pronuncia sono le consonanti dure, specialmente in parole con la erre arrotata, che
devono essere articolate in modo appropriato. Oggi, però, è difficile trovare cantanti in grado di farlo. Maria
Callas ci riusciva perfettamente, come diversi altri. Se infatti le parole vengono articolate come si deve, è già
garantita una buona dose di intensità.
Ho sempre in mente Sesto Bruscantini: penso alla varietà, al modo in cui riusciva a mantenere uniforme la
linea del canto, producendo però un'infinità di colori. Questo denota un grande cantante. Il migliore era
Aureliano Pertile, ricordo come eseguiva l'Improvviso dell'Andrea Chénier: quell'aria cantata da Pertile
dovrebbe essere fatta ascoltare tutti i giorni a cantanti, strumentisti, direttori e registi, perché sentano
quante inflessioni e quanti colori egli era in grado di trarre anche da una singola parola. Mi torna in mente
spesso, perché per me è come una finestra sul Golfo di Napoli.
Avvicinarsi a Verdi, quindi, dal mio punto di vista significa fare musica insieme, tenendo sempre presente
che si è in un teatro, dove la parola verdiana, l'accento verdiano, devono condurre, poi, alla definizione del
dramma.
Non mi considero un artista, bensì un artigiano della musica. Ho sempre considerato me stesso un outsider
del mondo della musica, del mondo dello spettacolo, del mondo delle luci, del mondo del palcoscenico. Cioè
colui che, per una serie di ragioni del destino o del fato, si è trovato a fare questa professione. E io la vivo,
l'ho sempre vissuta, in maniera molto rigorosa. Ma, appena terminato il mio compito di battitore in pubblico,
mi sono ritirato e ho guardato il mondo in cui ho operato per quelle ore come a qualche cosa fuori di me.
Una volta Herbert von Karajan, il mio amico direttore d'orchestra scomparso nel 1989, mi disse: «Ricorda
che essere un buon direttore significa avere per trent'anni la pazienza di ripetere ai propri musicisti sempre le
stesse cose essenziali». È un'indicazione che mi sforzo di seguire. Karajan è stato veramente il costruttore di
un suono moderno, un cultore del suono. Con Karajan si è avuto un suono addirittura portato quasi fino
all'estenuazione del suono stesso.
Non si tratta infatti solo di accompagnare i cantanti, come un tempo veniva concepito il ruolo del direttore,
ma di scoprire insieme con loro iin mondo. Certo, si corre il rischio di cercare qualcosa che non esiste. Verdi
creava per istinto molte sonorità. Non parlava inglese, per cui non poteva comprendere a fondo la lingua di
Shakespeare, però sapeva percepire subito un'atmosfera; non visitò mai l'Egitto, però nel terzo atto di Aida
riuscì a evocare l'atmosfera del Nilo.
C'è molto da analizzare in Verdi, ma non tanto per l'aspetto musicale quanto per quello drammaturgia).
Grande attenzione va posta, per esempio, all'uso della parola, non solo cantata ma anche parlata: pensiamo
alla lettera che Lady Macbeth sta leggendo nel primo atto, in cui il marito le narra del suo incontro con le
streghe e delle loro profezie. Oppure alla Traviata: anche lì c'è una lettera, accompagnata da un assolo di
violino, quando Violetta dice: «È tardi». È parlato, non cantato.
In questo caso l'indicazione di Verdi in partitura è: con voce sepolcrale; farebbe dunque pensare a una voce
molto bassa, tuttavia egli afferma di volere per il primo atto una voce da soprano leggero, di coloratura.
Allora, quale tipo di strumento aveva in mente? Una voce bella? Una voce capace di sfumature espressive?
In effetti nella Traviata la voce del soprano deve avere tre caratteristiche diverse: il primo atto richiede un
soprano leggero, per il secondo e il terzo ci vuole invece un soprano lirico se non spinto; ecco perché è
impossibile che una cantante sia perfetta per l'intera opera. Deve infatti saper interpretare i tre differenti
aspetti della personalità di Violetta: nel primo atto è una Traviata, una prostituta, nel secondo una donna
innamorata, nel terzo una moribonda che compie un gesto d'amore, disposta a benedire un altro futuro
legame di Alfredo. Una prostituta, una donna innamorata, una santa: tre personalità, ma soprattutto tre
personalità con tre voci diverse.
Nei miei primi anni scaligeri veniva spesso alle rappresentazioni Wally Toscanini, figlia del grande Arturo, e
abbiamo avuto modo di parlare tanto di suo padre. Mi raccontava che il Maestro, anche da vecchio, dopo
aver diretto un concerto, tornato a casa si metteva in un angolo e sfogliava di nuovo la partitura per
controllare tutte le cose che non erano andate nell'esecuzione. Sembra incredibile: a ottant'anni si ristudiava
La Traviata.
Oggi tutta questa attenzione mi sembra che purtroppo non venga più posta. Un tempo si richiedeva al
giovane direttore d'orchestra un tipo di preparazione che ora sarebbe impensabile.
Ricordo che Svjatoslav Richter, uno dei giganti del pianoforte con cui collaborai agli inizi della mia carriera,
era capace di stare a provare venti minuti per una modulazione. Non era mai contento, non era mai
soddisfatto, bisognava provare e riprovare alla ricerca della perfezione.
E sempre Richter, per accettare di essere diretto da me, allora giovane vincitore del Concorso Cantelli, mi
convocò a Siena all'Accademia Chigiana e qui, a sorpresa, mi sottopose a un durissimo esame di pianoforte:
dava per scontato che lo sapessi suonare.
Quando vedo dei giovani, brillanti direttori d'orchestra che non mettono neanche un dito sulla tastiera, mi
domando che cosa farebbero se si trovassero in una simile situazione...
Come diceva Toscanini: «Dirigere lo possono fare tutti, anche gli asini. Fare musica è di pochi».
Bernstein, per esempio, era un Dioniso della direzione d'orchestra, ma in lui questo elemento dionisiaco non
dava fastidio, perché era l'emanazione del suo modo di essere e la musica lo rifletteva. Lui era sincero. Gli
orchestrali che lui dirigeva si rendevano subito conto che i suoi movimenti quasi danzanti, il suo tripudio o
l'estrema sofferenza mostrata attraverso l'espressione del volto corrispondevano esattamente a lui: c'era
una verità, e i musicisti la pretendono e si accorgono all'istante se, invece, è semplicemente frutto di
istrionismo fine a se stesso.
Sta diventando molto di moda, però, affidare la bacchetta a tanti ragazzi la cui direzione è più un fatto di
energia che di vera interpretazione. Alcuni sono anche dotati da madre natura, ma non viene dato loro il
tempo di pensare, di maturare.
È vero che Pergolesi è morto a ventisei anni, Schubert a poco più di trenta, Mozart a trentasei, però non è
sempre giustificato gridare al miracolo perché è nato un novello genio.
Il mio, ci tengo a sottolinearlo, non vuole essere assolutamente un discorso contro i giovani, ai quali dedico
molte energie. Se però mi domandate, in conclusione, quale sia il modo giusto per accostarsi a una partitura,
ricorro alle stesse parole che usò Verdi per rispondere a chi gli chiedeva il segreto della sua genialità e della
sua produzione: «Tre cose: lavoro, lavoro, lavoro».
2
Stregati da Verdi
Ah! ah! ah! ah!
E che baccano sul caso strano
E che commenti per la città!
CORO, IN UN BALLO IN MASCHERA,
ATTO II, SCENA V
Quello con il pubblico è un rapporto difficile da descrivere. In una sala gremita che ascolta un'esecuzione c'è
silenzio e silenzio: ci può essere il silenzio pieno di tutto e il silenzio vuoto di tutto. Non posso spiegarlo a
parole, perché è una sensazione che avverto fisicamente. Anche se sono al buio e do le spalle alla platea, io
sento esattamente cosa prova il pubblico: se il suo è un silenzio carico di tensione, di emozione, di attesa, o
certe volte anche di livore, di avversione.
Con il pubblico di Verdi, in sala si ha subito la sensazione di un atteggiamento gioviale e cordiale: si vedono
le teste dondolare i vari motivetti. Non c'è l'atteggiamento di riverenza che, per esempio, si trova di fronte
alle opere di Wagner, quando si va a Bayreuth e si vedono tra la gente alcuni recarsi al Festspielhaus con già
nella testa, come degli zombie, l'immagine del mondo del Walhalla: davvero hanno già pericolosamente negli
occhi dei raggi e degli sguardi che fan paura!
Con Verdi, invece, c'è il dondolio delle teste al suono di un-ta-ta e c'è l'attesa dell'acuto del cantante, il banco
di prova. Nelle pagine precedenti ricordavo a tal proposito l'Esultate dell'Otello: se il tenore è bocciato in
quel momento, è condannato per l'intera opera. Io penso che l'Esultate sia stato molto esagerato nella sua
importanza, ma questo dipende da un certo approccio popolare del pubblico verso l'opera italiana che in
qualche modo deve anche rimanere. Perché, se aboliamo anche quello, se disinfettiamo tutto, facciamo
dell'ascolto un ospedale. Allora non bisogna esagerare da una parte, né inveire, come si faceva ai tempi di
Verdi, ma, nel complesso, io sono convinto che siamo un Paese molto più serio di quello che gli altri
ritengono, e che noi stessi pensiamo di essere, anche in musica.
A proposito del pubblico, voglio raccontare due aneddoti, legati a due diverse esecuzioni scaligere, in cui
questo ha avuto un ruolo fondamentale: il famoso «bis» del Va’ pensiero nel 1986 e la mia esecuzione al
pianoforte della parte orchestrale della Traviata, il 3 giugno 1995, in occasione di uno sciopero
dell'orchestra.
Quella del Nabucco fu per me una serata memorabile e il giorno dopo era su tutti i giornali: l'Italia all'epoca
non s'interessava solo di problemi sportivi o di quanto costa un calciatore.
Era la mia prima opera come direttore musicale appena eletto del Teatro alla Scala, era il 7 dicembre e la
rappresentazione stava andando avanti con un normale successo. Quando arrivai al momento del Va’,
pensiero, mi ricordo che si creò in sala una tensione particolarissima, unica. Ebbi la chiara sensazione che
Milano ritrovasse se stessa.
Nabucco, infatti, è' l'opera di Milano, è rimasta l'opera di una Milano del Risorgimento che ha portato
all'Unità d'Italia, ed è un'opera che appartiene profondamente agli italiani. (La Lega ne ha fatto il proprio
inno ma è sbagliato perché, anche se volessimo pensare a un inno — ammesso che la pagina di un'opera
possa diventare un inno —, I Lombardi alla prima crociata sarebbe più indicato che non il Va’, pensiero.)
Già nelle prove avevo avvertito che il coro che attacca il Va’, pensiero alla Scala ha un significato, un colore,
un'atmosfera, un'aura particolare impossibile da trovare in qualsiasi altro teatro, anche italiano. Sembra
davvero che quella musica appartenga a quel palcoscenico. Non so come spiegarlo, ma eseguirla lì è più
«giusto».
Quando finimmo il Va’, pensiero, l'urlo del pubblico fu una delle cose indimenticabili della mia vita. Il
Nabucco non era stato più eseguito da diversi anni, e capii benissimo che il pubblico mi voleva dire: «Grazie!
Ci avete riportato ciò che è nostro, ciò che è la nostra identità, ciò in cui ci identifichiamo!».
Gli applausi non si fermavano ma, dovendo pensare anche all'arcata drammatica dell'opera, a un certo
momento cercai di alzare la bacchetta.
«No! Bis! Bis! Bis! Bis!»
In quel momento mi trovai in un dilemma spaventoso. Era la mia prima opera come direttore musicale,
quindi fare il bis poteva in qualche modo sancire il mio successo, ma sapevo benissimo che, dai tempi di
Toscanini, i bis erano banditi, giustamente, perché sono un'interruzione dell'opera.
Diverse volte ho tentato inutilmente di alzare la bacchetta, quasi però con il timore che questo grande
entusiasmo si tramutasse in insulti. Già a Toscanini era successo, ai tempi: nel Ballo in maschera il pubblico
voleva il bis dell'aria del tenore, Toscanini si era rifiutato e si era scatenato l'inferno contro di lui, per cui alla
fine aveva dato un pugno sopra il leggio, se ne era andato e dopo qualche giorno era partito per l'America;
ovviamente non solo per quello, come sappiamo.
Io non sapevo cosa fare. I coristi erano rimasti immobili, nella posizione voluta dal regista, ed erano proprio
davanti a me. Lanciai loro uno sguardo interrogativo ed essi, con gesto lento e solenne, annuirono: «Sì,
possiamo. Lo faccia». Ottenuto il consenso del coro, allora, girai le pagine tornando indietro e, quando,
soprattutto dal loggione, il pubblico capì, si scatenò un altro boato, ancora più forte, di approvazione.
Non immaginavo che tutto questo avrebbe poi creato una serie di accese discussioni. Era giusto o non era
giusto fare il bis? L'argomento divenne materia di importanza tale da occupare le prime pagine dei giornali,
anche i politici dissero la loro.
Fu un'esperienza indimenticabile. Oggi non Credo che un episodio del genere potrebbe interessare agli
uomini di cultura e ai politici fino a questo punto; allora c'era invece una passione completamente diversa e
quello era un gesto che riguardava una tradizione ancora sentita. Giuseppe Tarozzi, un critico, verdiano
accanito, scrisse addirittura che Muti finalmente aveva fatto di nuovo «impregnare» i muri della Scala della
musica di Verdi.
Un altro bis del Va’, pensiero che ha suscitato un certo scalpore è stato quello all'Opera di Roma il 12 marzo
2011, quando l'ho fatto cantare dal pubblico, quasi con spirito risorgimentale, deprecando i tagli alla cultura:
un appello affinché la nostra patria non diventi davvero «bella e perduta».
Altri momenti per me memorabili con il pubblico sono legati alla Traviata.
Penso innanzi tutto al 1990, quando riportai La Traviata alla Scala, con la regia di Liliana Cavani, dopo
ventisei anni di assenza, fra attese, speranze, sussulti, attacchi di ogni tipo. Si era infatti messo in moto tutto
l'ardore popolare, con i suoi pro e contro. C'era chi diceva: «Finalmente La Traviata ritorna!», ma anche chi
mi accusava: «Come osi toccare quest'opera dove si sono cimentate le più grandi dive?».
Io desideravo con tutto me stesso che questa musica tornasse a risuonare sotto la volta del Teatro alla Scala,
al di là delle esigenze di certi melomani che non gradivano che i loro ricordi venissero in qualche modo
«sporcati» da esecuzioni che non potevano reggere il confronto con le grandi interpretazioni del passato. Ma
non si può fermare il corso della storia, e della storia dell'interpretazione, con alti e bassi che siano e, alla
fine, La Traviata fu fatta, col risultato che, mentre prima era intoccabile, adesso forse è diventata un po'
troppo alla mano.
Fu un'esperienza estremamente faticosa. Era come andare in guerra, e io pensai che avremmo potuto
vincerla solo creando una compagnia di giovani: non perché il giovane è perdonato, ma perché avremmo
aperto una porta verso il futuro, verso una nuova aurora.
La Traviata tornò in scena il 21 aprile 1990, i protagonisti erano due sconosciuti, Tiziana Fabbricini nel ruolo
di Violetta e Roberto Alagna in quello di Alfredo. Fu una di quelle sere in cui, entrando in buca, temevo che mi
venisse un infarto. Sapevo che ci eravamo impegnati al massimo, che avevamo lavorato sodo per il nostro
pubblico, ma il pensiero predominante era: che cosa succederà stasera?
Avevamo la sensazione di andare al patibolo. Gli spettatori erano insolitamente silenziosi, non perché
fossero concentrati, ma perché c'era tensione fra i due gruppi opposti: alcuni erano semplicemente felici di
poter riascoltare La Traviata alla Scala, altri erano pronti a provocare un pandemonio se qualcosa fosse
andato storto. Ricordo l'emozione dei musicisti, la commozione di qualcuno quando attaccammo il preludio,
poi tutto il primo atto si svolse senza alcun disturbo. Terminate le acrobazie vocali della Fabbricini, il sipario
si chiuse, ci fu un attimo di agitazione, poi la liberazione per tutti: l'opera era tornata, accolta con successo.
Ancora una volta era come se improvvisamente la sala si fosse riappropriata di qualcosa che le apparteneva.
Una serata che non dimenticherò mai.
Un'altra Traviata indimenticabile fu il 3 giugno 1995, la sera del famoso sciopero dell'orchestra, annunciato
a mia insaputa alle cinque del pomeriggio, quando mi ritrovai a suonare per intero l'opera al pianoforte sul
palcoscenico, cosa che fece uno scalpore enorme in tutto il mondo.
Mi ricordo il teatro gremito, con il pubblico che inveiva contro il sovrintendente perché l'aveva fatto entrare
e quindi ora pretendeva lo spettacolo. Soprattutto dai palchi e dal loggione urlavano e si agitavano; dal mio
camerino, attraverso il televisore a circuito chiuso, vedevo braccia che si protendevano e gente che sbraitava
e che aveva deciso di passare la notte in teatro.
Mi sentivo umiliato, perché ritengo che non si debba mai creare il silenzio: quella di punire il pubblico non è
una forma di protesta giusta.
Non sapevo proprio cosa fare e improvvisamente mi venne in mente di suonare io il pianoforte. Allora
affrontai il pubblico, dicendo: «Guardate, la buca è completamente vuota, un direttore d'orchestra senza
orchestra praticamente è muto...». Non è Muti, è muto. C'era un silenzio in sala... Fino ad allora avevano urlato
improperi contro tutti, ora aspettavano che finissi la frase — se avessi detto: «Adesso quindi andate a casa»,
sarebbe successo un inferno! — e continuai: «Se volete, l'opera posso suonarvela io». Ci fu un urlo di
consenso. «Però datemi il tempo...»
Andai allora dietro le scene e cercai il pianoforte a coda, ma era stato portato dai facchini al piano superiore
e i facchini erano andati via: per riportarlo giù ci sarebbe voluta almeno un'ora... A quel punto probabilmente
la Scala sarebbe già stata bruciata.
Qualcuno, per fortuna, mi indicò un altro pianoforte nei camerini dei cantanti, un mezza coda: suonai un
arpeggio, una scala, capii che era possibile usarlo, anche se non era l'ideale, così feci portare il pianoforte in
scena, col sipario chiuso. Ma non era finita: subito ci rendemmo conto che il pianoforte non stava fermo
perché la scena aveva una forte pendenza, quindi scivolava verso la buca. Allora chiamammo i macchinisti
che dovettero mettere dei pezzi di legno sotto. «Bum! Bum!»: il pubblico sentiva queste martellate, chissà
cosa stava accadendo...
Il corpo di ballo non era entrato in sciopero e tutte le ballerine e i ballerini si sedettero intorno al pianoforte
come in un salotto ottocentesco a Parigi: era molto bello. Poi si aprì il sipario con un'ovazione della gente.
Cominciammo dal preludio e andammo avanti.
Forse solo in quel momento mi resi conto della gravità e della difficoltà dell'operazione. Se avessi suonato
male, qualche grido dal loggione mi sarebbe arrivato e tutto il castello sarebbe crollato: basta poco a
interrompere un incanto. Invece il destino volle che tutto andasse perfettamente... probabilmente il buon
Verdi intervenne.
Il coro non aveva voluto partecipare all'esecuzione, anche se non era in sciopero, il che la rese forse ancora
più interessante, perché così i cantanti erano liberi di muoversi intorno al pianoforte, improvvisare qualche
semplice azione. E l'opera finì tra applausi e gente che sillabava il mio nome. Poche ore dopo, questa notizia
stava già facendo il giro del mondo.
3
Il perfetto accordo tra musica e parola
Andiam. Andiam.
Ve; la traggedia mutò in commedia.
CORO, IN UN BALLO IN MASCHERA,
ATTO II, SCENA V
Verdi aveva una mente teatrale: nulla è casuale nelle sue opere. C'è un senso del dramma e un uso della
musica sapientissimo, in apparenza semplice, però scientificamente studiato. Ecco perché Verdi è
importante: non tanto per la sapienza dei concertati o per l'invenzione melodica delle sue arie — che senza
dubbio sono veicolo di grande forza e di grande emozione per raggiungere il pubblico —, bensì per la
costruzione drammatica del teatro.
È, infatti, Verdi che scrive la regia. Ovviamente non lo fa dando delle indicazioni sceniche (tipo «entra da
destra» o «esce da sinistra»), però con la sua musica ti indica esattamente che sta avvenendo un movimento,
che è necessario un movimento, che deve entrare qualcuno; evoca, definisce il carattere del personaggio.
Solo un altro musicista è riuscito a creare in maniera sublime questa simbiosi tra parola e musica: Mozart. E
Verdi è l'unico compositore che si sia avvicinato alla perfezione dei recitativi mozartiani.
Occorre dunque accostarsi a Verdi cercando di capire esattamente ciò che ha voluto dire con i segni che ha
scritto. Nei recitativi i cantanti molto spesso sono approssimativi, perché Credono che il recitativo sia una
recitazione libera, ma questa libertà deve essere ottenuta attraverso la rigorosa osservanza del testo. Il che
non significa solfeggiare, ma vuol dire che c'è sempre una ragione drammatica se una nota è più corta o più
lunga, se c'è un punto o una pausa: non è casuale.
È risaputo che, nello scrivere i recitativi, Verdi leggeva le parole del libretto ad alta voce, camminando avanti
e indietro nella sua stanza, ripetendole in continuazione finché non prendevano il volo, vestendosi della
melodia che avrebbe dato loro e diventando musica: la pulsazione ritmica delle parole scaturiva
direttamente dal modo in cui le pronunciava.
Eseguire i recitativi con trascuratezza reca quindi danno alla grandezza di Verdi, perché essi non sono meno
importanti delle arie.
Per fare qualche esempio, quando Verdi scrive un motivetto come La donna è mobile, non scrive una
canzonaccia da taverna per caso: ha un'intenzione drammaturgica molto precisa. Si capisce chiaramente che
vuole sottolineare quali sono le caratteristiche della personalità del Duca di Mantova, il quale all'inizio
dell'opera è anche capace di essere un raffinato corteggiatore con le varie dame.
Oppure, nel Ballo in maschera, opera del 1859, nel secondo atto, Verdi crea in Riccardo una situazione di
passione amorosa sfrenata verso Amelia, la moglie del suo migliore amico, fino quasi al limite dell'erotismo,
grazie a un accordo di nona che si apre poi in un accordo di quarta e sesta quando canta: «Sia distrutto il
rimorso, l'amicizia nel mio seno: estinto tutto, tutto sia fuorché l'amor!».
Nel Ballo in maschera Verdi si diletta a usare il contrappunto in un modo più raffinato rispetto al solito; con
quest'opera vuole dimostrare di non essere solo un compositore che sa come conquistarsi il pubblico, ma
anche un musicista ben preparato tecnicamente, quindi i colori sono davvero speciali. Subisce un po'
l'influenza del grand opéra francese, ma l'inizio di quest'opera rivela un nuovo Verdi, con colori che non si
ritroveranno nelle creazioni successive.
Un Ballo in maschera è un'opera sui generis, tecnicamente una delle più difficili per il soprano, per il tenore e
soprattutto per il baritono. Il personaggio di Oscar dimostra quanto Verdi conoscesse e amasse Mozart,
perché Oscar è una sorta di Cherubino (su quest'analogia sono state espresse una gran quantità di teorie,
che lascio discutere ai musicologi e agli storici), come l'uso di diversi complessi, quali la banda dietro le
quinte e l'orchestra d'archi che suona il minuetto in palcoscenico nel finale, deriva sicuramente da Don
Giovanni. L'influenza di Mozart è dunque molto più evidente nel Ballo in maschera che in opere precedenti.
Tuttavia il momento di maggiore interesse nel Ballo in maschera è il duetto d'amore del secondo atto.
Nell'arco di poche parole Verdi crea un'atmosfera erotica, sensuale, per la quale Wagner avrebbe impiegato
almeno venti minuti: ci riesce con un singolo accordo, un accordo che spiega tutto.
Nella storia della musica, nei temi d'amore, in Berlioz, Cajkovskij, c'è sempre un accordo dissonante, che
indica dolore: l'amore non può esistere senza dolore, è un'idea molto romantica.
Non Credo che Verdi si riferisse consapevolmente a questo concetto filosofico, gli veniva d'istinto. Pensiamo
alla sesta ascendente nel duetto d'amore del Ballo in maschera: non s'innalza solo verso il paradiso celeste,
ma anche verso un paradiso sensuale; quando Amelia finalmente ammette di amare Riccardo, le parole che i
due si scambiano non hanno grande importanza, non è necessario sentire il tenore che ripete: «M'ami,
Amelia!». In questo punto spingo l'orchestra fino al suo limite estremo e le voci diventano parte della
tessitura, come se quest'espressione d'amore facesse risplendere tutto l'universo. È uno di quei momenti in
cui Verdi raggiunge il suo culmine, è davvero insuperabile; inoltre, benché l'opera abbia come protagonista
un sovrano, la stessa trama può riferirsi benissimo a tre persone comuni: è il tipico triangolo, un'esperienza
che può accadere a chiunque.
Qui siamo di fronte al Verdi della piena maturità, che esprime così la sua passione amorosa. Quando Verdi,
nel 1887, arriva a Otello (Otello di Shakespeare rivisitato da Boito), non c'è più l'amore vissuto nella maniera
più concreta ma piuttosto una meditazione sull'amore.
Nel Falstaff rappresentato per la prima volta nel 1893, infine, Verdi ha raggiunto una fase ancora più
avanzata della sua vita e lo vediamo prendere le distanze da tutto. La riflessione amorosa è resa come un
gioco da ragazzi, realizzato nell'amore fanciullesco e purissimo tra Nannetta e Fenton.
Se dobbiamo però pensare all'opera più moderna nella concezione drammatica, la scelta non può che cadere
sul Luisa Miller.
Quando a Verdi, già avanti negli anni, fu chiesto quale opera avrebbe salvato se fossero state tutte bruciate,
rispose: «Il mio gobbo». Sapeva, infatti, che Luisa Miller era non solo la più commovente, ma anche la più
audace.
Fra le opere della trilogia (Luisa Miller, del 1851, Il Trovatore e La Traviata, del 1853), è senza dubbio la più
moderna, perché concepita con un'unica struttura compatta, senza arie chiuse perché si sviluppi atto dopo
atto senza interruzioni. In essa ogni nota ha la sua ragion d'essere in funzione di ciò che la precede e di ciò
che la segue. È già quasi un'anticipazione di quella che sarà l'arcata wagneriana: un'opera che fugge, che si
consuma sviluppandosi, come una cometa che, nella velocità tremenda, poi consuma se stessa.
Il Luisa Miller, andato in scena la prima volta nel 1851, comincia con il famoso «Quel vecchio maledivami!».
Sin dalle prime parole emerge dunque il tema della maledizione, potremmo dire del destino, che Verdi
svilupperà poi più tardi, come vedremo. (Il titolo dell'opera, peraltro, originariamente era proprio La
maledizione.)
Studiando approfonditamente quest'opera, ho capito che questo tema viene sviluppato anche musicalmente,
in modo scientifico. Il Luisa Miller è strutturato in pratica tutto su una nota: il Do naturale, con cui l'opera
inizia e su cui si svolge il tema della maledizione; in questo senso potremmo quasi definirla un'opera
epicentrica. Ogni persona che entra nel cerchio della maledizione entra in questa nota, che risucchia tutto al
proprio interno: un cerchio del male da cui, naturalmente, non si può uscire; un orrido luogo dove tutto
sprofonda.
Purtroppo anche il Luisa Miller ha subìto molte licenze e fraintendimenti interpretativi. Per esempio, se si
canta La donna è mobile con la puntatura finale, con il Si naturale che, voglio sottolinearlo, non è scritto in
partitura, si ferma quasi certamente l'esecuzione, ed è il più grande insulto che si possa fare alle intenzioni
del compositore; se invece si evitano queste interpolazioni, il pubblico non è portato ad applaudire, e ogni
atto scorre dall'inizio alla fine senza sospensioni.
Un altro fraintendimento ricorrente avviene quando Luisa Miller canta: «Mi coglierà sventura, ah no!» e,
dimenticando la gobba e di essere sciancato, si erge in piedi e spara l'acuto interminabile: «È folliiia». Verdi
non scrive così. Quello di Luisa Miller è un pensiero, egli medita e si domanda: «Sarò colto da questa
maledizione?»; poi, quasi scrollando la testa, dice: «Ma no, non è possibile, un pensiero di questo genere è una
follia».
In più, se l'acuto è fatto bene, il pubblico applaude fragorosamente, ma così nessuno ascolta le prime battute
dell'orchestra, il Do maggiore, pieno di felicità: il colpo di teatro che dovrebbe accompagnare alla gioia di
Gilda riportata al padre.
Il Trovatore, invece, è un'opera completamente diversa. Ha una fattura dalle grandi arcate. Mentre il Luisa
Miller è conciso e veloce, Il Trovatore è vasto: è come una foresta di suoni, di echi, di fuochi, di lune. Ed è
un'opera di ampi spazi scenici: non ci sono la piccola casa di Luisa Miller o l'interno del palazzo ducale o la
taverna; qui siamo di fronte a torri, merli, e così è anche la musica, naturalmente.
È la più difficile delle opere della trilogia perché vi ha poco spazio la recitazione. Da ragazzo lo consideravo
anch'io, come tutti, un'opera di fuoco e guerra, in seguito però cambiai parere e ora la mia concezione del
Trovatore è assai differente dall'idea comune.
Quando gli italiani parlano della Traviata e del Trovatore, dicono «La Traviata» con voce dolce, delicata, e
invece «Il Trovatore» con voce forte, vigorosa. In realtà dovrebbe essere il contrario: si dovrebbe dire
«Trovatore» in tono dolce, perché si tratta di un poeta, di un artista, di un uomo mite che canta
accompagnandosi con un liuto, e «Traviata» in modo calcato, perché si sta parlando di una prostituta, di una
donna che ha abbandonato la retta via. Quindi, se persino i titoli vengono pronunciati con un accento
improprio, come posso far capire al pubblico che Il Trovatore è un'opera di pianissimi? Leggendo la partitura
si trova un'infinità di piano e pianissimo: c'è persino un punto segnato pppppp . . . quindici volte piano, poco
prima del finale della seconda parte.
Il Trovatore è un fiume di musica dalla prima all'ultima nota ma, fra le opere della trilogia, è quella con la
strumentazione meno interessante dal punto di vista del timbro e dell'invenzione. In Luisa Miller, per
esempio, il duetto con il violoncello e il contrabbasso o l'uso del corno inglese sono elementi di grande
interesse compositivo e di ricerca di nuove sonorità.
Anche nella Traviata, in una partitura apparentemente semplice, sono da notare l'uso degli archi durante i
recitativi e il modo piuttosto nuovo per l'epoca in cui essi vengono utilizzati per ragioni espressive. Ma nel
Trovatore no. L'orchestra è completamente subordinata ai cantanti: è canto, canto, canto, per tutta l'opera. E
per questo servono grandi cantanti, ma dove trovarli è impresa ardua.
Il Trovatore è un'opera con personaggi giovani, innamorati. La mia ambizione è sempre stata quella di creare
un Conte di Luna che non fosse il tipico baritono che recita il ruolo del cattivo. Luna è il personaggio più
tragico e degno di compassione, simboleggia l'amore, la tragedia, la solitudine, è colui che perde tutto, il suo
dramma è essere condannato a vivere mentre tutti gli altri muoiono per causa sua. Inoltre, è sua l'aria più
bella dell'opera.
C'è da aggiungere che, benché nel Trovatore il fuoco sia un elemento ricorrente, il vero motivo conduttore va
cercato nella notte. Quest'opera è come un dipinto di Biicklin o un poema di Foscolo, contemporanei di
Verdi. Per rendere l'atmosfera della notte, di castelli, fantasie, sogni, è necessario che i personaggi siano
credibili, tutto dev'esser bello: lo scenario, gli interpreti.
Con La Traviata non siamo più in un mondo epico, mitologico, di fantasia. Non è più la leggenda, non è più
una favola: è la vita; in qualche modo, mutatis mutandis, è il Così fan tutte di Mozart, cioè la vita di ogni
giorno, dove sul tavolo vengono messi gli ardori, le gelosie, i dolori, le malattie, le speranze, le illusioni, le
delusioni. È un'opera molto autobiografica, in cui è esplicita una denuncia della società borghese retriva, di
personaggi che, nell'ossequio di una morale codina, accusavano il suo modo di vivere, il suo amore per
Giuseppina Strepponi quasi clandestino (anche se Verdi e la Strepponi non nascondevano di vivere a
Sant'Agata). Non è solo una storia d'amore sfortunata, quindi, ma è la vita di ogni giorno, e questo forse
risulta ancora più evidente ai nostri occhi oggi.
La Traviata è scritta audacemente, mettendo sul palcoscenico uomini e donne della sua epoca. In questo
senso è un'opera ancora più immortale, non solo per la qualità della musica, ma anche per i contenuti, che
ancora sono validissimi.
Anche quest'opera avrebbe bisogno di essere riguardata con uno spirito estremamente nuovo,
abbandonando certe formule di esecuzione che sono diventate ormai classiche, incatramate. Non bisogna
mai dimenticare che La Traviata è opera di morte, e che Violetta, quando si apre la scena, è una donna che sa
di essere malata e colpita, e per questo non vuole amare: mentre fino ad allora si era abbandonata al vino,
alle feste, agli amori, al piacere, per poter dimenticare, ora l'amore sarebbe una delusione, perché senza
futuro.
I due preludi, gli unici due nella Traviata, quello iniziale e quello del terzo atto, sono preludi di tristezza,
hanno odore di cimitero, di foglie marce cadute nella pioggia, soprattutto il secondo. La musica porta in
maniera molto diretta e decisa la tragedia. È come un precipitare.
Verdi è geniale per questo: perché con poche note è in grado di creare un mondo; non c'è bisogno di venti
pagine di tessuto sinfonico per mettere in scena una situazione. Si apre un precipizio e subito dopo c'è una
sospensione, ma anche quella sospensione dev'essere eseguita in maniera che crei un senso di angoscia e
incubo: che cosa sta avvenendo? Poi però ascoltiamo dei trilli: Verdi ci trasmette quasi una frenesia, una
gioia di vivere, ma anche una specie di mancanza di controllo con questi trilli; sembrano cose che brillano,
che bruciano. E in questa musica appaiono genialmente, come fantasmi, tutti i personaggi che poi saranno la
chiave di lettura dell'opera: appaiono come fantasmi e si muovono in questa festa drogata, in cui ognuno è
schiavo della situazione nella quale è irretito e da cui cerca di evadere.
In questo marasma generale, nasce l'amore. Nasce un fiore che in un certo senso diventa anche sacro, perché
finisce col donarsi nonostante la morte sia lì. C'è tuttavia un senso di speranza sino all'ultimo, per esempio
nell'aria Parigi, o cara, che generalmente viene cantata a tempo di funerale (e così, Alfredo manda a morire
quella poveretta più velocemente cantandole una nenia funeraria), invece Verdi nella Traviata dà sempre
delle indicazioni di tempo che richiamano il movimento (andante, andantino, andante mosso), perché è
come la vita che deve scorrere, non si deve fermare.
In Parigi, o cara, Alfredo cerca veramente di dare speranza a Violetta, non è solo una menzogna quella che
sta cantando: lui spera per sé e per lei, e lei, dolcemente, fa eco a questa sua speranza e sembra quasi
riprendersi, ultimo trucco della vile signora vestita di nero che ci dà spesso la sensazione di migliorare
proprio nel momento in cui ci dà l'ultimo colpo.
Dopo la trilogia notiamo nell'opera di Verdi un rinnovamento formale. Sicuramente subisce l'influsso del
grand opéra francese, caratterizzato da un notevole sfarzo nell'allestimento scenico e da soggetti di
argomento storico o religioso che, viste le grandi scene di massa, richiedevano la presenza di numerose
comparse sul palco. Ecco allora I vespri siciliani e Simon Boccanegra. Ma l'opera in cui questo nuovo impianto
formale ebbe il maggior successo è Aida.
Rispetto ai precedenti schemi verdiani, che vedevano un'assoluta preponderanza dell'elemento vocale, Aida
rappresenta davvero una svolta, perché l'uso dell'orchestra è molto più incisivo e determinante. È anch'essa
un'opera popolare, ma non la consideriamo tale, forse per la sapienza orchestrale superba che Verdi mostra
nella sua composizione. È infatti un'opera molto complessa dal punto di vista della strumentazione, molto
più raffinata. Pensiamo all'eleganza con cui Verdi rende l'ambientazione esotica, o alle danze.
Vi è in Aida una perfetta fusione di tradizione e rinnovamento, cosa facilitata anche dalla novità del soggetto,
dalla solennità dell'atmosfera e dei protagonisti.
Con Aida, che fu commissionata dal khedivè egiziano Ismail Pascià non per l'inaugurazione del canale di
Suez, come in genere si dice, bensì per l'apertura del nuovo Teatro dell'Opera al Cairo, e che occupò Verdi nel
corso del 1870, siamo completamente fuori dal «girone» della trilogia. L'opera è in quattro atti e ha un
impianto colossale, con cori e scene di grande effetto.
La cosa più strepitosa della bellezza di Aida è che Verdi, pur non essendo mai stato in Egitto, riesce a creare
con la musica l'atmosfera del Nilo, del deserto, quella luce... Per esempio nel preludio del terzo atto, con il
flauto e i violini che arpeggiano, ci dona proprio i riflessi della luna sulle onde del Nilo, un fiume magico e
splendente.
Ricordiamo che all'epoca c'era una vera e propria moda per il mondo egizio, e certo Verdi è riuscito a dare
con le sue note più sensazione dell'Egitto rispetto a tanti musei e a ricreare quel mondo in maniera sublime,
con una ricchezza armonica maggiore rispetto a tutte le opere precedenti.
Il grande successo di Aida si deve però alla fortissima tensione drammatica che riesce a rendere. Lo stesso
Verdi lo riconobbe, affermando: «nell'Aida vi è più mordente e più — perdonate la parola — teatralità».
Questo aspetto della teatralità, della parte più drammaturgica dell'opera di Verdi, ci porta inevitabilmente a
parlare del libretto e del rapporto di Verdi con i librettisti.
È fondamentale tenere sempre presente, infatti, che Verdi parte dal libretto. La musica è scritta per quelle
parole, è suggerita da quelle parole, poi le supera, le fa dimenticare certe volte, fino al punto che alcuni
cantanti sillabano senza pensare a quello che stanno dicendo; però di Verdi noi sappiamo non solamente
quanto controllasse i librettisti (e in alcuni casi quasi li minacciasse, per spronarli), ma anche quanto li
guidasse, correggendoli e in un certo senso sostituendosi a loro.
Io trovo che i libretti di Verdi siano sempre molto efficaci, perché sono concisi. Con poche parole riescono a
creare una situazione profonda. Penso per esempio al Luisa Miller, quando il Duca di Mantova dice: «Due che
s'amano son tutto un mondo»; sembra una frase stupida, però in un libretto è fondamentale la capacità di
concisione e questa è una frase perfetta in bocca a un libertino capace di trascinare una donna nel gorgo
della seduzione, perché piena di promesse, di slancio.
Tutte le parole dei libretti di Verdi sono a mio parere estremamente efficaci. Molte volte mi piace ripeterle,
sapendo benissimo che non sono dei capolavori di scrittura, però certamente sono servite a Verdi. Sono
come quel marmo informe che Michelangelo prendeva a Carrara per tirarne fuori il capolavoro, la vita, la
meraviglia.
Questi sono i libretti di Verdi: parole che hanno la loro efficacia e che lui, a furia di ripeterle e di dar loro la
sua inflessione di recitante, ha vestito di musica.
Alla fine arriviamo alla presenza di Arrigo Boito, che scrisse due capolavori assoluti, l' Otello e il Falstaff dove
la parola acquista un significato molto poetico e, nel Faistaff soprattutto, ci sono molti neologismi.
Io Credo che Verdi, anche con i librettisti precedenti, si divertisse a giocare con le parole. Alcune frasi, messe
poi in bocca al popolo, evidentemente davano anche vita a doppi sensi che servivano proprio per alimentare
la sua fortuna (pensiamo per esempio al Luisa Miller, quando il Duca si veste da studente, va a trovare Gilda
e dice: «Ah, cogliere potessi il traditore che sì mi sturba»).
Quello dei libretti è un aspetto sicuramente da non trascurare per l'interprete. Molto spesso i musicisti
danno poca importanza al testo, soprattutto quando ci sono i concertati, in cui tutti cantano: i cantanti hanno
linee di parole diverse che si sovrappongono e quindi al pubblico il testo risulta incomprensibile.
Compito del direttore d'orchestra, o del cantante che voglia davvero approfondire, è quello di avere in ogni
caso una comprensione profonda di tutte le parole, anche di eventuali neologismi. Diversamente, il direttore
dovrebbe solo far quadrare la sillabazione della parte cantata con la musica.
Nell'Attila, per esempio, il testo di Solera è di una certa pregnanza. Nel grande concertato della prima parte
dell'opera, il coro (Unni, Eruli e tutte le varie stirpi di barbari) dice in omaggio ad Attila, definendone la
personalità: «Se flagella è torrente che innonda; / è rugiada se premia il valor». È abbastanza pittoresco o
barocco, però è molto efficace. Nella stessa parte, mentre il coro canta queste parole, Odabella, che poi
ucciderà Attila, dice: «Di vendetta l'ora è giunta... fu segnata dal Signor» e Attila canta un'altra frase. Quindi le
voci si sovrappongono e il pubblico non coglie assolutamente il significato di quello che dicono.
La cosa più interessante, che ha attirato la mia attenzione, è la parte di Attila, che in questo punto viene quasi
sommersa dalla potenza del coro e dell'orchestra; fa armonia, però Verdi la usa per far dire ad Attila:
«Quell'ardire, quel nobile viso. Dolcemente mi fiedono il cor!». Io non avevo mai sentito il verbo «fiedere», e
naturalmente sono andato a interessarmi: significa «ferire», «percuotere» e lo usa anche Dante nel
Purgatorio (nel canto IX, al verso 25, e nel canto XXVIII, al verso 90, come ho appuntato alla pagina 57 della
mia partitura).
Può sembrare pedanteria l'andare a cercare il significato di una parola sommersa dalla quantità del coro e
dell'orchestra, e nessuno del pubblico lo avvertirà, ma sono convinto che debba essere questo il criterio di
ogni direttore d'orchestra nell'interpretazione di un'opera.
Per fare un altro esempio, ricordo che Marcel Prawy, drammaturgo dell'Opera di Vienna per più di mezzo
secolo, era venuto alle mie prove della Traviata, a Salisburgo. Aveva novant'anni. Era rimasto folgorato
durante la mia prova con Renato Bruson per il fatto che fossi stato quasi mezz'ora a provare il passo in cui
Germont canta: «È grave il sacrifizio, ma pur tranquilla udite. Bella voi siete e giovane. Col tempo...».
Io chiedevo a Bruson che tra «Col» e «tempo» ci fosse una lievissima frazione di secondo, quasi di imbarazzo
— tant'è vero che Violetta dice: «Ah, più. non dite...», perché lei stessa rimane quasi orripilata dall'idea che
col tempo tutto si aggiusta, tutto cambia —, e gli chiedevo che le due parole avessero colori diversi. Ma
bisogna trovare il modo di farlo: se è troppo è troppo, se è troppo poco non ha senso.
Ricevetti poi una lettera da Marcel Prawy in cui mi scriveva: «Per tanti anni ho sentito La Traviata, ma non mi
ero mai accorto di questa cosa». Ecco, è questo il lavoro da fare su Verdi.
In genere, però, sono cose che passano completamente inattese, inascoltate, non sembrano importanti,
oppure si va sul generico: il cantante si mette una mano sul cuore e crede di creare così il senso del dolore,
agita una mano nell'aria e crede di esprimere indifferenza. E allora il lavoro che si apre, e che diventa una
voragine sempre più vasta, è quello di trovare la giusta recitazione. Perché Verdi va recitato, non va
solamente cantato.
Il problema è che oggi sembra non esserci più tempo a disposizione: spesso in Italia, nei vari teatri di Stato,
le opere si fanno addirittura senza prove, la compagnia di canto e il direttore si incontrano il giorno prima e
poi la sera si ritrovano a far l'opera davanti al pubblico. Non saprei come altro definirlo se non
dissacrazione.
Vorrei dedicare l'ultima parte di questo capitolo sul teatro ai registi con cui ho lavorato. A passarli in
rassegna tutti sarebbero davvero tanti, ma se penso alle mie intramontabili esperienze formative, il primo
nome che devo fare è quello di Giorgio Strehler, con cui ho avuto la fortuna di fare tre opere: Le nozze di
Figaro, Don Giovanni e Falstaff
Da lui ho imparato moltissimo: ho imparato che cos'è un attore e ho capito anche che si può essere né
antichi, né moderni, ma grandi, senza essere necessariamente né di avanguardia, né di retroguardia. Strehler
era Strehler. Conosceva la musica, quindi non avrebbe mai fatto nulla che andasse contro la musica.
Lavorava sempre vicino al direttore d'orchestra in un atto d'amore verso l'opera che per il regista si fermava
impietosamente dopo la prova generale. Mi diceva: «Dopo la prova generale io mi ritiro e lascio a te il compito
di godertela tutta!».
Ricordo che una sera ero entrato verso le venti dalla parte posteriore della sala mentre Strehler stava
facendo una prova di luci. C'erano solo lui e i tecnici sul palcoscenico. Vidi una cosa fantastica, un'immagine
meravigliosa, un sogno, con questi blu e questi colori intensi che caratterizzavano le sue regie. Non avevo
mai visto una scena così magicamente illuminata. Lui andò avanti fino a mezzanotte, correggendo quella
scena che io avevo già trovato sublime e perfetta. Questa è una delle cose che mi hanno formato: il suo senso
della ricerca continua.
Ho avuto poi esperienze con altri grandi registi. Ricordo con grande affetto Franco Enriquez, al Maggio
Musicale Fiorentino: è stato per me un regista importante perché con lui ho fatto le primissime opere. Mi
piace poi ricordare Luca Ronconi, Roberto De Simone o, fra gli stranieri, Graham Vick, Werner Herzog...
Ma ho avuto anche diversi problemi con certi registi tedeschi che usano l'opera italiana chiaramente senza
capirla e mettendoci dentro delle cose che non c'entrano niente, come per esempio Don Giovanni in
Lambretta o in Ferrari, o sulla sedia a rotelle, la Mimì che muore per droga, Il ratto del serraglio in uno yacht
di camorristi, oppure il Luisa Miller in un pub di Londra gestito da mafiosi.
Mi ricordo di un regista famoso che non aveva capito assolutamente nulla. Traviata, secondo atto: papà
Germont va da Violetta e si presenta; tradotto in maniera un po' napoletana, le vuole dire: «Tu sei una poco
di buono e ti devi togliere di mezzo perché se no mi inguai la situazione familiare». Verdi annuncia il suo arrivo
con una musica che ci fa subito capire che entra un tronfione, uno pesante, non una persona piacevole; poi ci
indica anche il passo che deve avere. Papà Germont dovrebbe entrare su questa musica e subito dopo
rivolgersi a Violetta: «Madamigella Valéry?».
Questo regista, mentre l'orchestra suonava, non faceva entrare nessuno. Poi, quando finiva questa
introduzione, papà Germont irrompeva a velocità supersonica e, arrabbiatissimo, diceva: «Madamigella
Valéry?». Questo non significa interpretazione, significa aver tradito ciò che Verdi voleva. È tradimento. Non
è questione di moderno o di antico: è incapacità di cogliere nella musica quelle indicazioni che poi ti possono
permettere di fare una regia che non sia la dissacrazione del testo musicale.
Non posso non rievocare infine anche uno scenografo, Giacomo Manzù. Di lui ho un ricordo straordinario.
C'era un genio dietro a questa persona semplice e anche un po' rude. Ci eravamo incontrati per l'Ifigenia in
Tauride, a Firenze. Lui mi aveva subito chiesto di raccontargli la storia e immediatamente, mentre parlavo, si
era messo a disegnare un medaglione, che poi sarebbe diventato il centro della messinscena.
Facemmo insieme anche un Macbeth: tutto era bianco per dare il senso del funereo. Un muro attraversava il
palcoscenico, completamente bianco, con una lancia e un drappo. Non ostacolava la musica: aiutava la
situazione musicale.
Mi viene in mente una frase che ho letto in un libro sui rapporti epistolari tra Vasilij Kandinskij e Arnold
Schiinberg (Scheinberg era anche pittore e Kandinskij sapeva molto di musica). Schónberg, parlando della
messinscena della Mano felice, uno dei suoi primi lavori, dice: «Vorrei che sulla scena nulla intralciasse la
comprensione del pubblico, dell'uditore, perché se il pubblico non capisce ciò che sta vedendo si distrae dalla
musica». Ed è proprio così: sulla scena vi devono essere cose che siano di facile comprensione, altrimenti il
pubblico si distrae.
4
Chi può legger nel futuro?
Vieni, e t'asconda il velo
Ad ogni sguardo umano.
Aura o pensier mondano
Qui vivo più non è.
Al ciel ti volgi e il cielo
Si schiuderà per te.
CORO DI RELIGIOSE, IN IL TROVATORE,
ATTO II, SCENA III
Spesso si leggono tante inutili domande, come: Verdi era credente? Non era credente?
Che fosse un mangiapreti lo sappiamo. Era anche nato in una terra di mangiapreti, come l'Emilia. C'è
qualcuno che l'ha voluto agnostico, qualcuno che l'ha voluto ateo, ma nessuno a mio parere può, né deve
mettersi nelle vesti, nella testa o nel cuore di un'altra persona. Dobbiamo soltanto giudicare qual era la sua
posizione di fronte all'Altissimo o all'Aldilà attraverso le sue musiche.
Il fatto che tante opere verdiane presentino un riferimento diretto all'Aldilà e spesso si concludano
esprimendo desiderio d'amore e di conciliazione lascia trapelare il pensiero di un uomo che in cuor suo ha
fede. La prima versione della Forza del destino termina in modo tragico: il tenore si uccide. Verdi la modificò:
nella nuova versione aggiunse l'esortazione del Padre Guardiano: «Non imprecare; umiliati a lui ch'è giusto e
santo. Chi adduce a eterni gaudi per una via di pianto».
Nel finale di Aida, che non è certo opera di carattere religioso, i due amanti, prossimi a morire, cantano: «A
noi si schiude il ciel».
Luisa Miller finisce con la maledizione, ma le ultime parole di Gilda sono dense di amore e di compassione.
Persino in opere che abbondano di sangue e crimini, lo sguardo di Verdi si rivolge sempre all'eterno.
Certo, questo non prova che egli avesse il dono della fede, era un laico sicuramente, un uomo pieno di dubbi,
però il modo in cui il vecchio Verdi mise in musica le parole di Dante nei quattro pezzi sacri coincide con
alcune delle più profonde concezioni teologiche; per esempio «Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta
più che creatura», nella sua contraddittorietà è uno dei concetti più alti della teologia. Solo Verdi ebbe il
coraggio di musicare questo testo, così pregnante in senso sia poetico che teologico.
Scrisse lo Stabat Mater e il Te Deum per coro e grande orchestra, le Laudi alla Vergine per quattro voci
femminili a cappella. Per l'Ave Maria utilizzò una scala particolare: non è né maggiore, né minore, né
dodecafonica, gli intervalli sono molto strani. Il compositore la definì «enigmatica», perché in armonia non
esiste nulla di simile, e su di essa creò questo brano sorprendente.
Il fatto che Verdi verso la fine della sua vita abbia sentito il desiderio di musicare testi sacri fornisce un
indizio per interpretare l'intero suo percorso. All'inizio della sua carriera di compositore scrisse il Nabucco,
non proprio, come risaputo, per ragioni patriottiche; quando lesse il libretto che Merelli gli aveva proposto,
Verdi scoprì il fascino della Bibbia (in seguito fu lui stesso a confermarlo). Già questo è segno di un animo
rivolto al mondo spirituale.
Nel Nabucco, nel canto del popolo ebreo, gli italiani ravvisano un'esortazione a dar voce ai loro sentimenti di
rivolta contro l'oppressore. Sin da quest'opera il compositore dimostra di sentirsi a proprio agio quando
parla di Dio, e nella maggior parte delle sue opere successive si trovano elementi di contatto con il mondo
spirituale. Però in Verdi non c'è mai il sovrannaturale.
Verdi, dopo aver vissuto campi di guerra, corti piene di traditori, di vendicatori, sotterfugi amorosi, padri o
suoceri ipotetici che appartengono a una borghesia che lui detestava, mette tutto sul piatto e alla fine si
schiude sempre un cielo, che però non so se lui sentisse come punto di arrivo di ognuno di noi o solo come
speranza.
Sappiamo che Verdi chiese di essere sepolto con la partitura del Te Deum, fra le ultime cose che scrisse, fra il
1886 e il 1897. Il Te Deum finisce con i violini nell'acutissimo Mi naturale; poi loro chiudono questo suono e
si apre una voragine, con i violoncelli e i contrabbassi nel Mi grave. Quindi da un suono celestiale che va
verso l'alto si passa agli abissi più imponderabili dell'inferno, e in mezzo c'è il nulla. Basta questo per
rendere la genialità di Verdi.
In questo spazio così irraggiungibile tra cielo e terra intesa come inferno, come luogo di dolore, c'è il dubbio,
di nuovo. «In te, Domine, speravi,» urla il coro «in te... speravi», e poi si va nel nulla... Con un senso del dubbio:
devo sperare? Posso sperare? Mi è lecito sperare?
Ma questo senso del dubbio era già presente nel Requiem, una delle sue più grandi creazioni, una grande
pagina di riflessione.
Fu ideato dopo la morte di Rossini, nel 1869, ma fu poi composto dopo la morte di Manzoni, nel 1873, e a lui
è dedicato. Fu diretto per la prima volta da Verdi in persona, nella chiesa di San Marco a Milano, il 22 maggio
1874, in occasione del primo anniversario della morte dello scrittore, che con Verdi aveva condiviso i valori
risorgimentali.
È spesso adoperato da certi direttori per sfoggiare la propria capacità di «atletismo» sul podio, invece è una
pagina di grande profondità: che cos'è la morte e che cos'è la nostra liberazione?
Alla fine c'è un enorme punto interrogativo. Verdi termina infatti il Requiem con un accordo di Do maggiore
— adoperato per secoli nella storia della musica come un accordo di luce, di gioia, di serenità (pensiamo alla
Creazione di Haydn, al finale del Guglielmo Tell di Rossini, alla sinfonia Jupiter di Mozart) —, che si copre
però di una specie di coltre scura, perché non sappiamo esattamente se siamo in Do maggiore o nella
dominante di un Fa minore.
Un accordo di Do maggiore, che è l'accordo della luce, ammantato di scuro: è davvero geniale. Diventa la
tonalità del dubbio. E intanto il soprano canta: «Libera me, Domine, de morte aeterna»; è l'ultima esausta
perorazione dopo averlo gridato, e quasi dopo aver inveito con questa richiesta che sembra un ordine al
Padre Eterno (quasi gli volesse dire: «dal momento che mi hai creato, prenditi cura di me! È tua
responsabilità»).
La chiave per comprendere il Requiem si trova dopo che il soprano canta: «Tremens fizctus sum ego et timeo»,
alla fine del Libera me. Nella partitura c'è scritto lunga pausa, ma la maggior parte dei direttori trascura
questa indicazione. Il termine «tremito» significa più che «paura»; «et timeo» è come l'atteggiamento di un
bambino, «Ho tanta paura». Il soprano sta pregando Dio, «Aiutami, sono nelle tue mani». Lunga pausa. Poi
quegli accordi martellanti.
Questa è la chiave del Requiem: «Dio, ti prego, sono indifeso, come un bambino, aiutami». Silenzio. Cosa segue?
Qual è la risposta? Ecco un altro punto di domanda. Dio non ha misericordia? O forse Verdi ritiene che Lassù
non ci sia nulla che offra speranza? Poi di nuovo le parole «Libera me, Domine».
Bruckner scrisse per Dio, Verdi no. È un dramma dell'uomo moderno. Lunga pausa.
Ascoltando il Requiem bisogna prestare molta attenzione in questo punto: «et timeo», questa è la risposta.
Terribile. In genere suggerisco ai professori d'orchestra e agli artisti del coro di non muoversi, di non
sistemarsi gli abiti durante questa lunga pausa: i duecento interpreti devono mantenere la tensione emotiva,
non tanto perché sono in palcoscenico durante un concerto, quanto perché devono riuscire a trasmetterla al
pubblico.
Mozart scrisse che la sostanza della musica sta soprattutto fra una nota e l'altra: il silenzio talvolta è molto
più significativo dei suoni. Questa lunga pausa fa parte della musica: perché alcuni direttori non la
rispettano?
Il Requiem è stato ammirato da grandi musicisti, come Brahms per esempio, e odiato da alcuni grandi critici,
come Eduard Hanslick.
I mezzi di scrittura che Verdi adopera sono esattamente quelli delle opere: anche se nel Sanctus c'è il trionfo
del contrappunto e anche in altri brani la scrittura è fortemente contrappuntistica, non solamente monodica
e basata su melodie che tutti conosciamo, come il famoso Ingemisco.
Per quanto riguarda l'esecuzione, come sempre bisogna trovare il giusto equilibrio tra l'espressione che
Verdi vuole e la consuetudine dei cantanti, che certe volte cantano in modo tronfio ed esteriore.
Una cosa su cui ho combattuto è la resa delle parole iniziali: «Requiem aeternam dona eis». Molto spesso
sento che il sottovoce del coro è passivo, invece ho sempre cercato di ottenere da tutti i cori del mondo che
«Requiem» non venisse cantato come un'invocazione, ma come un complemento oggetto: è un accusativo.
Quindi quella parola, pur nel pianissimo, deve avere dentro un'energia. È una richiesta, non è una
constatazione o una speranza di stasi.
Dopo questa sequenza iniziale, andiamo nel baratro, nell'oscurità e poi entrano i violini, dove lo stesso
elemento sembra acquistare una certa luce di speranza.
Un'altra cosa che mi ha sempre molto irritato nelle esecuzioni del Requiem è quando, dopo questa
introduzione, entra il tenore come fosse Radamès, cioè con piglio eroico e con il desiderio di far capire a tutti
che voce abbia: «Kyrieeee eeeeleeeeeeeisooon», soddisfatto. Raramente ho trovato un tenore che non lo
cantasse così. Ma rendiamoci conto che sta dicendo: «Signore, abbi pietà di me»! Verdi non poteva pensare
che questo inizio fosse eroico: è una richiesta, è una supplica, tant'è vero che Verdi per questa parte
desiderava quasi una voce da prete, che nella sua idea significava una voce che fosse il contrario del tenore
eroico.
Quando si dice: «è una voce da Requiem, non è una voce da Requiem, è una voce da Aida, non è una voce da
Aida...», più che parlare di voce, se è da Requiem o non è da Requiem, bisogna considerare il suo accento. È
questa la cosa importante: c'è, infatti, il tenore di Faistaff un tenore lirico leggero, e c'è il tenore di Otello,
lirico spinto o drammatico.
Poi entra l'altro cantante e dice: «Ah, sì? Adesso arriva il mio turno, ti faccio vedere io!». Ma, addirittura, al
soprano Verdi chiede un pianissimo, mentre agli altri un piano. Quindi il Requiem è fatto di pianissimissimi,
non solamente del forte...
Sembra invece che certe volte si aspetti il momento del Dies irae per uno scatenamento generale. E allora il
Requiem diventa una serie di arie e ariette, dove anche il Lacrymosa viene trascinato spesso in maniera
esageratamente lacrimevole, senza pensare che viene proprio da un passo delle vecchie processioni e delle
bande funebri, per cui il tempo del Lacrymosa potrebbe essere in qualche modo simile alla marcia funebre
dell'Eroica di Beethoven.
Fra i moltissimi Requiem della mia vita, ne ricordo alcuni in particolare. Una cosa interessante è stata, in un
concerto scaligero, l'esecuzione della prima versione del Requiem, che mostra delle diversità rispetto alla
seconda, usualmente eseguita. Per esempio, il finale non è affidato al «Libera me, Domine» e quindi le ultime
parole non sono affidate al soprano bensì al coro dei bassi, che dà una sensazione completamente diversa,
molto più lugubre e cavernosa.
Il Requiem è una delle partiture più pericolose, perché si sa come si comincia ma non come si finisce. E qui
non vale neanche la famosa battuta di Sir Thomas Beecham, il direttore d'orchestra, che una volta,
scherzando, disse a un giovane collega: «Tanto non ti preoccupare, le cose importanti in un'esecuzione sono la
prima e l'ultima battuta!».
Il Requiem inizia con «Mi-Do-La-La-Sol-Fa-Mi», e fin lì andiam tutti bene; poi comincia una specie di via
crucis, perché hai a che fare con i quattro cantanti, con le trombe esterne, con il famoso passo dei violoncelli
nell'Offertorio, difficilissimo, dove l'intonazione molto spesso ,è precaria; poi le trombe possono steccare nel
Tuba Mirum, per cui, come si dice a Napoli, finisce proprio a carte quarantotto... Poi ci sono le parti a
cappella, dove spesso il quartetto ha una pecora zoppa, che nell'intonazione vacilla, così certe volte cominci
con Verdi e, durante il percorso della parte a cappella, attraversi altri periodi della storia della musica molto
più vicini a noi... sfiori la dodecafonia... poi per fortuna l'ingresso dell'orchestra riporta nell'ascoltatore un
momento di fiducia nell'esecuzione. A parte le battute, il Requiem è davvero pieno di trabocchetti, di
difficoltà.
Mi ricordo una volta che, durante una prova del Requiem ad Amsterdam, in uno di questi tratti a cappella
dove non si capiva più niente e l'unico elemento certo erano gli occhi stralunati del soprano e del
mezzosoprano, che sentivano provenire dalle voci maschili qualcosa di estremamente insidioso e allora mi
guardavano come per dire «Aiuto, aiuto, cosa succede qui?», mi son fermato e il basso ha detto, testuali
parole: «Ma maestro, voi musicisti, musicologi, critici, compositori, non potete fare qualche cosa per porre
rimedio alle insufficienze di scrittura verdiana?». Gli ho chiesto: «A quali insufficienze si riferisce?». E lui:
«Potrebbero, in queste parti, mettere degli strumenti che avvolgano, aiutino...».
Un'altra volta, in un'esecuzione con la Scala all'estero, il tenore, nell'Hostias (che è in Do maggiore), è entrato
esattamente mezzo tono sotto, cioè in Si maggiore, mentre l'orchestra era in Do maggiore e, siccome non
aveva più modo di correggersi, è andato avanti in Si maggiore, quindi praticamente abbiamo avuto la
sovrapposizione bitonale.
Quando il tenore ha finito, io ho tenuto fermo l'ultimo accordo molto più a lungo di quello che è scritto in
partitura, per cercare di purificare l'aria, con il pubblico che era entrato in un silenzio diverso... un silenzio
attonito: «Ma è vero quello che stiamo sentendo?».
Lasciando quest'accordo di Do maggiore lungo lungo, ho preparato l'entrata del basso, il quale poi ha fatto
un trascinamento, «Oooooooooh!», che sembrava la messa in moto di una vecchia macchina. Ecco, in quel
momento io, che solitamente non sono uno che suda, ho avuto proprio chiara la sensazione, ed è stata l'unica
volta nella mia vita, che dal mio corpo partisse una specie di Fontana del Tritone, ho sentito litri di acqua
uscire dalla mia testa.
Potrei raccontare però anche tantissimi episodi meravigliosi. Un Requiem, per esempio, indimenticabile, di
tanti anni fa, a Monaco, al Bayerischer Rundfunk, dove addirittura Joachim Kaiser, il grande critico della
«Siiddeutsche Zeitung», il papà dei critici tedeschi, fece una recensione che fu messa in prima pagina, tant'è
vero che insolitamente quella mattina fui salutato con estrema deferenza dal portiere dell'albergo. Ritengo
questo Requiem uno dei più belli e dei più riusciti nella mia vita (con Jessye Norman soprano, Agnes Baltsa
mezzosoprano, José Carreras tenore, ed Evgeny Nesterenko basso, con un coro strepitoso come quello del
Bayerischer Rundfunk e quell'orchestra meravigliosa).
Ricordo poi il Requiem del Maggio Musicale Fiorentino, il primo Requiem che ho diretto nella mia vita, nella
basilica di San Lorenzo a Firenze. In quella basilica la cupola è del Brunelleschi, dentro ci sono le cappelle
medicee di Michelangelo, l'orchestra era messa tra i due pulpiti di Donatello e poggiava sul grande altare del
Verrocchio... In un momento come questo tu ringrazi Dio di essere nato in questa terra.
Io avevo fatto la prova generale alla mattina, quindi c'era un certo tipo di luce, la sera mi trovai con la chiesa
illuminata per il concerto. Per attaccare dovevo guardare i violoncelli, a destra. La fila dei violoncelli finiva
proprio sotto uno dei pulpiti di Donatello, illuminato ad arte. Non riuscivo a partire. Vedendo tutte queste
figure dello stiacciato donatelliano che venivano fuori, con la luce diretta in un certo modo, ebbi un momento
di sgomento.
In quell'occasione, nel Tuba Mirum ebbi l'audacia di mettere un gruppo di trombe alla mia sinistra e un altro
in fondo alla chiesa, all'ingresso. Era un'operazione estremamente audace, però a me interessava che il
suono delle trombe, partendo dal fondo e attraversando tutta la navata della chiesa, sembrasse rivoltarsi su
se stesso, decuplicarsi: veramente sarebbero state le trombe del Giudizio. Fu un momento di grande magia.
Ci sono state poi altre situazioni memorabili, come il Requiem con Carlo Bergonzi, nella piazza di Busseto.
L'inizio era stato tranquillo, anche perché Bergonzi lo cantava in maniera estremamente musicale e civile,
proprio pensando «Signore, abbi pietà» e non facendo Radamès. All'attacco del Dies irae, col timpano e tutta
l'orchestra «Pam-pam-pam», per un attimo non si è visto più niente, perché tutti i piccioni che dormivano lì,
al primo colpo del Dies irae, si son spaventati e sono usciti. Sembrava un film di Hitchcock.
E, insieme con i piccioni, le zanzare! C'è stato un momento in cui alcuni strumentisti si son fermati per darsi
schiaffi sulla faccia a causa delle zanzare. Diciamo che in quel frangente veramente il Dies irae ha acquisito
anche un oggettivo... elemento di rappresentazione!
Dopo aver scandagliato l'aspetto più spirituale di Verdi, vorrei tornare sull'argomento affrontato sopra,
ovvero sul suo rapporto con la Chiesa e il clero.
Non posso che pensare alla figura di Fra Melitone, nella Forza del destino. Vi è in lui un'anticipazione della
figura di Falstaff e per me è l'elemento di maggiore interesse nella Forza: Melitone non è un comprimario, è
già Falstaff, per il modo in cui il ruolo è scritto e per quello che il personaggio dice. C'è lo stesso senso di
ironia, tristezza, collera, sofferenza.
Melitone è solitamente rappresentato come un buffone, ma in lui si percepisce la stessa amarezza nei
confronti del mondo che si ritroverà in Falstaff. Melitone rivela quindi quale opinione Verdi avesse di monaci
e preti: li considerava esseri umani come gli altri, con problemi e difetti, non tutti santi; persone che, quando
parlano di moralità e di destino, spesso cercano di convincere più che altro se stessi.
Melitone è una figura tragica: certo è scherzoso, sembra un buffone, ma quando dice al Padre Guardiano che
i grandi uomini godono tutti i benefici, mentre la povera gente è lasciata nella polvere, non fa
un'osservazione da sciocco, ma piuttosto si dimostra una persona con molti problemi, un po' come Falstaff.
In realtà una caratterizzazione troppo marcata di Melitone, il monaco dal nasone rosso, è assolutamente in
contrasto con quanto egli dice. In Melitone Verdi ritrae il tipico monaco dei monasteri di allora (forse ce n'è
qualcuno così anche oggigiorno); mi riferisco a coloro che non prendevano i voti per vocazione, ma
consideravano il monastero un rifugio dalle miserie della vita. Conoscendo la vita, Melitone è in grado di
coglierne tutti gli aspetti iniqui, anche nell'ambito del monastero: il Padre Guardiano ha di che star bene,
mentre tutti gli altri poveri soffrono.
Questa è un'altra critica di Verdi, e Melitone la esprime con leggerezza, come dicevano i Romani: «Ridentem
dicere verum: quid vetat?». Ecco, questo è Melitone, ma la sua indole è seria, come quella di Falstaff.
Un'altra opera in cui affronta il rapporto con la Chiesa, in questo caso tra Stato e Chiesa, è il Don Carlos. La
melodia è completamente diversa da quelle che ci si aspetterebbe da Verdi. Solo il personaggio di Filippo ha
la tipica linea melodica verdiana. Normalmente è possibile riconoscere certe frasi come tipicamente
verdiane, ma scrivendo Don Carlos Verdi crea nuove vie, forse influenzato dal fatto che l'opera sarebbe
andata in scena a Parigi. Don Carlos nasce dunque come opera francese, con un Verdi che sceglie nuovi
percorsi.
L'intera opera ha caratteri inconsueti: all'inizio della versione in quattro atti, per esempio, il declamato dei
corni; il vero tema dell'opera non è tanto l'amore quanto il conflitto tra Stato e Chiesa; i grandi momenti
coinvolgono ben poco il personaggio di Don Carlo, non gli sono concessi in effetti spazi importanti rispetto a
Filippo, al Grande Inquisitore, a Eboli, al soprano e specialmente al baritono. Proprio quello del protagonista
è il ruolo che suscita minor interesse nel compositore.
Il Grande Inquisitore è il rappresentante di un'istituzione che nel XVI secolo esercitava il potere assoluto in
Spagna, in Italia. Nell'opera di Verdi intenzionalmente il personaggio è cieco: perché questa scelta? Il Grande
Inquisitore è cieco non solo fisicamente, ma anche spiritualmente; il compositore delinea questo
personaggio in un modo speciale: usa il controfagotto, strumento il cui timbro sottolinea il carattere rauco
dell'animo, come se si trattasse di un verme. È un suono che disturba. Questo rispecchia il disprezzo di Verdi
per l'atteggiamento intellettuale e spirituale degli ecclesiastici di allora.
Oggi la Chiesa è molto più flessibile, ma anch'io da bambino ho avuto esperienza di quanto fosse rigido il
controllo che esercitava; quando andavo a confessarmi, mi pareva di esser davanti al tribunale
dell'Inquisizione: il sacerdote mi guardava fisso negli occhi e mi chiedeva esattamente come e perché.
Ovviamente dovevo rispondere per filo e per segno, altrimenti mi avrebbe negato l'assoluzione, seguiva poi
una buona dose di Pater Noster...
Se così avveniva quando io ero bambino, chissà ai tempi di Verdi: le restrizioni erano soffocanti, specie nelle
località più piccole. Tuttavia l'atteggiamento del compositore nei confronti della Chiesa, provocato dal
desiderio di libertà, non fu privo di contraddizioni. A Sant'Agata Verdi era solito controllare i suoi lavoranti
di nascosto, per verificare che tutto procedesse come lui voleva: libertà per lui, controllo sugli altri, la stessa
condotta che Verdi criticava nella Chiesa.
Parallelo a questo mondo spirituale c'è un mondo animato da streghe, fate e folletti che Verdi mette
magistralmente in musica.
Pensiamo al Macbeth, opera del 1847, con il quale entriamo in un mondo profetico. I personaggi sono infatti
tre: Macbeth, Lady Macbeth e le streghe, che sono veramente creature fantastiche. E pensiamo anche al
Falstaff; che vede la mascherata di folletti e fate.
Una cosa molto interessante che emerge analizzando il Macbeth è che, quando Verdi tratta argomenti che
hanno a che fare col destino e col fato, usa temi circolari, come un anello che parte da un punto e a esso
ritorna. Pensiamo all'inizio della Forza del destino, al Luisa Miller, al Macbeth.
Si potrebbero scrivere intere pagine sull'attacco di Macbeth, che può sembrare un inizio semplice, ma, se si
analizza, mostra una sapienza incredibile. La partitura, infatti, è molto raffinata: in alcuni momenti i colori
dell'orchestra preannunciano già l'espressionismo. Nel suo intento di evocare un'ambientazione scozzese
cruda, selvaggia, Verdi ebbe un lampo di genio.
Si pensi ad esempio al timbro dei legni all'inizio: non sono in molti ad accorgersi che si tratta dell'imitazione
di una infernale cornamusa. È consuetudine suonare questo passo in modo morbido e mellifluo, e anch'io
quando diressi Macbeth per la prima volta nel 1974 lo eseguii come tutti gli altri, legato, ma questa
particolare combinazione di legni dovrebbe produrre un suono ruvido.
Sono sicuro che, sebbene Verdi non lo abbia effettivamente indicato così, questa fosse la sua intenzione: dare
al suono un accento rustico. Si sente davvero l'odore acre dello zolfo. E osserviamo i salti degli intervalli, il
salto di settima discendente, che poi diventa di nona dissonante, dal Re bemolle al Do: dà una dissonanza
che crea un senso di disagio, anche all'ascolto.
Questo è il genio di Verdi, ma per capirlo e intuirlo uno impiega trenta, quaranta, cinquant'anni della sua
vita. Queste cose sono lì, ma aspettano di essere maieuticamente fatte emergere.
La sapienza di Verdi era arrivata già a un altissimo livello: pensiamo anche alla scena del sonnambulismo,
nel quarto atto del Macbeth, una pagina strepitosa perché non è propriamente un'aria, bensì una sorta di
recitazione, un recitativo accompagnato da un elemento ritmico ossessivo, con questo lamento del corno
inglese, una specie di upupa.
Ricordo che Vittorio Gui, il fondatore del Maggio Musicale, mi disse un giorno: «Non dimenticare che il tema
strumentale nella scena del sonnambulismo sta a significare il movimento delle mani nel tentativo di toglier via
il sangue dalla mano assassina». Forse sì, forse no, comunque ha senso, altrimenti l'accompagnamento risulta
poco efficace; bisogna trovarne la motivazione drammatica, e in effetti collegando l'elemento ritmico alla
situazione drammatica si chiarisce la scelta musicale di Verdi.
Pensiamo anche a «Le sorelle vagabonde van per l'aria, van sull'onde, sanno un circolo intrecciar...», alla fine
della prima scena del primo atto del Macbeth: se uno prende il tempo giusto e l'elemento «un-ta, un-ta» lo fa
leggerissimo, senza far sentire le battute che passano, queste streghe diventano spiriti aerei che volano per
l'aria. È chiaro che Verdi le pensava in questi termini.
Va poi osservato l'uso dell'orchestra infernale nella passeggiata dei vari re che succederanno a Duncan, uno
dietro l'altro: l'uso dell'orchestra giù nel centro del palcoscenico, in modo che questi suoni vengano fuori
dalla caldaia delle streghe, è la dimostrazione di un compositore che rispetto alla sua epoca è avanti di
decenni.
5
Verdi, l'italiano
Oh patria terra, alfin io ti rivedo,
Terra sì cara e desiata! Ognora
In sul lido ospitai, che m'accogliea,
Sempre di te la mente si pascea!
OBERTO,
IN OBERTO, CONTE DI S. BONIFACIO
ATTO I, SCENA III
Nell'aprile 1848 Verdi scriveva al librettista Francesco Maria Piave, arruolato a Venezia nella Guardia
Nazionale, una lettera nella quale affermava:
Sl, sì, ancora pochi anni, forse pochi mesi, e
l'Italia sarà libera, una, repubblicana. Cosa
dovrebbe essere? Tu mi parli di musica!
Cosa ti passa in corpo?... Tu credi che io voglia
ora occuparmi di note, di suoni?... Non c'è
né ci deve essere che una musica grata
alle orecchie degli Italiani nel 1848.
La musica del cannone!
Verdi è figlio del Risorgimento e, da parte sua, vi fu anche una partecipazione attiva agli avvenimenti
risorgimentali: ricordiamo che nel 1861 fu eletto deputato del Parlamento italiano e nel 1874 fu nominato
senatore a vita; il suo stesso cognome era diventato vessillo dei rivoluzionari: gridando e apponendo sui
muri la scritta «Viva V.E.R.D.I.», infatti, volevano in realtà scrivere «Viva Vittorio Emanuele Re d'Italia».
È, tuttavia, nelle sue opere che troviamo il maggior contributo alla causa, perché la sua musica era popolare,
nel vero senso del termine: era un linguaggio che andava dritto al cuore delle persone, trasmettendo il
proprio messaggio. Coinvolgeva tutti in maniera travolgente — dai salotti alle strade, alle osterie, agli
organetti di barberia — e diventava proprietà del popolo, il quale poi a volte ci scherzava anche sopra,
storpiando i versi per fare delle caricature. Come, per esempio, i versi del terzo atto del Luisa Miller: «Un dì,
si ben rammentomi, / O bella, t'incontrai... / Mi piacque di te chiedere, / E intesi che ci stai», invece di «che qui
stai».
Oggi, purtroppo, qualche cosa è cambiato nella pronuncia dei cantanti o nel tipo di ascolto del pubblico o
nella pigrizia che sta invadendo l'animo di tutti. Abbiamo bisogno dei sottotitoli, in tutti i teatri sono ormai
stati installati davanti a ogni poltrona i display su cui scorre il testo del libretto mentre l'opera è in scena, se
no non capiamo nulla. All'epoca, invece, anche con un livello di istruzione inferiore, la gente capiva ed era in
grado di ripetere a memoria le arie. Tant'è che Verdi non voleva che si divulgasse il motivetto della Donna è
mobile prima del tempo, perché sapeva che poi sarebbe stato carpito da tutti e fischiettato prima ancora che
l'opera andasse in scena.
Quando ero ragazzo, i padri della patria erano Vittorio Emanuele, Mazzini, Garibaldi e Verdi. E non solo: a
quell'epoca venivano trasmessi alla nostra cultura e immaginazione come dei santi, erano immacolati. Poi,
dopo, abbiamo scoperto che erano uomini anch'essi, aldilà della genialità nei vari campi, con le loro passioni
e le loro debolezze umane.
Senza dubbio, non si può parlare del primo Verdi senza riconoscere il suo contributo alla causa della libertà
italiana: egli ebbe grande influenza sui patrioti, con la sua musica praticamente li armò, alcune delle sue
opere ebbero maggiore effetto di cento inni nazionali.
Bisogna tuttavia aggiungere che il suo intento iniziale non era stato quello di adoperarsi per la causa della
rivoluzione. Semplicemente, sapeva che quel tipo di musica avrebbe incontrato il favore del pubblico perché
corrispondeva alla disposizione d'animo della popolazione in quel momento storico.
Non bisogna infatti mai dimenticare che Verdi, come ogni altro compositore, voleva il successo; per questo
all'epoca scelse di scrivere in un certo modo: per farsi un nome. Diciamo che, da arguto contadino qual era,
aveva capito quanto il momento storico fosse adatto per proporre opere a sfondo patriottico.
Quando pensiamo alle opere patriottiche di Verdi, la nostra mente va subito al Nabucco, che fu
rappresentato per la prima volta alla Scala il 9 marzo 1842. E questo perché il Nabucco, col Va', pensiero, si
continua ancora a cantare, in genere in maniera sbagliata, a voce ampia, mentre Verdi lo vuole sottovoce,
grave, lento, come deve essere il canto di un popolo esiliato.
La partitura del Nabucco non è assolutamente elementare: ha delle preziosità. Ha una sinfonia, molto
famosa, giustamente. E anche se Verdi, come abbiamo detto, non aveva pensato al Nabucco quale grimaldello
del Risorgimento contro gli austriaci ed era stato attratto più dal fatto biblico, è chiaro che gli elementi
risorgimentali erano dentro di lui: la partitura della sinfonia già contiene elementi anti-Radetzky e questo
dagli austriaci veniva avvertito.
Alla Scala aleggiava un clima teso, le forze armate austriache che riempivano il teatro provavano un certo
timore e Radetzky mandava segnali di preoccupazione a Vienna, che Vienna peraltro non raccoglieva con
grande interesse.
Il Va', pensiero fu la molla che spinse Verdi a scrivere il Nabucco e il successo dell'opera fra i rivoluzionari
italiani e l'entusiasmo che provocò spinsero poi Verdi a battere il chiodo sull'unificazione dell'Italia.
Anche Attila ha il taglio di un'opera fortemente patriottica. Nella scelta delle tonalità, nel fatto che è molto
veloce, succinta e concisa, mostra uno scatto e una forza, come se fosse la summa di una serie di inni
nazionali, di inni di Mameli di alto livello.
(Io ho sempre detto che l'inno di Mameli non va sostituito, perché dentro c'è il vigore, quasi lo spirito
garibaldino, che è giusto che un inno abbia. Non sono d'accordo con quelli che ne fanno una sorta di
profonda pagina di meditazione.)
È difficile definire chi era Attila, perché ancora oggi il direttore d'orchestra, musicisti o registi discutono sulla
figura di Attila e su quella di Ezio, il grande generale che nella storia sconfisse Attila e che nell'opera,
attraverso Odabella e altri personaggi, riesce a far sì che Attila venga ucciso.
Certamente è un gigante nella partitura verdiana e non è di sicuro un personaggio con pelle di tigre, rozzo e
volgare, anzi: è dotato di grande nobiltà e si impone sugli altri, con la sua figura e con il suo senso dell'onore,
e anche con le sue passioni, i suoi amori, il desiderio della vita, la sete di conquista.
Si impone in maniera grandiosa di fronte alla potenza militare dell'impero romano, rappresentato da Ezio, e
anche di fronte a tutto il mondo della sacralità di Roma, rappresentato da Papa Leone. L'incontro tra Attila e
il Papa, peraltro, è una grande pagina di musica, un momento davvero straordinario.
Quindi la figura di Attila nell'opera di Verdi non è quella del selvaggio, ma di una grandissima personalità, di
un re, di un conquistatore, di un ammaliatore, dotato di un grande senso dell'onore, capace di rivolgersi a
Ezio considerando la grandezza del suo interlocutore e ritenendolo un suo pari, quindi degno di grande
rispetto.
Per quanto riguarda l'aspetto esecutivo, mi piace sottolineare che anche nell' Attila bisogna avere il coraggio
di staccare i tempi e di avere un taglio netto nella definizione delle articolazioni ritmiche, che non devono
suonare come «banda».
In quest'opera, tutte le figure, anche le più piccole, come Uldino, il braccio destro di Attila, hanno una grande
valenza: ricordano delle statue greche.
L'ingresso di Odabella è quello di una grande virago. Infatti è una delle parti più difficili nel repertorio
verdiano, perché richiede un soprano drammatico, capace di tagliare lo spazio del teatro come una lama, ma
anche di cantare con estrema morbidezza, quasi come un flauto.
L'Attila ha anche momenti di grandissima scoperta timbrica da parte del giovane Verdi; per esempio l'aria
del murmure, del ruscello, cantata da Odabella, è scritta da Verdi con uno strumentale singolare: un corno
inglese, che contrappunta la linea del soprano, un violoncello solo, un contrabbasso solo e un'arpa.
Verdi, avendo capito che attraverso la musica poteva scuotere il clima politico, ed essendo diventato uno dei
personaggi più importanti del Risorgimento, seguitò a scrivere opere che riflettessero un atteggiamento
rivoluzionario, in maniera più o meno palese.
Pensiamo, per esempio, alla prima scena del quarto atto del Macbeth, quando il coro canta: «Patria oppressa!
Il dolce nome / No, di madre aver non puoi, / Or che tutta a figli tuoi / Sei conversa in un avel». È celata, ma non
è altro che una lamentazione risorgimentale. Così come la conclusione stessa del Macbeth, che vede la
liberazione dall'oppressore.
Verdi, però, continuerà a essere uomo del Risorgimento anche dopo; tant'è vero che quando, nel 1881,
riprende Simon Boccanegra, dopo più di vent'anni, pur nel rifacimento di quest'opera tanto sofferta, non
modificherà l'elemento epico del popolo: la grandezza qui è proprio nella proposizione della lotta tra plebe e
nobiltà come elemento trainante.
Concordo con Massimo Mila quando, nell'Arte di Verdi, scrive: «Il popolo come forza politica non aveva mai
avuto una più vigorosa caratterizzazione musicale se non nelle Passioni di Bach».
Era eco di quella forza rivoluzionaria che Verdi aveva dentro di sé e che mai lo abbandonerà.
Per concludere questo capitolo, vorrei fare un'ultima considerazione.
Ho voluto dare a questo libro il titolo “Verdi, l'italiano”, non tanto per l'aspetto patriottico che traspare in
tante sue opere, come abbiamo appena visto, quanto invece per l'italianità, in senso lato, di cui esse sono
intrise.
Nelle opere di Verdi, infatti, c'è la vita e c'è la riflessione sulla morte, però si respira tutto il nostro carattere
italiano, dando a questa parola il significato più vasto possibile: traspaiono il desiderio, la passione, l'amore,
il silenzio, la delusione, talvolta anche l'insolenza, l'aggressività o l'intolleranza, che comunque fanno parte
della nostra cultura, della nostra natura.
Verdi è l'artista che meglio è riuscito a esprimere il nostro temperamento. Non si può generalizzare, perché
ovviamente l'Italia è fatta di tanti diversi italiani, però c'è un modo di essere italico che Verdi rappresenta in
maniera vivida e in questo senso mi piace parlare di «italianità verdiana».
6
Verdi e Wagner
Vecchio, che mai facesti?
Nostro rivale egli è
ERNANI, IN ERNANI
ATTO II, SCENA XIII
Verdi sarà sempre attuale, perché ha espresso in maniera inimitabile i sentimenti che caratterizzano
l'umanità. Sono convinto che anche Wagner sia immenso, come è immenso Verdi, però penso, naturalmente
posso sbagliarmi, che nel futuro l'umanità avrà più bisogno di Verdi che di Wagner. Io ho diretto tanto
Wagner nella mia vita, la sua musica è meravigliosa ed è ammaliatrice, è capace di drogarti.
Ricordo che Carlos Kleiber mi diceva, quando veniva alla Scala durante le mie prove delle opere wagneriane:
«Al momento del risveglio di Brunhilde o nel finale del Crepuscolo, la musica diventa talmente sublime che
potresti anche morire sul podio». È vero: ti inebri a un punto tale — è come una droga che ti pervade, che ti
attraversa — che perdi il senso del reale. Anche se cerchi di dominare la partitura con estremo spirito
oggettivo, come potrebbe fare un direttore adusato a partiture di altro genere che quindi analizzasse
Wagner in maniera clinica, a un certo punto la musica stessa prende il sopravvento e dall'orchestra si erge
una colonna di suono che avvolge il direttore e i musicisti. C'è una magia che in quel momento ti brucia, e si
brucia. Dopodiché sei travolto e stravolto. Quando dirigi Wagner, è difficile dopo liberartene: ti rimane
addosso una specie di malia, di magia, che porti per lungo tempo.
Però non dobbiamo dare a Wagner e al suo ingresso in Italia i meriti di aver trasformato Verdi, affermando
che solo in questa occasione sarebbe entrato in contatto con una realtà europea diversa: Verdi era sempre in
contatto con la realtà europea perché viaggiava, aveva diretto le sue opere a Vienna e a San Pietroburgo, era
stato a Parigi.
Io amo talmente Verdi in tutta la sua arcata che non saprei scegliere una sua pagina in particolare. Possiamo
dividere l'opera di Verdi in due parti: il primo Verdi, dalla prima opera fino all' Otello (lo stesso Verdi dice:
«Fino all'Otello ho scritto per il pubblico, con il Falstaff alla fine ho scritto qualche cosa per me»), e il Verdi
della maturità: un lungo percorso che parte dal bel canto e poi, piano piano, va avanti in una maniera sempre
più complessa, fino ad arrivare alla sublimazione del Falstaff Tuttavia, nel corso degli anni, studiando Verdi e
dirigendo alcune delle sue prime creazioni, come Nabucco, Macbeth, Ernani, Attila, oltre all'ouverture di
Alzira e Un giorno di regno, sono rimasto molto colpito dall'aver riscontrato che gli elementi del primo Verdi
tornano tutti nell'ultimo Verdi.
Nelle opere del primo periodo, Verdi ricorre sempre a momenti di musica da camera: l'opera viene
affidata a una voce con pochi strumenti, e questo è di derivazione chiaramente schubertiana, non vi è
dubbio alcuno, e ci sono poi elementi belliniani, elementi del bel canto, però c'è già l'affermazion
drammatica di questo gigante che squinternerà completamente tutto il mondo a lui circostante e
precedente.
Verdi spesso è tornato e ritornato sulle sue partiture; pensiamo al Macbeth, per esempio. Certamente il
secondo Macbeth mostra la mano di un musicista più agguerrito e la capacità di scrivere arie che
resteranno fondamentali nella letteratura verdiana, come La luce langue.
Nella seconda versione Macbeth viene ucciso e scompare, come scompare in fondo Lady Macbeth, che
muore pazza, completamente nella follia; nella prima versione, invece, vediamo morire Macbeth, il che dà a
questo personaggio un briciolo di umanità, perché lo si vede colpito a morte, sofferente, che impreca contro
la «vii corona», causa di tutti i mali.
Ai tempi in cui Verdi studiava, a Milano, in Lombardia, era in voga non solo la musica di Rossini, Donizetti,
Bellini e della scuola napoletana, ma anche quella di Haydn, Mozart e Schubert. In realtà nelle prime
composizioni di Verdi, come il Notturno, si riconoscono timbri e atmosfere che più che all'Italia fanno
pensare ai Paesi d'Oltralpe. Ma fu questa una delle maggiori difficoltà dei compositori italiani di quel
periodo: ricevevano dalle scuole una solida preparazione, tuttavia non potevano permettersi di perdere
tempo scrivendo lamusica sinfonica o da camera, perché l'unica strada verso il successo era l'operai e Wagner
La musica da camera del giovane Verdi ha però uno stile che deriva direttamente dal suo studio della
musica austriaca e tedesca. L’atmosfera della natura, dell'amore, con gli ornamenti del flauto, proviene
chiaramente dal mondo di Orfeo ed Euridice di Gluck. Questo era insolito per un giovane compositore
italiano.
Certo, la sua vena musicale derivava dalla scuola italiana, ma le sue prime partiture rivelano un legame tra
i due versanti delle Alpi. E sin dall'inizio, nelle ouverture di Oberto, Un giorno di regno, Aroldo, Alzira, l'orchestra
offre tutti i contrasti drammatici e dinamici che raggiungeranno il loro apice molto più tardi in Otello,
dove Verdi si dimostra più esperto nella scrittura musicale, avendo assorbito la cultura europea
intorno. a lui, da Parigi a San Pietroburgo a Vienna.
In Nabucco e in alcuni punti di Ernani, si notano inoltre combinazioni di strumenti insolite per l'epoca,
in Macbeth ci sono tracce di un mondo che si ritroverà molti decenni dopo. In questo contesto, il Notturno
ha la sua importanza, perché aiuta a comprendere i riferimenti musicali di Verdi: è molto classico e ci
dimostra che Verdi, nato nel 1813, non era estraneo alla scuola napoletana. Basta tornare indietro di un
paio di decenni per trovare Cimarosa e Paesiello: erano compositori d'opera, ma su solide basi classiche. Dal
modo in cui Verdi usa la voce e gli strumenti obbligati del Notturno si deduce che, sebbene in seguito abbia
usato la voce diversamente, con talune esagerazioni atte a riscuotere successo di pubblico, egli era già
pienamente se stesso quando nacque come com­ positore.
La cantabilità, lo stile italiano di cantare o di scrivere una melodia, aveva per lui la massima importanza e
quando in seguito, sotto l'influenza di Wagner, si affermò la nuova scuola, Verdi ne rima­ se
profondamente turbato.
Egli propugnava il ritorno alla tradizione italiana, non nel senso di un ritorno conservativo al passato, ma
come un riconoscere e non dimenticare le proprie radici.
Il suo contrappunto non è mai quello dei fiamminghi, bensì quello di Palestrina, che lui mette sempre al
centro del cosmo musicale come punto di riferimento per la musica italiana. Verdi infatti individuava in
Palestrina il compositore da cui assimilare per potersi distinguere come italiani: parlava sempre
dell'italianità del canto.
In fondo, nelle opere di Verdi, anche nelle più cupe, nei momenti torbidi e nelle tempeste varie del Luisa
Miller o dell'Otello, la luce generale è sempre una luce diversa dai colori tenebrosi della musica tedesca. Bisogna
inoltre tener presente che Verdi non era cresciuto né viveva a Napoli o a Roma, ma in una regione in cui, in
conseguenza della dominazione austriaca, la musica austrotedesca aveva un'influenza pari a quella italiana.
Conoscere questa duplicità è fondamentale per una corretta comprensione di Verdi il quale, nell'accogliere
entrambi gli stimoli, produsse un risultato assolutamente personale.
Sappiamo poi benissimo, tuttavia, che lui aveva una specie di avversione all'invasione tedesca, e certo, da
buon emiliano, reagiva all'influsso di questa musica anche per reazione contro un atteggiamento provinciale
dei cosiddetti «uomini di cultura» di allora, che ritenevano di aver finalmente trovato con Wagner la «vera»
musica e avevano buttato Verdi alle ortiche, cosa che lo indusse a un lungo silenzio, dopo il quale si vendicò,
lasciandoci fortunatamente delle colonne immense.
Quando ho cominciato a ristudiare Otello nel 2001 - il mio ultimo Otello risaliva all'esecuzione di
vent'anni prima a Firenze e nel frattempo avevo eseguito molto Wagner e parecchio repertorio
sinfonico, Bruckner, Mahler, compositori del tardo Ottocento -, credevo che, riaffrontandolo, vi avrei
riconosciuto l'influenza di Wagner. Una tesi sostenuta da molti musicologi, visto che Verdi respirava
l'atmosfera di fine secolo, studia a Wagner e, quando Lohengrin fu rappresentato a Bologna nel 1871
(prima opera wagneriana rappresentata in Italia), andò ad ascoltarlo. In realtà, nel ristudiare Otello, mi
sono reso conto che questa presunta influenza di Wagner è molto meno evidente rispetto alla presenza di
elementi del primo Verdi sviluppatisi e maturati nel seguito della sua carriera compositiva.
È vero, il tema finale diOtello ricorda vagamente
l'inizio del Parsifal, in qualche modo si percepisce che dal punto di vista tematico vi sono similitudini, ma
Credo si trattasse semplicemente di melodie tipiche di quel.periodo.
Anche in Haydn, Mozart o Beethoven si trovano sporadiche analogie. Non è che copiassero: a
quell'epoca i compositori avevano preferenza per determinate costruzioni melodiche e armoniche.
Tuttavia in Otello c'è una raffinatezza che deriva inequivocabilmente dal modo in cui Verdi scriveva
all'inizio della sua carriera. In Nabucco egli utilizza strumenti, come il corno inglese o il concertato dei sei
violoncelli nella Preghiera di Zaccaria, che sono inconsueti per i compositori di quel tempo.
In conclusione, Verdi può essere paragonato a un grande fiume, che cresce e si arricchisce man mano che
incontra i suoi affluenti, rimanendo sempre fedele a se stesso.
Per quante influenze abbia subìto, non ebbe mai bisogno di imitare: è Verdi dalla prima all'ultima nota, già
nel Notturno. Fin dai suoi inizi sono riconoscibili lasua forza e la sua individualità.
7
Passione e disincanto
È sogno o realtà?
FORD, IN FALSTAFF
ATTO II, PARTE I
Verdi visse alcuni anni di silenzio, anche con rabbia per la divisione che si era creata tra la musica tedesca e
quella italiana. In questa fase era arrivato quasi a dubitare di se stesso, rispondendo per esempio a chi lo
spronava a riprendere il lavoro, nell'anno della fondazione del teatro di Bayreuth (1876): «Sono stato
artista anch'io», o, tre anni più tardi: «Sono troppo vecchio, lascio spazio ai giovani». Grazie
all'interessamento di Giulio Ricordi avvenne però un incontro destinato a cambiare le sorti di Verdi e,
fortunatamente per noi, della storia della musica. Il compositore conobbe lo scrittore Arrigo Boito, il quale
gli propose di musicare il suo libretto dell'Otello, proposta che da subito lo affascinò.
Abbiamo testimonianza di questo interesse dal carteggio di quei giorni tra Verdi e il pittore Domenico
Morelli, in cui quest'ultimo veniva esortato a tentare di abbozzare una scena dell'Otello:
Per es.: quando Otello soffoca Desdemona;
o meglio ancora (sarebbe più nuovo), quando
Otello straziato dalla gelosia, sviene, e
Jago lo guarda e con sorriso d'inferno dice:
" opera, fra.Rmaco io" . . . Che figura Jago1.1.1.
A quella lettera il pittore aveva risposto di trovare molto bella quella situazione e di avere in mente un prete
che pareva proprio lui. Musica per le orecchie del mangiapreti Verdi, che rispose:
Bene, benone, benissimo, benississssimo! Jago
colla faccia da galantuomo! Hai colpito! Mi
par di vederlo questo prete, cioè questo Jago
con la faccia da uomo giusto! Presto dunque.
È un carteggio che testimonia quanto nello spirito di Verdi si fosse di nuovo acceso qualcosa. Infatti presto si
mise a comporre, forse trattenuto in un primo tempo dall'affrontare lo stesso tema già trattato nel 1816 da
Rossini.
L Otello è un'opera complessa, che possiamo analizzare sotto tanti punti di vista.
È l'opera nella quale Verdi, che era un grande esperto nel riuscire a evocare le situazioni, scrive la più
maestosa tempesta chesia mai stata composta in musica, più potente persino di quella dell'ouverture
dell'Olandese volante di Wagner, in cui il compositore tedesco con le sue note riesce a rendere le onde e i
gorghi con cui la nave si alza e poi si inabissa.
L’Otello si apre davvero con la forza impetuosa della natura.
Verdi teneva moltissimo a questi elementi, -soprattutto agli elementi del mare. È importante però capire
che qui Verdi descrive non solo un fenomeno naturale, ma anche, e soprattutto, una tempesta dell'animo;
per farlo si serve di ogni strumento a sua disposizione, incluso l'organo, come un pittore che adoperi
l'intera tavolozza.
L’incipit dell'Otello ti investe con una violenza tremenda, seguita da fuochi e da lampi, e poi si acquieta,
così come si acquieta la tempesta interiore e trova la pace nell'incontro tra Otello e Desdemona. Otello
indugia con Desdemona nei racconti del loro amore che pare, però, un sentimento da terza età.
Quando i due amanti si ritrovano dopo mesi di separazione, parlano come due persone anziane: Otello dice
a Desdemona: «E tu m'amavi per le mie sventure / ed io t'amavo per la tua pietà». Desdemona gli risponde:
«Ed io t'amavo per le tue sventure / e tu m'amavi per la mia pietà.» Questo duetto del primo atto non sembra
per nulla l'incontro di una giovane donna veneziana con il prode Moro da cui lei si sente attratta; musicalmente
è un duetto splendido, ma i due personaggi non . si esprimono come amanti appassionati - cosa che ci
aspetteremmo - come accade in altre opere verdiane.
Sicuramente Desdemona prova attrazione per Otello, ma di questo non si trova traccia nell'opera. L’unico
momento in cui traspare qualcosa di erotico è il racconto del sogno di Jago, nel secondo atto («Le labbra lente,
lente movea, / nell'abbando­ no / del sogno ardente»).
Verdi era di temperamento molto geloso e certo c'è un aspetto autobiografico nell'opera; si pensi che
all'epoca Verdi era innamorato di Teresa Stolz, ed era un periodo di grande rivalità con Angelo Mariani,
direttore di opere verdiane e wagneriane a Bologna.
Ma, se la gelosia è palesemente la forza dominante in Otello- non ècerto un'opera sull'amore-, alla fine
l'elemento catalizzatore dell'opera non è la gelosia di Otello, bensì la perfidia di Jago, che investe tutto e
tutti. Tant'è vero che poi Verdi, nel rifacimento di Otello, aggiusta il finale nel terzo atto e lo cambia - è la
versione che io eseguo solitamente - snellendolo, in modo che la parte di Jago, che sul palcoscenico incalza
tutti, abbia un risalto maggiore rispetto alla prima versione.
Verdi teneva molto al personaggio di Jago e sembra piuttosto concentrare la sua attenzione su di lui, tant'è
vero che in un primo tempo voleva addirittura che l'opera si intitolasse ]ago e non Otello. D'altronde,
considerando la personalità e l'età di Verdi a quell'epoca, è probabile che fosse incline a esprimere
sentimenti di gelosia più che di amore.
Al contrario di Falstajf, che avrà un colore molto chiaro, Otello ha prevalentemente un timbro cupo. Verdi
usa spesso questo termine, anche nel Requiem: è ilsuono dei contrabbassi e dei clarinetti bassi.
Quando alla Scala proposi l'Otello, nel 2001, con la regia di Graham Vick, e chiamai Domingo, la mia
preoccupazione fu quella di trovare la tinta scura di quest'opera, secondo le indicazioni molto preciseate da
Verdi sul diapason.
In una sua lettera (fortunatamente non è più il Verdi giovane, che doveva consegnare le partiture agli
impresari i quali ne divenivano in un certo senso i proprietari, utilizzandole come volevano, ma il Verdi
protetto dalla Società italiana degli Autori ed Editori) Verdi scrisse che voleva che il diapason nell' Otello
fosse molto basso (430). Non è neanche un quarto di tono rispetto agli abituali 442 e l'orecchio sente un
cambio di colore più che un cambio di altezze nei suoni, però Verdi lo richiedeva perché tutta la tinta
dell'Otello diventasse scura e l'intera opera acquistasse un colore bronzeo.
Alla Scala facemmo l'Otellocon un diapason 436, che fu una grande conquista; per le repliche di Parigi dovemmo
far fare degli strumenti apposta, perché alcuni strumenti si adattano facilmente a un diapason così basso,
mentre altri hanno bisogno di essere costruiti appositamente per questa altezza di suono.
Il risultato, in ogni caso, fu che tutta la tinta di quell'Otello, nell'orchestra e anche nel canto, divenne
completamente diversa da quei colori più vivaci, più brillanti e più smaglianti che eravamo abituati ad
ascoltare. (Peraltro, per anni e anni, le orchestre hanno mantenuto un diapason a 445, oggi abbassatosi a
442, che è un po' più «umano».)
Otello è il fiume che giunge al mare, porta con sé tutti gli elementi dello stile e del talento di Verdi e
l'orchestrazione è più raffinata rispetto alle opere precedenti. Senza nulla togliere a tante pagine già di
Nabucco, che sono perfettamente concepite, per non parlare di Macbeth, opera nella quale, se il direttore sa
capire quale significato abbia la combinazione di oboe, clarinetto e corno inglese, si possono sentire timbri
che portano Verdi molto in avanti. Otello però è un compendio di tutto.
Il Credo è l'unica vera aria in Otello, sebbene non sia concepita con una chiusura. Conosco questo brano sin
da quando ero bambino.
È evidente che, ogniqualvolta Verdi si trova a esprimere atteggiamenti malvagi o cinici, dimostra di essere
assolutamente a suo agio; sembra provare piacere nell'affermare «Così è il mondo», oppure «È vecchia fola il
ciel»; il senso delle parole di Jago è che il paradiso è unsciocca fantasticheria, una menzogna.
Là tradizione vuole che Jago termini il Credo con una risata: io non lo approvo, è orribile; l'unico vero
commento a questa frase deve essere affidato all'orchestra, uno strepito diabolicd: la musica dovrebbe avere
davvero un suono infernale. La gran risata rende invece la situazione troppo realistica: quando mai i
personaggi di un'opera ridono a piena voce? Tutto va reso solo attraverso la musica.
Il Credo è una delle pagine più popolari, cavallo di battaglia dei baritoni, ma bisogna dire che, dal punto di
vista della fattura, in un'opera che guarda così tanto in avanti come l'Otello, è una delle parti che più guarda
indietro, riproponendo stilemi già conosciuti.
Prima di concludere il discorso su Otello, vorrei fare un'ultima considerazione sull'Esultate, di cui ho già
parlato nelle pagine precedenti.
Ogni tanto salta fuori qualcuno che dice che la frase «L'orgoglio musulmano sepolto è in mare; nostra e del ciel
è gloria» andrebbe tolta, per non urtare la sensibilità islamica.
Io non ho mai pensato di dare a questa frase un particolare significato politico o di altra natura: è un
versetto di un libretto e come tale va preso. Se noi dovessimo esaminare eticamente o dal punto di vista
religioso i libretti e censurarli, dove andremmo a finire? Un'opera va aggiustata per il nostro uso e consumo
del momento? Sinceramente non vedo in quella frase nessuna forma di antagonismo. La storia è
testimonianza di tante situazioni e nón può essere bruciata.
Veniamo ora all'ultima opera di Verdi, il Falstaff: Fu Boito a proporlo e a insistere affinché Verdi vi si
dedicasse. A tal proposito è interessante il loro carteggio iniziale. Verdi scriveva a Boito, il 7 luglio 1889:
Voi nel tracciare Falstaff avete mai pensato alla cifra enorme de' miei anni? So bene che mi
risponderete esagerando lo stato di mia salute, buono, ottimo, robusto... E sia pur così:
ciò malgrado converrete meco che potrei esser tacciato di grande temerità nell'assumermi
tanto incarico. E se non reggessi alla fatica? E se non arrivassi a finire la musica?
Boito rispondeva a Verdi, il 9 luglio 1889, per cercare di convincerlo:
Lo scrivere un'opera comica non Credo che la affaticherebbe. La tragedia fa realmente
soffrire chi la scrive, il pensiero subisce una suggestione dolorosa che esalta morbosamente i
nervi. Ma lo scherzo e il riso della commédia esilarano la mente e il corpo. «Un sorriso
aggiunge un filo alla trama della vita.» ...
Lei ha desiderato tutta la sua vita un bel tema d'opera comica, questo è un indizio che la vena
dell'arte nobilmente gaia esiste virtualmente nel suo cervello; l'istinto è un buon consigliere.
C'è un modo solo di finir meglio che coll'Otello ed è quello di finire vittoriosamente col
Falstaff. Dopo aver fatto risuonare tutte le grida e i lamenti del cuore umano finire con uno
scoppio immenso d'ilarità! c'è da far strabiliare!
Il 10 luglio 1889 Verdi era persuaso:
Amen; e così sia! Facciamo addunque Falstaff!
Non pensiamo pel momento agli ostacoli, all'età, alle malattie!
Falstaff è davvero il compendio della vita di Verdi. Sono convinto che qui Verdi diventi protagonista; è infatti
un'opera autobiografica, sicuramente nella seconda parte.
Falstaff è l'anziano Verdi che riflette sul proprio percorso come uomo e come compositore. Lo stesso
compositore che, alla fine, chiedeva che le sue carte venissero bruciate. È come se mettesse ín scena la
propria vita, sorridendo ma senza nascondere una vena di amarezza e facendo un discorso molto cinico.
In Falstaff Verdi fa anche spesso uso di frammenti di opere precedenti, quasi per farsene beffa: una manciata
di parole di Traviata o Trovatore, una battuta musicale qui, una battuta là. Non è facile accorgersene, ma
studiandolo approfonditamente risulta evidente.
Chissà quante volte nella sua vita Verdi aveva sentito parlare dell'onore, ma a Falstaff, nel primo atto, fa
esclamare: «Il vostro Onor! Che onore?! che onor? che onor! che ciancia! / Che baia! — Può l'onore riempirvi la
pancia? / No. Può l'onor rimettervi uno stinco? Non può. / Né un piede? No. Né un dito? Né un capello? No. /
L'onor 'non è chirurgo. Che è dunque? Una parola. / Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che vola». L’onore,
dunque, è solo aria che vola, non serve a nulla.
Falstaff tenta e ritenta, ma alla fine si ritrova nel Tamigi, all'inizio del terzo atto: «Mondo ladro. Mondo
rubaldo. / Reo mondo! ... / Tutto declina».
È chiaro che si tratta di Verdi, che sta facendo un ritratto di se stesso e poi, in conclusione, alla fine dell'opera
afferma: «Tutto nel mondo è burla», come se intendesse «tutto quello che ho realizzato non ha alcuna
importanza, è solo uno scherzo».
Riguardando al passato non si sente soddisfatto di quello che ha compiuto, non crede veramente in quello
che ha raggiunto: l'urlo del trombone nel finale di Falstaff è quasi diabolico.
Per quanto riguarda il tema dell'amore, considero che una delle più grandi conquiste di Verdi sia stata quella
di riuscire a scrivere con l'animo di un giovane innocente, a ottant'anni e dopo averne trascorsi cinquanta a
mettere in musica passioni sanguinose e turbolente.
L'anziano Verdi chiude infatti la sua carriera descrivendo un innocente amore giovanile,quello tra Fenton e
Nannetta, mentre nelle vicissitudini di Falstaff con Alice e Meg dà all'amore esiti quasi tragici, come se non ci
credesse più.
Nel secondo atto, Falstaff dice: «Quand'ero paggio / Del Duca di Norfolk ero sottile, / Ero un miraggio / Vago,
leggero, gentile, gentile». Questo suo pavoneggiarsi non è da intendere semplicemente come una frase del
grande amatore che si considera ultimo esempio di virilità, bensì è una ironica visione di tutta quella che è
stata la sua vita, di uomo e di compositore.
Falstaff è veramente l'ultimo Verdi, tant'è vero che l'amore, che è stata una costante in tutte le sue opere, qui
si traduce in una contemplazione.
Io trovo che il Falstaff sia di perfezione unica. È la sola opera di Verdi che veramente possa reggere il
confronto con opere come il Così fan tutte, di Mozart con Da Ponte, dove il tema degli intrighi amorosi è
trattato senza malizia, senza cattiveria, senza malvagità, sempre col sorriso.
Mi riferisco, prima di tutto, a una perfezione teatrale: Falstaff è teatro, se si può dire è un'opera di
declamazione, e i personaggi sono scolpiti in maniera molto definita, non hanno bisogno di altri elementi per
comunicare con il pubblico.
Nel Così fan tutte c'è addirittura lo scambio delle coppie, però senza tragedia, col sorriso condotto sino alla
fine. E così è in Falstaff Il vecchio ne fa di cotte e di crude, lo buttano nel Tamigi eccetera, ma c'è sempre una
levità, un sorriso che Verdi raggiunge. Lui così scuro, così pessimista, così brontolone, con tutti i silenzi, i
turbamenti, l'invocazione della musica italiana del passato e di Palestrina, alla fine riesce a superare tutto
scrivendo Falstaff il coronamento culturale, spirituale ed esistenziale della sua vita.
Verdi, fra le proprie opere, avrebbe salvato il Luisa Miller. Personalmente, come tra le opere di Mozart, se
dovessi sceglierne una, non potrei fare a meno di portare con me il Così fan tutte, tra le opere di Verdi
sceglierei il Falstaff per me sarebbe davvero un grande compagno di strada.
Epilogo
«Ho cercato di servirti»
Comandare, impor tu déi,
Ben servirti ognun saprà.
SGHERRI, IN I LOMBARDI...,
ATTO I, SCENA V
Nella mia vita ho diretto moltissime opere di Verdi. Spero di fare in futuro anche opere cosiddette minori,
come per esempio Aroldo, Alzira, La battaglia di Legnano, Il corsaro... vorrei poterle visitare tutte.
C'è un'opera che ho guardato più volte ma mi sono sempre fermato perché l'ho trovata molto diseguale: la
Luisa Miller, che ha momenti straordinari, stupendi e fantastici, ma ne ha altri piuttosto stanchi, ed è l'unica
opera che non so se dirigerò mai, lo vedremo.
Come dice il Padre Guardiano nella Forza del destino: «Chi può legger nel futuro?».
Il mio impegno, al momento, in vista delle celebrazioni per l'anno verdiano, è rivolto allo studio del Simon
Boccanegra. Non l'avevo mai diretto perché è sempre stato molto difficile trovare un cast «all'altezza», però
alla fine ho rotto gli indugi e mi sono convinto che era inutile aspettare.
Si tratta di un'opera che, grazie a Boito, è stata rimaneggiata dopo più di vent'anni.
Verdi aveva già delle perplessità sul soggetto, che definisce triste, molto triste, molto desolante,
aggiungendo: «D'altra parte è triste perché dev'essere triste».
Tra la prima versione e la seconda versione ci sono però parecchie differenze: si sente che sono passati tanti
anni e soprattutto si sente che c'è la mano di Boito.
Il Boccanegra, nella seconda versione del 1881, è un'opera bifronte, perché da una parte guarda avanti e
lascia capire che Otello è alle porte, dall'altra in alcune cose guarda indietro, in un certo ricordo di opere del
passato. In questo sembra quasi ritornare al primo Boccanegra, che viene dopo la trilogia e mantiene
qualcosa dí quelle opere popolari.
Quindi c'è la convivenza di questi due elementi: un'opera che guarda avanti e un'opera che guarda indietro.
Commentando la seconda versione, Verdi afferma: «Abbiamo raddrizzato le gambe al vecchio Boccanegra»,
perché lui sapeva, pur amando l'opera e considerandola non inferiore alle altre sorelle, che nella prima
stesura non c'era teatralità.
Nella seconda versione ci sono momenti di una notevole bellezza e soprattutto si sente che la mano della
strumentazione di Verdi è diventata molto più raffinata, senza che Wagner abbia avuto una qualche
influenza su di lui. Il Boccanegra, nella seconda versione, ha certi passi che addirittura fanno presagire quelli
che saranno i procedimenti armonici e melodici di Mahler. Ecco perché Mahler amava tanto il modo di
strumentare di Verdi: lo avvertiva come affine.
Certe formule armoniche più elaborate sono il risultato del processo naturale di evoluzione di un genio. È
chiaro poi che, quando l'aria culturale di tutta l'Europa si arricchisce di elementi nuovi, questi vagolano.
Certe formule circolano e diventano cibo naturale dei creatori, che le assorbono.
Va tenuto presente costantemente, in tutte le opere, in tutti i personaggi, che Verdi è però un musicista che
ha una sua autonomia, una sua storia particolare e soprattutto un suo carattere, che non va confuso con altri.
Ogni parte della sua opera è preziosa per capire il grande messaggio della sua musica, che non è una musica
che cede a determinate mode o a determinati compromessi, ma evolve da un'idea iniziale molto forte, da una
genialità che in qualche modo si manifesta già anche nelle prime opere, ed è profondamente intrisa di
italianità, nel senso più generale che si possa dare a questo termine, come abbiamo ampiamente visto nelle
pagine precedenti.
Per concludere queste considerazioni sul nostro grande compositore, qual è il segreto che trovo in ogni sua
partitura?
Per me, che non pensavo di fare il musicista, l'aver incontrato Verdi sulla mia strada mi ha dato una delle
ragioni per cui valeva la pena vivere questa vita.
I suoi personaggi sono uno specchio per ognuno di noi e ci sono tante sfaccettature in cui ciascuno può
trovare refrigerio e anche una risposta ai propri problemi, alle proprie sofferenze, alle proprie gioie.
Verdi è prima di tutto un uomo di teatro. Perciò la mia lettura delle opere di Verdi parte sempre dal punto di
vista della parola, così come la mia interpretazione: ogni accordo, ogni croma, ogni semi-croma ha una sua
ragion d'essere che è sempre di natura teatrale e drammatica.
Verdi è come un maestro, che ogni tanto ci prende per mano e ci fa capire un momento dell'esistenza.
Avviandomi a concludere questo libro, mi piace ripetere la frase di D'Annunzio che trovo proprio vera:
«Diede una voce alle speranze e ai lutti. / Pianse ed amò per tutti».
Verdi ha pianto e amato per tutti noi, non solamente noi italiani, perché la sua grandezza è stata quella di
aver portato tutte queste storie a livello universale. Per cui non è solamente la cultura italiana che si ritrova
in Verdi, ma il mondo intero.
Mi hanno chiesto, a volte, cosa direi a Verdi se avessi la possibilità di incontrarlo. Penso che, dopo essere
sbiancato in volto, le mie parole non potrebbero che essere queste: «Ti ho amato per tutta la mia vita di
musicista e ti ho servito, ho cercato di servirti. Però non mi dire se ho fatto bene o male, perché se mi dici che ho
fatto male dopo non avrei più scampo e sarebbe una terribile condanna in eterno...».