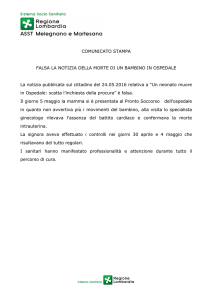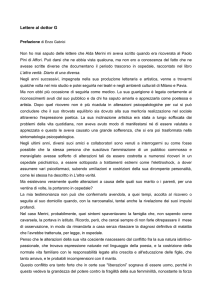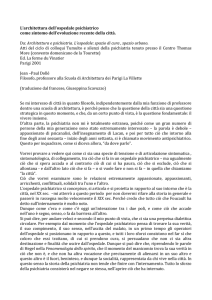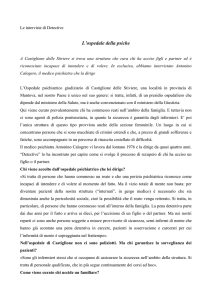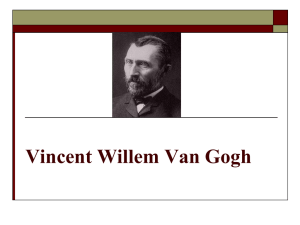ISTRUZIONI PER
CURARE IL DOLORE
DELL’ANIMA
NUOVE TERAPIE
«Una volta
dimesso
il paziente
psichiatrico
non può essere
lasciato solo».
Con questa
filosofia
è nata Redancia,
galassia che
raccoglie
18 comunità
e appartamenti
protetti. E dove
si mette al centro
la persona,
non la malattia
Lo psichiatra Michele
Solari, fondatore di
Redancia, con un
paziente della
comunità Crogiuolo
Villa Caterina.
di Bettina Bush
Foto Giuliano Koren
D 158
3 MARZO 2012
D 159
atteo vedeva
le persone attraverso uno
spazio che
non era fatto
di aria trasparente, ma di
un muro d’acqua che rendeva le immagini lontane, poco definite, e soprattutto poco
presenti. Si sentiva in fondo a una piscina, senza nessuno che potesse
entrare in contatto con lui. Cercava
una mano che lo tirasse fuori, che
rompesse quella barriera di densa
trasparenza. Solo dopo Matteo ha saputo che quella sensazione di distacco e di assenza aveva un nome, e
che la derealizzazione era uno dei
tanti sintomi del suo malessere. Tutto
era cominciato qualche anno prima:
un piccolo fastidio agli occhi, qualche macchia che girava rendendo
difficile qualsiasi attività. Ma la risposta dei medici era sempre la stessa:
nessun problema fisiologico, gli occhi di Matteo erano perfettamente
sani. Dopo è arrivata una delusione
sentimentale: per alcuni sarebbe stato un piccolo incidente di percorso,
per lui il crollo totale. Le macchie sono diventate ingestibili, ma finalmen-
M
«No al rientro in
famiglia, il luogo
delle dinamiche
negative.
Meglio puntare
su una controllata
autonomia»
te avevano un nome, scotomi. Intanto la derealizzazione cresceva: quella
maledetta piscina lo stava inghiottendo come un buco nero. Poi, finalmente, è arrivata la mano che lo ha
stretto, ed è cominciato il suo percorso salvifico. Una strada non facile,
ma almeno Matteo non si sentiva più
solo, aveva trovato un posto in una
comunità dove il suo dolore ha ricevuto un ascolto. Il suo mondo nuovo,
dove l’odore della sofferenza è intriso
nell’ambiente, è abitato da persone
che hanno disturbi di personalità,
depressione, schizofrenia, bipolarismo, disturbi psicotici, tutte etichette
che descrivono emozioni alterate del
rapporto tra il mondo esterno e quello interno. La sua comunità è un universo dove gli ospiti come lui sono
seguiti da psicologi, psichiatri, educatori, infermieri, un modello che
usa l’etica come filo conduttore per
l’intervento psichiatrico: «La prima
comunità Redancia è nata negli anni 90», spiega Giovanni Giusto,
fondatore di questa piccola galassia
di strutture, «e l’idea è nata quando,
lavorando nei servizi di salute mentale della Asl ligure, mi sono reso conto
che mancavano strutture intermedie
tra l’ospedale e la casa. Quando poi
sono passato all’ospedale di Cogoleto
(Genova) ho ulteriormente realizzato
In alto, lo
psicopedagogista
Mauro Siri.
In questa foto,
pazienti
di Crogiuolo.
che neppure quel tipo di struttura
bastava per curare la malattia, e infatti i ricoveri di pazienti gravi si ripetevano. Per questo ho deciso di fondare le comunità. Il progetto man
mano è cresciuto, attualmente abbiamo 18 strutture, molte in Liguria.
Si parte dalle quelle contenitive, per i
casi più difficili, e si arriva agli appartamenti protetti, soluzioni per dare
una maggiore indipendenza. Abbiamo circa 500 pazienti, ogni ospite
costa mediamente 135 euro al giorno, molto meno del posto letto in
ospedale, e la Asl ligure, dalla quale
bisogna passare per arrivare da noi,
in lista d’attesa ha 200 persone».
Ricovero in ospedale e comunità sono due esperienze completamente
diverse, e diversi sono anche i risultati. In cosa differiscono?
«Il primo è una struttura statica dove
gli aspetti vitali, emotivi, passionali
vengono sopiti e non utilizzati per i
cambiamenti. Nella comunità Redancia invece si mette al centro la
persona e non la malattia. Per noi la
diagnosi è poco importante, quasi irrilevante. Siamo noi che ci adattiamo
al paziente, e non viceversa. Il nostro
approccio è di estremo rispetto per
l’ecologia mentale del soggetto che ci
viene affidato, per le sue abitudini, la
sua storia, la sua sensibilità, il suo
modo di essere nel mondo, un mondo che per il paziente psichiatrico è
pieno di fantasmi e di disperazione.
Grazie alla psicoterapia residenziale
cerchiamo di disintossicare il paziente dalle angosce che lo assillano con
diverse tecniche, passando per la
psicoanalisi e l’intervento cognitivo
comportamentale».
Utilizzate anche farmaci?
«Il farmaco è fondamentale: quando
è ben utilizzato permette che la relazione tra medico e paziente si sviluppi più rapidamente».
Qual è l’obiettivo delle comunità
3 MARZO 2012
Un momento
d’incontro
tra i pazienti
e gli operatori.
Ogni ospite costa
135 euro al giorno,
molto meno del
posto in ospedale.
UNA
MAMMA
RACCONTA
di Erica Baldi
Paura, amore incondizionato,
sorprese (belle e brutte), sensi di
colpa, fatica e infine la decisione di
entrare nella comunità Redancia.
Una mamma racconta la sua
convivenza con un figlio affetto da
disturbi della personalità.
Qual è il problema di suo figlio?
«Le diagnosi sono difficili. Si parla
genericamente di disturbi della
personalità, comportamento
narcisistico, sindrome bipolare.
Luca ha un modo di ragionare
particolare e tutto suo. È un
ragazzo intelligentissimo, brillante,
perspicace e molto sensibile.
Forse troppo. Alle elementari
riusciva benissimo in alcune
materie, come matematica e
scienze, mentre andava malissimo
in italiano e storia. Pensavamo che
fosse una sorta di piccolo genio».
Quando è entrato in comunità?
«Appena diciottenne. Un problema
da superare, per gli altri normale,
per lui è stato il tracollo. E a quel
punto la convivenza in famiglia
è diventata difficilissima, quasi
insostenibile. A livello pratico,
Luca non sa organizzarsi nelle
D 162
Redancia?
«Teniamo conto degli aspetti biologici e psicologici, e di un possibile
reinserimento sociale e lavorativo
dei pazienti. Abbiamo anche una
cooperativa, la Bitta, che dà lavoro
a una quarantina di pazienti nel
campo della ristorazione, della pulizia e del guardianaggio».
Come lavorate, nella pratica?
«Prendendo spunto da Marc Augé
partiamo dal nonluogo, un posto
dove il paziente è libero di essere
quello che è. Il nonluogo è come la
sala d’attesa, dove puoi intrecciare
o meno rapporti con altri. I pazienti
sono molto sensibili e indifesi, si
sentono oggetto di richieste pressanti: qui possono scegliere. Questo
è un guscio, dà protezione, è la pelle, che fa da tramite con l’esterno e
permette la relazione con l’altro, attivata dagli operatori».
Quanti pazienti dimettete?
«Chi entra deve già avere il suo progetto per uscire. La nostra psichiatria termina con un’apertura verso
l’esterno, creando “la pelle”, appunto. Abbiamo una percentuale di
dimissioni intorno al 60 per cento».
UNA BUONA ALLEANZA
La comunità è una strada lunga.
Punto di partenza è l’alleanza tra il
paziente e il suo medico, che permette di rendere le relazioni impazzite qualcosa di possibile e sostenibile, di leggere nella vita del soggetto le pagine più significative e di
cercare insieme una soluzione a
«In questo posto
il paziente è libero
di essere quello che è.
Il nonluogo è come
la sala d’attesa,
dove puoi intrecciare
o meno rapporti
con gli altri»
traumi, frustrazioni e desideri: «Nel
mio lavoro, parto dal presupposto
che il paziente è il nostro primo
maestro», afferma Michele Solari,
psichiatra e direttore sanitario di
Redancia 1. «In comunità avevamo
un grave schizofrenico, che aveva
passato un periodo in Opg, l’ospedale psichiatrico giudiziario. Ci siamo resi conto, con sorpresa, che il
suo periodo di vita meno doloroso
era proprio quello passato laggiù, in
virtù di una relazione che aveva stabilito con un importante boss mafioso. Nel ruolo di “servitore del capo” aveva trovato protezione e identità. Sulla base di questa ipotesi abbiamo organizzato un setting di cura che riproducesse questa situazione, ovviamente a livello simbolico, e il paziente ha cominciato a
migliorare. Per alcuni soggetti molto
gravi, il primo obiettivo è anche l’ul-
3 MARZO 2012
Due immagini della
comunità terapeutica
Redancia 1.
cose quotidiane, come prepararsi
da mangiare, usare i mezzi
pubblici. Può capitare che prenda
il taxi per fare due fermate
di autobus. Non pensa in
prospettiva, e non considera
le conseguenze delle azioni.
Soprattutto, è un ragazzo
sofferente. Ha sempre riversato
su di me una violenza non fisica,
ma psicologica. Nell’ultimo
periodo in casa era diventato
la mia ombra. Dopo due ricoveri
in psichiatria siamo riusciti a farlo
entrare in questa comunità. Ora è
lì da un anno. Tra nove mesi forse
uscirà, e se tutto va bene avrà un
appartamento dove vivere da solo,
seguito dagli assistenti. Non è
bello dirlo, ma da quando lui è via
io posso respirare».
Come ha affrontato la malattia?
«La domanda che mi faccio più
spesso è: perché è successo?
Colpevolizzarsi è la cosa più
facile, in questi casi. Colpa mia?
Di mio marito? Di quella maestra?
Del trasloco? Ora so che la
malattia di mio figlio è un insieme
di predisposizione genetica e
fattori ambientali: le persone
incontrate, i luoghi frequentati...».
Chi o che cosa l’ha aiutata?
«Quello che fa la differenza, in
queste situazioni, è l’umanità delle
persone. Nei reparti di psichiatria
il dialogo è freddo, insopportabile.
La risposta sono le medicine,
pesanti e mal tollerate dai ragazzi.
Nella comunità Redancia ci si
sente meno soli, e i medici sono
davvero motivati».
Quali aspettative, per Luca,
dopo il periodo in comunità?
«Ogni tanto spero che possa
guarire, ma so che non succederà.
Quello che può accadere è una
guarigione collettiva e familiare.
Se noi diventiamo forti, lui
in qualche modo guarisce. Il suo
miglioramento è legato allo stile
di vita che riuscirà ad avere, alla
morbidezza che
troverà sulla sua
strada, al dolore
che riusciremo a
risparmiargli».
D 164
timo: assicurare la sopravvivenza
con una buona qualità della vita, in
un contesto protettivo. Se la guarigione clinica non è possibile, cerchiamo almeno una forma di guarigione sociale».
Quali sono le patologie maggiormente a rischio?
«Ricordo un caso di suicidosi: più
che una precisa patologia, una condotta caratterizzata dal cronico ripetersi del tentativo di uccidersi. Dopo
23 prove, ostentatamente aggressive, preparate con lucida determinazione, è arrivato la ventiquattresima, fatale e questa volta riuscita,
incredibilmente, per errore. La paziente era figlia di una donna che
aveva tentato più volte di abortirla,
ed era come se, venendo al mondo,
portasse già scritto il proprio destino. Un caso nel quale si potrebbe
dire che il trauma patogeno era già
in atto prima della nascita».
Vite diverse, e casi complessi,
ognuno con i suoi bisogni. Come si
organizzano tempi e percorsi?
«Attualmente in Liguria il limite
temporale in comunità è di 36 mesi, una sfida per i medici che vogliono costruire progetti più a lungo
termine. Ma se le strutture terapeutiche hanno il mandato di agire
sempre più velocemente, bisogna
potenziare le reti di sostegno extraistituzionale, perché la persona che
ha acquistato indipendendenza poi
non può essere abbandonata».
Una costante, dopo il percorso comunitario, è quella di evitare il rientro a casa, in famiglia, il luogo dove
spesso sono nate e si sono sviluppate le dinamiche negative. Meglio
puntare su soluzioni abitative indipendenti, cosa non semplice per
persone con disagio: «Il rientro a
casa dopo un’esperienza comunitaria è un momento particolarmente
delicato», spiega Mauro Siri, psicopedagogista di Redancia, «e non
può esser lasciato al caso, c’è il rischio di rovinare il lavoro fatto. I
servizi pubblici di igiene mentale, in
seguito ai tagli di budget, non riescono a far fronte alle esigenze attuali. Basti pensare che, in alcuni
casi, uno psichiatra deve occuparsi
di centinaia di pazienti, in situazioni
spesso gravi. Per loro, dedicarsi alla
riabilitazione domiciliare di casi già
passati anche per la comunità è
un’utopia».
Esiste una soluzione?
«La riabilitazione domiciliare è
un’esigenza. Sarebbe fondamentale
poter creare un’équipe di professionisti sul territorio, capaci di valutare
il soggetto non solamente dal punto
di vista clinico, ma con una forte attenzione agli aspetti psicosociali,
per restituirgli una piena autonomia. Gli ambiti dove il paziente ha
bisogno di aiuto vanno dalle abilità
di base al lavoro: in questi casi, sono utili le working experience, percorsi di riqualificazione professionale creati per le fasce più deboli.
Una rete leggera per collegare professionisti, pazienti e strutture. Un
progetto possibile».
«Questo è un
guscio, è la pelle
che fa da tramite
con l’esterno
e permette la
relazione con gli
altri là fuori»