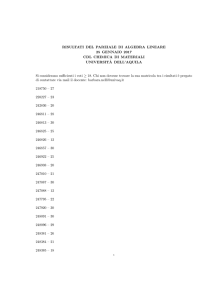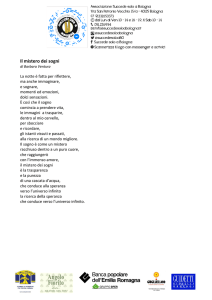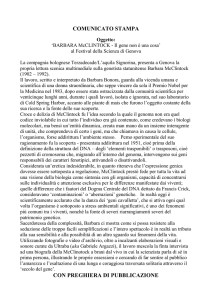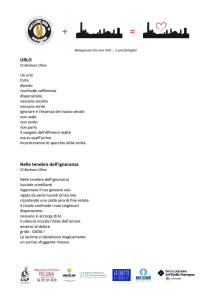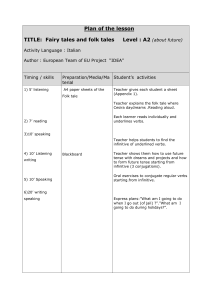iFdI
the best of
2014
INDICE
1. “Genealogia della cultura” di Michele Castelnovo.............................................. 3
2. “Ammazziamo il Gattopardo: puntualizzazioni alla presentazione del libro” di
Silvia Lazzaris..................................................................................................... 6
3. “Storia di una guerra e di uno stupro: La Ciociara di Alberto Moravia” di
Dalila Forni....................................................................................................... 10
4. “I sogni segreti di Walter Mitty: la storia di un uomo alla scoperta di sé e del
mondo” di Giulia Malighetti.......................................................................... 14
5. “Barbara di Jacques Prévert: una poesia di amore e guerra” di Dalila Forni..16
6. “Non hanno abolito storia dell'arte nelle scuole” di Michele Castelnovo....... 19
GENEALOGIA DELLA CULTURA
di Michele Castelnovo
Attualità
La parola "cultura" deriva dal latino "colĕre", che significa "coltivare". Questa
origine etimologica è riscontrabile ancora oggi, nell'uso corrente che ne si fa:
basti pensare all'ambiguità semantica della parola "colto", dove un accento
segna la differenza tra una persona ed un ortaggio.
In latino "colĕre" però non significa solo coltivare. Dal dizionario latino-italiano
di G. Pittàno, Mondadori 1965:
Cŏlo, -is, colŭi, cultum, -ĕre, tr. 3a.
I. coltivare, praticare
II. curare, aver cura, adornare
III. abitare, frequentare
IV. onorare, venerare, celebrare
Così in Cicerone (106 a.C. - 43 a.C.) abbiamo che "colĕre" si riferisce tanto ai
campi, quanto alle amicizie, alle virtù e agli studi (agros colere, amicos
colere, virtutem colere, studia colere). Ed è proprio con Cicerone che questa parola
viene usata nell'accezione con cui ancora oggi noi parliamo di cultura.
Come è noto, infatti, Cicerone fu colui che diffuse la filosofia presso i romani
e costruì il vocabolario filosofico che ancora oggi noi usiamo (ad es. la parola
"sostanza" deriva dal latino "substantia", termine da egli usato per tradurre il
greco ὑποκείμενον, hypokeimenon).
Trovandosi
a
dover
tradurre
il
termine παιδεία, paidèia (educazione,
formazione),
Cicerone
scelse
proprio "colĕre". Identificando la cultura con la filosofia, infatti, egli sosteneva
che la pratica filosofica conducesse - tramite la cultūra animi - gli uomini da una
vita selvaggia, contadina a una vita civile, ovvero associata in comunità. Vale a
dire: la cultura è il coltivare, l'esercitare la mente, consentendo di fare
un upgrade ontologico da uno stato di inciviltà alla civiltà.
In questa accezione la parola "cultura" nel corso del Medioevo è andata
sovrapponendosi a "humanitas", designando a grandi linee ciò che ancora oggi
noi definiamo cultura umanistica.
Così la parola "cultura" ha identificato per secoli l'attività di studio,
l'acquisizione pratica di un sapere teoretico. Con l'espressione "una persona di
cultura" infatti tendiamo ad indicare una persona erudita, che ha molto studiato
e accumulato molti saperi.
Nel corso del XVIII secolo, grazie ai lavori del filosofo tedesco J. G. von
Herder (1744 - 1803), la cultura perde il suo significato di arricchimento
personale, andando a indicare il generale processo di civilizzazione del genere
umano che si stacca dalle proprie radici naturali. L'acculturazione è un processo
progressivo che segue un piano provvidenziale, il quale si attua nel passaggio
da un popolo all'altro.
Nella prima metà dell'Ottocento, con la nascita di un'antropologia scientifica, il
termine "cultura" acquisì un nuovo significato. Per il tramite dei primi etnografi
tedeschi, infatti, il pensiero di Herder giunse alla nascente antropologia
evoluzionista. Uno dei padri della disciplina, E. B. Tylor (1832 - 1917), diede una
nuova definizione di cultura nel suo testo più noto, Primitive culture(1871):
« La cultura, o civiltà, intesa nel suo ampio senso etnografico, è
quell'insieme complesso che include la conoscenza, le credenze, l'arte,
la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita
dall'uomo come membro di una società. »
Leggendo queste parole, non può che risuonare nell'orecchio l'eco delle parole
di K. Marx (1818 - 1883), che ne L'ideologia tedesca(composto tra il 1845 e il 1846,
ma pubblicato solo nel 1932) introduce il concetto di sovrastruttura, con il quale
indica la produzione ideologica e culturale (le rappresentazioni del mondo, i
miti, le idee, i concetti, il diritto, la religione, la politica...) di una società, distinta
dalla produzione materiale, le cui modalità costituiscono la struttura, che a sua
volta determina necessariamente la sovrastruttura.
Tornando a Tylor, nonostante tutto egli è figlio del proprio tempo e, pur
ampliando i significati designati dal termine "cultura", continua a concepirla
come un sinonimo di "civiltà", inserendosi in una tradizione che affonda le
proprie radici nell'Illuminismo europeo e che trae nuova linfa dai lavori di G.
W. F. Hegel (1770 - 1831), per il quale, tramite la dialettica tra finito e infinito, si
invera un susseguirsi di civiltà che prendono sempre più coscienza di sé,
creando l'istituzione dello Stato etico, che è Stato in quanto rappresenta lo
Spirito Assoluto nella finitezza dell'essere. Lo Stato etico dunque è il prodotto
della graduale civilizzazione dei popoli e la civiltà è un processo graduale e
continuo, mosso da un ideale teleologico, che va considerato per come si è
presentato nella storia dello Spirito, a seconda del grado di evoluzione delle
forme di vita associata.
Sebbene sia stata per lungo tempo intesa come tale, "cultura" e "civiltà" non
sono sinonimi. Esiste infatti una tradizione di pensiero per cui la cultura vada
intesa più come i mōres romani che come un processo di crescita, individuale o
collettiva che sia. L'idea stessa di cultura come coltivazione lascia intendere un
processo di evoluzione unilineare, così come da un seme nasce una pianta.
Mōs, mōris significa infatti costume, uso, usanza, abitudine. Abitudine viene dal
latino hăbĭtŭdo, -dĭnis, che a sua volta deriva da hăbĭtŭs, -us, cioè abito, veste. Un
abito si mette e si toglie, ma alla nascita si è nudi. Così - in senso metaforico - gli
abiti di una società sono le costruzioni simboliche che si accumulano o
abbandonano nel tempo storico; indicano ciò che è considerato socialmente
accettabile o meno.
In questo senso allora un'abitudine è la tendenza a ripetere e a rinnovare
determinati abiti sociali. Intendere la cultura come insieme dei mōres di un
popolo, cioè come abitudini, ovvero ripetizioni di vesti comportamentali,
significa dunque abbandonare la scaletta evoluzionista - tipicamente
occidentale ed eurocentrica - per cui esiste una cultura, coincidente con la
civiltà, dall'alto della quale guidicare le altre società. Ogni popolo ha una sua
cultura e non si dispone di un metro di valutazione unilineare. Dire ciò significa
affermare che i popoli che usano la magia a scopo guaritivo non sono meno
civili di chi usa la medicina. Significa inoltre porsi in un'ottica di relativismo
culturale, per la quale ogni società è un capitolo del grande libro contenente gli
infiniti modi di fare umanità.
Già: il concetto di umanità è qualcosa che l'uomo costruisce e ridefinisce di
continuo. L'humanitas europea non è che uno dei molteplici modi in cui l'uomo
ha parlato di sé e chi non ha mai letto Dante non è meno umano di chi recita
la Divina Commedia a memoria.
Oggi, davanti al progressivo smembramento dell'umanismo e conseguentemente - delle discipline umanistiche, non ha senso domandarsi "che
fine farà l'umanità?", perché semplicemente una nuova cultura sta
soppiantando un'idea di uomo che fatto il suo corso.
Ciò non significa che l'umanità sia morta, bensì che una nuova umanità ha
iniziato a formarsi e non siamo ancora in grado di dire se il processo si sia
compiuto, né quindi di esprimere giudizi su questo uomo nuovo. Certo è che la
modernità ha fatto irruzione in tutto il mondo, omologando ai suoi standard
persone di tutte le culture. Questo ha avuto indubbiamente dei vantaggi (come
ad esempio la possibilità di guarire malattie reputate inguaribili), ma - come
ogni cosa - ha avuto anche il suo rovescio della medaglia: tutte le culture
particolari, con le proprie peculiarità, stanno cedendo il passo ad una cultura
unica, globale.
Meglio? Peggio?
Ai posteri l'ardua sentenza...
Come visto all'inizio, "colĕre" significa anche "aver cura". Allora fare cultura
dovrebbe voler dire prendersi cura della cultura, tanto nel senso ciceroniano di
erudizione quanto in quello antropologico di insieme degli usi e dei costumi.
Entrambi sono due mondi che stanno scomparendo. Prendersene cura significa
imparare la lezione del passato per affrontare al meglio le sfide del futuro.
31 marzo 2014
"AMMAZZIAMO IL GATTOPARDO": PUNTUALIZZAZIONI ALLA
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
di Silvia Lazzaris
Attualità
"Ammazziamo il Gattopardo": il nuovo libro di Alan Friedman che ha scatenato
un ciclone mediatico su cui è doveroso puntualizzare.
E infatti la presentazione del libro di ieri, in Sala Buzzati del Corriere della Sera, è
risultata atipica rispetto al solito.
Non solo perché è inconsueto trovare a commentare un libro personalità come
De Bortoli, Paolo Mieli, Corrado Passera e Pippo Civati, per di più tutte
insieme.
Ma anche perché è suonata tutta come una sorta puntualizzazione continua.
Una presentazione-puntualizzazione.
Noi eravamo lì, e cerchiamo di riassumere le note salienti dell'evento.
Le puntualizzazioni di Friedman: l'intento del libro non è una critica a Napolitano
Friedman svela che il concepimento è iniziato nel marzo dell'anno scorso. Non
aveva in mente un libro che avrebbe svelato dei retroscena della politica
italiana. Il primo titolo, bocciato dall'editore, suonava infatti in maniera diversa
"Incubo italiano: come salvare il paese o almeno evitare il peggio". L'idea iniziale del
libro era di indagare e raccontare in modo documentato (con anche l'utilizzo di
videoregistrazioni - sul sito del corriere si può trovare una "web-serie" delle
videoregistrazioni), perché l'Italia non sia riuscita negli ultimi decenni ad
affrontare riforme per rimettersi in carreggiata. Ha deciso di intervistare l'Italia
che muove i fili: presidenti del consiglio, figure politiche e nuove figuresimbolo come Matteo Renzi, ma anche banchieri e personalità accademiche.
Insomma una specie di diagnosi del problema a cui segue l'elenco delle
ricette per risanare il paese. Il libro non è quindi certo incentrato sul passaggio
dal governo Berlusconi al governo Monti. Questo è solo un elemento.
Il ciclone mediatico, invece, è ruotato intorno alla critica al presidente della
repubblica Giorgio Napolitano. Ed è consistito in un fraintendimento del libro.
C'è un solo capitolo, dice Friedman, che riguarda la questione di Giorgio
Napolitano, Mario Monti, e Silvio Berlusconi. In questo capitolo si afferma in
maniera documentata (che Monti ha tentato adesso di smentire, ma "è difficile
smentire un video"), che Napolitano abbia sondato il polso di Monti quando
Berlusconi era ancora in carica - per quel poco che possa valere, io devo ancora
capire cosa ci sia di incostituzionale.
Gli altri capitoli costituiscono quello che alcuni hanno chiamato una
"controstoria": retroscena di altri eventi a partire dal malgoverno della prima
repubblica, ad esempio una lunga intervista con Amato che spiega la
costruzione e la crescita del debito del paese a partire dagli anni '80.
Altra puntualizzazione a cui Friedman tiene è quella sul proprio atteggiamento di
americano che commenta i fatti politici italiani e viene a darci consigli: chiarisce
che ama l'Italia. Che ha imparato ad amare questo paese "tanto strano quanto
meraviglioso". E sottolinea che non si debba fraintendere. Che non si debba
utilizzare un'ottica anglosassone per capire l'Italia. Bisogna capire l'Italia nel
modo italiano. Non si possono prendere esempi anglosassoni, ma italianizzare
tutto.
La ricetta che si dà nel libro è costituita di dieci punti, che riguardano:
l'abbattimento del debito, la creazione di condizioni di lavoro, l'urgenza di un
minimo vitale per tutelare le fasce più deboli, come rendere il sistema
pensionistico più efficiente ed equo, l'importanza di un programma nuovo per
l'occupazione femminile (chiarisce "non è solo questione di asili nidi"), la
garanzia di una vera meritocrazia, la sanità non solo come questione di costi
standard e sprechi, le regioni e le competenze da togliervi per riportarle al
centro, la questione di una patrimoniale leggera.
Il libro, a quanto pare, è anche intervallato da scenette comiche tratte soprattutto
dall'intervista con D'Alema, che tra le tante comiche che dice, confida a
Friedman "Sa, io tutti i giorni leggo i suoi articoli del New York Times".
Friedman ci riflette un po'. "Ma io non scrivo più sul New York Times dal 2003!"
Le puntualizzazioni di De Bortoli: si tratta di un'inchiesta giornalistica
incontrovertibile
De Bortoli ci tiene invece a sottolineare il valore di un'inchiesta giornalistica
documentata con videoregistrazioni e realizzata da un grande giornalista che
possiede l'arte di "ammaliare gli interlocutori" come Friedman. È un libro ben
fatto, un'inchiesta incontrovertibile, verificata con grandissimo scrupolo. E qui,
il direttore del Corriere, offre uno spuntino di lezione di giornalismo con il
retrogusto
amaro
di
chi
risponde
a
una
critica.
Un buon giornalista deve pubblicare tutte le notizie, dice, non deve polemizzare
mai con nessuna notizia e dare il giusto risalto alle notizie che hanno valore. Ci
tiene a dire che sono tanti i giornalisti che fanno bene il proprio mestiere, e che
non
fanno
affatto
parte
di
chissà
quale
complotto.
Il mestiere del giornalismo è incalzare il potere senza fare sconti a nessuno,
emettere nelle condizioni di avere ingredienti non avariati per costruirsi un
giudizio e per esercitare il proprio compito di cittadino. "Si fa tutto quello che è
giusto fare perché bisogna presentare alla pubblica opinione tutti gli elementi positivi o
negativi". Conclude il suo intervento con un "e meno male che abbiamo avuto
Giorgio Napolitano, meno male che abbiamo avuto un'istituzione di garanzia che si è
resa conto che lo stato in cui si trovava il nostro paese doveva essere risolto".
Le puntualizzazioni di Mieli: nessuna furberia da parte della casa editrice
Mieli, direttore della casa editrice che pubblica il libro, Rizzoli, parla di quei
giornalisti che si sono chiesti "Perché far uscire il libro proprio in questo giorno?",
alludendo a qualche furberia da parte della casa editrice. E commenta "Se lo
leggete sui giornali, chi l'ha scritto o è un cretino o è in malafede. In genere è un
cretino. E comunque spesso i cretini sono in malafede". Si mette quindi a raccontare
il processo attraverso cui si arriva alla pubblicazione: c'è una lavorazione che
dura sei mesi, poi il libro viene consegnato, rivisto, stampato, e questo prevede
altri quattro mesi. Alla fine, due mesi prima della data d'uscita si decide la data.
Per quella data le macchine si mettono in moto e producono decine di migliaia
di copie. Quindi l'uscita di un libro si prevedrebbe con un anticipo di svariati
mesi. Chiunque abbia mai lavorato con il mondo dell'editoria non potrebbe
sospettare che ci sia stata un'operazione "ad-orologeria".
Gli interventi di Civati e Passera più che puntualizzazioni sono commenti
politici, come del resto è prevedibile: Civati sostiene quanto sarebbe forte una
campagna elettorale in questo momento, quanto sarebbe importante andare a
votare prima o poi. "Questo Gattopardo lo sta sottovalutando ancora chi scrive in
queste pagine", afferma, nonostante si dichiari d'accordo con il contenuto del
libro. Ci dev'essere una politica che dia strumenti a queste scelte, una politica
coraggiosa.
Anche Passera sottolinea quanto sia importante portare un cambiamento in
Italia, e dichiara che presto presenterà dei punti, su cui però non dà altre
informazioni.
Vorrei chiudere con delle parole di Friedman, che - sempre per quello che può
valere - a me è piaciuto molto.
Non è un giornalista-canaglia, a meno che il vero giornalismo non possa fare a
meno di affibbiarsi questo appellativo. Per come è stato presentato, il lavoro di
Friedman mi sembra davvero un contributo di rilievo: utile non solo a noi oggi,
per la costruzione di un'idea più consapevole dei meccanismi politici e dei vizi
storici del nostro paese che ci hanno condotto a questa situazione, ma utile nella
ricostruzione storica futura del difficile periodo che stiamo vivendo.
Premiamo e incentiviamo la chiarezza di opere come questa.
Ecco la conclusione del suo intervento:
«Gli italiani non sono per niente stupidi. Credo preferirebbero non leader politici che
promettono la luna e poi danno briciole, ma leader che si alzano in piedi e dicono
onestamente "Questa impresa non sarà facile, ci vuole coraggio, ci vuole spirito di
sacrificio collettivo, ma se uniamo le forze potremo rifare il nostro paese e riprenderci in
mano il nostro futuro. Ma le forze della conservazione sono fortissime. Questo libro si
chiama "Ammazziamo il Gattopardo" perché le forze della conservazione politica sono
quelle che dicono come Tancredi nel Gattopardo "Se vogliamo che tutto rimanga lo
stesso dobbiamo cambiare tutto". Questo è il Gattopardo da ammazzare (non il
giaguaro di Bersani). Questa è una mentalità troppo pesante nella cultura politica ma
forse anche nella classe dirigente in generale».
13 febbraio 2014
STORIA DI UNA GUERRA E DI UNO STUPRO: LA CIOCIARA DI
ALBERTO MORAVIA
di Dalila Forni
Letteratura
Nel 1957, un decennio dopo la fine della seconda guerra mondiale, Alberto
Moravia pubblica il romanzo La ciociara. La trama dell’opera è piuttosto
semplice: siamo in Italia, nell’anno 1943, Cesira, una negoziante vedova
piuttosto spregiudicata, è costretta a fuggire da Roma con la figlia di diciotto
anni, Rosetta. E’ proprio la madre in prima persona a raccontarci la loro
esperienza: abbandonata la propria bottega – ma sicura di potervi fare ritorno
entro poche settimane – la donna si dirige con la figlia verso Vellecorsa, in
Ciociaria, dove è convinta di poter trovare rifugio nella casa dei propri genitori.
Tuttavia, il treno che trasporta lei e Rosetta si ferma nel paesino di Fondi: qui le
due protagoniste vengono a contatto con i contadini del luogo e sono accolte
insieme ad altri sfollati in alcune piccole capanne. La vita della campagna è
semplice e rurale, soprattutto agli occhi di due donne di città come Cesira e
Rosetta: i nove mesi trascorsi tra i braccianti e i fuggitivi sono caratterizzati da
una forte monotonia, interrotta solo dalla paura per le bombe lanciate dagli
aerei e dalla mancanza di cibo, che diventa via via un bene sempre più prezioso.
Durante questo insolito soggiorno madre e figlia fanno la conoscenza di vari
personaggi, tra cui possiamo ricordare Michele, un giovane laureato antifascista
e piuttosto idealista con cui stringono subito un forte legame di amicizia. In
questi lunghi mesi di esilio l’arrivo degli inglesi sembra essere l’unica speranza
di salvezza, ma proprio nel momento in cui Cesira e Rosetta pensano di poter
far ritorno a Roma in sicurezza, le due vengono attaccate da un gruppo di
marocchini: il risultato di questo scontro impari sarà lo stupro della piccola
Rosetta, che da questo momento subirà una vera e propria metamorfosi.
Questo episodio, seppur descritto nella seconda metà del libro, è il punto
centrale dell’opera; scrive infatti Moravia al riguardo in una lettera al suo
editore del 1956: “Il titolo resterà ‘La Ciociara’ benché il titolo più appropriato sarebbe
‘Lo stupro’. Anzi addirittura, alla maniera classica ‘Lo stupro d’Italia’, come a
sottolineare non solo la violenza sulla ragazza, ma lo stupro di un intero paese
causato dalla guerra. Sempre al suo editore, l’autore propone per la copertina
del romanzo un’opera di Picasso – per esempio un dettaglio di Guernica –
oppure di Goya, in modo da far comprendere immediatamente al lettore quali
siano i temi trattati, ovvero gli orrori della guerra.
Va inoltre evidenziato come il romanzo sia fortemente autobiografico: sebbene
sia difficile identificare Moravia con Cesira – un personaggio sicuramente molto
distante dallo scrittore – un’esperienza simile fu vissuta anche dell’autore che,
nel settembre del 1943, per fuggire dalla violenza della guerra si rifugiò con la
moglie Elsa Morante sui monti della Ciociaria, dove restò per otto mesi, in
modo analogo a Cesira e Rosetta. Si tratta di un avvenimento fortemente
traumatico per lo scrittore, che lo ricorda come uno dei momenti peggiori della
propria vita insieme agli anni in cui, durante l’infanzia, fu colpito dalla
tubercolosi.
L’esperienza personale dello scrittore vieni quindi ripresa ampiamente nel
romanzo: solo Cesira, Rosetta e Michele sono personaggi inventati, tutti gli altri
si legano infatti in qualche modo agli sfollati conosciuti da Moravia durante il
suo esilio sulle montagne. Nonostante lo scrittore abbia affermato che durante il
periodo passato sui monti romani il suo unico pensiero fosse la sopravvivenza,
e non di certo la scrittura, alcuni testimoni assicurarono di aver visto più volte
Moravia alle prese con dei quadernetti sui cui era solito annotare qualcosa,
forse dettagli poi tornati utili per la stesura dell’opera.
Il primo capitolo del romanzo venne scritto dall’autore nel 1946; Moravia
tuttavia non seppe inizialmente come continuare la narrazione, forse intimidito
dai fatti ancora troppo vicini che aveva vissuto in prima persona e sicuramente
molto impegnato a causa delle sue attività giornalistiche, narrative e
cinematografiche. Il romanzo fu quindi completato soltanto dieci anni dopo la
guerra, quando lo scrittore ebbe modo di prendere le distanze e poter riflettere
in modo più distaccato sull’accaduto.
Moravia si nasconde quindi dietro a Cesira, seppur da lui così diversa, per
raccontare gli avvenimenti e le sensazioni della guerra da lui sperimentati. Tutti
gli eventi narrati sono visti attraverso gli occhi – spesso ingenui, spesso fin
troppo furbi – della donna; di conseguenza, ogni personaggio che il lettore
incontra durante il romanzo viene filtrato dal giudizio di lei, a partire dalla
figlia Rosetta – descritta come una ragazza pura e religiosa – fino ad arrivare a
Michele – l’intellettuale che la donna non riesce a comprendere sempre a fondo
nonostante l’affetto che li lega.
Nonostante la storia sia ricca di sentimenti, il tema dell’amore non viene mai
toccato: Cesira è totalmente distaccata dal marito ormai morto per cui – già
dalla nascita di Rosetta – non provava più attrazione, il suo unico amore sembra
essere infatti quello per la sua bottega e la sua “roba”; la figlia, educata dalle
suore, è casta e dedita solo alla preghiera e all’ubbidienza per la madre, anche
se questa fragile educazione religiosa vacillerà presto; mentre il giovane
Michele sembra non avere attenzioni che per i suoi libri e soprattutto per le sue
idee e i suoi princìpi.
Lo scrittore dà voce alla donna utilizzando un linguaggio popolare, schietto,
privo di fronzoli e spesso dialettale. Nella mente del lettore sembra proprio
Cesira, e non più Moravia, a ideare e raccontare la (sua) storia: la lingua
utilizzata – soprattutto nel primo capitolo – rispecchia pienamente la
determinatezza e per certi versi la “virilità” della donna, che in più di
un’occasione si lascia andare a delle volgarità. Proprio questo linguaggio così
diretto che caratterizza e rende veritiera l’opera non è stato del tutto compreso
dalla critica, tanto che quando il primo capitolo del romanzo fu pubblicato su di
una rivista, Moravia venne denunciato per oscenità, vincendo però poi la causa.
Se la lingua di Cesira semplifica la narrazione, una parte piuttosto ostica è
quella centrale, in cui le due donne, segregate sui monti della Ciociaria,
trascorrono le giornate in un costante stato di noia. Questa monotonia viene
trasmessa efficacemente anche al lettore attraverso lunghe pagine in cui
vengono descritte varie azioni quotidiane ma in cui, in fin dei conti, non
succede nulla. In questo modo anche chi legge, seguendo le semplici vicende
delle donne e dei contadini, può constatare quanto la guerra possa essere
portatrice non solo di violenza e paura, ma anche di tedio e ripetitività: gli
sfollati in campagna non possono fare altro che aspettare che qualcuno – per
alcuni gli inglesi, per altri i tedeschi, per altri ancora non importa chi – ponga
fine alla guerra. Inoltre il lettore può, in queste pagine centrali del romanzo,
conoscere sempre di più Cesira e Rosetta, capendo poi nella parte finale quanto
la guerra abbia trasformato entrambe in soli nove mesi.“Quella lentezza accresce i
valori e gli effetti dell’ultima parte” dice Bompiani, l’editore di Moravia. E lo
scrittore aggiunge: “[…] questa attesa delle truppe alleate, questo vivere sempre
all'aperto immersi nella natura, questa solitudine formavano intorno a me un'atmosfera
insieme disperata e piena di speranza che non ho mai più ritrovato da allora. O meglio
sì, l'avevo provata in un altro momento estremo della mia vita, durante gli anni del
sanatorio. Anche lì avevo aspettato qualche cosa in condizioni di sofferenza. E questo
qualche cosa che aspettavo era in fondo la stessa cosa, allora come adesso. La fine di una
condizione malsana e dolorosa, il ritorno alla normalità.”
Come già detto, oltre alla guerra il punto centrale della narrazione, seppur
collocato nella parte finale del romanzo, è lo stupro. Le due donne vengono
infatti attaccate da una banda di stranieri e sarà in particolare la piccola Rosetta
– di diciotto anni d’età ma descritta ancora come una bambina per i suoi
comportamenti – a subirne le maggiori conseguenze dal punto di vista
psicologico: non sarà più da questo momento la ragazzina perfetta e
comprensiva, ma una donna disinibita, annoiata, priva di valori e di affetti. Il
dolore è però anche quello di una madre che non solo si vede sporca per aver
ceduto alle lusinghe di un corteggiatore prima della partenza da Roma, ma
considera distrutta dal peccato anche una figlia che considerava “una santa”. A
rendere lo stupro un avvenimento ancora più sconvolgente è la collocazione
dell’evento: le donne vengono attaccate proprio quando pensano di essere salve
e di poter tornare finalmente a Roma, e il tutto accade in una chiesa,“sotto gli
occhi della Madonna”, come dirà Cesira.
Il romanzo è stato poi riproposto nel 1960 in una versione cinematografica
diretta da Vittorio De Sica; è celebre l’interpretazione dell’allora ventiseienne
Sophia Loren, che vinse proprio grazie a questo film il suo primo Oscar.
Si tratta in conclusione di un’opera in grado di far riflettere in modo semplice e
genuino su un tema complesso come la vita durante la guerra, facendo
emozionare il lettore che non può non empatizzare con le due donne
protagoniste.
4 aprile 2014
“I SOGNI SEGRETI DI WALTER MITTY”: LA STORIA DI UN UOMO
ALLA SCOPERTA DI SÉ E DEL MONDO
di Giulia Malighetti
Cinema
"Vedere il mondo, cose pericolose da raggiungere, avvicinarsi,trovarsi l’un
l’altro, e sentirsi. È questo lo scopo della vita'' (motto di Life Magazine)
“Vedere il mondo”, una cosa mica da poco per chi, come Walter Mitty (Ben
Stiller), nella sua vita non ha visto che New York, la città in cui vive e lavora, e
poco altro. Una cosa mica da poco per chi, come il nostro protagonista, non ha
molto da aggiungere alla sezione “luoghi visitati” del proprio profilo su un
social network di incontri online. Vedere il mondo, però, è quello che Mitty fa
da sedici anni rinchiuso in uno scantinato a sviluppare i negativi che il
misterioso fotografo Sean O’Connell (Sean Penn) gli manda dagli angoli più
disparati del pianeta. Ed è quello che comincerà a fare quando scoprirà che il
Life Magazine, il giornale per cui lavora, sta per essere ridotto ad una versione
“.com” e il negativo della foto che dovrebbe comparire sulla copertina
dell’ultimo numero proprio non si trova.
“Cose pericolose da raggiungere”. La Groenlandia, ad esempio, dove Walter va
dopo aver collegato tra loro alcuni indizi lasciatigli da Sean nelle sue fotografie.
Oppure l’Islanda, che Mitty raggiunge in nave, dopo essersi gettato da un
elicottero guidato da un ubriaco appena scaricato dalla fidanzata conosciuto in
un pub. Ed è proprio in Islanda che il nostro si avvicina al grande fotografo, che
manca di un soffio nonostante la discesa in skateboard lungo la strada verso
l’aeroporto; è qui che sfugge ad una eruzione vulcanica. E ancora, le montagne
dell’Afganistan, dove per passare si è costretti a offrire ai guerriglieri la torta
fatta dalla mamma, o le vette dell’Himalaya.
“Avvicinarsi”, a Sean, a Cheryl (Kristen Wiig), la bella collega assunta da poco
con cui Walter tenta di approcciare mandandole “mi piace” al suo profilo,
all’operatore (Patton Oswalt) adibito all’assistenza del sito, a cui Walter telefona
quando si accorge che i suoi likes non arrivano a destinazione e con cui
continuerà a sentirsi in tutto il suo peregrinare, che provvederà ad aggiornare la
sua lista di “luoghi visitati” e “cose fatte”, facendo lievitare le visualizzazioni al
suo account. Avvicinarsi anche a se stessi, dopo che si aveva riposto il proprio
spirito di avventura in un cassetto insieme al diario di viaggio regalato dal
padre e ci si era rimboccati le maniche, dopo la sua morte, per trovare un lavoro
come cameriere in una catena di pizzerie e guadagnarsi da vivere.
“Trovarsi l’un l’altro”, altra cosa difficile per il nostro Walter, un sognatore ad
occhi aperti, che ha sempre vissuto nel suo mondo in cui lui è protagonista di
storie a mezzo tra il rocambolesco e l’eroico. Trovarsi l’un l’altro nello stesso
ufficio, ma non avere il coraggio di parlarsi, trovarsi in ascensore con il
responsabile della acquisto del giornale da parte del web e spegnerlo
(ovviamente sognando ad occhi aperti) con sagacia; trovarsi con Sean, che
nessuno della redazione aveva mai incontrato, a kilometri di distanza lontano
da tutto su una montagna in Asia; trovarsi con la propria sorella (Kathryn Han),
una’altra sognatrice che non ha mai smesso di credere di poter diventare la star
di qualche musical, e con la propria mamma (Shirley Mc Laine), che non ha
mai buttato via nessuna delle cose del figlio, nemmeno quel borsello regalatogli
da Sean e che potrebbe essere la chiave di tutta la questione. Trovarsi
all’aeroporto di Los Angeles, di ritorno dal giro di mezzo mondo, con quel
famoso operatore del sito di incontri, l’unico, in quella situazione, in grado di
poter tirar fuori il nostro Mitty dai guai.
“Sentirsi”, per davvero. Non tramite internet o quel Social Network che tanto
angustiava Walter quando non riusciva ad approcciare Cheryl, da cui si
eliminerà quando comincerà a vivere per davvero, nonostante i contatti sempre
più frequenti. Non al cellulare, un normalissimo apparecchio “a conchiglia” di
quelli che non si vedono più dal 2005. Sentirsi nelle fotografie ancora analogiche
di Sean, nella porosità della carta dell’ultimo numero del Life Magazine.
“E’ questo lo scopo della vita”, che Walter comincia a capire nel momento in cui
comincia a vivere per davvero, staccandosi dalla convinzione di essere un uomo
“qualunque”, perché un uomo qualunque non lo è mai stato (cosa che aveva
ben capito Sean, che rivelerà la gratitudine nei confronti di Mitty con un regalo
inaspettato) , allontanandosi dalla tecnologia inutile dietro la quale cercava di
nascondersi senza comunque esserne troppo convinto, come si vede bene
quando, prima di mandare il “like” a Cheryl, esita parecchio
“I sogni segreti di Walter Mitty” è un film brillante, divertente e profondo allo
stesso tempo, dove ciascuno può, a più livelli, rispecchiarsi nel protagonista, un
uomo comune ma non banale, che ha sempre avuto la potenzialità dentro sé ma
non aveva ancora trovato il coraggio o lo spunto giusto per svilupparla, proprio
come si fa con le fotografie.
2 gennaio 2014
BARBARA DI JACQUES PRÉVERT: UNA POESIA DI AMORE E GUERRA
di Dalila Forni
Letteratura
Ricordati Barbara
Pioveva senza sosta quel giorno su Brest
E tu camminavi sorridente
Serena rapita grondante
Sotto la pioggia
Ricordati Barbara
Come pioveva su Brest
E io ti ho incontrata a rue de Siam
Tu sorridevi
Ed anch'io sorridevo
Ricordati Barbara
Tu che io non conoscevo
Tu che non mi conoscevi
Ricordati
Ricordati quel giorno ad ogni costo
Non lo dimenticare
Un uomo s'era rifugiato sotto un portico
E ha gridato il tuo nome
Barbara
E sei corsa verso di lui sotto la pioggia
Grondante rapita rasserenata
E ti sei gettata tra le sue braccia
Ricordati questo Barbara
E non mi rimproverare di darti del tu
Io dico tu a tutti quelli che amo
Anche se una sola volta li ho veduti
Io dico tu a tutti quelli che si amano
Anche se non li conosco
Ricordati Barbara
Non dimenticare
Questa pioggia buona e felice
Sul tuo volto felice
Su questa città felice
Questa pioggia sul mare
Sull'arsenale
Sul battello d'Ouessant
Oh Barbara
Che coglionata la guerra
Che ne è di te ora
Sotto questa pioggia di ferro
Di fuoco d'acciaio di sangue
E l'uomo che ti stringeva tra le braccia
Amorosamente
È morto disperso o è ancora vivo
Oh Barbara
Piove senza sosta su Brest
Come pioveva allora
Ma non è più la stessa cosa e tutto è crollato
È una pioggia di lutti terribili e desolata
Non c'è nemmeno più la tempesta
Di ferro d'acciaio e di sangue
Soltanto di nuvole
Che crepano come cani
Come i cani che spariscono
Sul filo dell'acqua a Brest
E vanno ad imputridire lontano
Lontano molto lontano da Brest
Dove non vi è più nulla
(J. Prévert, Barbara)
Barbara è forse uno dei componimenti più famosi del poeta francese Jacques
Prévert (1900 – 1977). Nel 1946, nel dopoguerra, esce la raccolta di
poesie Paroles, dove Barbara è contenuta. Già dai primi versi il poeta delinea il
luogo in cui l’opera è ambientata: si tratta di Brest, una cittadina portuale
francese bombardata nel 1944. La poesia, scritta in prima persona, comincia con
un’esortazione rivolta a Barbara a ricordare qualcosa di ormai passato;
moltissimi versi infatti, fatta eccezione per l’ultima parte del componimento,
iniziano con la parola “ricordati”.
La donna, figura centrale della poesia, è descritta con pochi aggettivi che sono
però molto incisivi: “sorridente / serena rapita grondante” o, ripresi con un
chiasmo qualche verso dopo, “grondante rapita rasserenata”. Barbara, con la sua
bellezza e la sua allegria, sembra portare luminosità e spensieratezza nel
paesaggio, descritto dall’autore come un luogo colpito da una pioggia “senza
sosta”. Tuttavia, in contrapposizione alla ‘tradizione letteraria’, che vede la
pioggia come qualcosa di particolarmente triste, l’acquazzone simboleggia in
questo caso la felicità e l’amore che inonda la città: la pioggia è infatti descritta
con due semplici aggettivi colmi di positività, “buona e felice”.
Il poeta – che dai primi versi potrebbe sembrare un amico, forse addirittura
l’amante, della donna – è in realtà un passante che, pur non conoscendola,
osserva Barbara mentre felice corre incontro ad un uomo e lo abbraccia
amorevolmente. L’unico legame che chi scrive ha con la donna è quindi quello
dei loro sorrisi che si incrociano per le strade della città, niente di più. Il poeta è
un semplice osservatore che, guardando la ragazza, si invaghisce della sua
spensieratezza, tanto da arrivare a darle del tu. L’elemento del guardare,
dell’osservare senza però essere visti, è spesso presente nelle opere di Prévert:
un esempio è la poesia I ragazzi che si amano, dove il poeta descrive alcuni
giovani amanti, pur essendo soltanto un osservatore completamente esterno ai
fatti.
L’atmosfera piovosa ma serena delle prime strofe subisce un cambiamento
radicale al verso 37. La guerra irrompe brutalmente nel componimento e il
poeta, al posto che esortare Barbara a ricordare, si rivolge alla donna con un
“Oh Barbara”, come a volerla compatire con tristezza. La pioggia quindi non è
più felice ma “di ferro/ di fuoco d'acciaio di sangue” o “di lutti terribili e desolata”,
come se a piovere non fossero delle gocce d’acqua ma delle bombe, quelle che
hanno infatti colpito la cittadina francese durante la seconda guerra mondiale.
Anche il linguaggio subisce un brusco cambiamento nell’ultima parte della
poesia: mentre nelle prime strofe la lingua è semplice e familiare, così da
coinvolgere immediatamente il lettore, nelle ultime due diventa gergale e
volgare, con parole come “coglionata” o “crepano”. Si tratta di un linguaggio
antipoetico utilizzato per denunciare gli orrori della guerra che, oltre ad
uccidere esseri umani innocenti, distrugge gli amori felici, come quello di
Barbara e dell’uomo che la chiamava sotto ad un portico, che potrebbe essere
ora morto disperso.
Questi ultimi versi sono ricchi di nostalgia verso una felicità ormai passata; la
malinconia è ricreata dal poeta tramite l’uso di termini che rimandano alla
morte, alla violenza e alla distruzione. Anche quando la guerra e i
bombardamenti sono finiti, il paesaggio rimasto è terrificante: tutta la città è
ormai solo un ammasso di macerie e desolazione. Significativa è anche l’ultima
parola: “nulla”, come se fosse proprio il nulla, la morte, a vincere.
I versi della poesia sono inoltre caratterizzati da piccole ma significative
immagini, essendo poi privi di punteggiatura e interruzioni si ottiene una
grande fluidità che crea nel lettore un particolare effetto, come se stesse facendo
scorrere tra le proprie mani una serie di fotografie.
La lingua utilizzata da Prévert è semplice e diretta: la poesia è scorrevole e
immediatamente comprensibile, priva di aulicismi o espressioni complesse ed è
quindi particolarmente apprezzabile in lingua originale anche per chi non
conosce il francese in modo approfondito. Nonostante questa semplicità, i versi
non sfiorano mai la banalità, ma sono sempre nitidi e significativi. Gli aggettivi
sono pochi ma ben calibrati e molto rilevanti: servono a delineare prima di tutto
la bella Barbara, poi la città piovosa ma felice e, infine, la distruzione che
colpisce Brest e i suoi abitanti.
Sono poi presenti numerose ripetizioni che creano come una sorta di ritornello,
dando così alla poesia una musicalità in grado di incantare il lettore: il testo è
infatti stato spesso ripreso e messo in musica da numerosi artisti.
14 febbraio 2014
NON HANNO ABOLITO STORIA DELL'ARTE NELLE SCUOLE!
di Michele Castelnovo
Attualità
No. Non hanno abolito definitivamente la Storia dell'Arte dalle scuole
secondarie.
Ma come?! Su Internet ho letto di sì!
Oggi la mia home di Facebook si è riempita di post indignati. Veniva condiviso
un articolo con la più classica delle didascalie: "VERGOGNA! TUTTI A CASA!
CHE SCHIFO!".
L'articolo in questione è intitolato: "L'Italia cancella l'arte dalle scuole, è definitivo".
Insospettito dalla notizia, ho fatto un po' di ricerche su Google e ho trovato un
unico altro articolo su questa tema, dal titolo "Abolita la Storia dell'Arte in Italia".
N.B. entrambi gli articoli hanno l'odierna data di pubblicazione, il 05 febbraio 2014.
Ambedue gli articoli sostengono che alcuni giorni fa la Commissione Cultura,
Scienze e Istruzione della Camera dei Deputati abbia detto di no al reintegro
dell'insegnamento della Storia dell'Arte nelle scuole superiori. Non essendo
riportata alcuna fonte - sempre più insospettito - ho deciso di fare un po' di
verifiche.
Oggi la Commissione VII della Camera si è sì riunita, ma non per discutere di
questo. Ho cercato se per caso se ne fosse discusso ieri o nei giorni scorsi:
niente. Ho cercato allora di fare un po' di mente locale e di ricordare quando era
scoppiato il caso. Mi sono così ricordato che tutto era iniziato lo scorso autunno.
Infatti il Disegno di Legge in materia di istruzione era stato presentato il 12
settembre 2013. In seguito era nata una petizione online, dal suggestivo titolo
"Ripristiniamo la Storia dell'Arte nelle scuole" o qualcosa di comunque affine. In
Commissione il 31 ottobre era stato presentato un emendamento all'articolo
5dall'On. Costantino, deputata di Sel, che recita:
tra le discipline scolastiche le cui ore di insegnamento sono state eliminate o
ridotte negli ultimi anni in diversi indirizzi delle scuole secondarie superiori, una è
particolarmente grave per un Paese come l'Italia: ci si riferisce alla storia dell'arte.
I maltrattamenti alla Storia dell'Arte infatti non sono opera dell'attuale
legislatura, ma della precedente (la Berlusconi-Monti). In particolare ci si
riferisce alla Riforma Gelmini del 2008 (Decreto Legge 133 e 169/2008), la quale
prevedeva il riordino delle scuole superiori.
Come si evince dall'Allegato B, la Storia dell'Arte non è stata abolita. È vero -
come riportato in uno degli articoli citati - che sono stati aboliti gli istituti d'arte,
che nei nuovi licei artistici ne sono state ridotte le ore, che è stata eliminata dai
bienni dei licei classici e linguistici e dagli indirizzi di Turismo e Grafica degli
Istituti tecnici professionali. Ma dire che la Storia dell'Arte sia stata abolita,
usando titoli e toni apocalittici, non solo è falso, ma è anche moralmente
scorretto.
In ogni caso l'emendamento della Costantino è stato bocciato, nonostante
il parere favorevole (pag. 72) dell'attuale Ministro dell'Istruzione, Maria Chiara
Carrozza (che in tutto ciò non ha nulla a che vedere!).
Comunque sia l'emendamento è stato bocciato il 31 ottobre 2013, cioè circa 3
mesi fa.
Con questo DDL non è stata abolita la Storia dell'Arte. È stato solo bocciato un
emendamento che chiedeva di tornare alla situazione ante Gelmini.
Sono rimasto colpito da un po' di cose.
Primo. Perché la protesta è infuriata questo autunno ed oggi, a 6 anni dalla
riforma Gelmini? È vero che all'epoca le proteste furono molte ed anche accese,
ma prima di ottobre 2013 io non ho mai sentito parlare di abolizione della Storia
dell'Arte nelle scuole superiori. A maggior ragione non vedo che senso abbia
farlo oggi.
Secondo. Perché questi articoli sono stati pubblicati oggi? Le risposte che mi
sono dato sono state due: o per far riscoppiare il caso, avere tante
visualizzazioni e quindi tanti introiti pubblicitari, o per disinformazione.
Terzo. Perché tutto questo catastrofismo, questo millenarismo? La Storia
dell'Arte non è stata cancellata da tutte le scuole superiori ma solo in alcune ed
in alcune altre è solo stata ridotta.
La mia personale opinione è che la Storia dell'Arte - in Italia, che ne è la madre sia da studiare in ogni scuola di ogni ordine e grado. Non sto quindi né
difendendo la Riforma Gelmini (per carità!) né sputando sul patrimonio patrio.
Sono sinceramente rimasto stupito dai toni usati negli articoli (e nei commenti
ad essi):
Cosa sarà della nostra cultura fra 5/6 anni? Chi si ricorderà i nomi delle opere, degli
autori, dei quadri e delle sculture, dei monumenti e delle statue. Che generazioni stiamo
crescendo?
O, ancora:
Mai più, tra i banchi di scuola, risuoneranno i nomi di Giotto, Leonardo, Michelangelo,
Caravaggio, Van Gogh e Picasso. Se sapete chi sono ritenetevi fortunati, i vostri nipoti
non potranno dire altrettanto.
Ok, la strada imboccata non è delle migliori. È profondamente sbagliato che
non si studi Arte nei bienni del Liceo Linguistico o - soprattutto - del Classico,
che si elimino gli istituti d'arte ecc., ma da qui a paventare una catastrofe
culturale mi sembra che il passo non sia poi così breve. Si è sempre in tempo ad
invertire la rotta.
La fine non è vicina.
L'unica cosa ovvia è che però non si deve proseguire su questa strada: bisogna
avere il coraggio di imprimere una svolta e tornare ad investire in cultura e
scuola - un binomio che dovrebbe essere inscindibile.
Però fino allora - per favore! - evitate i toni che nemmeno Gioacchino da
Fiore usava! Avrete qualche visualizzazione e qualche soldo in più sul vostro
blog, ma non è così che si fa informazione, specialmente se si scrive sul web,
dove nessuno controlla la veridicità di quanto affermato né si prende la briga esclusi rari casi - di riportare le fonti.
5 febbraio 2014