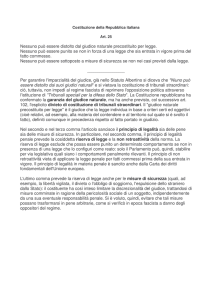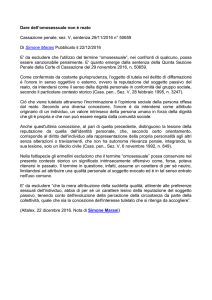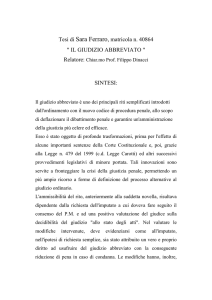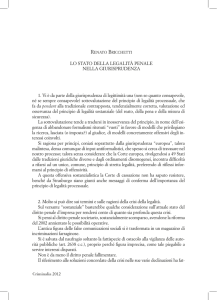NUMERO 1 GENNAIO-LUGLIO 2011
CAMERA PENALE VENEZIANA
“ANTONIO POGNICI”
BOLLETTINO
Presidenza
Fabiana DANESIN
Segreteria
Marco VIANELLO
Redazione
Fabiana DANESIN
Federica BASSETTO – Federico CAPPELLETTI –
Paola LOPRIENO – Marco VIANELLO
Comitato Scientifico
Damiano BEDA – Lorenza GAMBARO – Gianluca LIUT –
Alvise MUFFATO – Paolo RIZZO
Coordinatore
Luigi RAVAGNAN
PER IL SITO INTERNET
www.camerapenaleveneziana.it
SEZIONE PRIMA - DIRITTO PENALE
1
Tribunale Ordinario di Venezia – Ufficio del Giudice Monocratico di Dolo – Sent. 21.2.2011 (Dep.
il 29.4.2011) – Dott.ssa Nicoletta Stefanutti – Imp. XY + 3
Traffico illecito di rifiuti – Abuso d’ufficio – “Medesimo fatto” contestato – Mancata
applicazione del principio del “ne bis in idem” – Ragioni.
(Artt. 53 bis del D.Lvo 22/1997 e 323 c.p. in relazione all’art. 649 c.p.p.)
L’accezione di “medesimo fatto” utilizzata dal nostro legislatore allorquando sancisce uno dei
principi cardine del nostro ordinamento giuridico – il principio del “ne bis in idem” – deve essere
intesa non solo nella sua dimensione naturalistica ma anche nella sua dimensione giuridica. La
ratio della norma è invero quella di impedire che un soggetto venga più volte giudicato per uno
stesso fatto ritenuto in violazione di una medesima disposizione normativa e garantire in tal modo
al cittadino la certezza della definitività del giudizio. Diverso è tuttavia evidentemente il caso in cui
quello stesso fatto integri violazione di più disposizioni normative, in riferimento a ciascuna delle
quali il Giudice dovrà fondare le proprie determinazioni, ferma restando la necessità di una
successiva valutazione in termini di concorso di reati.
Traffico illecito di rifiuti – Fatti commessi prima dell’introduzione della normativa – Mancata
assoluzione predibattimentale dell’imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato – Ragioni.
(Artt. 53 bis del D.Lvo 22/1997)
Allorquando una normativa introdotta successivamente alla commissione di un fatto non vada a
colmare un vuoto normativo ma sia soltanto atta a costruire un’ipotesi autonoma di reato con
previsione di pena più severa di quanto già precedentemente previsto dall’Ordinamento, il Giudice
non potrà assolvere l’imputato in fase predibattimentale dovendo egli necessariamente valutare,
nel merito, se quello stesso fatto, così come si è configurato, sia sussumibile o meno in una delle
fattispecie astratte previste dalla normativa in vigore al momento della commissione dello stesso.
In tal caso egli dovrà applicare quest’ultima previsione normativa ed irrogare la pena prevista, non
potendo – in ragione del principio del “favor rei” - applicare la pena più severa prevista dalla
normativa entrata in vigore in un momento successivo alla commissione del fatto.
Questione di illegittimità costituzionale – Sentenza di accoglimento della Corte Costituzionale
– Abrogazione di una norma penale di favore – Fatti commessi prima della norma di favore
abrogata – Inapplicabilità della norma di favore – Ragioni.
La Sentenza di accoglimento pronunciata dalla Corte Costituzionale a seguito di presentazione di
una questione incidentale, mediante la quale venga abrogata una norma penale di favore entrata in
vigore dopo la commissione del fatto, esplica i suoi effetti nel giudizio principale. In siffatti casi il
Giudice investito della causa principale dovrà applicare la norma in vigore al momento in cui è
stato commesso il fatto per cui si precede, non potendosi invocare il principio del “favor rei” in
ragione del fatto che nessun pregiudizio sarebbe ravvisabile in capo a colui che, consapevolmente,
si era liberamente autodeterminato sulla base del pregresso, a lui meno favorevole, panorama
normativo.
NOTA
La Sentenza che fornisce lo spunto per il commento che ci si appresta a sviluppare è certamente
articolata e complessa, oltreché ricca di interessanti spunti di riflessione individuabili nel contenuto
delle massime che precedono. L’argomentazione che tuttavia ha occupato maggiormente il
Giudicante nella stesura della Sentenza in commento, per la rilevanza della questione ai fini della
decisione, è senza dubbio quella relativa agli effetti esplicati dalla Sentenza della Corte
Costituzionale – investita nel corso del procedimento penale di una questione di costituzionalità nel giudizio principale. Al fine di poter compiutamente comprendere i termini della problematica in
esame, appare indispensabile una seppur breve premessa al fine di delineare i termini della
questione sottoposta all’attenzione del Giudice di Prime Cure. Secondo l’ipotesi accusatoria gli
imputati avrebbero infatti effettuato - in concorso tra loro, attraverso l’allestimento di mezzi ed
attività continuativa organizzata - un traffico illecito di rifiuti tossico nocivi, nella fattispecie
costituiti da un ingente quantitativo di ceneri di pirite, destinandoli ad un’attività non consentita,
consistita nel miscelamento con altre ceneri di pirite, anziché destinarli in discarica. Sebbene la
contestazione del fatto fosse estremamente chiara, il problema si poneva in termini di normativa
applicabile, in ragione del fatto che la materia in questione è stata, nel corso degli ultimi anni,
oggetto di repentine e profonde modifiche legislative, sia a livello nazionale che comunitario. Ben
lungi dal voler tediare il lettore ripercorrendo l’intero excursus normativo e giurisprudenziale,
nazionale e comunitario, sviluppatosi sul punto, mi limiterò a focalizzare l’attenzione sugli
interventi maggiormente rilevanti per il caso sottoposto all’attenzione del Giudicante. Avuto infatti
riguardo al tempus commissi delicti contestato, la prima norma di riferimento nella successione
normativa è l’art. 6 comma 1 lett. a) del D.Lvo 22/1997, in base al quale le ceneri di pirite
rientravano a pieno titolo nel concetto di rifiuto. Nelle more del procedimento penale era tuttavia
entrato in vigore il D.Lvo 152/2006 il quale, all’art. 183 lett. n) quarto periodo, aveva
esplicitamente statuito che le ceneri di pirite rientravano tra i sottoprodotti non soggetti alle
disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo (“Norme in materia di gestione dei rifiuti
e di bonifica dei siti inquinati”). Tale norma evidentemente si poneva come norma di favore in
relazione al fatto sottoposto al vaglio del Giudicante il quale, applicando tale normativa, avrebbe
dovuto prosciogliere gli imputati dai reati loro ascritti “perché il fatto non sussiste”, essendo venuto
meno per le ceneri di pirite il requisito dell’ “essere rifiuto”. Sennonchè, successivamente, con D.
Lvo 4/2008 veniva modificato il contenuto della lettera p) del D.Lvo 152/2006, fornendo una
definizione di sottoprodotto più in linea con la disciplina comunitaria, definizione che non
consentiva assolutamente di collocare le ceneri di pirite nella nozione di sottoprodotto. A questo
punto ben si comprendono le ragioni sulla base delle quali veniva sollevata una questione di
illegittimità costituzionale dell’art. 183 comma 1 lett. n), quarto periodo, del D.Lvo 152/2006, in
quanto ritenuto in contrasto con gli art. 11 e 117 della Costituzione. La Corte Costituzionale,
investita della questione, ha ritenuto di doverla accogliere ed ha conseguentemente dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 183 comma 1 lett. n), quarto periodo, del D.Lvo 152/2006
“nella parte in cui prevedeva che le ceneri di pirite rientrassero tra i sottoprodotti e quindi non
fossero soggette alle disposizioni di cui alla parte quarta del Testo Unico ambientale”. Tale essendo
il giudizio espresso dalla Corte Costituzionale e derivandone di conseguenza l’abrogazione della
norma di favore di cui all’art. 183 comma 1 lett. n), quarto periodo, del D.Lvo 152/2006, si poneva
il problema di valutare se ed in che termini tali pronuncia incidesse nel giudizio principale pendente
innanzi il Giudice di Primo Grado. In sostanza si trattava di stabilire se, in siffatto caso, a
prescindere da ogni valutazione, fosse comunque applicabile la norma penale di favore, nel rispetto
del principio del “favor rei” di cui all’art. 2, comma 4, c.p., e del principio di irretroattività della
legge penale sfavorevole, sancito dall’art. 25 della nostra Costituzione, o se invece tale norma non
fosse applicabile in ragione del fatto che si trattava di norma penale che, sebbene di favore, era
entrata in vigore in un momento successivo alla commissione del fatto-reato per il quale vi era
processo e che era stata abrogata. Tale questione è stata oggetto di attente valutazioni e dettagliate
argomentazioni da parte del Giudice di Primo Grado il quale, dopo aver preso in esame una serie di
pronunce giurisprudenziali, che vengono peraltro minuziosamente richiamate nel corso della stesura
della motivazione, ha ritenuto di dover sostenere che la norma penale di favore oggetto di
discussione, essendo entrata in vigore in un momento successivo al tempus commissi delicti
accertato, ed essendo stata abrogata dalla Corte Costituzionale, non fosse applicabile al caso in
esame. Osservava inoltre che, poiché al momento in cui vennero commessi i fatti era “pacifico che
si applicassero le sanzioni penali previste dal legislatore italiano per l’inosservanza delle norme
introdotte in ossequio alle direttive comunitarie sui rifiuti”, il problema, al più, non si poneva certo
in termini di violazione dell’art. 25 della Costituzione bensì, semmai, verteva sulla corretta
individuazione del campo di applicazione dell’art. 2 comma 4 c.p., con particolare riferimento al
caso di specie. Il Giudicante inoltre, concordando pienamente con quanto già in precedenza
sostenuto dalla Consulta, osservava che era necessario diversificare la situazione di colui che pone
in essere un fatto in relazione al quale venga in un momento successivo emanata una norma penale
di sfavore, dalla situazione di colui che ponga in essere un fatto nella vigenza di una norma penale
sfavorevole e che voglia poi beneficiare di una norma penale di favore entrata in vigore in un
momento successivo e poi abrogata. Invero, mentre per il primo di questi due soggetti si pone un
problema di tutela del cittadino, il quale deve essere posto nelle condizioni di conoscere, nel
momento in cui commette un fatto, le conseguenze delle proprie azioni, per il secondo soggetto tale
problema non si pone, essendo egli stato a perfetta conoscenza della risposta punitiva
dell’Ordinamento ai fatti di cui si rendeva responsabile. Ebbene, è proprio sulla scorta di tali
motivazioni che si ritiene che solo a tutela del primo di tali individui sia invocabile il principio di
irretroattività della legge penale sfavorevole, sancito dall’art. 25 della nostra Costituzione, come
“garanzia del cittadino contro gli arbitri del legislatore”. Profondamente diversa è la ratio sottesa
al principio del “favor rei” di cui all’art. 2 c.p., in quanto in tal caso non si pone un problema di
tutela del cittadino che deve essere posto nelle condizioni di conoscere le risposte punitive
dell’Ordinamento e le conseguenze delle proprie azioni, bensì un problema di adeguamento del
Sistema, e conseguentemente delle sanzioni da irrogarsi, al mutamento delle valutazioni del
legislatore in ordine al disvalore del fatto, nel rispetto del fondamentale principio di uguaglianza
sancito all’art. 3 della nostra Costituzione, principio cardine ed imprescindibile. Ed è proprio su
questo punto che si fondano le ulteriori considerazioni a cui si rimandava il Giudicante il quale, ad
ulteriore sostegno delle proprie determinazioni, osservava che, per le ragioni suesposte, mentre il
principio della irretroattività della norma penale sfavorevole è principio assolutamente inderogabile,
il principio di retroattività della norma penale di favore “è destinato a trovare applicazione, in
quanto la norma sopravvenuta sia, di per sé, costituzionalmente legittima”. [Lorenza Gambaro]
2
Corte d’Assise di Appello di Venezia - Sent. n. 18/2010 del 24.9.2010 - Pres. Est. Risi - Imp. XY
Omicidio volontario –
Compatibilità.
(artt. 575 e 577 C.P.)
Circostanze aggravanti – Premeditazione – Dolo condizionato –
La premeditazione è costituita da due elementi, uno di carattere cronologico e l’altro di carattere
ideologico, e rappresenta il massimo grado d’intensità del dolo. Essa può desumersi da tutta una
serie di elementi indiretti ed esteriori riferiti alla condotta posta in essere, antecedenti alla
esecuzione del delitto (come per esempio l’anticipata manifestazione del proposito, il movente, la
preordinazione dei mezzi di esecuzione e di occultamento delle prove). Detta aggravante è
assolutamente compatibile con il dolo condizionato (c.d. premeditazione condizionata) e tale
situazione si verifica in tutti quei casi in cui l’agente ha già deliberato in termini di certezza la
propria scelta di commettere il reato. Tuttavia, egli ha condizionato il suo concreto verificarsi alla
realizzazione di un determinato evento, conseguente ad un certo atteggiamento assunto dalla
persona offesa, di talché all’avverarsi della condizione il processo esecutivo ne consegue su un
piano quasi automatico, poiché sciolta la riserva sull’an, il quid, il quando e il quomodo sono già
stati interamente deliberati e programmati attendendo solo di essere eseguiti.
Corte d’Assise di Appello di Venezia - Sent. n. 1/2011 del 28.1.2011 - Pres. Est. Risi - Imp. XY
Omicidio volontario – Circostanze aggravanti – Premeditazione – Concorso di persone nel
reato – Estensione dell’aggravante ai correi – Ragioni (artt. 110, 575 e 577 C.P.)
Non può escludersi l’aggravante della premeditazione in caso di concorso di persone nel reato,
quando emerge chiaramente la consapevolezza del correo di partecipare con la propria condotta,
anche solo passiva, alla realizzazione del disegno criminoso e la volontà di aderire in toto al
progetto delittuoso precedentemente ideato, anche solo da uno dei correi (fattispecie in cui la Corte
d’Assise d’Appello di Venezia ravvisava la sussistenza dell’aggravante della premeditazione in
capo alla convivente dell’omicida per avere questa perfezionato dei contratti assicurativi sulla vita
di alcuni dipendenti ed ex soci del convivente, contratti finalizzati ad incassare il relativo premio
dopo la morte dell’assicurato e di cui risultava beneficiaria, nonché per aver condiviso le modalità
di esecuzione degli omicidi programmati).
Corte d’Assise di Appello di Venezia - Sent. n. 4/2011 del 25.3.2011 - Pres. Est. Risi - Imp. XY
Concorso in omicidio volontario – Sentenza irrevocabile che esclude l’aggravante della
premeditazione nei confronti di alcuni correi – Influenza sull’altro giudizio – Sussistenza –
Ragioni.
(artt.110, 575, 577 C.P. e art. 648 C.P.P.)
Una sentenza divenuta irrevocabile non dispiega nessuna efficacia vincolante nel medesimo o in un
diverso giudizio storico fattuale e va liberamente apprezzata dal Giudice, unitamente agli altri
elementi di prova, senza che operi alcuna preclusione al nuovo giudizio e, questo, neppure sotto il
profilo logico, con specifico riferimento all’aggravante della premeditazione. Infatti, nel concorso
di persone nel reato, tale circostanza deve essere estesa al coimputato che non abbia direttamente
premeditato il reato, qualora questi abbia acquisito, prima dell’esaurirsi del proprio apporto
volontario alla realizzazione dell’evento criminoso, l’effettiva conoscenza dell’altrui
premeditazione (fattispecie in cui la Corte d’Assise d’Appello di Venezia aveva ritenuto di
confermare la sentenza di primo grado in merito alla sussistenza in capo all’imputato
dell’aggravante della premeditazione, laddove, la stessa era stata esclusa nei confronti dei correi
giudicati separatamente).
NOTA
Le tre sentenze sopra riportate affrontano il tema comune della circostanza della premeditazione di
cui all’art. 577, comma 1, n. 3 C.P.
Detta aggravante si caratterizza per essere una circostanza attinente all’intensità del dolo ed, in
particolare, per rappresentare il massimo grado di questa intensità, assumendo una sua precisa
autonomia normativa solo con riferimento al delitto di omicidio o di lesioni.
Gli elementi costitutivi della circostanza in esame si sostanziano:
1) nell’esistenza di un apprezzabile intervallo di tempo tra l’insorgenza del proposito criminoso
e l’attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunità del
recesso (elemento di natura cronologica);
2) nella perduranza, senza soluzioni di continuità, di una ferma risoluzione criminosa
nell’animo dell’agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica).
La sussistenza della premeditazione – come del resto di tutti i fenomeni di tipo psicologico – può
essere ricavata ex post solo dalla presenza di una pluralità di elementi sintomatici idonei a
consentire la ricostruzione del processo volitivo che ha sostenuto il soggetto agente e che possono
essere ravvisati a titolo esemplificativo: nel movente del fatto, nella preordinazione accurata dei
mezzi per porlo in essere, nella ricerca dell’occasione più favorevole per realizzarlo e nelle modalità
di esecuzione del delitto, tutti elementi da cui è possibile desumere che l’evento posto in essere non
è meramente occasionale, ma, piuttosto, meditato.
In particolare, per quanto attiene al movente, inteso quale momento iniziale del processo volitivo
che induce e spinge l’agente a realizzare il suo proposito criminoso, esso rileva quale elemento
concretamente valutabile ai fini della ricostruzione del processo psicologico così come la
preordinazione, da intendersi come predisposizione dei mezzi e degli strumenti necessari
all’esecuzione del reato che, sebbene di per sé non idonea ad integrare l’aggravante della
premeditazione, risulta, tuttavia, in grado di evidenziare l’esistenza di un considerevole lasso
temporale fra la decisione e la sua attuazione.
Quanto alle modalità di esecuzione del fatto criminoso, si osserva che esse assumono rilievo non
solo sotto il profilo psicologico ma, a seconda della fattispecie concreta in cui si realizzano, anche
sotto il profilo del requisito cronologico-temporale.
Come emerge dalla sentenza n. 1 sopra richiamata la circostanza che qui occupa può essere estesa al
concorrente nel reato purché sia provata l’effettiva conoscenza del progetto criminoso da parte di
costui e la sua volontà adesiva a tale intento, tanto da portarlo a far propria la particolare intensità
del dolo altrui (cfr. Cass. Pen. n. 4977/2009).
Si deve altresì ritenere la piena compatibilità del dolo condizionato con l’aggravante della
premeditazione la quale ricorre, dunque, anche quando l’attuazione del proposito criminoso è
condizionata al verificarsi, o non, di un determinato evento. Si parla, in tal caso, di premeditazione
condizionata che si ha, appunto, quando, accertata l’esistenza dei due necessari elementi
cronologico e ideologico, quest’ultimo si concreti in una risoluzione criminosa precisa e ferma in
tutte le sue componenti psicologiche e in cui la condizione si pone come un avvenimento previsto, e
nella maggior parte dei casi conseguente ad un certo atteggiamento assunto dalla persona offesa,
atto a sospendere o ad annullare la decisione già presa.
Da ultimo, pare opportuno precisare che l’esistenza di una sentenza irrevocabile che statuisce
l’esclusione della sussistenza della premeditazione, già contestata in altro processo ai correi, non
osta, nel caso di giudizio relativo ad un coimputato giudicato separatamente, alla positiva
configurabilità in capo a quest’ultimo dell’aggravante stessa.
E ciò per due motivi:
innanzitutto, perché il principio contenuto all’art. 238 bis c.p.p. soggiacendo alla regola di giudizio
prevista dall'art. 192 comma 3 c.p.p., conduce il Giudice del nuovo giudizio ad operarne una
valutazione libera ed autonoma unitamente agli altri elementi di prova;
in secondo luogo trattandosi di una circostanza soggettivamente valutabile ben può essere
riconoscibile in capo ad uno solo dei coimputati se se ne ravvisino nella sua condotta delittuosa gli
elementi caratterizzanti, quali, quello cronologico ed ideologico lì dove sono escludibili con
riferimento ai correi. [Dott.ssa Giuseppina Maritato - Dott.ssa Melania Benetti; Praticanti Avvocato
presso la Corte d’Appello di Venezia]
3
Tribunale Ordinario di Venezia - Ufficio del Giudice Monocratico Penale - Sent. 10.2.2011- Est.
Calabria - Imp. XX
In senso conforme: Tribunale Ordinario di Padova - Ufficio del Giudice Monocratico - Sent.
15.11.2010 - Est. Garbo- Imp. YY
Misure di sicurezza- reato ex art.2 L.1423/56- illegittimità del provvedimento del Questoreassoluzione
Il provvedimento di cui all'art.2 L.1423/56 è un atto complesso che deve contenere tanto
l'ingiunzione a fare rientro nei luoghi di residenza, quanto l'inibizione al ritorno in difetto di
autorizzazione: trattasi di prescrizioni la prima delle quali costituisce il prius, logico e giuridico,
della seconda.
NOTA
La sentenza in commento è degna di nota tanto per il principio di diritto che vi si pronuncia, quanto
per l'attualità che la stessa riveste rispetto all'elevato numero di procedimenti per questo tipo di
reato.
L'imputato XX doveva rispondere ex art. 2 L.1423/56 per non aver rispettato l'ordine del Questore
che gli faceva divieto di rientrare nel Comune di Venezia per un determinato periodo. Il
provvedimento amministrativo, prius logico e giuridico della contestazione del reato ex art.2
L.1423/56, consisteva tuttavia nella sola prescrizione del divieto di far rientro nel territorio
comunale, nulla prescrivendo sull'ingiunzione di rimpatrio. Il Tribunale di Venezia ha dichiarato
illegittimo l'ordine del Questore che non contenga la duplice prescrizione: l'ordine di rimpatrio,
ovvero l'ingiunzione al soggetto di fare rientro nel luogo di residenza, ed il divieto di far ritorno nel
territorio del comune da cui è stato allontanato. Osserva testualmente il giudicante, richiamando sul
punto le pronunce della Corte d'Appello di Venezia ( Corte App. Ve n.281 del 19/2/2004- n. 968 del
23/5/2007) “Trattasi di prescrizioni la prima delle quali costituisce il prius, logico e giuridico,
della seconda e la conferma della essenzialità della quale si trae dalla considerazione che è la
stessa legge ( art.163 TULPS) a disciplinare le modalità esecutive del rientro”. La mancata duplice
prescrizione del provvedimento del Questore ha determinato la pronuncia di assoluzione
dell'imputato in ragione del fatto che l'art.2 L. 1423/56 assume – anche per orientamento
consolidato della giurisprudenza ( Cass. 5/2/98 n.1366)- a schema tipico del reato una condotta
omissiva plurima ripartita in due elementi che, seppur non aventi una autonomia propria,
dimostrano tuttavia una interdipendenza: il mancato allontanamento del soggetto dal luogo in cui è
stato bandito, ed il mancato adempimento dell'obbligo di rimpatrio. Il primo elemento ha natura di
reato permanente, considerato che lo stato di antigiuridicità perdura sin tanto che l'autore si trattiene
nel luogo in cui gli è fatto divieto di trovarsi; il secondo è reato omissivo istantaneo, che si cosuma
con la scadenza del termine entro il quale il soggetto avrebbe dovuto raggiungere il luogo di
destinazione.
L'omessa prescrizione del Questore dell'ordine di rimpatrio del destinatario del provvedimento,
comporto la illegittimità- se non anche nullità- dello stesso. Sul punto dispone testualmente il
Tribunale di Padova- Ufficio del Giudice Monocratico- Sentenza 15/11/2010- Est. Garbo- Imp.YY
“ ...l'ordine di rimpatrio non può che far parte del contenuto essenziale dell'atto, costituendone
requisito di legittimità la cui mancanza in die nell'atto comporta il vizio di violazione di legge in
quanto carente di uno dei contenuti essenziali prescritti dalla norma (art.2 L.1423/56)”.
In ordine, poi, alla natura della patologia del provvedimento amministrativo, il medesimo Tribunale
osserva “ ...alla luce della nuova disciplina della patologia del provvedimento amministrativo, il
provvedimento debba più correttamente ritenersi affetto da nullità per carenza di un elemento
essenziale ex art.21 septies L.241/1990”. [Damiano Beda]
4
Tribunale Ordinario di Venezia - Ufficio del Giudice Monocratico Penale – Sent. 1424/10 - Est.
Moretti - Imp. XY.
Falsità materiale commessa dal privato – Truffa - Lasciapassare oneroso per accesso a ZTL
(Zone Traffico Limitato) – Alterazione, artifizi e raggiri - Sussistenza.
(Artt. 477, 482 – 640 c.p.)
Va affermata la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati ascritti – l’indagine tecnica
condotta sul documento (lasciapassare Z.T.L.) viene ad accertare senza possibilità di residui dubbi
l’avvenuta alterazione.
Trattasi di tentativo di ingannare gli operatori addetti alla verifica dell’autorizzazione –
lasciapassare.
NOTA
Il caso in esame si pone alla attenzione nell’ambito del tema, sempre più frequente, relativo alle
truffe riguardanti le autorizzazioni / lasciapassare per l’accesso alle zone cittadine sottoposte a
traffico limitato.
L’imputato veniva sorpreso alla guida di bus turistico mentre si trovava in area delimitata dalla
Autorità comunale e qualificata come Z.T.L.
Gli accertamenti posti in essere nella immediatezza dagli operatori del personale addetto al
controllo facevano emergere la presenza di autorizzazione comunale al transito verosimilmente
falsa trattandosi di documento non più in uso da tempo ed altresì essendo lo stesso modificato
artificiosamente in alcune sue parti.
La sentenza in oggetto muove da questi presupposti e risulta di particolare interesse in quanto si
ritiene che nella condotta dell’imputato vadano ravvisati gli estremi dei reati in contestazione e
siano pertanto integrati i reati di truffa (sia pure a titolo di tentativo) e di falsità materiale.
L’argomento Zone a Traffico Limitato è oggi sempre più di maggiore attualità nei centri urbani
cittadini, non sono insolite violazioni delle aree d’accesso anche se spesso punite solo dal punto di
vista della sanzione amministrativa. La sentenza in oggetto analizza la questione dal punto di vista
penalisitico ed offre pertanto uno spunto sul tema.
Nel caso di specie la sussistenza del reato di falsità materiale è fondata sulla alterazione del
documento in oggetto, una analisi tecnica comprovava che il medesimo era stato modificato
attraverso la alterazione di alcuni caratteri numerici indicanti i giorni di validità dello stesso, questo
all’evidente fine di consentire il transito del bus anche in giorni diversi ed ulteriori rispetto a quelli
originariamente autorizzati.
Da ciò il Giudice ritiene esservi tentativo di porre in inganno gli operatori addetti alle verifiche al
fine di procurarsi l’ingiusto profitto ed il conseguente danno in capo alla società assegnataria della
riscossione oltre che del Comune di Venezia soggetto istituzionalmente legittimato al regolare
svolgimento del servizio ZTL.
Vanno quindi a configurarsi nel caso di specie entrambi i reati in contestazione essendo il delitto di
falso documentale ex art. 477-482 c.p. ontologicamente distinto dalla connessa truffa e
caratterizzato da diverso bene giuridico offeso. Vanno altresì riconosciuti i danni in capo alle parti
civili costituite. [Alvise Muffato]
5
Tribunale Ordinario di Como – Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari – Sent. n. 987 del
21.12.2010 – Est. Bianchi - Imp. XY
Decreto Legislativo n. 59 del 18/2/2005 – Smaltimento e recupero dei rifiuti speciali – Mancata
ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla Regione con l’Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA) – Buona fede del gestore – Mancanza dell’elemento soggettivo - Assoluzione
perché il fatto non costituisce reato
Va mandato assolto perché il fatto non costituisce reato l’imputato del reato previsto dall’art. 16
comma 2 del Decreto Legislativo 18/2/2005 n. 59 accusato di non aver ottemperato alle
prescrizioni contenute nell’AIA qualora risulti che lo stesso abbia agito in buona fede.
NOTA
L’imputato, nella sua qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione della società, era
accusato di non aver ottemperato a talune prescrizioni previste dall’Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA), ovvero il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto a determinate
condizioni di conformità ai requisiti del decreto legislativo n. 59/2005 relativo alla prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC). Peraltro con l'entrata in vigore del D.Lgs 128/2010,
correttivo del Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/06), il D.Lgs 59/2005, il riferimento normativo
principale per il tema IPPC, è stato abrogato ed è divenuto parte integrante del TUA, fonte
normativa meramente compilativa.
Nel caso che ci occupa veniva in rilievo l’art. 16 del decreto legislativo n. 59/2005 il quale
prevedeva, al secondo comma, l’applicazione dell’ammenda da 5.000 a 26.000 euro nei confronti di
colui che pur essendo in possesso dell’AIA non osserva le prescrizioni della stessa o quelle imposte
dall’autorità competente, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Nella fattispecie erano tre
le contestazioni mosse alla società. Si assumeva che l’imputato non avesse versato la fideiussione in
favore della Regione Lombardia nei termini previsti dall’AIA, che non avesse contraddistinto i
rifiuti giacenti presso l’area di stoccaggio con appositi cartelli indicanti la natura e la pericolosità
degli stessi e, infine, che avesse annotato sul registro di carico e scarico con il codice D15 (deposito
preliminare) anziché utilizzare il codice D13 (raggruppamento preliminare), così come previsto
dall’autorizzazione, i rifiuti in entrata presso l’impianto.
Con riferimento alla prima contestazione il G.I.P. rilevava che la società aveva versato la
fideiussione alla provincia di Como ma che il ritardo nell’effettuare la voltura di essa a favore della
regione Lombardia dipendesse da ragioni imputabili all’amministrazione anziché all’imputato. Lo
stesso ente pubblico aveva infatti successivamente riconosciuto che la società operava
regolarmente.
Per quanto riguarda il mancato contrassegno dei rifiuti giacenti presso le aree di stoccaggio con
appositi cartelli recanti indicazioni relative alla pericolosità e alla natura dei rifiuti stessi, dopo un
primo provvedimento di diffida col quale si invitava la società ad ottemperare alle prescrizioni
dell’AIA, la stessa società replicava che nessuna concreta indicazione sulla modalità di
assolvimento dell’incombente era stata fornita dall’autorità, e che il metodo fino ad allora utilizzato
fosse comunque idoneo all’identificazione. L’obbligo previsto dall’AIA risultava dunque rispettato
mediante l’applicazione sulla colonna dei rifiuti stoccati del codice identificativo CER di
appartenenza per identificare la natura ed il pericolo del rifiuto stesso.
Infine, sull’utilizzo del codice D15 anziché D13 la società contestava che, come già riferito in
risposta alla diffida dell’autorità, l’attività di smaltimento di rifiuti consistente nelle operazioni di
deposito preliminare D15 fosse propedeutica all’operazione di raggruppamento preliminare D13 e
che quindi quest’ultima non fosse da considerarsi alternativa a quella di deposito preliminare, ma
successiva. La stessa amministrazione medio tempore rispondeva fornendo le direttive sull’utilizzo
dei codici D13 e D15 e in seguito accertava come la società si fosse diligentemente adeguata alle
indicazioni impartitele.
All’esito dell’istruzione dibattimentale, il Tribunale di Como rilevava essere emersa l’assoluta
buona fede dell’imputato nonché “la ragionevolezza delle obiezioni dallo stesso contrapposte alle
osservazioni formulate dalle pubbliche amministrazioni”. Evidente era infatti la diligenza che aveva
contraddistinto l’operare della società di fronte ad ogni contestazione dell’autorità competente,
diligenza consistente soprattutto nel conformarsi a quanto stabilito dagli organi competenti una
volta che questi ultimi avessero fornito indicazioni sufficientemente chiare per la società.
L’imputato ha in ogni caso agito nella convinzione di operare conformemente alle prescrizioni
imposte dall’AIA. Talvolta peraltro si è potuta ravvisare la responsabilità della stessa
amministrazione nell’essere poco chiara e troppo generica nel fornire le indicazioni guida alla
società imputata nel procedimento davanti al Tribunale di Como per permettere di agire secondo il
volere delle autorità, in una materia peraltro molto complessa e particolareggiata come quella dei
rifiuti. Si può quindi ravvisare un errore scusabile dell’imputato nel non conformarsi
pedissequamente a quanto previsto dall’AIA, errore che esclude la colpevolezza dello stesso con
conseguente assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
Vanno infatti ricordati le innumerevoli decisioni della Suprema Corte tra le quali quella secondo cui
“in materia contravvenzionale, è configurabile la cosiddetta "buona fede" ove la mancata
coscienza dell'illiceità derivi non dall'ignoranza della legge, ma da un elemento positivo e cioè da
una circostanza che induce nella convinzione della sua liceità, come un provvedimento dell'autorità
amministrativa, una precedente giurisprudenza assolutoria o contraddittoria una equivoca
formulazione del testo della norma” (Cass. penale, sez. III, 21-04-1989, n. 6160) e inoltre la
decisione in base alla quale “nelle contravvenzioni la buona fede del trasgressore diventa rilevante
quando si risolve - in presenza ed a causa di un elemento positivo estraneo all'agente - in uno stato
soggettivo tale da escludere la colpa. Ne deriva che difetta l'elemento psicologico, per scusabilità
dell'errore, qualora l'agente abbia tratto il convincimento di liceità da un fatto positivo
dell'autorità” (Cass. penale, sez. I, 17-07-1989, n. 10424) e infine quella per cui “la esclusione
della colpevolezza nelle contravvenzioni non può essere determinata dall'errore di diritto
dipendente da ignoranza non inevitabile della legge penale, quindi, dal mero errore di
interpretazione, che diviene scusabile quando è determinato da un atto della pubblica
amministrazione o da un orientamento giurisprudenziale univoco e costante, da cui l'agente tragga
la convinzione della correttezza dell'interpretazione normativa e, di conseguenza, della liceità della
propria condotta” (Cass. penale, sez. III, 21-04-2000, n. 4951).
Non si può infatti negare che la genericità delle contestazioni e delle successive indicazioni
impartite alla società sul come porre rimedio alle violazioni dell’AIA integrino quell’elemento
positivo richiesto, estraneo all’autore dell’infrazione, idoneo a configurare la scusabilità, la non
rimproverabilità dello stesso.
E’ dunque condivisibile il ragionamento che sta alla base della sentenza in commento, laddove il
Giudice ha ritenuto l’assenza del dolo nella condotta dell’imputato, avendo lo stesso provato di
avere adoperato tutte le cautele possibili. [Monica Introvigne]
6
Corte d’Appello di Venezia – Terza Sezione Penale - Est. Gallo - Imp. XY
Stupefacenti – Attenuante del fatto di lieve entità – Riconoscimento – Ragioni
(Art. 73 co. 5 DPR 309/90)
La circostanza attenuante de qua non è più rigidamente vincolata al quantitativo di sostanze
stupefacenti ma impone di prendere in considerazione la globalità del fatto e cioè, oltre alle
quantità, altri elementi che possono neutralizzare in positivo od in negativo il ruolo di incidenza
dell’elemento ponderale nella lesione del bene giuridico quali i mezzi, le modalità e le circostanze
dell’azione.
La sentenza così motiva:
(Omissis) - Per quanto concerne la richiesta di concessione dell'attenuante di cui al comma 5
dell'art. 73 D.P.R. 309/90 va, innanzitutto, chiarito che ha errato il giudice di primo grado ritenendo
ostativa alla concessione dell’attenuante la condanna riportata dall’imputato.
Infatti, il precedente penale (oltretutto lieve), cioè il giudizio sulla personalità dell'imputato, non
influisce sul riconoscimento dell’attenuante in questione.
E’ giurisprudenza pacifica che non hanno rilievo preclusivo i precedenti specifici dell'agente, che si
collocano al di fuori degli elementi di valutazione fissati dalla disposizione predetta (v., tra le tante,
Cass. pen., sez. VI, sent. n. 35325, 29 maggio/9 settembre 2003, imp. Kedidi, in CED RV. 226761
ovvero sez. VI, sent. n. 42112, 14 ottobre/2 novembre 2009, imp. Belaiba, in CED RV. 245022).
Piuttosto, già in passato la S.C. (sez. VI, 27 gennaio 1994, imp. D'Alessandro, in C.E.D. RV:
197298) aveva rilevato che l'abrogazione parziale, a seguito della procedura referendaria conclusasi
con l'emanazione del D.P.R. 171/1993, dispiegava i suoi effetti anche in relazione agli ambiti di
operatività della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R.
309/1990, sol che si consideri il venir meno del divieto dell'uso personale, sancito dal primo comma
dell'art. 72, dell'art. 76 e dei riferimenti relativi e soprattutto, dell'inciso, contenuto nell'art. 75,
primo comma, "in dose non superiore a quella giornaliera, determinata in base ai criteri indicati nel
comma 1 dell'art. 78".
Con la conseguenza che non poteva più assumere valenza negativa ai fini della concessione della
attenuante in questione l'accertata destinazione a terzi dello stupefacente detenuto, neppure quando
essa avesse alla base un'attività continuativa di spaccio; il tutto secondo quanto emerge dall'art. 74,
comma 6, del D.P.R. 309/1990 che, col suo riferimento ad un'associazione costituita per commettere
"fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73", renderebbe illogico ammettere la lievità del fatto
relativamente ad un reato associativo e negarla per tutti gli episodi che costituiscono attuazione di
quel programma (cfr., anche, sez. VI, 24 marzo/30 maggio 1994, n. 657, Rizzi e sez. V, 14
febbraio/6 giugno 1994, n. 313, Greco ovvero più recentemente, sez. VI, sent. n. 25998, 29
maggio/27 giugno 2008, imp. Lataj, in CED RV. 240569; sez. VI, sent. n. 25988, 29/05/2008, imp.
L. in Cass. pen. 2009, 4, 1697).
In effetti, secondo la visione della giurisprudenza della Corte regolatrice, poichè è richiesta una
valutazione della situazione complessiva, vale a dire del fatto considerato sotto tutti i suoi aspetti,
al fine di stabilire se esso determini o meno un particolare allarme sociale, la valutazione della lieve
entità non va più compiuta in base a meri criteri quantitativi, ma nel contesto delle situazioni
previste dalla norma, globalmente considerate, e rapportata al parametro dell'allarme sociale,
potendosi concludere per la lieve entità quando, a seguito della detta valutazione complessiva, il
fatto appaia tale da determinare soltanto modeste reazioni e preoccupazioni nella comunità (Cass.,
sez. IV, 16 aprile/20 maggio 1993, De Rosa).
Attualmente la circostanza attenuante de qua non è più rigidamente vincolata al quantitativo di
sostanza stupefacente ma impone di prendere in considerazione la globalità del fatto e cioè, oltre
alla quantità, altri elementi che possono neutralizzare in positivo od in negativo il ruolo di incidenza
dell'elemento ponderale nella lesione del bene giuridico quali i mezzi, le modalità e le circostanze
dell'azione.
Insomma, è necessario valutare il fatto nella sua oggettiva portata offensiva.
Solo una valutazione complessiva consente in concreto un giudizio di lieve offensività del reato
(cfr. Cass., sez. IV, 25 gennaio/28 febbraio 1995, n. 151, Carminati).
Più in particolare, la S.C. ha chiarito perspicuamente che la disposizione dell'art. 73, comma 5,
D.P.R. 309/90 va interpretata partendo dal suo dato testuale in correlazione non solo con le altre
disposizioni ma anche in relazione all'intero sistema penale.
Dal dato testuale si evince che l'attenuante non può essere esclusa senza tener comunque conto,
oltre che della «qualità» e «quantità» delle sostanze anche dei «mezzi», delle «modalità», e delle
«circostanze dell'azione», sia di ordine oggettivo che soggettivo.
Il dato sistematico impone, inoltre, di tener conto innanzitutto del fatto che l'ipotesi attenuata è
punita con pena che, per il "massimo" prevista, in relazione a quelli contemplati generalmente nel
nostro sistema penale, rende necessaria un'interpretazione non restrittiva del carattere «lieve» del
fatto.
Parimenti il dato sistematico impone di considerare che nell'art. 73 è prevista per le ipotesi base una
pena elevata: in una tale ottica ne deriva che il «fatto di lieve entità» deve essere individuato con
criteri interpretativi che consentano di rapportare in modo razionale la pena al fatto, tenendo conto
di quel criterio di ragionevolezza espresso dall'art. 3 Costituzione che impone tanto al legislatore
quanto all'interprete, in materia penale, la proporzione fra la quantità e qualità della pena e
l'offensività del reato (sez. VI, 17 maggio/14 giugno 1994, Vizza: in riferimento ai minimi edittali
previsti in precedenza per le droghe cd. leggere e per quelle cd. pesanti ma che anche attualmente
sono elevati per tutte le sostanze tanto più che sono elevatissimi i massimi previsti dalla legge).
Insomma, il giudice di merito deve di regola compiere una valutazione complessiva del fatto
contestato, condotta sulla base dei parametri di riferimento specificamente indicati nella norma (v.
Cass. pen., sez. VI, sent. n. 6394, 5 gennaio/21 maggio 1999, imp. Zema, in CED RV. 213455).
Ciò non è in contraddizione con l’affermazione delle Sezioni Unite della S.C. che già in passato
(sent. n. 17, 21 giugno/21 settembre 2000, imp. Primavera ed altri, in CED RV. 216668) e
recentemente (sent. n. 35737, 24 giugno/5 ottobre 2010, imp. Rico, in CED RV. 247911) hanno
affermato che la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma
quinto, D.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale
della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati
dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli
indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di
incidenza sul giudizio.
Su tali affermazioni si ritiene generalmente (e genericamente) che il dato quantitativo abbia
senz’altro un’incidenza negativa su tutte le altre circostanze eventualmente favorevoli intendendo
che il quantitativo di stupefacente detenuto o ceduto debba essere assolutamente esiguo.
Ma la Suprema Corte più volte ha cercato di mitigare tale interpretazione.
Infatti, pur aderendo ad una tesi alquanto restrittiva è significativo che si sia precisato che al fine di
valutare la sussistenza dell'attenuante de qua ogni altra pur favorevole circostanza risulta priva di
rilevanza per ritenere di lieve entità il fatto, qualora il dato ponderale superi il limite rappresentato
da una soglia ragionevole di valore economico (Cass. pen., sez. VI, sent. n. 2888, 4 febbraio/6
marzo 1998, imp. Gottardo S., in CED RV. 210386 oppure sez. IV, sent. n. 31663, 27 maggio/11
agosto 2010, imp. Ahmetaj, in CED RV. 248112).
Altre volte il giudice di legittimità ha fatto presente che “solo qualora la quantità di sostanza
stupefacente si riveli considerevole, la circostanza è di per sé sintomo sicuro di una notevole
potenzialità offensiva del fatto e di diffusibilità della condotta di spaccio” (giurisprudenza
prevalente contro la tesi della trascurabile offensività: v. Cass. pen., sez. VI, sent. n. 6394, 5
gennaio/21 maggio 1999, imp. Zema, in CED RV. 213455 ovvero, più recentemente, sez. IV, 1
maggio 2008, sent. n. 22643, imp F., in Guida al diritto 2008, 27, 93).
Insomma, per l'applicazione dell'attenuante della lieve entità del fatto prevista dal comma 5 dell'art.
73 d.p.r. n. 309 del 1990, il dato ponderale della sostanza detenuta assume valore preclusivo solo
quando esso è preponderante; mentre, qualora tale dato non sia rilevante, assumono valore i
parametri sussidiari previsti dalla norma e relativi ai mezzi, alle modalità e dalle circostanze
dell'azione (così Cass. pen., sez. VI, sent. n. 21962, 2 aprile/17 maggio 2003, imp. Armenti, in CED
RV. 225414).
Anche recentemente è stato riaffermato che la concessione della circostanza attenuante del fatto di
lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 è possibile solo se una
valutazione complessiva del fatto (mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità delle
sostanze) consente in concreto un giudizio di lieve offensività del reato: pertanto, le condizioni
dell'azione, come possono portare a far ritenere di rilevante offensività la detenzione per spaccio di
una modesta quantità di droga, così al contrario possono portare a neutralizzare l'elemento
ponderale e qualitativo e, quindi, a far ritenere come dotata di un minimo di offensività la
detenzione per spaccio di una quantità non modesta di droga (Cass. pen., sez. VI, 16/02/2010, sent.
n. 24432, imp. D.S. e altro, in Guida al diritto 2010, 35, 66).
Alla luce di questi chiarimenti del giudice di legittimità va riesaminata l’ultima decisione in materia
delle Sezioni Unite (sentenza n. 35737 del 2010) con la precisazione che per forza in quel caso il
concetto di “lieve entità” doveva essere maggiormente rigido in quanto era in discussione la
compatibilità dell’attenuante con l’aggravante della cessione di droga a persona minore di età.
Orbene, nella definizione del fatto “di lieve entità” le Sezioni Unite richiamano analoghe previsioni
quale quella di cui all’art. 5 L. 895/1967: peraltro, riguardo a questa attenuante, le stesse Sezioni
Unite hanno ritenuto che la riduzione della pena è riconnessa alla minore - non minima - offensività
del fatto (sent. n. 7551, 8 aprile/27 giugno 1998, imp. Cerroni, in CED RV. 210797).
Il fatto è che quell’aggettivazione “minimo” è giustificata in riferimento all’aggravante della
cessione di stupefacente a persona di minore età ma rischia di diventare fuorviante negli altri casi
comuni.
Pare giusto tener conto del fatto che la norma in questione non utilizza un aggettivo superlativo o di
valenza analoga bensì solo la indicazione di lievità che richiede una definizione da parte
dell’interprete secondo i criteri interpretativi normali ed alla luce della realtà quotidiana.
Infatti, si potrebbe richiamare la circostanza che quando il legislatore ha voluto indicare una
minima, trascurabile entità del fatto ha utilizzato aggettivi quale “particolare” come nel capoverso
dell’art. 648 c.p. (v. anche il numero 4 dell’art. 62 c.p.)
Oltretutto, proprio questo riferimento semantico è ancor più significativo sol che si consideri che
proprio nella normativa sugli stupefacenti vi è una simile indicazione.
Il comma 14 dell’art. 75 D.P.R. 309/1990 prevede la possibilità del formale invito da parte del
Prefetto a non far più uso di sostanze stupefacenti qualora si tratti di “caso di particolare tenuità”.
La qual cosa non può non significare che il “fatto lieve” è qualcosa di più.
Appare, quindi, più ragionevole la definizione terminologica di “ridotta valenza offensiva” (v.
Cass. pen., sez. VI, sent. n. 8857, 15 giugno/30 luglio 1998, imp. Canepi P., in CED RV. 212005).
Non si tratta di un’inutile specificazione terminologica se si considera che le stesse Sezioni Unite
citate richiamano il fatto che l’attenuante di cui si discute è dettata da un’esigenza “che si inserisce
perfettamente in un quadro di ragionevolezza della disciplina legislativa costituzionalmente
rilevante”.
Tanto vero che viene ricordato l’orientamento in materia del giudice delle leggi il quale ha chiarito
che l’attenuante "permette una modulazione della sanzione sufficientemente rispettosa del criterio
di ragionevolezza" (Corte Cost. sent. n. 333 del 1991).
Successivamente la stessa Autorità - come riconosciuto ancora dalle Sezioni Unite della S.C. - ha
rilevato che è necessario dare ampio spazio alle valutazioni discrezionali del giudice di merito al
fine di evitare automatismi sanzionatori relativi "alla predeterminazione dell'esito del giudizio di
bilanciamento tra circostanze eterogenee" (Corte cost. sent. n. 192 del 2007, n. 257 del 2008, n. 171
del 2009).
Ed appare estremamente chiaro l’orientamento delle Sezioni Unite che si riporta testualmente:
“Sotto un altro profilo, occorre considerare che l'individuazione del disvalore oggettivo dei fatti
reato tipici, e, quindi, del loro diverso grado di offensività, spetta al legislatore, in applicazione del
principio della riserva di legge del trattamento sanzionatorio, ma tale principio deve essere
coordinato con quello, anch'esso costituzionalmente rilevante, della individualizzazione della pena
(artt. 132 e 133 c.p.; Corte cost. n. 285 del 1991, n. 145 del 1998, n. 456 del 1997, n. 220 del 1996,
n. 213 del 2000); compete, pertanto, al giudice di valutare le particolarità del caso singolo onde
individualizzare la pena, stabilendo in base ad esse quella adeguata al caso concreto”.
In tale prospettiva non deve essere trascurato, nell’esegesi della fattispecie attenuata, il fatto che il
legislatore ha strutturato la circostanza come ad effetto speciale in quanto determina non già una
semplice riduzione di pena bensì addirittura una variazione, piuttosto sostanziosa, della pena
edittale.
A ciò si aggiunga che è stato previsto un range tra il minimo ed il massimo talmente ampio da
permettere al giudice una notevole possibilità di diversificazione della sanzione.
La qual cosa consente di adottare una pena più severa qualora il quantitativo di sostanza detenuta o
ceduta dall’imputato non sia proprio modesta.
In definitiva, tenuto conto di quanto finora detto, della severità delle pene previste, della realtà in
relazione alla diffusione del fenomeno della droga appare del tutto ragionevole non limitare la
concessione dell’attenuante al caso in cui il quantitativo di stupefacente sia, come ritiene taluno,
“trascurabile”.
Si richiama, quindi, quell’orientamento giurisprudenziale - niente affatto minoritario - che stabilisce
che solo qualora la quantità di sostanza stupefacente si riveli considerevole, la circostanza è di per
sé sintomo sicuro di una notevole potenzialità offensiva del fatto e di diffusibilità della condotta di
spaccio (v. ancora, oltre alle già citate, Cass. pen., sez. IV, 21/05/2008, sent. n. 22649, imp. N. ed
altro, in Guida al diritto 2008, 31, 103)
Del resto, il sesto comma dell’art. 74, prevedendo un’associazione costituita per commettere i fatti
descritti dal comma 5 dell’art. 73 fa intendere che l’attenuante è applicabile anche qualora vi sia una
piccola organizzazione e, naturalmente, un piccolo accumulo di sostanze nonché quando lo spaccio
sia continuativo (v., recentemente, Cass. pen., sez. VI, sent. n. 25988, 29/05/2008, imp. L. in Cass.
pen. 2009, 4, 1697. Giurisprudenza costante: in senso conforme, ad esempio, sez. IV, 27 novembre
1997, n. 1736, imp. Fierro, in Cass. pen., 1999, p. 1971; sez. VI, 10 marzo 1995, n. 5415, imp.
Corrente, in C.E.D. RV. 201644; sez. VI, 14 febbraio 1994, sent. n. 6615, imp. Greco, ivi, RV.
199198).
Ed, ancorché non rinvenuto tutto lo stupefacente a disposizione dell’organizzazione, sarebbe
semplicemente irrealistico ritenere che gli associati detengano soltanto qualche piccola dose.
Sarebbe, quindi, del tutto contrario a logica e giustizia ammettere l’attenuante in presenza di un
certo quantitativo di sostanza stupefacente nel caso di un’associazione ed escluderla, viceversa, nel
caso vengano giudicati uno o più imputati per fatti non associativi.
Come accennato già qualche anno fa, quando le pene per il reato di cui all’art. 73 erano ancor più
severe, era stato affermato che la disposizione di cui al quinto comma andava interpretata, partendo
dal suo dato testuale, in correlazione con le disposizioni dei commi primo e quarto dello stesso
articolo [che allora prevedeva un’altra pena per le sostanze di cui alle tabelle II e IV] e in relazione
all'intero sistema penale.
Dal dato testuale si evince che la lieve entità del fatto può essere ritenuta in via alternativa, sia in
relazione "ai mezzi", alle modalità o alle circostanze dell'azione", sia in relazione "alla quantità o
alle qualità delle sostanze".
La S.C. aveva fatto presente che il "fatto di lieve entità" doveva essere individuato con criteri
interpretativi che consentano di rapportare in modo razionale la pena al fatto, tenendo conto di quel
criterio di ragionevolezza che (vale tanto per il legislatore quanto per l'interprete), l'art. 3 della
Costituzione prescrive in materia penale in ordine alla proporzione fra la quantità e la qualità della
pena e l'offensività del fatto.
Il giudice, pertanto, nel valutare fattispecie di spaccio di sostanze stupefacenti, non può negare la
sussistenza del fatto di lieve entità senza tener conto, oltre che della "quantità e qualità delle
sostanze", anche dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione, sia di ordine oggettivo
che soggettivo, e non può comunque negarla ove il reato, nella sua componente oggettiva e
soggettiva, non assuma una consistenza tale da rendere proporzionata al fatto - secondo il sopra
indicato criterio di ragionevolezza - la pena (in tal senso Cass. pen., sez. VI, sent. n. 6887, 17
maggio/14 giugno 1994, imp. Vizza, in CED RV. 198750; cfr. sez. VI, sent. n. 4194, 8 marzo/19
aprile 1995, imp. Salmi Ben, in CED RV. 200797).
Tale orientamento deve essere ripreso pur a seguito delle modifiche in ordine all’entità della pena
così come, in effetti, evidenziato nella motivazione delle Sezioni Unite della S.C. che si è riportata.
Da altro punto di vista, non può non essere tenuto conto dello stato di tossicodipendenza
dell'imputato (criterio già affermato nella motivazione della sentenza n. 17 delle Sezioni Unite, 7
marzo 2000, ric. Primavera ed altri).
Naturalmente, lo stato di tossicodipendenza in tanto può venire preso in considerazione ai fini della
concessione dell'attenuante del fatto lieve prevista dal quinto coma dell'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre
1990 n. 309 in quanto vi sia un rapporto diretto tra lo stato di tossicodipendenza e la condotta
imputata (Cass. pen., sez. VI, sent. n. 2877, 14 gennaio/6 marzo 1998, imp. Carriglio C. ed altri, in
CED RV. 210375).
Orbene, insegna la S.C. che ai fini dell'applicazione dell'attenuante del fatto di lieve entità lo stato di
tossicodipendente può rilevare se si accerti che lo spaccio non ha dimensioni ragguardevoli, sì da
fare apparire verosimile che l'imputato ne destini i proventi all'acquisto di droga per uso personale
(Cass. pen., sez. V, sent. n. 25883, 3 aprile/19 giugno 2009, imp. Bacarella ed altri, in CED RV.
243895; v., già, sulle condizioni personali del soggetto sez. VI, sent. n. 1663, 29 ottobre/14
dicembre 1993, imp. Dall'O').
Nel caso di specie, deve essere dato rilievo, a parere della Corte, soprattutto al quantitativo di droga
ceduta dal … nelle due occasioni che sono note che non può che essere apprezzato in termini di
ridottissima consistenza, essendosi trattato di vendite di dosi del valore di euro 20,00 ciascuna.
Non può essere assolutamente contestato che nel caso del … si trattava di un modestissimo spaccio
sia in considerazione del prezzo già detto sia in considerazione delle circostanze della condotta
delittuosa.
Infatti, si trattava di un semplice spaccio da strada senza alcuna organizzazione ed, oltretutto, posto
in essere senza alcuna attenzione od accorgimento.
E l'imputato ciò faceva, come ha riferito fin dal primo momento già alla P.G., per guadagnare quel
tanto da potersi permettere le dosi per il proprio fabbisogno di tossicodipendente.
E per la concedibilità dell'attenuante speciale della lieve entità, in relazione alla quantità di
stupefacente, essa deve essere valutata sul presupposto che parte dello stupefacente sarà consumata
dal soggetto tossicodipendente, cioè che non è tutta destinata a fini di spaccio.
Last but not least nel caso in esame si trattava di hascisc ed appare nel giusto la Difesa quando fa
presente che il legislatore, pur nell’unificazione della sanzione penale per tutte le sostanze
stupefacenti, ha ritenuto pur sempre una minore valenza di tale droga.
Infatti, il Decreto Ministeriale 11 aprile 2006 (che indica i limiti massimi degli stupefacenti
detenibili per uso personale) prevede per il THC un moltiplicatore tra dose personale e dose soglia
di 20.
E’ di tutta evidenza come con tale elevato moltiplicatore (ad esempio, per la cocaina è 5) la
Commissione di esperti istituita dal Ministro della Salute, e quindi il legislatore, ravvisi una minore
valenza stupefacente a tale sostanza.
Infatti, il giudice di legittimità, nel dichiarare infondata la questione di costituzionalità dell’art. 73
D.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dall’art. 4 bis della l. n. 49 del 2006, in relazione all’art. 3
Cost., nella parte in cui prevede il medesimo trattamento sanzionatorio per le condotte aventi ad
oggetto “droghe pesanti” e “droghe leggere”, ha precisato proprio che, ai fini della sussistenza della
circostanza attenuante del <<fatto di lieve entità>> è possibile attribuire rilievo non soltanto alla
maggiore o minore purezza della sostanza, ma anche alla natura della stessa facendo riferimento
esplicito al predetto Decreto Ministeriale ed al "moltiplicatore variabile" della "dose media singola",
determinato, per le sostanze ritenute meno pericolose, in termini più ampi (Cass. pen., sez. IV, sent.
n. 22643, 21 maggio/5 giugno 2008, imp. Frazzitta, in CED RV. 240854).
Testualmente: «In tema di sostanze stupefacenti, ai fini della sussistenza della circostanza
attenuante del "fatto di lieve entità" è possibile attribuire rilievo non soltanto alla maggiore o
minore purezza della sostanza, ma anche alla natura della stessa (in quanto il d.m. 11 aprile 2006,
nel fissare la "quantità massima detenibile" di droga, ha fatto ricorso per le principali sostanze ad un
"moltiplicatore variabile" della "dose media singola", determinato, per le sostanze ritenute meno
pericolose, in termini più ampi), sempre che non risultino ostativi gli altri parametri indicati nell'art.
73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.
Con il "moltiplicatore" si è attribuita una diversa valenza "qualitativa" alle diverse sostanze
stupefacenti (per quelle meno pericolose il moltiplicatore è stato infatti calcolato in termini più
ampi); può utilizzarsi tale argomento per attribuire un rilievo (anche) alla "natura" della sostanza ai
fini e per gli effetti dell'attenuante del fatto di lieve entità, superando così quell'orientamento, in
precedenza consolidato, in forza del quale per il parametro della "qualità" richiesto dal comma 5
dell'art. 73 poteva attribuirsi spazio solo alla maggiore o minore "purezza" della sostanza
stupefacente, restando invece indifferente la natura della stessa. Da ciò consegue anche che, per i
derivati della cannabis, cui si è riconosciuta una minore pericolosità, tanto da utilizzarsi ai suddetti
fini il moltiplicatore "20", può riconoscersi un più ampio spazio per la concedibilità del "fatto di
lieve entità» (riportata anche in Cass. pen. 2009, 4, 1664 con nota dottrinale; vedi anche: Cass. pen.
n. 38879 del 2005).
E tanto è conforme proprio alle indicazioni della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R.
309/90 quando cita fra i parametri di applicazione dell’attenuante la “qualità” delle sostanze.
Adesso che non esiste più una differenza legislativa nella punibilità di marijuana, hascisc ed altre
sostanze simili, è chiaro che il concetto predetto può e deve essere applicato a queste sostanze.
Conseguentemente, al fine di equilibrare meglio la pena rispetto alle altre sostanze stupefacenti ben più dannose e pericolose - è opportuno, se non necessario, fare ricorso “con maggiore
larghezza” all’attenuante del fatto di lieve entità.
Del resto, il quantitativo complessivamente sequestrato all’imputato, pur non essendo modesto, non
può essere considerato considerevole (aggettivo usato dalla citata giurisprudenza della S.C.), cioè
rilevante.
Infatti, come detto, va tenuto conto che dei circa 300 grammi di hascisc detenuti dall’imputato - non
certo di eccelsa qualità - una buona parte era destinata ad uso personale e l’altra, si è visto, era
ceduta in circostanze e con modalità che non evidenziano un particolare allarme sociale né, si può
dire, procuravano un particolare danno.
Per inciso, la Corte Costituzionale non considera strettamente oggettiva l'attenuante in questione
poiché tra le "circostanze dell'azione" menzionate nella disposizione sono comprese anche le
"circostanze soggettive tutte, e quindi anche le finalità della condotta tenuta dall'agente" (già citata
sentenza della Corte Costituzionale n. 333 del 1991).
Il riferimento - è evidente - è ad un eventuale stato di tossicodipendenza dell’imputato.
Tuttavia, l’aggettivazione “TUTTE” indica che viene ritenuta nel giusto quella giurisprudenza che
nella valutazione complessiva per l’applicazione dell’attenuante ricomprende tutte le componenti
oggettive e <soggettive> dell'azione perché solo così è possibile pervenire in concreto ad un
giudizio di lieve entità del fatto (v., ad esempio, Cass. pen., sez. IV, sent. n. 9082, 19 settembre/11
ottobre 1996, imp. Avi, in CED RV. 206098 ovvero sez. III, 22 giugno/23 luglio 1993, imp.
Menabò).
E nel caso di specie non appare affatto trascurabile il dato soggettivo: il … non appare certo un
pericoloso e callido malfattore, bensì un povero ragazzo indotto a commettere il delitto dalla sua
tossicodipendenza.
In conclusione, ritiene la Corte di riconoscere la sussistenza dell'attenuante di cui al comma 5
dell'art. 73 D.P.R. 309/90 applicando peraltro per la fattispecie in esame, in considerazione del
quantitativo di stupefacente detenuto, una pena base elevata (Omissis).
SEZIONE SECONDA - DIRITTO PROCESSUALE PENALE
7
Corte d’Appello di Venezia – Prima Sezione Penale – Sent. 25.10.2010 – Pres. Scutari - Est. Casol
Imp. XY
Revisione – Sopravvenienza o scoperta di nuove prove – Dichiarazioni testimoniali – Requisiti
- Ammissibilità
(Artt. 629, 630, 631, 190 c.p.p.)
Nel caso in cui successivamente alla condanna sopravvengano dichiarazioni testimoniali
tendenzialmente capaci di giustificare una pronuncia di proscioglimento, il giudice di merito deve
limitare il giudizio di ammissibilità alla verifica che le stesse prove non siano vietate dalla legge
ovvero inutilizzabili.
NOTA
Con la sentenza in commento, la Corte d’Appello di Venezia affronta una questione assai
problematica relativa alla revisione delle sentenze di condanna.
Essa affronta il tema della sopravvenienza o scoperta di nuove prove, con specifico riferimento alle
dichiarazioni testimoniali acquisite dalla difesa in epoca successiva al processo di merito,
soffermandosi in particolare sui profili della tardività e della formalità delle stesse.
Rifacendosi alla numerose pronunce della Corte di legittimità sul punto (anche relative al medesimo
procedimento di revisione), la Corte veneta ha spiegato come il giudice di merito non possa
dichiarare l’inammissibilità delle suddette dichiarazioni testimoniali per la tardività della stesse.
Nella motivazione della sentenza, infatti, la Corte d’Appello ricorda come l’art. 630 comma primo
c.p.p. autorizzi la richiesta di revisione in presenza di “nuovi elementi estranei e diversi da quelli
del processo definito”, sottolineando come la revisione sia il “mezzo con il quale si risolve la
contraddizione tra questa verità formale e successiva verità reale emersa da situazioni nuove, non
valutate nella sentenza e che ne denunciano l’ingiustizia, smentendo cioè in modo evidente la
presunzione di verità che le assiste”.
Posto questo, l’eventuale tardività con cui è stata dedotta una prova testimoniale potrà al più essere
apprezzata ai fini della valutazione sulla veridicità della stessa, ma non potrà assolutamente
escluderne a priori l’ammissibilità in sede di revisione, in considerazione del fatto che quella stessa
prova, non essendo stata dedotta in sede di giudizio, non è mai stata nemmeno implicitamente
valutata in quella sede.
Ciò che è imprescindibile, al fine dell’ammissibilità del giudizio di revisione, è che le nuove
dichiarazioni testimoniali abbiano la forza, ex art. 631 c.p.p., di “ribaltare il costrutto
accusatorio”.
Per quanto attiene alle formalità di assunzione delle dette dichiarazioni testimoniali, la Corte veneta
fa suo l’orientamento secondo il quale il codice di rito non richiede una preventiva acquisizione
della prova testimoniale con forme sacramentali, pur sussistendo la possibilità di acquisirle in via
preventiva attraverso le investigazioni difensive, modalità di assunzione che però non può essere
obbligatoriamente imposta.
Ad avviso della Corte, l’unico accertamento cui è tenuto il giudice di merito, anche nel giudizio di
revisione, è quello dettato dall’art. 190 c.p.p.: il giudice deve quindi limitarsi a valutare che le prove
non siano vietate dalla legge, né che siano manifestamente superflue o irrilevanti. Superato tale
vaglio di ammissibilità della prova, il profilo della corretta acquisizione della stessa resta assorbito e
“sanato” dalla successiva fase dibattimentale del giudizio di revisione.
Si coglie appieno la pregnanza e l’importanza della presente sentenza della Corte d’Appello di
Venezia: la stessa infatti, in una tematica tanto delicata quanto controversa quale quella
dell’acquisizione delle prove testimoniali in seno al giudizio di revisione, apre all’interpretazione
più “liberale” e meno formalistica delle norme sul punto, correttamente finalizzata a che la verità
processuale possa avvicinarsi quasi sino a toccare la verità storica degli avvenimenti. [Paola
Loprieno]
8
Tribunale del Riesame di Venezia – Ord. 31.03.2010 – Pres. Santoro – Ind. XY - Decreto di
Archiviazione del Gip di Venezia del 10.12.2010
Tribunale Ordinario di Venezia – Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari – Decreto di
archiviazione del 10.12.2010 – Giud. Galasso – Ind. XY
Reato tributario – Tardività delle indagini ed inutilizzabilità dei documenti acquisiti fuori
termine
Reato tributario – Superamento del termine delle indagini preliminari – Sequestro
documentale – Tardività – Conseguenza – Annullamento ed inutilizzabilità
Reato tributario – Inutilizzabilità – Documentazione probatoria indispensabile sequestrata
oltre il termine delle indagini preliminari – Conseguenza – Archiviazione del procedimento
per impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio
Non sono utilizzabili le prove documentali acquisite a seguito di un sequestro disposto (ed eseguito)
successivamente allo scadere del termine delle indagini preliminari, non prorogate perché la
proroga era stata richiesta tardivamente dal PM e perciò non concessa dal GIP, ancorché venga
aperto un nuovo procedimento penale diversamente rubricato e relativo ad una diversa ipotesi
incriminatrice, la quale tuttavia tragga spunto da quella stessa documentazione tardivamente
sequestrata e dichiarata inutilizzabile dal GIP che non aveva concesso la proroga. (Nella
fattispecie, la conseguenza di tale inutilizzabilità è stata l’archiviazione di entrambi i procedimenti
d’indagine, il primo, in quanto non prorogato, ed altresì il secondo - per il quale il Tribunale del
Riesame ha dichiarato l’inutilizzabilità della documentazione a suo tempo sequestrata fuori
termine nel primo procedimento d’indagine, disponendone quindi la restituzione agli aventi diritto non sussistendo a quel punto gli elementi per sostenere l’accusa in giudizio sull’ipotesi formulata
dalla G.diF. e basata esclusivamente sulla interpretazione della documentazione tardivamente
sequestrata).
NOTA
La vicenda processuale in oggetto nasce a seguito di un’ipotesi accusatoria formulata dalla G.diF.
Veneziana (sulla base di un esposto di un ente previdenziale) quanto al delitto di associazione per
delinquere diretto alla fraudolenta sottrazione al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lvo n.
74/2000) da parte di una società armatoriale, accusata di esterovestizione di attività imprenditoriali
proprie, attraverso la costituzione fittizia di società estere nelle quali, in tesi di accusa, venivano
fatti confluire gli assets societari (navi).
E’ accaduto così che il PM richiedeva la proroga delle indagini al GIP senza tener conto che, avendo
ipotizzato il reato associativo, non doveva considerarsi la pausa feriale a mente dell’art. 2 della
legge sulla sospensione dei termini feriali; nel contempo, cioè durante il periodo non prorogato, lo
stesso PM disponeva il sequestro dell’intera (cospicua) documentazione societaria la quale, in tesi
d’accusa, avvalorava l’ipotesi di illecito tributario per il quale stava procedendo.
Tuttavia, a seguito di memoria difensiva presentata ex art. 406 comma 3 c.p.p., il GIP fissava
l’udienza di cui al comma 5 dello stesso art. 406 c.p.p. ed, a seguito della stessa, respingeva la
richiesta di proroga del PM con il conseguente effetto di rendere inutilizzabili gli atti d’indagine
acquisiti oltre il termine non prorogato; ovvero, nella specie, tutta la documentazione sequestrata.
Il PM a quel punto, pur se ripetutamente sollecitato dalla Difesa in tal senso, non richiedeva subito
l’archiviazione del procedimento d’indagine (restando a quel punto utilizzabili unicamente l’esposto
dell’ente previdenziale ed il rapporto di PG svolto sullo stesso), né esercitava l’azione penale ma,
dopo diversi mesi, richiedeva solo l’archiviazione parziale dello stesso quanto al delitto associativo,
mentre reiscriveva il procedimento medesimo sotto diverso numero di ruolo quanto al diverso reato
di omessa dichiarazione dei redditi (art. 5 D.Lvo n. 74/2000).
Nel contempo, il PM disponeva il dissequestro della documentazione tardivamente sequestrata nel
primo procedimento ed il contestuale nuovo sequestro, pressoché integrale, della medesima
documentazione, tuttavia nell’ambito del “nuovo” procedimento d’indagine diversamente rubricato.
La Difesa proponeva allora richiesta di riesame di quest’ultimo provvedimento di sequestro e
depositava memoria nel rito e nel merito nella quale si sosteneva, quanto al rito, che l’originaria
inutilizzabilità degli atti d’indagine (sequestro) conseguente alla tardività degli stessi, già dichiarata
dal GIP nel primo procedimento, non poteva essere superata dall’iscrizione di un nuovo
procedimento d’indagine per un reato diverso rispetto a quelli ipotizzati nel precedente
procedimento, in quanto la vicenda storica oggetto di entrambe le indagini era la medesima.
Il Tribunale con il provvedimento che si commenta ha accolto la tesi difensiva, annullando il
sequestro e stabilendo l’importante principio di diritto secondo cui non possono valorizzarsi, ai fini
dell’integrazione del “fumus” del reato per secondo ipotizzato, unicamente gli stessi elementi
probatori desumibili (tutti) dagli atti sequestrati tardivamente nel diverso, primo, procedimento
d’indagine, già dichiarati inutilizzabili dal GIP con il provvedimento che aveva negato la proroga.
“Diversamente opinando” osserva infatti il Tribunale del Riesame di Venezia “si verrebbe infatti
ad inammissibilmente ratificare un ‘modus operandi’ suscettibile di tradursi in un meccanismo di
sostanziale elusione della disciplina dei termini d’indagine e delle sanzioni processuali dalla stessa
previste”.
A seguito del suddetto provvedimento del Tribunale del Riesame di Venezia, il PM richiedeva allora
al GIP l’archiviazione anche del secondo procedimento, proprio in forza di quel provvedimento di
riesame, sostenendo: “Infatti conditio sine qua non per la sussistenza dell’ipotesi accusatoria ex
art. 5 del D.lgs. 74/2000 era l’acquisizione della documentazione sequestrata; venendo meno
quindi tale sequestro non sussistono i presupposti per sostenere l’accusa in dibattimento”.
Il (diverso) GIP adito disponeva quindi l’archiviazione anche del secondo procedimento d’indagine
poiché: “difettando agli atti riscontri documentali a sostegno dell’ipotesi accusatoria”, ovvero
poiché non sarebbero mai utilizzabili gli atti sequestrati fuori termine delle indagini preliminari
relative al primo procedimento d’indagine.
Appare assai rilevante il principio affermato dal Tribunale del Riesame di Venezia, e ratificato dal
GIP veneziano che ha disposto l’archiviazione del secondo procedimento, in quanto ribadisce la
portata decisiva dell’inutilizzabilità degli atti d’indagine, una volta che la stessa si sia determinata e
sia stata altresì dichiarata, seguendo il dettato normativo espresso dall’art. 406 c.p.p.
L’inutilizzabilità stessa infatti non può in alcun modo essere superata, men che meno attraverso
assai discutibili architetture processuali le quali, mediante l’iscrizione di un nuovo procedimento
penale d’indagine quanto ad un diverso titolo di reato riferito alla medesima vicenda, rinnovano un
provvedimento di sequestro degli stessi documenti, già una prima volta tardivamente sequestrati e
perciò inutilizzabili.
Tale conclamata inutilizzabilità sarebbe stato peraltro insuperabile anche qualora il PM di Venezia
avesse adottato la diversa procedura della riapertura delle indagini di cui all’art. 414 c.p.p., anziché
limitarsi a “travasare” gli atti, già malamente acquisiti in un primo procedimento, in uno nuovo,
siccome aveva fatto quello stesso PM.
Anzi, proprio la richiesta di riapertura di un procedimento senza fatti nuovi, avrebbe vieppiù
evidenziato allo stesso GIP che ne fosse stato richiesto la conclamata ed insuperabile inutilizzabilità
degli atti d’indagine, già una prima volta illegittimamente acquisiti ed in concreto unica fonte
d’accusa del procedimento stesso.
Appare a questo punto quanto mai opportuno approfondire il tema dell’inutilizzabilità nell’ambito
del vigente sistema processuale penale, quale istituto di generale applicazione nell’ambito del
procedimento penale prima, nonché del processo in un secondo momento.
L’inutilizzabilità, in particolare, va innanzitutto distinta dalle ipotesi di nullità, per loro natura
tassative e specificamente legate agli atti processuali, riferendosi l’inutilizzabilità all’ambito più
generale e distinto delle prove le quali, ai sensi dell’art. 191 c.p.p., sono sempre ex sé inutilizzabili
qualora illegittimamente acquisite, sia che tale acquisizione sia avvenuta all’interno del
procedimento vero e proprio – ovvero, per così dire,“in rerum naturae” – sia che le stesse siano
state acquisite nel corso del procedimento/processo senza il rispetto delle regole che ne disciplinano
l’acquisizione.
È bene allora subito chiarire che sul punto la giurisprudenza della Corte Suprema, ha stabilito che
una cosa è l’inutilizzabilità di cui all’art. 191 c.p.p. ed altra cosa è quella dettata dalla norma di cui
all’art. 406 c.p.p., tanto che quest’ultima, a differenza della prima non è rilevabile d’ufficio ma solo
su eccezione di parte; cosicché la stessa inutilizzabilità non potrebbe operare nel giudizio
abbreviato, ove il richiedente “accetta” l’intero contenuto probatorio legittimamente, seppur
tardivamente, raccolto (Cass. Pen. Sez. 6 – 24.2.2009 n. 16986).
Potrebbe a questo punto rilevarsi come nell’ipotesi di cui all’art. 406 c.p.p. qui in commento, la
forma superi la sostanza, nel senso che, anche una semplice (e non voluta) irregolarità di
acquisizione di una prova (magari rilevante od addirittura decisiva), la rende irrimediabilmente
ininfluente rispetto al compendio probatorio a disposizione del giudice (e del requirente) che si trovi
a dover decidere in merito ad un fatto/ipotesi di reato cui quella stessa prova inerisca.
In verità una tale critica non può trovare accoglimento alcuno nel nostro ordinamento, proprio
nell’ottica del più ampio principio di legalità che deve connotare tutti gli ambiti del procedimento
penale e del conseguente (eventuale) processo.
La prova illegittimamente raccolta è infatti di per sé, sempre, una prova poco attendibile e
comunque opinabile e perciò del tutto inaffidabile; cosicché la legge processuale penale, attraverso
l’istituto dell’inutilizzabilità, impone al giudice, su richiesta della parte, di non tenerne conto, senza
che sia necessario tuttavia ricorrere allo strumento molto più formalmente rigoroso (e tassativo)
delle nullità.
Di diversi e ben più pregnante portata è invece l’istituto dell’inutilizzabilità della prova, ove la
stessa venga raccolta “in violazione dei divieti stabiliti dalla legge “ (art. 191 comma 1 c.p.p.)
quando, per quanto già detto, non si tratti di violazioni intervenute nell’ambito del procedimento e
per le quali sia previsto un diverso regime di rilevabilità.
In quei casi, per così dire non regolamentati, vi sarà infatti l’obbligo di valutazione del giudice sulla
utilizzabilità della prova, tenendo conto della sua “non violazione” di legge, in relazione
all’ulteriore principio cardine del diritto alla prova (art. 190 c.p.p.) ove, non a caso, è pure previsto
dalla norma processuale il principio della ritualità, e quindi l’utilizzabilità, delle prove non
disciplinate dalla legge (art. 189 c.p.p.).
Per il vero, può apparire che l’interpretazione giurisprudenziale restrittiva come sopra riportata,
comporti un automatico ed indebito (poiché non espressamente previsto dal legislatore) concreto
restringimento dell’operatività della norma di cui all’art. 191 c.p.p., poiché priverebbe il giudice di
una pienezza di giurisdizione sulla utilizzazione della prova.
Così non è. Il giudice infatti non deve, né può avere alcun “arbitrio” sulla prova, attraverso
l’interpretazione più o meno soggettiva della norma dell’art. 191 c.p.p.; egli ha invece in quella
stessa norma uno strumento in più da utilizzare, nei casi non espressamente regolamentati dalla
legge processuale, nei quali egli si imbatta in una prova comunque a vario titolo irregolare poiché
formatasi in violazione di una legge, che così egli potrà legittimamente non utilizzare.
Conclusivamente peraltro deve altresì osservarsi che l’inutilizzabilità di una prova non preclude
affatto l’attività del Giudice il quale, ad esempio il GIP al termine delle indagini preliminari, resta
comunque libero di disporre l’acquisizione di nuove prove al fine di verificare l’esercizio
dell’azione penale rispetto ad una qualunque notizia di reato (art. 409 comma 4 c.p.p.).
Il nuovo processo penale, attraverso l’istituto dell’inutilizzabilità, fornisce uno strumento
obbligatorio ed utile al giudice (ed al PM) per stabilire quali siano le prove che egli stesso potrà
considerare ed usare per adottare le sue determinazioni nel processo e sul processo, sollevando così
da ogni ulteriore onere le parti ed il magistrato medesimo nel discernere il compendio probatorio
utilizzabile da quello che non deve esserlo.
L’inutilizzabilità rappresenta altresì un importante presidio alle garanzie di difesa, sia in senso
formale che sostanziale.
Quanto al primo aspetto, l’inutilizzabilità consente infatti alla Difesa dell’indagato/imputato, quanto
meno, una verifica sulla ritualità della prova che impedisce comunque l’immediata utilizzazione
degli atti qualora illegittimamente raccolti dal requirente secondo il principio ben espresso dal
brocardo: “male captum bene retentum”.
Quanto invece all’aspetto sostanziale del diritto di difesa, l’inutilizzabilità degli atti non rituali è
principio che meglio tutela la effettiva parità delle parti e, nel contempo, non impedisce alla Difesa
di scegliere l’utilizzazione di quegli stessi atti ove utili per la parte assistita. [Luigi Ravagnan]
9
Tribunale Ordinario di Venezia – Ufficio del Giudice Monocratico Penale – Ord. 300425/11 - Est.
Lancieri - imp. XY
Persona offesa – diritti e facoltà - qualifica di parte in senso tecnico – esclusione –
conseguenze.
Posto che non vi è dubbio che il libro primo del codice di procedura penale disciplina, nel titolo
sesto, la persona offesa quale soggetto distinto dalla parte civile, alla prima non può essere
attribuita la qualifica di parte processuale in senso tecnico. Ne discende, come logica conseguenza,
che i diritti e le facoltà della persona offesa dal reato possono essere fatti valere unicamente nei
casi espressamente previsti dalla legge. E', invece, da escludersi l'applicabilità alla persona offesa
delle disposizioni che disciplinano diritti e facoltà del Pubblico Ministero e delle altre parti private,
in particolare la scelta fatta dalle persone offese di non costituirsi parte civile dà loro i limitati
diritti - nell'ambito del processo penale - di cui all'art. 90 c.p.p., che certo non consentono di
interloquire durante l'udienza per iscritto con il Giudice e tanto meno di interloquire oralmente con
il Pubblico Ministero.
NOTA
Tizio, legale di YY, persona offesa nell'ambito del procedimento a carico di XX, a seguito di
un'udienza dibattimentale in cui gli era stato precluso di sedere a fianco del pubblico ministero e
dei difensori delle parti, onde poter liberamente conferire con l'organo dell'accusa nel corso del
dibattimento, deposita in cancelleria una memoria ex art. 90 c.p.p. con la quale rivendica il diritto
della persona offesa e del suo difensore a partecipare all'udienza dibattimentale esercitando le
facoltà riconosciute proprio dall'art. 90 c.p.p. e, dunque, presentare memorie al giudice ed al
pubblico ministero ed interloquire con quest'ultimo, sia per iscritto sia oralmente, anche e
soprattutto durante l'udienza. Ciò al fine di garantire alla persona offesa il diritto ad intervenire
tempestivamente, qualora se ne presentasse l'opportunità, senza dover attendere il termine
dell'udienza onde accedere alla cancelleria per il deposito di memorie. Richiama, altresì, il difensore
della persona offesa l'art. 146 delle disposizioni di attuazione laddove, nell'indicare la disposizione
nelle aule di udienza, prescrive che pubblico ministero e difensori siano posti allo stesso livello di
fronte all'organo giudicante.
Rileva il Giudice che il nostro codice di rito separa, anche “fisicamente”, collocandoli gli uni nel
titolo sesto gli altri nel titolo quinto del libro primo, i diritti e le facoltà della persona offesa e della
parte civile, cosicché alla persona offesa non può essere attribuita la qualifica di parte in senso
tecnico.
E, pertanto, sebbene il codice garantisca alla persona offesa diritti e facoltà particolarmente incisivi
nel corso delle indagini preliminari, la scelta di non costituirsi parte civile comporta alcune
inevitabili conseguenze. In particolare, proprio l'art. 146 delle disposizioni di attuazione non può
essere applicato al difensore della persona offesa, essendo riferito al pubblico ministero e alle altre
parti private. Parimenti non trovano applicazione l'art. 121 e l'art. 178 c.p.p. anch'essi espressamente
riferiti alle sole parti private, con l'eccezione (che conferma la regola) del comma 1 lettera c),
dell'art. 178 che garantisce la citazione in giudizio della persona offesa separatamente rispetto
all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private.
Per tale ragione, conclude il Giudice, la scelta fatta dalle persone offese di non costituirsi parte
civile dà loro i limitati diritti - nell'ambito del processo penale - di cui all'art. 90 c.p.p., che certo
non consentono di interloquire durante l'udienza per iscritto con il Giudice e tanto meno di
interloquire oralmente con il Pubblico Ministero.
Nell'esame della decisione riportata si impone una verifica dei poteri riconosciuti all'offeso
nell'ambito del procedimento penale.
Innegabile la distinzione richiamata dal Giudice tra persona offesa, quale titolare dell'interesse
tutelato dalla norma violata, e parte civile, quale soggetto danneggiato dal reato e, per questo,
legittimato a proporre l'azione civile anche nell'ambito del processo penale. La stessa collocazione
sistematica delle norme che disciplinano le due figure fa sì che, effettivamente, soltanto il
danneggiato costituitosi in giudizio possa rivestire la qualifica di parte del processo penale, con
l'inevitabile preclusione alla persona offesa di tutti i diritti e le facoltà riservati alle parti in senso
tecnico; tale purezza di ruoli non è fine a se stessa, ma “proietta la sua valenza sistematica lungo
l'intero iter procedimentale”1. A tale conclusione è giunta da tempo, dopo una serie di decisioni
contrastanti da parte delle sezioni semplici, anche la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite
2
. Ciò premesso resta da verificare in cosa consistano i diritti e le facoltà riconosciuti dall'articolo 90
del codice di procedura penale alla persona offesa e se essa continui ad essere, nonostante
1
BRESCIANI, Digesto Delle Discipline Penalistiche, Torino, 2005, IX, 536.
2
Cass. Pen., Sez. Un. 19 gennaio 1999, Messina, ANPP 1999, 34;
l'evoluzione subita negli ultimi vent'anni3, un “postulante”4 che subisce il doppio limite della
presenza del pubblico ministero da un lato e della parte civile dall'altro5.
L'avvento del codice Vassalli ha visto il riconoscimento alla persona offesa della posizione tipica
dell'accusa privata6, con un ruolo, tuttavia, ben distinto rispetto a quello della persona danneggiata
dal reato. La persona offesa gode nel sistema odierno di poteri di controllo sull'inattività del
pubblico ministero7, influenza le modalità di esercizio dell'azione penale 8 e diviene, a determinate
condizioni, titolare di un autonomo potere di vocatio in ius9 tuttavia, come vedremo a breve e come
lascia intendere la decisione in commento, con l'inizio del processo i diritti dell'offeso subiscono
ancor oggi una compressione per certi aspetti ingiustificata.
A tale proposito l'articolo 90 del codice di procedura penale accanto ad una riserva di legge
riconosce un generico potere di presentare, in ogni stato e grado del procedimento, memorie e, con
esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.
Il codice di procedura penale disciplina, quindi, in via separata tutta una serie di poteri volti
perlopiù a garantire alla persona offesa il corretto instaurarsi del contraddittorio e la facoltà di
intervento nel processo. Non a caso i diritti e le facoltà della persona offesa, sicuramente più incisivi
nel corso delle indagini preliminari, appaiono sostanzialmente finalizzati a garantire alla medesima
di poter esercitare il diritto di costituirsi nel processo in una posizione di sostanziale parità con le
altre parti processuali. E', tuttavia, innegabile che, qualora l'offeso decida di non costituirsi in
giudizio o qualora, ancor peggio, pur essendo il titolare dell'interesse violato, non abbia subito alcun
danno vedrà ridurre drasticamente le proprie possibilità di influenzare l'esito del giudizio. Si
osservi, a tale proposito, che l'articolo 466 del codice di procedura penale, del quale non può che
auspicarsi un'interpretazione estensiva10, limita il diritto a prendere visione del fascicolo per il
3
Ciò in conformità alle direttive internazionali che riconoscono l'offeso quale
“portatore di istanze autonome cui l'ordinamento deve dare spazio, riconoscimento e
soddisfazione”; cfr. Del Tufo, La tutela della vittima in una prospettiva europea, in Dir.pen. e
processo 1999,889 ss.
4
CORDERO, Procedura Penale, Milano, p. 273;
5
SPANGHER, I soggetti, in Conso-Grevi, I profili del nuovo codice di procedura
penale, Padova, 1993,80
6
AMODIO, La persona offesa dal reato, in Comm. Amodio-Dominioni, I, Milano
1989, 540.
7
Si veda l'art. 413 c.p.p. in tema di avocazione delle indagini.
8
Si pensi all'art. 459 c.p.p., che disciplina la facoltà del pubblico ministero di
procedere per decreto solo ove il querelante non abbia dichiarato di opporvisi.
9
Si pensi al ricorso immediato disciplinato dall'art. 21 D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.
10
Non sarebbe, invero, l'unico caso in cui il legislatore utilizza il termine “parti” in
modo improprio, riferendosi inequivocabilmente anche alla persona offesa; si pensi agli articoli 93 e
dibattimento e ad estrarne copia soltanto alle parti e ai loro difensori, con la conseguenza illogica di
costringere la persona offesa che intenda esercitare le proprie facoltà di depositare memorie e
indicare elementi di prova a presenziare alle udienze onde conoscere gli sviluppi del processo.
L'esigenza di un'interpretazione estensiva s' impone, peraltro, ove si consideri che tale norma
disciplina l'accesso al fascicolo del dibattimento durante il termine per comparire previsto dal
quarto comma dell'articolo 429 del codice di procedura penale. Ciò significa che l'accesso al
fascicolo per il dibattimento sarebbe precluso alla persona offesa che intendesse costituirsi parte
civile nel termine di cui all'art. 484, magari dopo aver appreso tardivamente dell'esistenza di
un'udienza notificata per pubblici annunzi 11.
Tra i diritti fondamentali dell'offeso vi è sicuramente quello di ricevere l'informazione di garanzia,
nei casi in cui esso sia previsto, con la conseguenza di porre tale soggetto nella condizione di
conoscere l'esistenza delle indagini e i fatti a cui si riferiscono 12. La persona offesa ha diritto ad
essere informata, ove ne abbia fatto domanda, della richiesta di proroga delle indagini, così come di
un'eventuale richiesta di archiviazione del procedimento, con conseguente diritto, in tale ultima
circostanza, a prendere visione degli atti di indagine onde poter in seguito presentare opposizione
con richiesta di prosecuzione delle indagini, indicando, a pena d'inammissibilità, l'oggetto
dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.
Ancora tra i principali diritti riconosciuti nel corso delle indagini preliminari, vi è quello a
partecipare all'assunzione di prove. La persona offesa può presenziare, anche munita di difesa
tecnica, agli accertamenti tecnici non ripetibili e all'incidente probatorio 13 esercitando, in
quest'ultimo caso un potere che le sarebbe precluso qualora la medesima prova fosse assunta nel
corso del dibattimento, ovvero quello di proporre al giudice, tramite il proprio difensore, domande
da rivolgere alle persone sottoposte all'esame14 . Allo stesso modo, la persona offesa mantiene il
diritto ad essere avvisata anche nell'ipotesi in cui l'assunzione di prove non rinviabili venga disposta
nella fase preliminare al dibattimento.
95 c.p.p.; AMODIO sub. Artt. 93 – 95 in Comm. Amodio – Dominioni, I, Milano, 1989, 562;
Si noti a tale proposito la recente giurisprudenza che riconosce alla persona offesa che
rivesta la qualifica di danneggiato la possibilità di chiedere l'ammissione dei testimoni, depositando
la relativa lista, anche prima della costituzione di parte civile, ciò nonostante l'art. 468 c.p.p. riservi
espressamente tale facoltà alle parti; Cass. Pen. Sez. V, 8/06/2005, N. CED 232297)
11
Si osservi, tuttavia, che il diritto della persona offesa viene parzialmente
salvaguardato dalla disposizione generale di cui all'art. 116 c.p.p., laddove prevede che durante il
procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie
spese di copie, estratti o certificati di singoli atti, previa richiesta al pubblico ministero o al giudice
che procede. Certo l'interpretazione letterale di tale norma non garantisce, invece, il più ampio
diritto di accesso al fascicolo regolato dall'articolo 466.
12
Anche se nella pratica spesso la persona offesa viene resa edotta circa l'esistenza e lo
stato del procedimento solo con la notifica del decreto di citazione a giudizio o dell'avviso di
fissazione dell'udienza preliminare eseguita, in estrema ipotesi, anche per pubblici annunzi ex art.
155 c.p.p.
13
Tuttavia, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 401 c. 3, c.p.p., solo previa
autorizzazione del giudice.
14
Art. 401, comma 5 c.p.p.
Ancora, la persona offesa riceve avviso della fissazione dell'udienza preliminare, anche se si discute
in dottrina circa la legittimità della sua presenza in tale contesto 15; è, invece, precluso alla
medesima ogni intervento nella fase cautelare.
La persona offesa può, inoltre, a mezzo del difensore nominato, svolgere indagini difensive,
esercitando una facoltà che rende certamente più concreta la possibilità di indicare elementi di
prova al pubblico ministero o al giudice.
E', tuttavia, nel corso del dibattimento che le facoltà dell'offeso paiono cedere il passo alla parte
civile costituita, così come agli enti e alle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato che
abbiano presentato l'atto di intervento 16.
Se accettiamo l'opinione universalmente condivisa in dottrina e giurisprudenza secondo cui la
persona offesa non è una “parte privata” in senso tecnico il ruolo di questa durante il dibattimento si
limita a quello di mero spettatore con la sola facoltà, appunto, di presentare memorie e indicare
elementi di prova. Facoltà che, tuttavia, non può essere relegata in margini così ristretti quali quelli
delineati dal giudice estensore del provvedimento che ci occupa. Vero che l'articolo 146 norme di
attuazione nel disciplinare la collocazione dei protagonisti del dibattimento nelle aule d'udienza fa
riferimento espresso alle parti private, cosicché la persona offesa e il suo difensore paiono trovare
posto solo tra il pubblico, non si può condividere l'affermazione secondo cui la presentazione di
memorie potrebbe avvenire solo in cancelleria 17. Tale interpretazione contraria alla lettera della
legge, che riferendosi ad “ogni stato e grado del procedimento” non può escludere a priori l'udienza,
priverebbe la persona offesa della facoltà, pure espressamente prevista, di indicare elementi di prova
laddove tale possibilità emerga, come spesso avviene, nel corso dell'udienza e la decisione in merito
non possa essere differita. Non vi è, infatti, dubbio che la facoltà di indicare elementi di prova possa
essere esercitata sia per orientare il requirente nello svolgimento delle indagini che per stimolare i
poteri ufficiosi del giudice 18. Si pensi in tal senso ad una prova da assumere ex articolo 507 c.p.p. la
cui acquisizione può essere disposta terminata l'acquisizione delle prove; la persona offesa che
rilevasse la necessità di procedere all'assunzione di una nuova prova verrebbe privata della
possibilità di sollecitare il giudice (fatta salva l'ipotesi di un rinvio di udienza) a causa di un
supposto divieto di depositare memorie nel corso dell'udienza; divieto che non appare giustificato
laddove tale attività non finisca per intralciare la prosecuzione del dibattimento (ad esempio a causa
di un esasperazione dell'esercizio di tale facoltà da parte dell'offeso, nel qual caso il giudice
potrebbe pur sempre utilizzare il proprio potere di disciplina dell'udienza).
Non pare, invece, riconoscersi alla persona offesa un diritto ad interloquire oralmente con il giudice
o con il pubblico ministero, possibilità, peraltro, preclusa laddove non sia garantita alla medesima
una collocazione che lo consenta; con la conseguenza che, almeno durante il dibattimento,
15
GUALTIERI, sub. art. 90, Codice di Procedura Penale Commentato, Giarda –
Spangher, 2007, I, 660.
16
Ai sensi dell'art. 505 c.p.p. gli enti e le associazioni intervenute nel processo a norma
dell'art. 93 possono chiedere al presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai periti , ai consulenti
tecnici e alle parti private che si sono sottoposte a esame.
17
In dottrina GHIARA, Persona offesa dal reato, in Comm. Chiavario I, 412; SETTE,
La Persona offesa nel nuovo codice di procedura penale, CP 1991, I, 1907
18
GUALTIERI, sub. art. 90, Codice di Procedura Penale Commentato, Giarda –
Spangher, 2007, I, 657.
nonostante l'evoluzione degli ultimi anni, l'offeso di oggi non appare poi molto lontano dal
“postulante” descritto dal Cordero. [Federica Bassetto]
10
Tribunale Ordinario di Padova – Ufficio del Giudice Monocratico - Ord. 24.02.2011 – Est. Cesaro –
Imp. XY
Giudizio abbreviato – consulenze tecniche – acquisibilità – presupposti - artt. 121, 233 c.p.p.
Nell’ambito delle consulenze tecniche bisogna distinguere fra quelle che si limitano ad esporre in
termini generali quelle che sono le cognizioni tecniche, scientifiche, specifiche dei periti, che
possono essere prodotte in ogni stato e grado del procedimento ex art. 121 c.p.p., e quelle che
fanno applicazione di queste cognizioni tecniche, le quali, prendendo in esame anche aspetti
peculiari specifici del caso concreto ed assurgendo ad elemento di prova, non possono essere
introdotte in forza dell’art. 121 c.p.p.
L’ordinanza così motiva:
- Il Giudice ritiene che nell’ambito delle consulenze tecniche si possano distinguere, da un lato,
consulenze tecniche espositive di competenze tecniche, scientifiche, specifiche dei periti in termini
generali, le quali possono essere prodotte come memorie ai sensi dell’articolo 121 c.p.p. in ogni
stato e grado del procedimento, perché si limitano ad esporre in termini generali quelle che sono le
cognizioni tecniche specifiche; dall’altro, le consulenze che fanno applicazione di cognizioni
tecniche che prendono in esame anche aspetti peculiari specifici del caso concreto ed assurgono ad
elemento di prova. Quest’ultime non possono essere presentate come memorie in ogni stato e grado
del procedimento, ai sensi dell’articolo 121 c.p.p.
Tribunale di Treviso – Ufficio del Giudice Monocratico - Ord. 9.02.2011 – Est. Vitale – Imp. XY
Dibattimento – consulenze tecniche - acquisibilità – presupposti - artt. 121, 233 c.p.p.
Risultano acquisibili come memorie ex art. 121 c.p.p., in ogni stato e grado del processo, le
consulenze tecniche che siano state siglate e fatte proprie dal difensore e che riguardino pareri di
carattere professionale in ordine ai fatti di causa.
L’ordinanza così motiva:
(Omissis) – Ritenuto, quanto alle memorie tecniche della difesa di parte civile (…) che le stesse
risultano acquisibili in ogni stato e grado del processo come memorie ex art. 121 c.p.p., essendo
state siglate e fatte proprie dal difensore. Le stesse infatti rientrano tra le memorie scritte che le parti
e i difensori possono presentare al giudice in ogni stato e grado del procedimento, quali pareri di
carattere professionale in ordine ai fatti di causa, quand’anche non provenienti dal difensore
nominato (cfr. Cass. Sez. VI, sent. 23/9/2008 n. 3500, Rossini ed altro). Rimane, peraltro, fermo, il
potere delle altre parti di contestare il contenuto delle valutazioni espresse dai consulenti attraverso i
propri consulenti, nonché il potere del giudice di disporre sul punto accertamento peritale d’ufficio
ai sensi dell’art. 508 c.p.p. (Omissis).
11
Tribunale di Treviso – Ufficio del Giudice Monocratico - Ord. 9.02.2011 – Est. Vitale – Imp. XY
Dibattimento – indagini difensive - acquisibilità – utilizzabilità – sussistenza - artt. 391 bis,
327 bis, 391 decies, 430, 431 c.p.p.
Per quanto attiene le investigazioni difensive, prodotte nel corso dell’istruttoria dibattimentale, non
sono acquisibili ex sé, potendo essere utilizzate ex art. 391 decies, 1°comma c.p.p. e quindi, ai fini
delle contestazioni nell’esame testimoniale (art. 500 c.p.p.), ai fini della lettura delle dichiarazioni
rese dall’imputato nel corso delle indagini preliminari e nell’udienza preliminare (art. 513 c.p.p.) e
ai fini della lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione (art. 512 c.p.p.)
NOTA
L’ordinanza qui in oggetto è frutto della richiesta del Difensore di Parte Civile di poter produrre, nel
corso dell’istruttoria dibattimentale, l’indagine difensiva integrativa da lui stesso svolta.
Ne nasce un’ampia controversia che vede l’immediata e alquanto ferma opposizione da parte della
Difesa dell’imputato sulla produzione di indagini difensive svolte da Controparte (in questo caso
P.C.) la quale, alla luce del principio del contraddittorio, richiama l’art. 430 c.p.p., 2°comma,
secondo cui la documentazione relativa all’attività integrativa d’indagine, successiva all’emissione
del decreto che dispone il giudizio, svolta dal Pubblico Ministero e dal Difensore, deve essere
immediatamente depositata presso la Segreteria del Pubblico Ministero con facoltà delle parti di
prenderne visione e di estrarne copia, previsione che evidentemente non ha avuto luogo. Inoltre, a
sostegno della propria opposizione rimanda all’art. 431 c.p.p. che al 2°comma afferma come “le
parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel
fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione
difensiva”, al fine di poter utilizzare le stesse indagini difensive per le contestazioni elencate
nell’art. 391 decies c.p.p.; accordo in tal caso mancante. Sottolinea altresì come sia nella stessa
disponibilità del Giudice, ex art. 507 c.p.p., terminata l’acquisizione delle prove e se risulta
assolutamente necessario, disporre anche d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, dando in
questo modo la possibilità alla Difesa dell’imputato di avere un congruo termine per eventualmente
portare una prova contraria, non rendendosi utilizzabile, se non vi è consenso, la produzione in fase
dibattimentale.
Di contro, il Difensore di Parte Civile, motiva il suo diritto di produrre le indagini difensive
ponendo l’attenzione su quanto disposto dall’art. 327 bis c.p.p., secondo cui “il difensore ha facoltà
di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio
assistito […] in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il
giudizio di revisione” facendo peraltro notare come l’art. 430 c.p.p. sia privo di sanzione.
Una riflessione ci viene imposta con riguardo all’acquisizione delle indagini difensive, in
particolare quando le stesse siano state svolte dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio.
È necessario, a parere dello scrivente, distinguere e non confondere i diversi “piani”dell’esperibilità
e dell’acquisibilità. Nel senso che, è vero che l’art. 327 bis vuole porsi come norma generale che
permette al difensore di svolgere, a garanzia del diritto di difesa, le investigazioni in ogni stato e
grado del procedimento, ma è anche vero che il legislatore con gli artt. 430 e 431 c.p.p. ha voluto
porre dei “paletti” nel momento in cui queste investigazioni vengano espletate dopo il decreto che
dispone il giudizio.
Difatti, mentre prima di questo specifico momento processuale, queste non solo possono eseguirsi,
ma anche depositarsi in ogni momento e senza alcun vincolo, dopo di esso, il diritto di esercizio
viene a coordinarsi con gli specifici criteri previsti dal codice, secondo cui le investigazioni
difensive, così espletate, devono in primis essere depositate presso la segreteria del P.M. e solo in un
secondo momento, previo accordo delle parti, possono entrare a far parte del fascicolo del
dibattimento.
E comunque, come argomenta giustamente il giudice, le dichiarazioni quali indagini difensive
potranno, semmai, essere utilizzate per le contestazioni ex artt. 500 e 513 c.p.p. o per la lettura
“quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione” (art. 512
c.p.p.), come disposto all’art. 391 decies c.p.p. primo comma, non potendosi ritenere acquisibili ex
sé.
Il Giudice peraltro ha sempre la possibilità, se lo ritiene necessario, di ammettere nuovi mezzi di
prova ex art. 507 c.p.p. [Veronica Scalia]
12
Tribunale Ordinario di Venezia – Ufficio del Giudice Monocratico Penale – Ord. del 18.06.2010 Est. Bitozzi - Imp. XY + 3
Incertezza del luogo di pesca – Questione di incompetenza territoriale – Rigetto – Ragioni.
“Preliminarmente il Giudice rigetta l’eccezione preliminare di incompetenza territoriale ritenuto
che non vi è certezza allo stato degli atti del luogo in cui sarebbe avvenuta la pesca dei molluschi
(emergendo detta circostanza da mere dichiarazioni unilaterali provenienti dagli imputati e prive di
riscontri), mentre vi è certezza del luogo di commercializzazione dei prodotti essendo
l’accertamento avvenuto presso il mercato ittico di Venezia. Ne consegue che va applicata la regola
di competenza di cui all’art. 9, 1° comma, c.p.p.”
NOTA
La predetta ordinanza è degna di segnalazione per il contrasto giurisprudenziale in tema di
competenza territoriale che crea all’interno del nostro Tribunale, ma soprattutto per le implicazioni
in ordine ai reati di falsità in atti. Il procedimento nasce dal rinvenimento di novellame di
cannolicchi sui banchi del Mercato Ittico di Venezia. All’epoca la Capitaneria di Porto di Venezia
sequestra 40 kg di molluschi bivalvi e ne ricostruisce la filiera commerciale. Sul banco degli
imputati, ai sensi degli artt. 24, 1° comma e 15, lettera C, L. n. 963/1965, si ritrovano quattro
persone: A e B per aver pescato novellame di molluschi bivalvi che hanno venduto a C che ha
venduto a D. La difesa degli imputati A e B eccepisce l’incompetenza territoriale del Tribunale di
Venezia in favore di quella di Rovigo, le difese di C e D eccepiscono l’attribuzione del fascicolo
alla Sezione distaccata di Chioggia. I documenti forniti dalle difese a sostegno delle proprie
eccezioni sono i documenti di registrazione dei molluschi, nonché i registri di carico e scarico dei
medesimi. Vale la pena, a questo punto, ricordare le norme sanitarie applicabili alla produzione e
alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi all’interno dell’Unione Europea. Il documento
di registrazione, che deve accompagnare ogni lotto di molluschi, serve per identificarli e deve
contenere informazioni concernenti lo status sanitario della zona di origine e il trattamento di
depurazione o di stabulazione eventualmente applicato, oltre che l’indicazione del produttore. Deve
sempre essere possibile risalire all'origine dei molluschi bivalvi immessi sul mercato, pertanto, le
indicazioni che figurano nel documento di registrazione devono essere ricollegate a ciascun lotto
immesso sul mercato tramite il registro di carico e scarico tenuto dal centro di spedizione. I
documenti di registrazione sono rilasciati su richiesta del produttore dall'U.S.L.L., che li numera in
maniera continua e in ordine di successione. L'autorità sanitaria tiene un registro in cui figurano il
numero dei documenti di registrazione e il nome delle persone che raccolgono i molluschi bivalvi
vivi a cui sono stati rilasciati. Il documento di registrazione di ciascun lotto di molluschi bivalvi vivi
deve riportare la data di consegna dello stesso al centro di spedizione, al centro di depurazione, alla
zona di stabulazione o allo stabilimento di trasformazione e deve essere conservato dai responsabili
di questi centri, zone o stabilimenti per almeno dodici mesi. Il produttore fa ugualmente.
Considerare il documento di registrazione dei molluschi bivalvi quale mero documento di parte non
idoneo ai fini della determinazione della competenza territoriale significa privarlo della qualità di
atto pubblico, che è il presupposto delle numerose condanne comminate nel tempo per falsità in atti
dal Tribunale di Venezia. [Elena Zennaro]
13
Giudice di Pace di Torino – Sent. n. 314 del 22.02.2011 – Giud. Polotti di Zumaglia Alberto - Imp.
XY
Direttiva 2008/115 CE - Applicabilità del reato di ingresso e soggiorno irregolare nel territorio
dello Stato (art. 10 bis T.U.) a seguito del mancato recepimento – Insussistenza – Assoluzione
perché il fatto non è previsto come reato.
Per effetto del prevalere delle norme direttamente applicabili della direttiva comunitaria 2008/115
CE (cd. Direttiva “rimpatri”), nel caso di specie, di quella prevista dall’art. 7, par. 1 relativo
all’obbligo di privilegiare il rimpatrio volontario entro un congruo termine su quello coattivo,
l’imputato del reato previsto dall’art. 10 bis D.L.vo 25 luglio 1998 n.286, va mandato assolto
perché il fatto non è previsto come reato con riferimento al periodo di trattenimento nel territorio
dello Stato sino allo scadere del termine previsto per il rimpatrio volontario.
Giudice di Pace di Mestre – Ord. del 16.03.2011 – Giud. Trucillo - Imp. XY
Direttiva 2008/115 CE – Applicabilità del reato di ingresso e soggiorno irregolare nel territorio
dello Stato (art. 10 bis T.U.) - Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
Va rimessa pregiudizialmente alla Corte di Giustizia la questione se la direttiva 2008/115 CE osti
alla previsione nazionale di cui all’art. 10 bis T.U. Immigrazione, che consideri reato punito con
l’ammenda da 5.000,00 a 10.000,00 euro il mero ingresso o trattenimento nel territorio nazionale
(in violazione delle disposizioni dettate in tema di immigrazione) del cittadino di paesi terzi. In
particolare va rimessa la questione se la deroga prevista dall’art.2 par.2 lett. b) della direttiva osti
all’applicazione dell’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva prevista dall’art. 16 T.U.
Immigrazioni, con particolare riferimento all’interpretazione del termine rimpatrio usato dal
legislatore comunitario e alla sua sovrapponibilità o meno, a quello di espulsione previsto dalla
citata disposizione interna.
L’ordinanza così motiva:
(Omissis). – Nel caso in esame sul quale è tenuto a pronunciare questo giudice, viene in rilievo la
disciplina dettata dall’art. 10 bis del D.L.vo. del 25 luglio 1998 n. 286 (ed T.U. immigrazione)
inserito nell’ordinamento nazionale dalla legge 15 luglio 2009, n. 94. Il predetto articolo dispone al
1° comma: “Salvo che il fatto costituisce più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si
trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizione del presente T.U., nonché di
quelle di cui all’art. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68 è punito con l’ammenda da euro 5.000,00
fino a 10.000,00. Qualora si giunga ad una sentenza di condanna per tale contravvenzione, il
giudice ha la facoltà ex art. 16 T.U. Immigrazioni, sempre che non ricorrano le cause ostative
dell’art. 14 comma 1, che impediscono l’esecuzione immediata della espulsione con
l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, di sostituire la pena pecuniaria con
la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore ai cinque anni.
NOTA
Questo provvedimento è successivo alla direttiva 2008/115 CE del 16 dicembre 2008 del
parlamento Europeo recante norme e procedure comuni applicate negli Stati inerenti al rimpatrio di
cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare, il cui termine di attuazione è scaduto il 24 dicembre
2010. In proposito secondo l’orientamento maggioritario espresso dai commentatori italiani, la
citata direttiva, avendo un contenuto punitivo chiaro, e incondizionato, quindi l’immediata
applicazione, senza necessità di alcun intervento da parte del legislatore nazionale, è divenuta self
executing, alla scadenza prevista per il recepimento. Se così è, occorre domandarsi, alla luce delle
disposizioni dettate dal legislatore comunitario, se esso ammette la possibilità, per uno Stato
membro, di punire con una fattispecie di reato, la condotta di un cittadino di un paese terzo che
soggiorni irregolarmente nel territorio comunitario.
Ebbene nella fattispecie disegnata dal legislatore italiano, non è attribuito alcun rilievo ai motivi che
hanno determinato l’ingresso e la permanenza irregolare se non per quanto attiene al quantum della
sanzione irrogabile, nemmeno qualora essi possano, in astratto, essere meritevoli di giustificare la
condotta del reato. Tale situazione, appare esattamente antitetica a quella perseguita dal legislatore
comunitario. Inoltre secondo le disposizioni nazionali citate, l’applicazione dell’ammenda
(sostituibile con un provvedimento di espulsione, per la verità poco attuato e di fatto poco attuabile
per vari motivi) discenderebbe direttamente dalla irregolarità del soggiorno, mentre ai sensi della
direttiva comunitaria lo Stato membro dovrà adottare una decisione di rimpatrio (art. 6.1.).
Ora alla luce di quanto detto, viste le discrasie tra quanto dispone il legislatore comunitario e quanto
concretamente è stabilito dalla normativa nazionale, (posta in luce anche dal difensore
dell’imputato con il conseguente rinvio) si potrebbe dedurre che, qualora la normativa nazionale sia
ritenuta incompatibile con il diritto comunitario la stessa debba essere disapplicata con conseguente
obbligo per questo giudicante di assolvere l’imputato dal reato ascrittogli.
Va inoltre considerata l’ipotesi che la Corte in indirizzo ritenga che la normativa comunitaria possa
essere interpretata nel senso di consentire l’istituzione di un reato di immigrazione clandestina,
strutturato come quello previsto dal legislatore italiano. In questo caso viene da sollevare il quesito
in relazione all’applicazione delle garanzie previste dalla direttiva 2008/115 CE.
La predetta direttiva all’art. 2 stabilisce che essa trova applicazione nei confronti dei cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare. Tuttavia vengono
previste delle deroghe a tale principio per:
- gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva a cittadini di Stati terzi se
sottoposti a respingimento alla frontiere, o fermati e scoperti dalle autorità in occasione
dell’attraversamento irregolare (via terra, mare o aria) della frontiera esterna di uno Stato membro
o che non hanno successivamente ottenuto un autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato
(art. 2 par. 2 lett. b);
- coloro che sono sottoposti al rimpatrio, come sanzione penale in conformità alla legislazione
nazionale, o sottoposti a procedura di estradizione (art. 2 lett. b).
Ebbene nel caso di interpretazioni estensive dell’art. 2 par. 2 lett. b direttiva 2008/115 Ce pare che il
legislatore nazionale abbia voluto eludere le garanzie dettate dal legislatore comunitario in materia
di rimpatrio di cittadini di paesi terzi, facendo si che il titolo posto alla base dell’intero
procedimento di espulsione sia costituito da un provvedimento giudiziale di espulsione
espressamente qualificato dal diritto interno come sanzione sostitutiva di carattere generale.
Pertanto le disposizioni della direttiva non troverebbero applicazione, sia per quanto attiene al
modus privilegiato del legislatore (partenza volontaria), sia per quanto attiene al tempus (termine di
sette o trenta giorni).
Se invece si ha l’interpretazione restrittiva dell’art. 2 par. 2 lett. b) della direttiva 2008/115 Ce allora
consegue che anche all’espulsione disposta come sanzione sostitutiva del reato di immigrazione
clandestina, (nei limiti già detti) sempre se tale fattispecie è compatibile con le direttive,
andrebbero applicate le disposizioni stabilite dalla predetta direttiva.
Di qui la necessità di sottoporre alla Corte di Giustizia i seguenti quesiti:
- se la direttiva 2008/115 CE osti alla previsione nazionale, quale quella di cui all’art. 10 bis
D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 che consideri reato punito con l’ammenda da 5.000,00 a
10.000,00 euro, il mero ingresso o trattenimento nel territorio nazionale, in violazione delle
disposizioni dettate in tema di immigrazione, del cittadino di paesi terzi;
- se l’art. 2 par.2 lett. b) della direttiva 2008/115 Ce possa essere interpretato nel senso di
escludere l’ambito di applicazione delle garanzie previste dalla citata direttiva all’espulsione
disposta a titolo di sanzione sostitutiva, quale quella prevista dall’art. 16, comma 1D.L.vo 25
luglio 1998, n. 286, a seguito della commissione di una fattispecie di reato che punisca il
mero ingresso ovvero trattenimento nel territorio nazionale, quale quella prevista all’art. 10
bis D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286. [Marco Vianello]
14
Corte d’Appello di Venezia – Prima Sezione Penale – Ord. 9.03.2011 – Est. Casol – Imp. XY
Correzione di errori materiali – Procedimento - Omessa pronuncia in merito alle statuizioni
civili – Ammissibilità
(Art. 130 c.p.p.)
Deve considerarsi errore materiale della sentenza, emendabile de plano, l’omessa indicazione
tanto della presenza della parte civile quanto della conferma delle statuizioni civili.
NOTA
La presente ordinanza della Corte d’Appello di Venezia si pone come fonte di profonde riflessioni
tanto per quanto attiene all’aspetto procedurale, quanto in relazione al concetto stesso di errore
materiale.
In merito al primo profilo, si sottolinea come la Corte Veneta abbia assunto il presente
provvedimento de plano, senza l’instaurazione di alcun contraddittorio, nonostante la previsione
dall’art. 130 c.p.p. che rimanda espressamente al procedimento in camera di consiglio ex art. 127
c.p.p. Se è pur vero, infatti, che la correzione dell’errore materiale può essere disposta, ex art. 130
comma I c.p.p., “anche d’ufficio”, tale locuzione si riferisce evidentemente all’impulso, non
necessariamente di parte, necessario per l’adozione del provvedimento correttivo, ma certamente
non attiene all’iter da adottarsi per l’emenda dello stesso. E’ certo infatti che, attraverso il richiamo
all’art. 127 c.p.p., il compilatore ha voluto che le parti, per definizione interessate alla modifica dei
provvedimenti giudiziari, debbano essere messe nelle condizioni di partecipare all’udienza di
correzione secondo, appunto, le meno rigide regole del procedimento in camera di consiglio. Regole
che, comunque, impongono la fissazione di un’udienza e dispongono che ne sia dato ed assicurato
avviso della stessa alle parti.
Per quanto attiene invece al concetto di errore materiale, è utile precisare come l’ordinanza in
questione sia venuta a correggere una sentenza dichiarativa di non doversi procedere per estinzione
del reato per intervenuta prescrizione, nella quale nulla era stato disposto in punto di statuizioni
civili, già riconosciute dal giudice di primo grado.
La Corte d’Appello di Venezia, quindi, ha ritenuto di far rientrare nel concetto di errori materiali
anche le omissioni relative alle statuizioni civili e con ciò incorrendo, a parere di chi scrive, in due
imprecisioni.
Primariamente, nella specie non si tratterebbe tanto di errori materiali, quanto di vere e proprie
omissioni che, a volere del codice di rito, possono essere corrette solo ove non determinino nullità e
ove non comportino una modificazione essenziale dell’atto; secondariamente, per insegnamento
costante della giurisprudenza di legittimità, si può porre rimedio alle omissioni ed agli errori solo
ove gli stessi riguardino statuizioni obbligatorie di natura accessoria a contenuto predeterminato le
quali, quindi, non vadano a modificare la portata essenziale del provvedimento.
Di fatto, possono quindi essere “sanate” solo le omissioni che non richiedono alcun potere
discrezionale da parte del giudice; tutte le altre dovranno essere emendate attraverso gli ordinari
strumenti di impugnazione degli atti.
Nella specie, è proprio l’art. 578 c.p.p. a pretendere che il giudice d’appello debba adottare una
decisione sull’impugnazione, sebbene ai soli effetti delle statuizioni civili. Tale decisione,
certamente più approfondita e pregnante di quella richiesta dal comma 2 dell’art. 129 c.p.p., è
quindi per definizione discrezionale e pertanto non può essere “sanata”, laddove omessa, attraverso
la procedura di correzione degli errori materiali di cui all’art. 130 c.p.p. [Paola Loprieno]
15
Tribunale Ordinario di Padova – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari – Ord. 1.3.2011 –
Est. Cameran – Imp. XY
Misura cautelare personale non custodiale – Irrevocabilità – Sentenza di condanna –
Cessazione
(Art. 657 e Art. 300 c.p.p.)
Ogni restrizione di libertà deve avere un titolo, che può riguardare la cautela durante il processo o
la esecuzione dopo; che un trattamento cautelare dopo la sentenza irrevocabile di condanna non
avrebbe senso; che la sua fungibilità e la sua continuità con la pena può essere stabilita solo dalla
legge, ed è quello che avviene per la custodia cautelare con gli artt. 657 e 300 co. 4 c.p.p., sulla
base, essenzialmente, di una “analogia” di contenuto con le sanzioni detentive, oltre che per una
ratio di continuità della prevenzione speciale, nei casi più gravi. E tale continuità garantisce
naturalmente le esigenze cautelari antecedenti al passaggio in giudicato, quando siano così
pressanti da richiedere la massima restrizione concepibile. Quando però la fungibilità manca,
perché la misura restrittiva non è considerata fungibile con la pena detentiva, appare ineludibile la
cessazione del trattamento che, del resto, ha fronteggiato fino a quel momento esigenze di spessore
non particolarmente rilevanti.
SEZIONE TERZA - DOTTRINA E DOCUMENTI
16
PROFILI DI APPLICAZIONE DELL’ ISTITUTO DELLA CONTINUAZIONE IN SEDE DI
COGNIZIONE ED IN SEDE ESECUTIVA
NOTA
L’istituto della continuazione, disciplinato dall’art. 81 C.P., richiede, quali elementi costituitivi e
qualificanti, l’esecuzione di un medesimo disegno criminoso e, al contempo, la prossimità
temporale delle azioni od omissioni che lo caratterizzano.
Appare opportuno evidenziare che la predetta unicità del disegno criminoso non può identificarsi
con la generale tendenza a porre in essere determinati reati, atteso che le singole violazioni devono
costituire parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un
determinato fine, richiedendosi, in proposito, la progettazione "ab origine" di una serie ben
individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali come un tutto
unitario.
Per quanto attiene alla contiguità temporale, essa deve essere intesa come la vicinanza nel tempo
delle condotte poste in essere dal soggetto agente, così da poter ricondurre dette condotte e i relativi
episodi criminosi nell’ambito di un unico progetto illecito ideato dall’agente medesimo.
Conseguentemente, l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la
contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra i fatti diversi, la successione degli
episodi sia tale da escludere logicamente la preventiva programmazione dei distinti reati, ponendo,
invece, in risalto l’occasionalità sopravvenuta di uno dei due (cfr. Cass. 35805 del 24.5.2007).
Pare opportuno, altresì, evidenziare che la materia della continuazione risulta fondata su una fictio
juris determinata dal principio del favor rei, per cui più reati concorrenti vengono considerati come
un unico reato al fine di attenuare il rigore del cumulo materiale delle pene.
Il vincolo della continuazione può ravvisarsi sia fra reati “interni” al medesimo procedimento, sia
fra reati ad esso “esterni”, fino a comprendere anche quelli già coperti da giudicato, da attuarsi ai
sensi dell’art. 671 C.P.P.
E’, quest’ultima, un’evenienza che pone delle problematiche lì dove i giudizi siano stati celebrati in
forme diverse ed, in particolare, nelle forme del rito ordinario l’uno e, del rito abbreviato nell’altro.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha assunto due diversi atteggiamenti.
Infatti, nel caso in cui si riconosca, in un giudizio abbreviato, l’esistenza del vincolo della
continuazione fra il reato per cui si procede ed altro precedentemente giudicato con rito ordinario,
si deve ritenere non realizzabile la riduzione di un terzo della pena, ai sensi dell’art. 442 C.P.P.,
sull’aumento di pena determinato ex art. 81 C.P. per i reati satelliti, poiché la riduzione del
trattamento sanzionatorio è subordinata, tassativamente e senza eccezioni, al fatto che la condanna
sia intervenuta a seguito di un giudizio abbreviato 19; e ciò in quanto la scelta del rito alternativo è
stata operata solo nell'ambito di quel particolare rapporto processuale e, pertanto, non è possibile
estendere i conseguenti benefici anche al giudizio celebrato nelle forme ordinarie.
Diversamente accade, di contro, nell’ipotesi in cui la disciplina del reato continuato debba essere
applicata in sede esecutiva, allorquando, cioè, tutte le sentenze siano già passate in giudicato, sia
pure una (o più) all’esito di un giudizio abbreviato e l’altra (o le altre) a seguito di un giudizio
ordinario.
19
Cass. n. 33856 del 9.7.2008. In tal senso Cass. n. 43024 del 25.09.2003.
In tal caso, la riduzione di pena conseguente alle prime deve essere estesa anche quando risulta più
grave la violazione di cui ai reati giudicati con il rito ordinario20.
Pur condividendo l’orientamento secondo cui la riduzione premiale per la scelta del rito abbreviato
non può trovare applicazione estensiva, in sede di cognizione, nell’ipotesi in cui i reati oggetto del
procedimento in corso siano da porre in continuazione con reati oggetto di separato giudizio
ordinario, è necessario precisare che non vi è una giurisprudenza consolidata in materia e,
comunque, l’attuale posizione di legittimità si presta ad alcuni profili di critica.
Invero, non è dato comprendere per quali ragioni, solo in sede di esecuzione, debba essere esteso al
reato (o ai reati) oggetto di giudizio ordinario, in deroga al principio generale sopra ricordato, il
beneficio della riduzione premiale connesso alla scelta del rito.
Ciò che appare, dunque, decisivo è il fenomeno del passaggio in giudicato della sentenza.
Parte della giurisprudenza ha cercato di giustificare questa scelta interpretativa evidenziando che,
solo nel momento in cui la sentenza che definisce il giudizio abbreviato diventa irrevocabile, si
consolida in maniera definitiva, dal punto di vista sanzionatorio, un vantaggio che l’imputato ha
acquisito come corrispettivo di quello ottenuto dallo Stato, sotto il profilo della economia
processuale.
Pertanto, a parere del citato orientamento della Corte di legittimità, in conseguenza della scelta di
rito in questione non vi è alcuna ragione logica e giuridica, ne’ alcun ostacolo di carattere tecnico,
per cui il predetto vantaggio debba venir meno nel momento in cui, come effetto dell’applicazione
in fase esecutiva di un istituto ispirato al favor rei, quale la continuazione, la pena autonomamente
determinata sulla quale è stata fatta operare la riduzione ex art. 442 C.P.P., venga trasformata in un
aumento ex art. 81 C.P. (cfr. Cass. n. 40448 del 2.10.2007).
Questa diversità di trattamento implica, immancabilmente, un vulnus difensivo in quanto, a seconda
del momento in cui viene concretamente applicato l’istituito della continuazione, si producono
diverse conseguenze e ciò appare difficilmente comprensibile dal momento che i presupposti
applicativi della disciplina in esame risultano essere i medesimi in entrambi i casi.
Tale soluzione appare oltretutto anche illogica poiché la difesa dovrebbe attendere il passaggio in
giudicato di tutte le sentenze (sia quelle che giungono da rito ordinario che da rito abbreviato) prima
di poter ottenere tale beneficio.
Quanto precedentemente osservato, inoltre, incide poi ed inevitabilmente sulle modalità di calcolo
della pena.
Nel primo caso, infatti, la sequenza di calcolo del trattamento sanzionatorio dovrà seguire il
seguente ordine: individuazione della pena base per il reato più grave, applicazione del regime di
comparazione fra aggravanti ed attenuanti, eventuale aumento per la recidiva, calcolo della
continuazione per tutti i fatti del procedimento con, infine, l’applicazione della diminuente di un
terzo della pena. Su tale sanzione andrà, poi, calcolato un ulteriore aumento ex art. 81 C.P. come al
reato (o ai reati) già giudicati con il rito ordinario.
Nel secondo caso, invece, il calcolo della pena seguirà le modalità consuete con l’applicazione della
diminuente processuale solo dopo aver praticato l’aumento per la continuazione.
Per tutte queste ragioni, a parere di chi scrive, si ritiene utile sottolineare che, in base al principio
del favor rei, posto a fondamento dell’istituto in esame, come sopra evidenziato, non appare del
20
Cass. n. 49981 del 19.11.2009 “Allorché il Giudice dell’esecuzione riconosca la
continuazione fra più reati, alcuni dei quali oggetto di condanna all’esito di giudizio
abbreviato, la riduzione spettante a norma dell’art. 442 C.P.P. deve essere riconosciuta
anche quando, risultando violazione più grave quella giudicata con il rito ordinario, la pena
autonomamente determinata per il reato definito con il rito speciale, sulla quale è stata
operata la diminuzione ai sensi del citato art. 442 C.P.P., si trasformi in aumento ex art. 81
C.P., che va, pertanto, ridotto di un terzo”.
In tal senso, Cass. n. 44477 del 4.11.2009.
tutto illogico estendere la riduzione per il rito anche alle pene riguardanti fatti giudicati nelle forme
ordinarie. [Dott.ssa Giuseppina Maritato - Dott.ssa Melania Benetti; Praticanti Avvocato presso la
Corte d’Appello di Venezia]