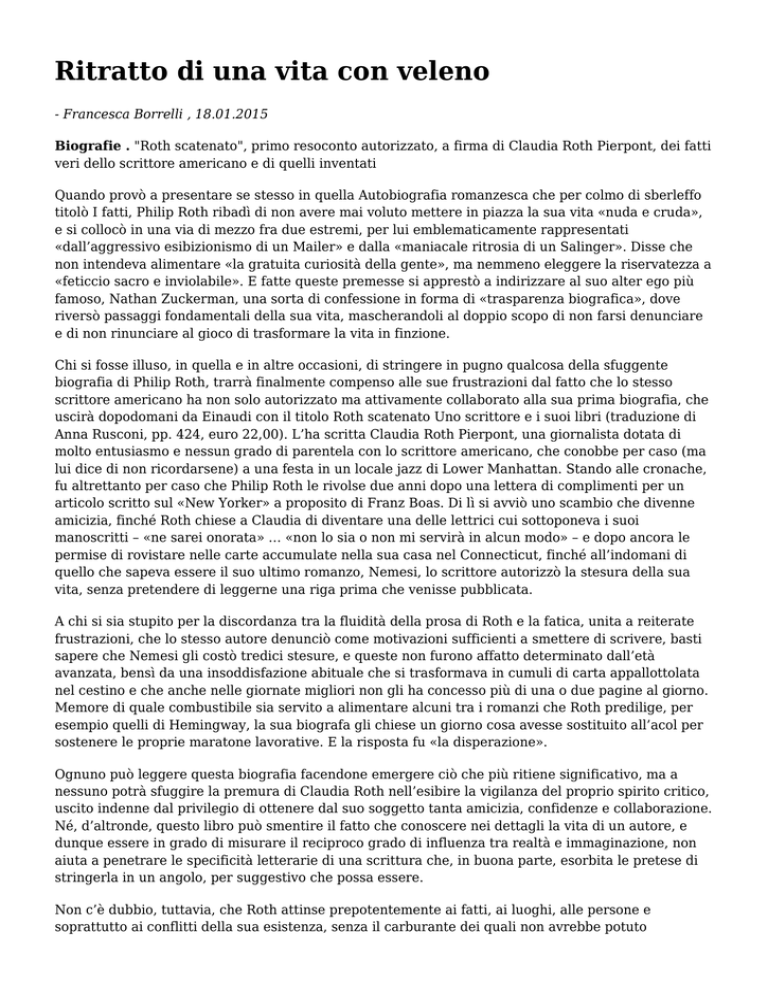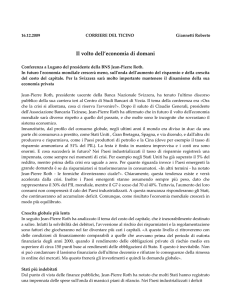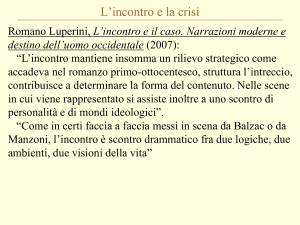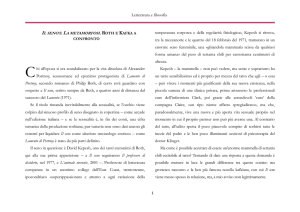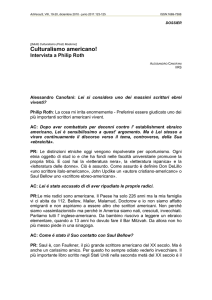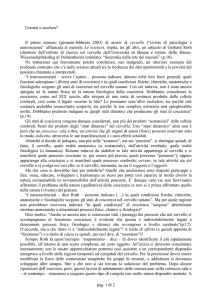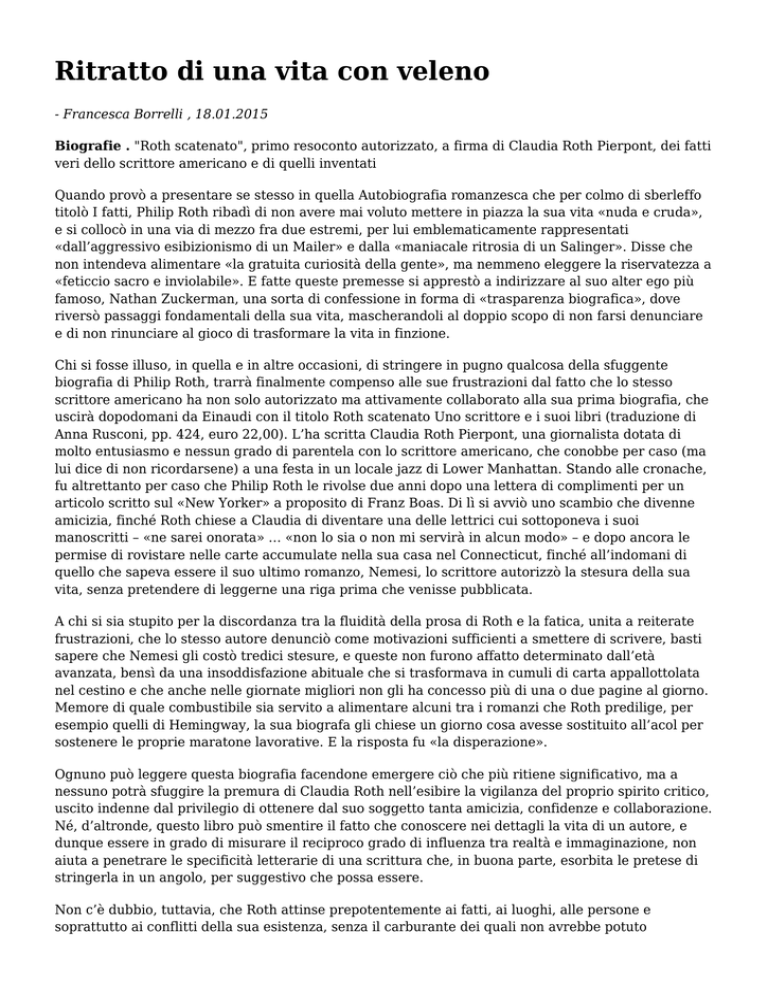
Ritratto di una vita con veleno
- Francesca Borrelli , 18.01.2015
Biografie . "Roth scatenato", primo resoconto autorizzato, a firma di Claudia Roth Pierpont, dei fatti
veri dello scrittore americano e di quelli inventati
Quando provò a presentare se stesso in quella Autobiografia romanzesca che per colmo di sberleffo
titolò I fatti, Philip Roth ribadì di non avere mai voluto mettere in piazza la sua vita «nuda e cruda»,
e si collocò in una via di mezzo fra due estremi, per lui emblematicamente rappresentati
«dall’aggressivo esibizionismo di un Mailer» e dalla «maniacale ritrosia di un Salinger». Disse che
non intendeva alimentare «la gratuita curiosità della gente», ma nemmeno eleggere la riservatezza a
«feticcio sacro e inviolabile». E fatte queste premesse si apprestò a indirizzare al suo alter ego più
famoso, Nathan Zuckerman, una sorta di confessione in forma di «trasparenza biografica», dove
riversò passaggi fondamentali della sua vita, mascherandoli al doppio scopo di non farsi denunciare
e di non rinunciare al gioco di trasformare la vita in finzione.
Chi si fosse illuso, in quella e in altre occasioni, di stringere in pugno qualcosa della sfuggente
biografia di Philip Roth, trarrà finalmente compenso alle sue frustrazioni dal fatto che lo stesso
scrittore americano ha non solo autorizzato ma attivamente collaborato alla sua prima biografia, che
uscirà dopodomani da Einaudi con il titolo Roth scatenato Uno scrittore e i suoi libri (traduzione di
Anna Rusconi, pp. 424, euro 22,00). L’ha scritta Claudia Roth Pierpont, una giornalista dotata di
molto entusiasmo e nessun grado di parentela con lo scrittore americano, che conobbe per caso (ma
lui dice di non ricordarsene) a una festa in un locale jazz di Lower Manhattan. Stando alle cronache,
fu altrettanto per caso che Philip Roth le rivolse due anni dopo una lettera di complimenti per un
articolo scritto sul «New Yorker» a proposito di Franz Boas. Di lì si avviò uno scambio che divenne
amicizia, finché Roth chiese a Claudia di diventare una delle lettrici cui sottoponeva i suoi
manoscritti – «ne sarei onorata» … «non lo sia o non mi servirà in alcun modo» – e dopo ancora le
permise di rovistare nelle carte accumulate nella sua casa nel Connecticut, finché all’indomani di
quello che sapeva essere il suo ultimo romanzo, Nemesi, lo scrittore autorizzò la stesura della sua
vita, senza pretendere di leggerne una riga prima che venisse pubblicata.
A chi si sia stupito per la discordanza tra la fluidità della prosa di Roth e la fatica, unita a reiterate
frustrazioni, che lo stesso autore denunciò come motivazioni sufficienti a smettere di scrivere, basti
sapere che Nemesi gli costò tredici stesure, e queste non furono affatto determinato dall’età
avanzata, bensì da una insoddisfazione abituale che si trasformava in cumuli di carta appallottolata
nel cestino e che anche nelle giornate migliori non gli ha concesso più di una o due pagine al giorno.
Memore di quale combustibile sia servito a alimentare alcuni tra i romanzi che Roth predilige, per
esempio quelli di Hemingway, la sua biografa gli chiese un giorno cosa avesse sostituito all’acol per
sostenere le proprie maratone lavorative. E la risposta fu «la disperazione».
Ognuno può leggere questa biografia facendone emergere ciò che più ritiene significativo, ma a
nessuno potrà sfuggire la premura di Claudia Roth nell’esibire la vigilanza del proprio spirito critico,
uscito indenne dal privilegio di ottenere dal suo soggetto tanta amicizia, confidenze e collaborazione.
Né, d’altronde, questo libro può smentire il fatto che conoscere nei dettagli la vita di un autore, e
dunque essere in grado di misurare il reciproco grado di influenza tra realtà e immaginazione, non
aiuta a penetrare le specificità letterarie di una scrittura che, in buona parte, esorbita le pretese di
stringerla in un angolo, per suggestivo che possa essere.
Non c’è dubbio, tuttavia, che Roth attinse prepotentemente ai fatti, ai luoghi, alle persone e
soprattutto ai conflitti della sua esistenza, senza il carburante dei quali non avrebbe potuto
combattere la fatica, anche fisica, che l’elaborazione della sua scrittura gli costava. A proposito di
luoghi vissuti, dopo avere trascorso a Londra sei mesi per otto anni consecutivi, si congedò dalla
città ricordandola come piacevole e, proprio perciò, disfunzionale al suo lavoro: perché – disse –
bisogna essere insofferenti per potere vedere. «Uno scrittore ha bisogno di veleni», racconta. E i
veleni non gli mancarono: il più potente, il più tenacemente infiltrato nei meandri della sua mente,
quello che più rischiò di essergli letale era dotato di un nome e un cognome, Margaret Martinson
Williams, dal 1959 sposata Roth. L’aveva scelta come compagna di vita poco prima dell’uscita di uno
dei suoi primi racconti, «Difensore della fede» (immediatamente attaccato per vilipendio dell’identità
ebriaca): protestante, biondissima, già in possesso di due figli, a una dei quali Roth si sarebbe assai
affezionato, Maggie gli era apparsa come «una sorta di incarnazione del sogno americano».
Tentò di liberarsene a più riprese, ma tutte furono vane: non soltanto impose la separazione, al
prezzo di vedersi estorte incredibili somme di denaro, ma si arrovellò per traslocare definitivamente
quella donna nei suoi libri. Finché un incidente automobilistico di cui Maggie restò vittima gli
strappò – nere su bianco – esclamazioni di esultanza, ma non ancora l’emancipazione dal fantasma di
lei.
Era così ossessionante la pressione emotiva di quei ricordi, che passarono sei anni dalla morte di
Margaret Martinson Williams prima che Roth riuscisse a trovare la giusta distanza per farne «la vera
eroina» della sua esistenza letteraria. Ci riuscì finalmente nella Mia vita di uomo, pubblicato nel
1974, dove alle sue sventure matrimoniali Roth intreccia quelle derivate dalla psicoanalisi: riportò
infatti sulla scena lo stesso dottor Spielvogel che aveva ascoltato Il Lamento di Portnoy, e nei cui
panni aveva calato il vero analista al quale si era rivolto nel passaggio più angoscioso della propria
vita; senonchè il dottore pensò bene di riportare il caso del suo illustre paziente su una rivista
scientifica, cambiandone il nome ma rendendone perfettamente riconoscibili le vicende. La vendetta
di Roth si tradusse in pagine memorabili.
Del resto, e molto più maniacalmente di quanto non si sarebbe disposti a credere, Roth trasse da
ogni dettaglio dei propri patemi le scintille per accendere la sua scrittura, formalmente esplosiva
prima ancora che contenutisticamente ribelle. Stando a questa biografia, non c’è donna che sia
passata nella vita dello scrittore americano senza trasferirsi in un ruolo romanzesco, e naturalmente
furono i passaggi più esasperati di ogni relazione a fruttargli le pagine migliori, a conferma del fatto
che i cattivi sentimenti giovano alla buona letteratura. Tuttavia, gli strascichi del matrimonio con
Maggie si tradussero nella più lunga «paralisi immaginativa» che Roth si sia mai concesso, dal ‘62 al
‘67, nel corso della quale si consolò brevemente anche con Jackie Kennedy, che solo una volta gli
dimostrò di sapere chi fosse, e fu quando lo invitò a salire da lei. Ma a distanza di anni, Roth ricorda
che baciarla «fu come baciare la faccia di una pubblicità». Meglio per lei, che scampò il rischio di
ritrovarsi fra le pagine di un romanzo.
Quasi nessun’altra ci riuscì, e l’elenco delle coincidenze tra nomi veri e nomi inventati è uno dei
passatempi che questo libro assicura, a chi se ne appassioni. Peraltro, quando nel 1996 Claire Bloom
pubblicò la propria autobiografia, le parti che riguardavano il suo matrimonio con Roth attrassero
sullo scrittore americano molto più interesse di quanto non gliene fosse venuto dal National Book
Award vinto l’anno prima per Il teatro di Sabbath, e di quante non gliene sarebbe arrivato, due anni
dopo, dal Pulitzer per Pastorale Americana.
Fu proprio per stare vicino a Claire Bloom che Roth si trasferì metà dell’anno a Londra: la
professione di attrice che lei esercitava con successo lo attraeva moltissimo, seguiva le sue prove, le
faceva ripetere i copioni: fu quando la vide in Luci della ribalta che se ne innamorò, ma passò quasi
un quarto di secolo prima di poterla avvicinare. I soggiorni londinesi cominciarono alla fine
dell’estate 1976, l’ambiente era elettrizzante, e Roth divenne in breve amico di Harold Pinter, di
John Le Carré, di Alfred Brendel.
A Londra conobbe anche una nipote di Kakfa, Marianne Steiner, che aveva ereditato alcuni dei
principali manoscritti dello zio da Max Brod. Con lei Roth parlò a lungo dei suoi ricordi praghesi, un
capitolo poco noto della biografia dello scrittore americano, che aveva cominciato a frequentare la
Cecoslovacchia nei primi mesi del 1972, accanto alla sua compagna di allora, Barbara Sproul, attiva
su quel fronte almeno quanto lui.
Fin dal suo secondo viaggio, Roth – che aveva fra le sue guide e i suoi alleati il drammaturgo e
romanziere Ivan Klíma e Milan Kundera – si fece dare un elenco di scrittori bisognosi e coinvolse un
gruppo di amici, tra i quali Updike, Alison Lurie, Cheevr, William Styron, John Hersey, perché li
sostenessero economicamente.Inoltre, progettò e diresse una collana della Penguin, «Writers from
the Other Europe», in cui pubblicava scrittori dell’est dei quali amava «il rapporto distaccato con il
realismo» e «la ricchezza della vena eccentrica».
Nel suo racconto di quegli anni riemerge ancora l’entusiasmo con il quale presentò quegli autori al
pubblico, commissionandone le prefazioni ai suoi amici, molti dei quali erano tra i più grandi
scrittori americani: «Volevo farli venire al mondo con squilli di tromba». A fronte di una avara
passione politica, che solo Nixon sembrò capace di trasformare in indignazione, altrettanto generosa
si conferma, alla lettura di questa sua biografia, la militanza di Roth sul fronte letterario, un fronte
sul quale consumò tutte le energie distolte ai suoi obiettivi erotici, e al tempo stesso sacrificò più o
meno tutti i rapporti della sua vita.
Le sparate antiebraiche dei suoi romanzi, per esempio, costarono lacrime di vergogna ai suoi parenti
piccolo borghesi, che dalla fine dell’Ottocento erano approdati a Newark con la grande ondata
migratoria degli ebrei russi e della Galizia polacca; e le sue mogli, nel migliore dei casi si arresero –
come disse Barbara Sproul – all’evidenza di avere «sposato i suoi libri», e nel peggiore dei rimanenti
casi si ritrovarono, neanche troppo trasfigurate, nei più bugiardi nonché lussuriosi esemplari che la
letteratura contemporanea abbia sfornato: ne fanno fede le varie maschere romanzesche assunte
dalla prima moglie Maggie, cui per fortuna seguì una sorta di antidoto di nome Ann Mudge, poi
emigrata nelle pagine di Everyman, che riuscì persino a trascinare Roth sul fronte pacifista: ancora
oggi lui la ricorda come uno tra i grandi amori della sua vita. Quanto ai suoi amici, anche loro
entrarono più o meno velatamente nei suoi libri e quando ne rimasero fuori, come nel caso di John
Updike, scontarono amaramente le recensioni critiche, e peraltro spesso malevole, di cui si erano
resi responsabili.
Ma forse mai come nel Teatro di Sabbath è possibile vedere all’opera l’abbraccio fusionale tra la vita
e le opere di Roth: pubblicato nel 1995, quel romanzo è ispirato dall’amore extraconiugale con una
sua vicina del Connecticut, trasferita nel personaggio di Drenka, e al tempo stesso si nutre dei
racconti sui trascorsi marinari e le esuberanze sessuali dell’amico pittore R. B. Kitaj; ma soprattutto
nasce dalla affannosa ricerca di un posto dove farsi seppellire, che Roth decise di intraprendere
all’indomani della morte prematura di un’altra amica e sua ex amante, Janet Hobhouse, sulla cui
tomba andava di notte, da solo, per assorbire l’atmosfera che avrebbe reso memorabili le
implorazioni di Sabbath sulla lapide della sua amata.
Nato da un senso di morte che, sebbene familiare a Roth non aveva mai preso possesso della sua
mente con altrettanta invadenza, Il teatro di Sabbath esibisce la più allegramente laida tra le
passioni erotiche, nella lingua più effervescente che lo scrittore americano avesse concepito: oggi la
considera «l’esperienza più libera della mia vita». Non a caso, al tempo della sua pubblicazione,
persino Frank Kermode si scomodò per dedicargli una recensione erudita, in cui si appellò a
paragoni con Thomas Mann, Milton, Robert Musil. Tempo due anni, e su tutt’altro registro Roth
avrebbe licenziato un altro capolavoro, Pastorale americana, che inaugura la fortunata stagione
della Trilogia americana, traversata da almeno un tema ricorrente: ciò che crediamo di sapere degli
altri è spesso drammaticamente sbagliato; e da un problema contenutisticamente e stilisticamente
impervio: come dare rappresentazione alla coscienza di un uomo che non sa di averne una.
Certo, parte del divertimento promesso dalla lettura di questa biografia deriva da una sorta di
agonismo che si crea tra i giudizi di Claudia Roth Pierpont e quelli di chi legge, tra divergenti
predilezioni e discordanze interpretative, con la tentazione costante di sondare lo iato tra i dettagli
della vita di Roth finalmente esibiti e gli indizi scovati al lume di una lettura ignara di altre leggi che
non siano quelle del testo. E forse, converrebbe tenere a mente, fin dalla prima pagina di questo
libro, l’ammonimento che Oscar Wilde seminò nella prefazione al Ritratto di Dorian Gray: «Ogni arte
è al tempo stesso realistica e simbolica. Chi varca i limiti di tale apparenza lo fa a proprio rischio e
pericolo».
© 2017 IL NUOVO MANIFESTO SOCIETÀ COOP. EDITRICE