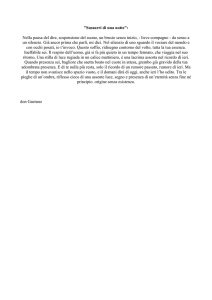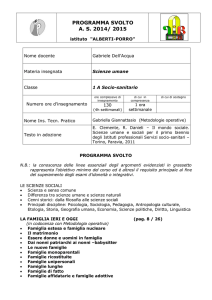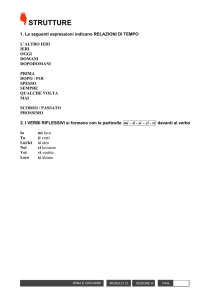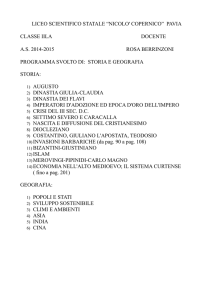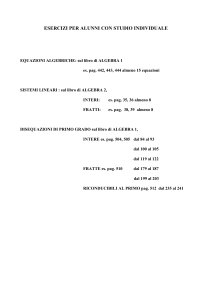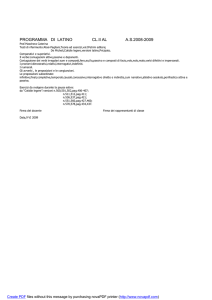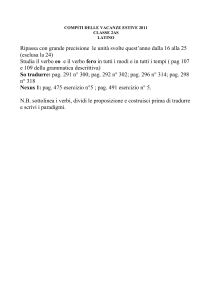RASSEGNA STAMPA
mercoledì 24 settembre 2014
ESTERI
INTERNI
LEGALITA’DEMOCRATICA
RAZZISMO E IMMIGRAZIONE
SOCIETA’
BENI COMUNI/AMBIENTE
INFORMAZIONE
CULTURA E SCUOLA
INTERESSE ASSOCIAZIONE
ECONOMIA E LAVORO
CORRIERE DELLA SERA
LA REPUBBLICA
LA STAMPA
IL SOLE 24 ORE
IL MESSAGGERO
IL MANIFESTO
AVVENIRE
IL FATTO
IL RIFORMISTA
PANORAMA
L’ESPRESSO
VITA
LEFT
IL SALVAGENTE
INTERNAZIONALE
L’ARCI SUI MEDIA
Da Ansa del 23/09/14
Ue: Arci, no a nomina di Navracsics a
commissario educazione
Lettera aperta presidente Chiavacci parlamentari europei
ROMA
(ANSA) - ROMA, 23 SET - La presidente nazionale dell'Arci, Francesca Chiavacci, ha
inviato una lettera ai parlamentari europei perché sostengano la richiesta, avanzata con
una lettera aperta da diverse reti associative europee, di non accettare la nomina di Tibor
Navracsics a Commissario Educazione, Cultura, Giovani e Cittadinanza. "In sintonia con le
motivazioni espresse nella lettera aperta", Chiavacci afferma di "non ritenere adatto a un
simile incarico l'esponente del partito al potere in Ungheria, che intimidisce le associazioni
e colpisce la libertà di stampa". E questo perché "educazione, cultura, giovani e
cittadinanza dovrebbero rappresentare settori prioritari per l'Unione Europea nella
prossima legislatura, oltre a essere tematiche che fanno di quella Commissione il
riferimento necessario per tutte le associazioni democratiche europee". Secondo la
presidente dell'Arci "il malessere sociale che attraversa il continente e che sta trovando
una pericolosa sponda in formazioni reazionarie e razziste, richiede all'Europa, oltre a
scelte diverse in materia economica e finanziaria, un deciso impegno per la cultura, per le
giovani generazioni, per allargare la partecipazione democratica e promuovere la
cittadinanza attiva".
Queste esigenze, conclude, "non possono trovare adeguata risposta se verrà confermata
la scelta di Navracsics in quel ruolo".(ANSA).
Da Redattore Sociale del 23/09/14
Arci ai parlamentari europei: "Non accettate
la nomina di Tibor Navracsics"
La presidente nazionale Francesca Chiavacci ha inviato una lettera ai
parlamentari europei perché sostengano la richiesta, avanzata da
diverse reti associative europee, di non accettare la nomina del
commissario ungherese. "Intimidisce le associazioni e colpisce la
libertà di stampa"
ROMA - La presidente nazionale dell’Arci, Francesca Chiavacci, ha inviato una lettera ai
parlamentari europei perché sostengano la richiesta, avanzata con una lettera aperta da
diverse reti associative europee, di non accettare la nomina di Tibor Navracsics a
Commissario Educazione, Cultura, Giovani e Cittadinanza.
In sintonia con le motivazioni espresse nella lettera aperta, Chiavacci afferma di non
ritenere adatto a un simile incarico l’esponente del partito al potere in Ungheria "che
intimidisce le associazioni e colpisce la libertà di stampa".
"Educazione, cultura, giovani e cittadinanza dovrebbero rappresentare infatti settori
prioritari per l’Unione Europea nella prossima legislatura - si afferma -, oltre a essere
2
tematiche che fanno di quella Commissione il riferimento necessario per tutte le
associazioni democratiche europee".
Secondo la presidente dell’Arci, "il malessere sociale che attraversa il continente e che sta
trovando una pericolosa sponda in formazioni reazionarie e razziste, richiede all’Europa,
oltre a scelte diverse in materia economica e finanziaria, un deciso impegno per la cultura,
per le giovani generazioni, per allargare la partecipazione democratica e promuovere la
cittadinanza attiva". "Queste esigenze - conclude - non possono trovare adeguata risposta
se verrà confermata la scelta di Navracsics in quel ruolo. Di qui la richiesta ai parlamentari
di opporsi a tale nomina.
Da Globalist.it del 23/09/14
Arci, la Chiavacci scrive ai parlamentari
europei
La richiesta è di non accettare la nomina di Tibor Navracsics a
Commissario Educazione, Cultura, Giovani e Cittadinanza.
In sintonia con le motivazioni espresse nella lettera aperta, Chiavacci afferma di non
ritenere adatto a un simile incarico l'esponente del partito al potere in Ungheria che
intimidisce le associazioni e colpisce la libertà di stampa.
Educazione, cultura, giovani e cittadinanza dovrebbero rappresentare infatti settori
prioritari per l'Unione Europea nella prossima legislatura, oltre a essere tematiche che
fanno di quella Commissione il riferimento necessario per tutte le associazioni
democratiche europee.
Secondo la presidente dell'Arci, Il malessere sociale che attraversa il continente e che sta
trovando una pericolosa sponda in formazioni reazionarie e razziste, richiede all'Europa,
oltre a scelte diverse in materia economica e finanziaria, un deciso impegno per la cultura,
per le giovani generazioni, per allargare la partecipazione democratica e promuovere la
cittadinanza attiva. Queste esigenze non possono trovare adeguata risposta se verrà
confermata la scelta di Navracsics in quel ruolo. Di qui la richiesta ai parlamentari di
opporsi a tale nomina.
LEGGI LA LETTERA IN VERSIONE INTEGRALE
http://www.globalist.it/Detail_News_Display?ID=63022&typeb=0&Arci-la-Chiavacci-scriveai-parlamentari-europei
Da Internazionale.it e Asca del 24/09/14
A Lampedusa a convegno attivisti dalle due
rive del Mediterraneo
La prossima settimana il Festival Sabir (ASCA) – Roma, 24 set 2014 – Intorno al primo
anniversario della grande strage di migranti dello scorso anno, nell’ambito del Festival
Sabir, due giorni di forum internazionale il 2 e il 4 ottobre. Arriveranno a Lampedusa un
gran numero di attivisti sociali della sponda nord e sud del Mediterraneo, quelli che tutti i
giorni con le unghie e con i denti difendono democrazia, diritti e dignita’ contro potenti
avversari e grandi minacce economiche, militari, sociali e culturali.
Discuteranno, in modo orizzontale e paritario, con europarlamentari progressisti,
intellettuali, personalita’ e artisti alla ricerca delle alleanze possibili e necessarie
sull’agenda di mobilitazione del prossimo anno e sulle Alternative Mediterranee.
3
http://www.internazionale.it/news/asca/2014/09/24/a-lampedusa-a-convegno-attivisti-dalledue-rive-del-mediterraneo/
4
ESTERI
del 24/09/14, pag. 1/6
Siria, tempesta di missili sui jihadisti Gli Usa:
“Volevano colpirci”
I raid compiuti con cinque paesi arabi contro l’Is, al Nusra e le milizie
Khorasan Obama: “Non è una guerra solo americana”
FEDERICO RAMPINI
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE
NEW YORK
«LA NOTTE scorsa, ai miei ordini le nostre forze armate hanno cominciato gli attacchi
contro lo Stato Islamico in Siria. Questa non è solo una lotta dell’America, con noi c’è
un’ampia coalizione». Barack Obama parla subito dopo la tempesta di missili e
bombardamenti aerei scatenata sulle milizie jihadiste in Siria. Il presidente rivela cosa lo
ha spinto ad accelerare i tempi dei raid aerei: un nuovo gruppo nato da Al Qaeda,
Khorasan, ha per missione prioritaria degli attentati terroristici in America e in Europa.
«Non ci sarà un rifugio sicuro per loro», scandisce Obama. Guidato da un ex luogotenente
di Osama Bin Laden, Khorasan è «a uno stadio avanzato di preparazione di attentati»,
spiega il comando operativo del Pentagono (Central Command o Centcom). Stanno
reclutando seguaci con passaporti occidentali, li addestrano come “fattorini del terrore”,
perché s’imbarchino su voli diretti in America e in Europa. Gli attentati userebbero
esplosivi dissimulati in «telefonini, computer portatili, materiali non metallici come tubetti di
dentifricio», secondo Centcom. I raid nella notte fra lunedì e martedì sono serviti «a
sventare la preparazione di attacchi imminenti contro obiettivi americani o in Europa».
Il Pentagono fornisce un elenco dettagliato: bersagli colpiti, forze aeree Usa e dai cinque
paesi arabi si sono unite all’offensiva americana. La tempesta di fuoco si è abbattuta su 14
bersagli distribuiti in quattro provincie della Siria. Uccisi 70 militanti, distrutti o colpiti
«campi di addestramento, basi, arsenali, depositi, veicoli e armi ». Nell’offensiva sono stati
lanciati 50 missili di crociera Tomahawk partiti da navi americane nel Golfo Persico e nel
Mar Rosso. Sono entrati in azione caccia-bombardieri F-15, aerei di ricognizione e
spionaggio elettronico. C’è stato perfino il battesimo di un apparecchio nuovo e
controverso, il caccia “invisibile” F-22 Raptor, costato 300 milioni di dollari per esemplare
(studiato all’ounicamente rigine per “bucare” le difese iraniane e attaccare i siti nucleari di
Teheran, secondo gli esperti). Secondo l’ammiraglio John Kirby, portavoce del Pentagono,
«questo è solo l’inizio».
La geografia dei bersagli è importante. Gli attacchi hanno colpito Raqqa che è in un certo
senso la capitale dello Stato Islamico, nonché le zone di Hasaka e Deir Al-Zour dove i
pozzi petroliferi sono una fonte di finanziamento dei jihadisti. Altri attacchi «condotti dagli
americani» hanno preso di mira la zona di Aleppo dove c’è il nuovo nemico, balzato al
rango di pericolo numero uno per l’America, cioè Khorasan. A differenza dell’Is, che ha
prima di tutto ambizioni territoriali in Medio Oriente e cioè la costruzione del Grande
Califfato, questa scheggia di Al Qaeda che è Khorasan ha nel suo statuto l’obbligo di
colpire l’Occidente. Infine, i raid aerei hanno colpito anche il Fronte Nusra, altra
derivazione di Al Qaeda della quale si era ipotizzato un possibile coinvolgimento a fianco
degli americani. «I militanti di Al Nusra che abbiamo colpito erano stranieri», precisa il
5
Centcom, a conferma dell’ondata di jihadisti che affluiscono in Siria dall’estero. E secondo
Al Nusra, un loro leader sarebbe stato ucciso durante i raid.
Obama sottolinea «la forza della coalizione che combatte insieme a noi». Elenca i paesi
arabi che hanno mandato i loro jet militari: Arabia Saudita, Giordania, Emirati arabi uniti,
Qatar, Bahrain. L’elenco è significativo in quanto c’è lì dentro una forte rappresentanza del
mondo sunnita, a riprova che i jihadisti dell’Is (pur combattendo anzitutto contro gli sciiti)
sono considerati un gravissimo pericolo anche dai loro “compagni di fede”. L’intervento dei
cinque paesi arabi serve anche a rafforzare la tesi americana secondo cui questi raid
avvengono nel rispetto della legalità interna- zionale, avvengono «per difendere l’Iraq, a
sua richiesta, contro l’aggressione esterna».
E Damasco? Nessuna opposizione, anzi una tacita approvazione degli attacchi americani
sul territorio della Siria, da parte di quel dittatore Assad che poco più di un anno fa
rischiava di essere lui il bersaglio di un bombardamento Usa (dopo le stragi di civili
compiute con armi chimiche). Damasco e Washington concordano sulla stessa versione:
«La Siria è stata informata in anticipo dei raid». Ma la Casa Bianca aggiunge due
precisazioni: «Non c’è stato nessun tipo di coordinamento. Li abbiamo avvisati solo perché
evitassero qualunque atto ostile contro i nostri aerei». Da parte americana si fa di tutto per
fugare l’impressione di un’alleanza “oggettiva” tra Obama e Assad. L’atteggiamento siriano
però di fatto attenua le obiezioni che erano state mosse dalla Russia e dall’Iran contro la
violazione dello spazio aereo e della sovranità territoriale nel caso di bombardamenti aerei
non autorizzati preventivamente.
La prima notte di attacchi aerei porta con sé l’inevitabile scenografia eccitata che
accompagna sempre le esibizioni della potenza aerea americana. Da Shock and Awe in
poi, il mondo è abituato alle prodezze tecnologiche della U.S. Air Force, nonché degli
arsenali missilistici più precisi del mondo. E tuttavia dietro i toni ufficiali Washington non
nutre illusioni: la lotta sarà dura, i raid non saranno risolutivi, altri dovranno metterci quegli
“scarponi sul terreno” senza i quali non si vince mai. Lo dimostra l’Iraq, dove questi raid
durano da un mese e non hanno salvato neppure i peshmerga curdi da gravi sconfitte sul
terreno. Tra i “segni meno” va aggiunta la latitanza della Turchia, unico paese musulmano
della Nato, che però starebbe considerando un proprio appoggio militare. In quanto agli
alleati europei della Nato, Matteo Renzi appena arrivato a New York fa sapere che l’Italia
fa parte della coalizione anti-Is ma vi parteciperà nel rispetto dei principi delle Nazioni
Unite e delle procedure del Parlamento italiano. Francia e Inghilterra probabilmente si
faranno vedere nelle prossime missioni aeree. E Obama con un gesto molto inusuale,
oltre a intervenire come tutti i capi di Stato all’assemblea generale, presiederà
personalmente una sessione del Consiglio di sicurezza Onu. All’ordine del giorno il
presidente americano mette i seguenti obiettivi: «Tagliare le fonti di finanziamento dei
jihadisti, contrastare la loro ideologia dell’odio, bloccare il flusso di combattenti verso
quell’area».
del 24/09/14, pag. 1/11
Damasco è soddisfatta per i raid. Teheran, solo apparentemente è
esclusa dai giochi: in realtà guida milizie sciite che godono
dell’appoggio aereo Usa e si muovono in sintonia con i vertici di Riad, la
potenza campione dei sunniti
6
Gli alleati arabi e la mano dell’Iran quello
strano patto che piace ad Assad
BERNARDO VALLI
ERA prevista da tempo. Ad affrettarla deve avere contribuito la pessima situazione militare
in Iraq. Adesso l’estensione dell’offensiva aerea americana alla Siria dà al tentativo di
contenere e col tempo distruggere l’autoproclamato Stato islamico tutti gli attributi di una
guerra vera. La durata? Sarebbe azzardato fare pronostici. Barack Obama si è ben
guardato dal farne. In quanto agli sviluppi il presidente americano non sembra invece
avere dubbi. Lui non lascerà un solo “santuario” ai terroristi. Ma l’impresa chiede tempo e
rischia di finire nella mani del prossimo inquilino della Casa Bianca.
Un intervento più ampio, sostenuto anche da paesi arabi, comunque si imponeva. Era
urgente. Sul piano politico e militare. L’allargamento del conflitto a gran parte della regione
del Tigri e dell’Eufrate, la Mezza Luna Fertile degli storici, un tempo “culla di civiltà”
diventata valle di tragedie, non riesce tuttavia a dissipare la confusione creata da un
groviglio di alleanze e di doppi giochi.
L’appoggio aereo degli Stati Uniti nelle ultime sei settimane ha consentito alle forze armate
irachene e alle milizie curde alleate di fermare la marcia su Bagdad delle truppe del
“califfato”, ma non ha evitato pesanti sconfitte nel resto dell’Iraq. Al punto che il governo
nazionale perde terreno, non controlla più circa un quarto del paese. Nelle province a
maggioranza sunnita, in particolare quella di Anbar, attigua alla capitale, intere unità sono
state circondate e decimate. Anche con esecuzioni sommarie. La passività della
popolazione sunnita, o addirittura la sua collaborazione, hanno favorito e favoriscono le
forze jihadiste del califfato espressione dell’estremismo sunnita. La solidarietà più
comunitaria che religiosa, gestita da un mosaico di tribù e dai residui dell’esercito di
Saddam Hussein ansiosi di una rivincita sugli sciiti, è un’arma efficace nelle mani dello
Stato islamico. Nella stessa Siria settentrionale quest’ultimo ha guadagnato terreno
provocando l’esodo della popolazione curda verso la Turchia.
Era dunque indispensabile colpire al più presto l’avversario nella sua tana siriana, nella
provincia settentrionale di Raqqa, la “capitale” dello Stato islamico. Da dove arrivano ordini
e aiuti. Ed era altrettanto urgente coinvolgere nell’operazione i paesi arabi sunniti, per
chiarire il loro fermo desiderio, armi alla mano, di distinguersi dall’estremismo sunnita.
Dichiarandosi un califfato esso si è posto al di sopra di tutti gli Stati musulmani, e ne ha
abolito virtualmente i confini poiché l’autorità del califfo abbraccia l’intero Islam.
L’autoproclamazione ha urtato tradizioni e suscettibilità. In molte capitali è apparsa
un’usurpazione. Una bestemmia. La partecipazione di Bahrein, della Giordania, del Qatar,
degli Emirati arabi uniti e soprattutto dell’Arabia saudita alle incursioni sulla Siria è stata
un’aperta dichiarazione di guerra a chi esercitando il terrorismo si è dichiarato successore
del Profeta, e quindi si è collocato in una posizione di superiorità rispetto agli stessi custodi
della Mecca e di Medina. La dignità offesa di presidenti, sovrani ed emiri al potere è
tuttavia estranea al sentire di parte delle popolazioni, attente ai più azzardati richiami
religiosi. Da qui il cospicuo numero di partecipanti alla grande coalizione promossa dagli
americani desiderosi di non esporsi troppo. Barack Obama è stato garbato, ha detto che
sono una quarantina, senza nominarli. I cinque paesi che hanno mandato i loro aerei sulla
Siria sono un’avanguardia di non poco conto, ma gran parte del mondo arabo non ha
osato andare oltre le dichiarazioni di principio o gli aiuti indiretti e il più possibile anonimi.
La loro riservata solidarietà è in tutti i modi preziosa.
Barack Obama ha potuto affermare che nella battaglia non ci sono soltanto gli Stati Uniti.
Ha aggiunto che farà di tutto per garantire la sicurezza dei membri della grande coalizione,
della regione e «del mondo intero ». Sebbene ambizioso l’impegno doveva essere
7
esplicitato. Il conflitto non è limitato al campo di battaglia iracheno-siriano. Le ramificazioni
dello Stato islamico sono larghe e imprevedibili. Lo ha rivelato nelle ultime ore la presa
dell’ostaggio francese in Algeria da parte di un’organizzazione che si dice ispirata dal
remoto califfato di Raqqa. Il gruppo originario, il «califfato», può essere eliminato o
indebolito dalle bombe guidate dei droni e dai missili della US Navy, ma per neutralizzare
la patologia micidiale dell’islamismo ci vorranno altre armi e tempi più lunghi. Il terreno di
scontro è più vasto della Mezza Luna Fertile, cosi battezzata per la sua forma geografica e
la generosità dei suoi raccolti, nel frattempo sfumata e sostituita dal petrolio. Insieme allo
Stato islamico gli Stati Uniti hanno bombardato il gruppo armato Khorasan composto da ex
militanti di Al Qaeda. Il suo capo, Muhsin al-Fadhli, era giovane, aveva 19 anni, l’11
settembre del 2001, ma ebbe un ruolo, pare, nell’organizzare l’attacco alle Torri gemelle.
La guerra civile ha creato in Siria un imprecisato numero di movimenti islamisti. Spesso in
concorrenza. Tutti sostengono di opporsi alle forze governative di Damasco, e
considerano Bashar el Assad, il loro principale nemico, ma al tempo stesso si scontrano,
nell’ambito della ribellione, con quelli di cui non condividono le idee. La mischia è feroce.
La più presa di mira è la Coalizione nazionale, considerata laica, alla quale gli americani
hanno deciso di fornire delle armi.
Si è cosi creata una situazione in cui gli Stati Uniti bombardano e al tempo stesso aiutano
l’opposizione. Le bombe sono per le forze jihadiste e l’appoggio per i moderati. I quali si
uccidono tra di loro, jihadisti contro laici, e simultaneamente combattono ognuno per conto
proprio contro Bashar al Assad. Gli americani escludono di avere coordinato la loro azione
con il presidente siriano. Rifiutano di collaborare con lui. Barack Obama l’ha accusato di
torturare la sua gente e gli ha negato ogni legittimità. Ma Damasco assicura di essere
stato informato da Washington dell’attacco allo Stato islamico e Bashar al Assad dice di
essere favorevole ad «ogni sforzo contro il terrorismo internazionale». Si dichiara
insomma soddisfatto delle incursioni americane contro il califfato.
Bashar al Assad, in quanto alawita appartenente a una comunità dell’area sciita, ha come
principale alleato l’iraniano Hassan Rohani. Il quale è però più realista del re. Denuncia
infatti l’azione militare degli Stati Uniti in Siria come illegale, perché avviene senza
l’autorizzazione di Damasco. Le contraddizioni, i doppi giochi, le false dichiarazioni sono
frequenti. L’Iran è in apparenza esclusa dai giochi, ma le milizie sciite sotto la sua
influenza o i suoi ordini, si battono sul terreno contro lo Stato islamico e con il «non
concertato» appoggio aereo americano. E in apparente sintonia con l’Arabia saudita.
Quest’ultima notizia, se confermata, sarebbe una grande novità mediorientale. I sauditi,
campioni dei sunniti, collaborano con gli iraniani, campioni degli sciiti. Due acerrimi nemici
si parlano sottobanco, per eliminare il califfato.
Del 24/09/2014, pag. 7
Usa, il riarmo nucleare del Premio Nobel per
la pace
Manlio Dinucci
Cinque anni fa, nell’ottobre 2009, il presidente Barack Obama fu insignito del Premio
Nobel per la Pace in base alla «sua visione di un mondo libero dalle armi nucleari, e al
lavoro da lui svolto in tal senso, che ha potentemente stimolato il disarmo». Motivazione
che appare ancora più grottesca alla luce di quanto documenta oggi un ampio servizio
del New York Times: «L’amministrazione Obama sta investendo decine di miliardi di dollari
8
nella modernizzazione e ricostruzione dell’arsenale nucleare e degli impianti nucleari
statunitensi». A tale scopo è stato appena realizzato a Kansas City un nuovo enorme
impianto, più grande del Pentagono, dove migliaia di addetti, dotati di futuristiche tecnologie, «modernizzano» le armi nucleari, testandole con avanzati sistemi che non richiedono
esplosioni sotterranee. L’impianto di Kansas City fa parte di un «complesso nazionale in
espansione per la fabbricazione di testate nucleari», composto da otto maggiori impianti
e laboratori con un personale di oltre 40mila specialisti. A Los Alamos (New Mexico) è iniziata la costruzione di un nuovo grande impianto per la produzione di plutonio per le
testate nucleari, a Oak Ridge (Tennessee) se ne sta realizzando un altro per produrre uranio arricchito ad uso militare. I lavori sono stati però rallentati dal fatto che il costo del progetto di Los Alamos è lievitato in dieci anni da 660 milioni a 5,8 miliardi di dollari, quello di
Oak Ridge da 6,5 a 19 miliardi. L’amministrazione Obama ha presentato complessivamente 57 progetti di upgrade di impianti nucleari militari, 21 dei quali sono stati approvati
dall’Ufficio governativo di contabilità, mentre 36 sono in attesa di approvazione. Il costo stimato è allo stato attuale di 355 miliardi di dollari in dieci anni. Ma è solo la punta
dell’iceberg. Al costo degli impianti si aggiunge quello dei nuovi vettori nucleari.
Il piano presentato dall’amministrazione Obama al Pentagono prevede la costruzione di 12
nuovi sottomarini da attacco nucleare (ciascuno in grado di lanciare, con 24 missili balistici, fino a 200 testate nucleari su altrettanti obiettivi), altri 100 bombardieri strategici (ciascuno armato di circa 20 missili o bombe nucleari) e 400 missili balistici intercontinentali
con base a terra (ciascuno con una testata nucleare di grande potenza, ma sempre armabile di testate multiple indipendenti). Viene così avviato dall’amministrazione Obama un
nuovo programma di armamento nucleare che, secondo un recente studio del Monterey
Institute, verrà a costare (al valore attuale del dollaro) circa 1000 miliardi di dollari, culminando come spesa nel periodo 2024–2029. Essa si inserisce nella spesa militare generale
degli Stati uniti, composta dal bilancio del Pentagono (640 miliardi di dollari nel 2013), cui
si aggiungono altre voci di carattere militare (la spesa per le armi nucleari, ad esempio,
è iscritta nel bilancio del Dipartimento dell’Energia), portando il totale a quasi 1000 miliardi
di dollari annui, corrispondenti nel bilancio federale a circa un dollaro su quattro speso
a scopo militare. L’accelerazione della corsa agli armamenti nucleari, impressa
dall’amministrazione Obama, vanifica di fatto i limitati passi sulla via del disarmo stabiliti
col nuovo trattato Start, firmato a Praga da Stati uniti e Russia nel 2010 (v.il manifesto del
1° aprile 2010). Sia la Russia che la Cina accelereranno il potenziamento delle loro forze
nucleari, attuando contromisure per neutralizzare lo «scudo anti-missili» che gli Usa
stanno realizzando per acquisire la capacità di lanciare unfirst strike nucleare e non essere
colpiti dalla rappresaglia. Viene coinvolta direttamente nel processo di «ammodernamento» delle forze nucleari Usa anche l’Italia: le 70–90 bombe nucleari statunitensi B-61,
stoccate ad Aviano e Ghedi-Torre, vengono trasformate da bombe a caduta libera in
bombe «intelligenti» a guida di precisione, ciascuna con una potenza di 50 kiloton (circa il
quadruplo della bomba di Hiroshima), particolarmente adatte ai nuovi caccia Usa F-35 che
l’Italia si è impegnata ad acquistare. Ma di tutto questo, nei talk show, non si parla.
Del 24/09/2014, pag. 6
L’Italia rispetta gli impegni, partono le armi di
Renzi
Sardegna. Ordigni bellici per i curdi lasciano il porto
9
Costantino Cossu
Ieri gli ordigni bellici contenuti nel deposito bunker di Santo Stefano hanno lasciato via
mare l’arcipelago della Maddalena. Sono una parte delle armi che il governo Renzi si
è impegnato a fornire ai peshmerga per contrastare l’avanzata dell’Isis nel Nordest
dell’Iraq. Nella stiva del cargo Maior, che il ministero della Difesa ha preso a nolo dalla
compagnia di navigazione “Levantina Trasporti” di Bari, sono stati caricati, l’altroieri, 2.000
razzi Rpg modello 7.9 e munizioni per fucili mitragliatori Ak 47 Kalashnikov (mezzo milione
di cartucce). Ieri la nave ha lasciato Santo Stefano carica di armi. Destinazione
sconosciuta. È probabile che attracchi in un porto italiano, forse Livorno, dal quale il carico
verrà poi trasportato in una base militare e da qui trasferito via aerea in Iraq. L’impegno
italiano nella guerra che infiamma il Medioriente viene dunque puntualmente rispettato.
Ampie assicurazioni agli alleati atlantici, del resto, sono state fornite dal ministro degli
esteri Federica Mogherini nelle sue ultime esternazioni.
Durante la conferenza internazionale sulla sicurezza a Parigi, e poi al palazzo di vetro di
New York, il capo delle diplomazia italiana ha ribadito l’impegno contro l’Isis. «Siamo tutti
d’accordo — ha detto all’Onu — sulla necessità di agire insieme e sull’urgenza di farlo.
L’Italia ha già avviato il ponte aereo per la consegna di armi e aiuti ai curdi, e proseguirà
con altri 18 voli entro settembre». Intanto ieri sono riprese le esercitazioni nel poligono di
Capo Teulada. Contemporaneamente nella base proseguono le attività di bonifica da parte
dei militari del V reggimento genio di Macomer, annunciate nei giorni scorsi subito dopo la
grande manifestazione di Capo Frasca contro le servitù militari. «Le attività addestrative –
ha annunciato il comando della base — proseguiranno secondo il calendario prefissato nei
72 km quadrati di proprietà del demanio». Escluso dalle esercitazioni a fuoco il cosiddetto
«Poligono D», che comprende la penisola dove sono in corso le bonifiche, quindi zona
interdetta. Qui le attività sono state rinviate e la data non è stata fissata.
A giugno a innescare la polemica sulle servitù militari in Sardegna era stata la notizia che
l’aeronautica israeliana aveva chiesto, come ogni anno, di poter usare, per una esercitazione di addestramento, il poligono di Capo Frasca, sulla costa occidentale dell’isola, proprio mentre erano in corso i bombardamenti a Gaza. La situazione era poi diventata
ancora più tesa lo scorso 4 settembre, quando, durante le esercitazioni, alcuni Tornado
tedeschi, sempre a Capo Frasca, avevano scatenato un incendio che ha distrutto 32 ettari
di macchia mediterranea, domato dagli uomini del corpo foresatale. Lo sdegno per il rogo
è sfociato, lo scorso 13 settembre, in una manifestazione di protesta, alla quale hanno partecipato circa 10 mila persone: una delle più partecipate degli ultimi anni.
del 24/09/14, pag. 1/6
La grande truffa dell’Iva in Italia per finanziare
i gruppi islamici
di Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella
Un miliardo sottratto ai contribuenti italiani da una frode fiscale sui certificati ambientali
scambiati sul mercato telematico: la Procura di Milano lo contesta a una trentina di
indagati di due associazioni criminali, una anglo-pachistana e una franco-israeliana, che
con i profitti della maxifrode sull’Iva hanno finanziato anche il terrorismo islamico. Uno
scenario intuito dai servizi segreti stranieri dopo un blitz nel 2010 in un covo talebano.
Cercavano Osama Bin Laden, trovarono solo un pugno di fatture. Ma per le forze alleate il
blitz in un covo dei talebani al confine tra Afghanistan e Pakistan nel 2010 si è rivelato una
10
miniera di informazioni che attraverso Europa, Medioriente e Hong Kong hanno portato
sulle tracce di una colossale frode fiscale sui certificati ambientali servita a finanziare
anche il terrorismo islamico. Le stesse orme seguite dalla Procura di Milano in un’indagine
che, innescata dalla denuncia di una commercialista terrorizzata, con l’incriminazione di 38
indagati e il sequestro di 80 milioni di euro colpisce ora un’associazione criminale anglopakistana e una franco-israeliana che dal 2009 al 2012 hanno rubato all’Italia più di un
miliardo di euro di Iva.
I documenti scoperti nel rifugio, non lontano dall’area dove il 2 maggio 2011 i Navy Seals
americani hanno ucciso Bin Laden, conducevano ad Imran Yakub Ahmed, un pachistano
di 40 anni con passaporto inglese residente a Preston (Gran Bretagna), amministratore
della milanese “Sf Energy Trading spa”, sulla quale stavano indagando i pm Carlo
Nocerino e Adriano Scudieri nel pool guidato dall’aggiunto Francesco Greco. I pm e la
Guardia di Finanza si erano mossi dopo che a presentarsi in Procura era stata una
commercialista di Milano spaventata dalla facilità con la quale guadagnava soldi a palate
lavorando per alcune società intestate a prestanome cinesi e italiani, cartiere che facevano
girare milioni di euro vendendo e acquistando migliaia di carbon credit .
Con l’accordo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica, infatti, ad ogni
Stato è assegnata una quota massima di produzione di CO2. Le aziende che producono
meno gas-serra del tetto assegnato possono vendere il rimanente della quota alle imprese
meno virtuose emettendo appunto carbon credit , certificati ambientali che possono essere
negoziati bilateralmente o in un mercato telematico, scambi sotto la supervisione di
autorità pubbliche nazionali quali in Italia il «Gestore dei Mercati Energetici», una spa che
fa capo al Ministero dell’Economia.
Le due organizzazioni criminali operavano sia singolarmente che insieme. Acquistavano i
certificati in Gran Bretagna, Francia, Olanda e Germania attraverso società fittizie con
sede in Italia, vere e proprie «cartiere» che producevano solo fatture e che erano intestate
o a prestanome quasi sempre cinesi o a persone estranee ma vittime di furti d’identità.
Dopo aver acquistato senza pagare l’Iva, esclusa in questo tipo di transazioni
intracomunitarie, le «cartiere» aggiungevano l’Iva al 20 per cento e vendevano i certificati
ad altre società, anche queste fittizie, che facevano da intermediari con gli ignari acquirenti
finali. Una volta incassata l’Iva, invece di versarla allo Stato italiano la «cartiera» chiudeva
i battenti e spariva nel nulla, mentre i soldi, milioni e milioni di euro, venivano dirottati su
conti correnti a Cipro e Hong Kong per finire a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Lì le
rogatorie avviate dai pm milanesi a caccia di Imran Yakum Ahmed sono cadute nel nulla,
mentre i soldi sottratti all’Erario italiano sono stati riciclati in diamanti ed investimenti
immobiliari. C’è stato anche qualcuno che non ha resistito e ha comprato due orologi da
50mila euro ciascuno in una prestigiosa gioielleria di Roma.
Ma l’aspetto più inquietante che emerge dalle carte dell’indagine milanese è che dietro le
«imponenti operazioni di riciclaggio» legate alla frode fiscale potrebbe celarsi un canale di
«finanziamento al terrorismo internazionale» di matrice islamica. A lanciare l’allarme sono
stati i servizi segreti americani e inglesi che hanno esaminato la documentazione trovata
tra le montagne tra Pakistan e Afghanistan e hanno segnalato tutto alla «Hm Revenue
& Custom di Londra», una sorta di GdF inglese, il cui ufficio stampa, contattato dal
Corriere della Sera , non ha fornito ulteriori dettagli perché non può «discutere di singoli
casi per ragioni legali». Peraltro i pm milanesi non hanno prove dirette su questo profilo,
né possono utilizzare le carte dell’intelligence . Questo meccanismo criminale è stato
replicato per anni in centinaia di transazioni facendo impazzire le polizie di tutta Europa,
fino a quando le due organizzazioni hanno trasferito gli affari in Italia dopo che altri Paesi
dell’Ue erano corsi ai ripari con norme che avevano di fatto rotto il giocattolo. Un ginepraio
in cui si sono mossi anche gli investigatori della «Bundeskriminalamt» tedesca, della
11
«Service National de Douane Judiciare» francese, ma anche di Belgio e Liechtenstein,
tutti coordinati da Europol e Eurojust. La conclusione è che i mercati energetici europei
sono «fortemente manipolati e comunque viziati da un numero impressionate di
transazioni commerciali effettuate al precipuo scopo di realizzare rilevanti frodi agli Erari».
La preoccupazione è alta, tanto che le indagini sono state estese a livello internazionale
acquisendo i dati in possesso del «Citl», l’ente di Bruxelles che monitora a livello europeo
gli scambi dei permessi di emissione di CO2.
Le indagini della Procura milanese, chiuse in questi giorni in vista della richiesta di
processo, solo per il primo filone hanno scoperto una frode da 660 milioni, di cui 80
sequestrati. Trentotto gli indagati di cui 11 ricercati, e un centinaio le perquisizioni eseguite
in società e abitazioni. Un’inchiesta parallela, ancora in corso, sta già disvelando un’altra
frode del tutto analoga che ha sottratto ai contribuenti italiani altri 450 milioni.
Del 24/09/2014, pag. 7
Oggi a Bruxelles il «Tribunale Russell»
Territori occupati. Crimini a Gaza: l’Onu raccomanda di deferire Israele
al Tpi
Luisa Morgantini
Si apre oggi, per due giorni, nell’Alberto Hall di Bruxelles, la sessione straordinaria del Tribunale Russell sulla Palestina che esaminerà gli attacchi sistematici sferrati da Israele
contro i civili e le infrastrutture durante l’«Operazione Margine Protettivo» nel luglio e agosto scorsi; raccogliendo le dichiarazioni di esperti e testimoni che erano sul posto durante
l’attacco, tra cui il giornalista britannico Paul Mason, del Channel 4 News ‚il Direttore del
Raji Sourani, i chirurghi Mads Gilbert e Mohammed Abou-Arab, il giornalista Martin
LeJeune e Ashraf Mashharawi . Recentemente, Human Rights Watch ha accusato Israele
di aver commesso crimini di guerra in un rapporto che analizza tre attacchi contro le
scuole di Jabalya,Beit Hanoun e Rafah, in cui sono rimaste uccise 45 persone, tra cui 17
bambini. Anche l’Onu e Amnesty International hanno trovato prove di crimini di guerra
e crimini contro l’umanità. Nei 51 giorni dell’offensiva israeliana, 2.131 palestinesi sono
rimasti uccisi, 501 erano bambini, 70% dei casi sotto 12 anni, sono 10.918 feriti, tra cui
3.312 bambini e 2.120 donne. Secondo l’Onu 244 scuole sono state bombardate e che
una è stata utilizzata come base militare. Almeno 10.920 abitazioni private sono state danneggiate o distrutte; tra queste, 2.853 sono state rase al suolo. Inoltre, sono stati colpite
anche 161 moschee, otto ospedali (sei resi inagibili), 46 Ong, 50 pescherecci e 244 veicoli. Più di 400 mila sono gli sfollati. È di ieri la relazione presentata da Flavia Pansieri al
Consiglio dei Diritti Umani Onu, raccomanda di deferire Israele al Tribunale Penale Internazionale dell’Aja, mentre il governo israeliano ancora una volta impediva l’entrata in
Israele e nei territori occupati della Cisgiordania alla delegazione dell’Onu, guidata da
Makarim Wibisono, che si recherà a Gaza via Egitto. Intanto il governo israeliano non si
ferma, e decide, nell’area occupata di Gerusalemme Est, la costruzione di 12 grattacieli,
ministeri ed un centro commerciale, mentre il parlamento, nelle mani dei coloni e dei
nazionalisti più oltranzisti, cosi come gran parte dei giudici dei tribunali, presentano leggi
per confische di terre, per impedire che vi siano amnistie per i prigionieri palestinesi, e i
giudici usano la mano dura, contro i minori a Gerusalemme Est e comminando alte penali
anche quando i giovani vengono rilasciati. In Cisgiordania, i coloni sempre più aggressivi
attaccano villaggi, raccolti e popolazione palestinese, ed i soldati fanno incursioni notturne
terrorizzando famiglie ed arrestando giovani che partecipano alle manifestazione dei comi12
tati popolari per la resistenza non-violenta. A Gaza con la «tregua» non ha cambiato
molto. Israele applica la solita tattica dilatoria. Il governo di unità nazionale palestinese va
al rallentatore. Qualche maglia si è allargata per importazioni ed esportazioni, ma a Rafah
il valico dall’Egitto ed Eretz, il valico per Israele, restano di fatto chiusi, l’assedio non è cessato. E i giovani fuggono da Gaza, attraverso i tunnel verso una libertà mai respirata ed
alcuni cominciano a morire nel Mediterraneo. Una ingiustizia infinita, che ricade su di noi,
su Unione europea, Usa, Paesi Arabi, Onu, che mai impongono sanzioni ad Israele, in
perenne violazione dei diritti umani e della legalità internazionale. Forti le responsabilità
del governo italiano, ma non sembra che né il premier Renzi a capo del semestre Ue, né
la Mrs Pesc Mogherini, abbiano il coraggio morale e politico per dire al governo israeliano
che non è al di sopra delle leggi.
* www.assopacepalestina.org
del 24/09/14, pag. 9
Israele: “Uccisi i killer dei tre studenti ebrei”
La rabbia di Hamas
FABIO SCUTO
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE
GERUSALEMME .
La tragica estate del 2014 si è chiusa all’alba di ieri con la morte dei due miliziani di
Hamas che avevano rapito e ucciso brutalmente i tre ragazzi delle scuole religiose di
Hebron in giugno. Cento giorni di caccia all’uomo nei quali le squadre speciali dell’esercito
e gli agenti dello Shin Bet sono stati a un soffio dalla cattura. L’ultimo nascondiglio di Amer
Abu Aisha e Marwan Qawasmeh, una falegnameria in seminterrato non distante dalla
strada principale della città, è stato identificato qualche giorno fa. Secondo lo Shin Bet i
terroristi erano al piano inferiore dell’edificio. Nei mesi scorsi si erano spostati da un
nascondiglio all’altro, con l’aiuto dei membri della famiglia Qawasmeh, che è considerata
una delle famiglie più rispettabili di Hebron. La maggior parte dei suoi membri sono affiliati
con Hamas, tra cui Hossam Qawasmeh, il comandante della cellula e la mente del
sequestro dei “ragazzi”, che è stato arrestato alcune settimane fa. Invitati ad arrendersi i
due miliziani delle brigate Ezzedin al Qassam hanno risposto con le armi, nella violenta
sparatoria che ne è seguita sono rimasti uccisi. A metà giornata, circa 3.000 persone
hanno partecipato ai loro funerali, i corpi avvolti nelle bandiere di Hamas che ha elogiato «i
due martiri combattenti».
Con la loro morte si chiude il tragico cerchio iniziato con il rapimento dei tre ragazzi
israeliani il 12 giugno scorso e la loro orribile morte scoperta tre settimane più tardi,
l’escalation delle operazioni israeliane contro gli uomini di Hamas in tutta la Cisgiordania
con oltre 400 arresti durante l’estate e sei palestinesi uccisi. Anche i 50 giorni di guerra a
Gaza trovano la loro origine nel rapimento di Eyal Yifrah, di 19 anni, Gilad Shaar e Naftali
Fraenkel, di 16. Il premier Benjamin Netanyahu è tornato ad accusare Hamas della
responsabilità della morte dei tre ragazzi. «Fin dal primo momento avevamo detto che
Hamas era responsabile — ha detto il primo ministro — la mano della giustizia di Israele,
la nostra lunga mano, ha raggiunto i killer».
Dopo il blitz israeliano a Hebron, Hamas ha ventilato la possibilità di ritirare per protesta la
sua delegazione al Cairo dove ieri sono iniziati i colloqui di “riconciliazione” con l’Anp.
Entrambe le parti devono trovare un’intesa sulla futura “governance” della Striscia.
13
Del 24/09/2014, pag. 7
Sabato 27 a Roma manifestazione nazionale
di solidarietà alla Palestina
Coordinamento comunità palestinesi in Italia
Ci troviamo ormai di fronte all’ennesima aggressione Israeliana contro il popolo palestinese, dalla pulizia etnica del 1948 e del 1967, al muro dell’apartheid dichiarato illegale
dall’Onu nel 2004, ai massacri compiuti in questi decenni,dall’embargo illegale imposto
alla Striscia di Gaza, alle violenze, alle discriminazioni ed ai sistematici omicidi di anziani,
uomini, donne e bambini compiuti nell’ultimo tentativo di sterminio del nostro popolo con
un silenzio assordante della comunità internazionale.
L’occupazione israeliana della Palestina è questo: colonie illegali, stermini, negoziati interminabili, rifiuto di qualsiasi forma di una pace giusta e conforme al diritto internazionale. Il
Coordinamento delle Comunità Palestinesi in Italia indice questa manifestazione nazionale
di solidarietà per chiedere: la fine dell’occupazione israeliana; il diritto
all’autodeterminazione ed alla resistenza del popolo palestinese; l’istituzione di uno stato
democratico e laico palestinese con Gerusalemme Est capitale; l’unità territoriale dello
Stato di Palestina; la fine di ogni accordo militare con Israele: la fine dell’embargo illegale
imposto alla Striscia di Gaza e la riapertura di tutti i valichi; la libertà di tutti i prigionieri politici palestinesi detenuti nelle carceri israeliane; l’attuazione della Risoluzione 194 dell’Onu
che afferma il diritto al ritorno dei profughi palestinesi. Al governo italiano in qualità di presidente del semestre Ue di adoperarsi per un riconoscimento totale ed effettivo dello stato
palestinese da parte di tutti i paesi membri della Comunità europea. A tutte le forze democratiche e progressiste : URLATE contro le ingiustizie che da quasi 70 anni il popolo palestinese è costretto a subire. Il Coordinamento delle comunità palestinesi in Italia chiede
a tutte le forze politiche e sindacali e a tutte le associazione e i comitati che lavorano per la
pace e la giustizia di aderire alla nostra manifestazione a questo indirizzo email.
[email protected]
del 24/09/14, pag. 17
Bastoni e crudeltà
Ora la Cina esporta la tortura nel mondo
Il boom dei prodotti per «interrogare»
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE PECHINO L’anno scorso la China Xinxing, azienda
statale cinese, ha esportato in Africa prodotti per 100 milioni di dollari. Tra gli articoli
sviluppati dalla fabbrica ci sono manette, sedie rigide per gli interrogatori, bastoni elettrici
che possono essere usati per infliggere scariche estremamente dolorose su zone delicate
del corpo, come i genitali, la gola, le orecchie.
La Xinxing non è sola: secondo Amnesty International ci sono almeno 134 imprese cinesi
impegnate nella produzione e nel commercio di strumenti «intrinsecamente crudeli e
inumani che dovrebbero essere messi al bando». Queste società dell’orrore sono in
maggior parte di proprietà statale e stanno vivendo un boom nella Repubblica popolare
14
«fabbrica del mondo»: il rapporto spiega che erano 28 dieci anni fa, si sono più che
quadruplicate. La tortura può essere un grande business. Un business globalizzato.
Naturalmente, il mercato esiste se c’è domanda e la richiesta di strumenti catalogati come
«anti-sommossa e per l’applicazione della legge» è aumentata sensibilmente a seguito
degli sconvolgimenti della Primavera araba e delle continue crisi nei Paesi africani e
asiatici retti da regimi autoritari e dittatoriali. La China Xinxing, per esempio, vanta 40
governi africani tra i suoi clienti. Ma l’export è florido anche in Cambogia, Nepal,
Thailandia, dove gli agenti usano mazze fornite di punte metalliche prodotte solo in Cina.
«È un business multimiliardario», dice Patrick Wilcken di Amnesty International, che ha
lavorato per quattro anni al rapporto. E aggiunge: «Pechino ha preso la testa nel
segmento più orrendo di questo commercio, dalle catene pesanti per il collo che riducono
la circolazione del sangue alle sedie per gli interrogatori, quella sorta di attrezzature di
polizia considerate clandestine». Clandestine, ma nel corso delle sue ricerche Amnesty ha
trovato prodotti del genere in fiere della sicurezza in Francia, Gran Bretagna, oltre che nel
Medio Oriente e in Sud Africa.
Cinesi leader del settore, dunque, ma anche democrazie solide non hanno la coscienza
tranquilla. Un funzionario della dogana di Londra per esempio ha risposto così alla
domanda del Daily Telegraph : «La dogana di Sua Maestà valuta ogni caso di potenziale
infrazione alle leggi sull’export. Comunque, una semplice brochure che pubblicizza
prodotti sensibili non è necessariamente un reato».
Resta il fatto che la Cina sembra essersi specializzata nella produzione e
commercializzazione di strumenti di tortura. I sistemi usati dalla polizia della seconda
economia del mondo sono stati spesso denunciati. La prova principe di ogni inchiesta è la
confessione e per ottenerla catene, bastoni, scariche elettriche sono pratica comune.
Per i funzionari del partito comunista accusati di «violazioni della disciplina», per esempio,
vige il regime dello «shanggui»: che si traduce «doppia previsione» e significa che chi è
inquisito deve ammettere la colpa entro il tempo previsto e nel luogo previsto.
La Corte suprema cinese a novembre del 2013 ha formalmente vietato la tortura come
mezzo per ottenere la confessione. E ha elencato i metodi orrendi usati negli interrogatori:
«Uso del congelamento del soggetto; esposizione forzata e protratta alla luce del sole, al
calore; privazione del cibo; privazione del riposo».
A una richiesta di commento sul rapporto di Amnesty International, la portavoce del
ministero degli Esteri di Pechino ha risposto negando: «Ho il piacere di ricordarvi che
questa organizzazione è sempre parziale verso la Cina, così io dubito profondamente che
la relazione sia onesta».
Guido Santevecchi
del 24/09/14, pag. 19
Brindisi, cravatte e camicie nere I fantasmi
che agitano il Nord Europa
DAL NOSTRO INVIATO SJÖBO (Svezia) Domenica 14 settembre il signor Anders Robert
ha compiuto 95 anni: festeggiamenti con una trentina di parenti e amici al Gastgifvaregard,
antico ristorante di Sjöbo, un villaggio di seimila abitanti nel Sud della Svezia. Campi di
patate, di foraggio. Villette di mattoni rossi a un piano con la bandiera nazionale piantata in
giardino. In questo distretto, nelle elezioni del 15 settembre, gli Sverigedemocraterna, i
Democratici svedesi, sono arrivati fino al 30% dei voti. Il loro leader, il trentacinquenne
15
Jimmie Akesson, vuole ridurre del 90% l’immigrazione e tagliare il più possibile il miliardo
di euro stanziato per l’accoglienza in bilancio statale che di miliardi ne conta 100. Il signor
Robert, però, ha votato «per la socialdemocrazia», come ha sempre fatto dal dopoguerra
in avanti. Ora il suo problema, quello di sua figlia Elizabeth, dei nipoti che lo guardano
mentre, in abito scuro e cravatta bordeaux, brinda «al futuro della Svezia» è capire se
bisogna davvero preoccuparsi o se «passerà anche questa volta», come è successo per il
collaborazionismo con i nazisti o il referendum anti-immigrati indetto nel 1986 in questa
circoscrizione.
Stefan Löfven, il segretario dei socialdemocratici, ha scalzato il premier moderato Fredrik
Reinfeldt, ma non riesce a formare il governo, perché quel 12,9% di consensi raccolto a
livello nazionale dai Democratici svedesi blocca il gioco delle alleanze. Per il momento
tutte le forze politiche tradizionali rifiutano non solo un accordo, ma anche il semplice
confronto con i populisti. E così il problema del signor Robert è anche il problema di
Löfven, della Svezia (9,5 milioni di abitanti), dell’Unione Europea.
Sabato mattina, 13 settembre. Il signor Michael Mortensen, 53 anni, manager di una
società hi-tech, si rilassa passeggiando nel parco di Aarhus, città portuale nella penisola di
Jutland, Danimarca centrale. Dice che nel passato il suo Paese è stato il più aperto in
Europa, ma ora questa condizione non è più «economicamente sostenibile». E allora
anche lui, vecchio liberaldemocratico, appoggia la linea politica del Dansk Folkeparti, il
Partito danese del popolo, che alle europee ha conquistato il primo posto con il 26,6%,
staccando di sette punti i socialdemocratici al potere e di dieci i liberali. In Danimarca si
vota tra un anno, ma la campagna è già cominciata. Il candidato da battere non è la
premier socialdemocratica, Helle Thorning-Schmidt, bensì Kristian Thulesen Dahl, 45 anni,
capo del Folkeparti, subentrato nel settembre 2012 alla fondatrice Pia Kjaersgaard. Le
forze populiste del Nord Europa non sono più outsider fastidiosi, ma in definitiva irrilevanti.
Ormai da tempo si sono liberate delle ferraglie neonaziste delle origini che risalgono agli
anni Novanta. Rimangono tracce, comunque inquietanti, di raduni e camicie nere, specie
nelle organizzazioni giovanili, in Svezia soprattutto. Ma il processo di dialisi politica è ormai
completato in tutta la Scandinavia. In Norvegia il Partito del Progresso, lo stesso cui
aderiva lo stragista Anders Breivik, adesso fa parte della coalizione di governo con i
conservatori. La sua leader, Siv Jensen, 45 anni, è anche ministro delle Finanze e da lì
insidia il bacino elettorale degli alleati. In Finlandia, i Perrussuomalaiset, i Veri finlandesi
guidati da Timo Soini, 52 anni, sono il terzo partito con il 13% e stanno erodendo i
consensi dei socialdemocratici. Il Dansk Folkeparti, pur restando sempre all’opposizione,
condiziona dal 2001 le priorità in tema di immigrazione fissate dagli esecutivi
liberaldemocratici. Tanto che oggi la legislazione danese in materia è tra le più spigolose
d’Europa. Qualche esempio: età minima (24 anni) per sposare il partner extra comunitario;
ostacoli enormi per il ricongiungimento familiare e così via. Ma anche i socialdemocratici si
stanno riposizionando. Venerdì 12 settembre il governo di Thorning-Schmidt ha
annunciato una clamorosa restrizione del diritto d’asilo rispetto agli standard delle
socialdemocrazie scandinave: solo un anno di permanenza e poi, se ci sono le condizioni
di sicurezza, i rifugiati potrebbero essere rispediti nei Paesi di provenienza.
I costi di almeno venti-trent’anni di apertura praticamente incondizionata cominciano a
pesare anche per queste economie solide e dinamiche. Il welfare, lo Stato sociale
svedese, assegna circa mille euro al mese ai disoccupati e altri 400 per pagare l’affitto di
una casa popolare, senza fare distinzione tra cittadini e immigrati. Il sistema danese ora è
un po’ meno generoso. In ogni caso le municipalità coprono le spese di luce, telefono e
canone tv per chi resta senza lavoro, stranieri compresi. In realtà, come nota Peter Helvig,
studioso dell’immigrazione all’università di Aalborg, Nord della Danimarca, è difficile
valutare esattamente benefici e perdite collegate ai flussi migratori. Ma i populisti nordici
16
spezzano in due ciò che dovrebbe rimanere unito, come la partita doppia (entrate e uscite)
di un’azienda. È un’operazione già vista altrove e che trova condizioni particolarmente
favorevoli nell’habitat scandinavo.
Quattro giorni di viaggio per rendersene conto: 493 chilometri, da Aalborg, estremo Nord
della Danimarca a Sjöbo, Svezia meridionale, con tappe ad Aarhus e Malmö. Il paesaggio
economico racconta anche qui le sofferenze dei vecchi complessi industriali. Ad Aalborg,
di fatto, restano solo i cementifici, obsoleti e inquinanti, mentre i cantieri navali sono stati
venduti ai coreani o smantellati, così come accaduto a Malmö. L’agricoltura intensiva
tiene, ma ad Aarhus si capisce come la ricchezza sia concentrata nella produzione di
tecnologia e nei servizi più sofisticati. La massa degli immigrati preme sulla base della
piramide, l’antica manifattura, oppure sul terziario più elementare (le imprese di pulizie o di
trasporto). Il numero uno del Dansk Folkeparti, Thulesen Dahl, osserva Susi Meret,
ricercatrice italiana specializzata in studi sulla «migrazione e diversità» nell’università di
Aalborg, si propone di impersonare la trasformazione danese. Si è laureato in Economia
ad Aalborg, l’università più innovativa e sperimentale del Paese. È entrato molto presto in
politica, iscrivendosi prima al Partito del Progresso, una formazione anti-tasse degli anni
Ottanta, poi seguendo nel Folkeparti Pia Kjaersgaard, 67 anni. Due anni fa la fondatrice,
figura storica del populismo danese, passò la mano a Thulesen Dahl. Nel corso della
campagna elettorale per le Europee il nuovo leader si è fatto fotografare con un primo
piano fin troppo rassicurante e lo slogan «Sicurezza e fiducia: si può». Le gigantografie
dominano, incontrastate, le piccole stazioni ferroviarie che scendono lungo la penisola
dello Jutland e poi fino a Nyborg, a Slagelse, a Ringsted, nelle due grandi isole. Tutto
bene finché il treno non sbuca nella periferia di Copenhagen, dove qualcuno ha disegnato
un paio di baffetti alla Hitler sul labbro perfettamente rasato di Thulesen Dahl. Un modo
rozzo e sbrigativo per cogliere, però, un punto. Se fosse solo una questione economica, di
manutenzione del bilancio pubblico, liberali e socialdemocratici avrebbero gli strumenti
tecnici per correggere le storture del welfare, togliendo spazio alle nuove forze.
Evidentemente c’è dell’altro. Le cifre lasciano spazio alle passioni, ai sentimenti e
soprattutto ai pregiudizi del territorio. I populisti danesi si scagliano contro «le gang
criminali» formate da immigrati lituani ed estoni, indicandoli come un pericolo per la
tranquillità dei cittadini pacifici e operosi. Resiste inoltre, in modo particolare in Svezia,
l’allergia all’Islam di importazione. Malmö, spiega Anders Hellstrom, 38 anni, professore
aggiunto di Scienze politiche all’Università locale, è la città frontiera in questo momento:
270 mila abitanti, 164 nazionalità, cento lingue diverse. L’opinione pubblica è divisa, ma
anche qui, nel Sud della Svezia, la maggioranza continua a difendere il modello di società
aperta, disponibile all’accoglienza e all’integrazione. Nelle ultime europee molti elettori di
Malmö hanno scritto sulla scheda il nome di Zlatan Ibrahimovic, stella del calcio mondiale,
cresciuto nel quartiere di Rosengard, dove erano approdati i genitori bosniaci. A Sjöbo,
cinquanta chilometri più a Ovest, i simpatizzanti dei Democratici svedesi, invece, si
mimetizzano, sfuggono. Per ora non vogliono esporsi. Anche se tra loro i nostalgici di
un’epoca solitaria e felice, forse, sono più numerosi dei razzisti.
Del 24/09/2014, pag. 4
Spagna, stop alla legge medievale sull’aborto
17
Diritti. Il premier Rajoy perde pezzi. Gallardón, il «grande inquisitore»,
titolare della Giustizia, è il primo ministro che si dimette
volontariamente dal governo. Lascerà la politica
Luca Tancredi Barone
La controriforma della legge sull’aborto del governo Rajoy scompare per sempre dal
panorama politico spagnolo. E si porta con sé il suo principale sponsor, il ministro della
Giustizia Alberto Ruiz-Gallardón, che si è dimesso ieri in serata.
Si tratta del primo ministro del governo Rajoy che a poco più di un anno dalle elezioni politiche lascia il governo in maniera volontaria (l’altro è stato il capolista alle europee, l’ex
ministro dell’Agricoltura Miguel Arias Cañete, che per candidarsi ha dovuto abbandonare
l’incarico per legge e oggi è commissario in pectore della Commissione Junker).
Poco prima di lasciare il paese alla volta della Cina, ieri in tarda mattinata il premier
Mariano Rajoy aveva annunciato pubblicamente che il governo ritirava il progetto di legge
per riformare la legge sull’aborto varata dal governo socialista nel 2010 che prevede dei
termini entro i quali l’aborto è permesso, estensibili nel caso di malformazioni.
La proposta popolare, coerentemente con il ricorso al tribunale costituzionale presentato
non appena il governo Zapatero aveva approvato la legge (e su cui il tribunale non si
è ancora espresso), prevedeva di restringere significativamente la possibilità di aborto,
fino a renderlo praticamente impossibile. Nel suo primo intervento pubblico dopo aver
assunto la guida del ministero della Giustizia a gennaio del 2012, Gallardón si era impegnato pubblicamente a cancellare la legge socialista. Ma l’impresa — un impegno elettorale del Partito popolare appoggiato entusiasticamente dalla Chiesa cattolica — si è rivelata molto più complicata del previsto. Il consiglio dei ministri aveva approvato, con fatica,
solo a fine 2013 il primo testo. Nel progetto, l’aborto era ammesso nel caso di stupro
(entro le prime 12 settimane) o in caso di grave rischio per la salute della madre (entro le
prime 22), ma non per malformazione del feto. Secondo il progetto di legge, la minaccia
per la salute della madre sarebbe stata molto più complicata da dimostrare. Inoltre, al contrario che nella legge attuale, le minori avrebbero dovuto ottenere un permesso dei genitori
per poter abortire. Attualmente in Spagna vengono effettuati circa 120mila aborti l’anno, il
90% dei quali entro le prime 14 settimane. La legge in vigore prevede la «depenalizzazione» entro le prime 14 settimane, estendibili a 22 nel caso di rischi per la salute della
donna o del feto. Il cammino di questo progetto di legge è stato fin dal principio molto accidentato. Di rinvio in rinvio, ci erano voluti cinque consigli dei ministri per poterlo approvare
e dal dicembre scorso la legge è rimasta chiusa in un cassetto. Gallardón si era impegnato
a presentarla in parlamento prima della fine dell’estate, ma dopo il consiglio dei ministri di
venerdì scorso era chiaro che non ci sarebbe riuscito. Domenica varie centinaia di persone avevano manifestato nella V marcia per la vita a Madrid minacciando il Partido
popular di ritirare il loro voto se avessero rinunciato alla legge.Le dimissioni di Gallardón,
chieste da tutti i partiti di opposizione, a questo punto sembravano inevitabili. Il ministro, ex
presidente della comunità di Madrid ed ex popolare sindaco di Madrid — che al diventare
ministro ha lasciato con un buco di bilancio enorme, il maggiore di tutta la Spagna — ha
annunciato che lascerà anche il suo seggio in parlamento. L’ex «promessa» del partito,
che quando era sindaco ammiccava alla sinistra, si ritirerà a vita privata. Durante il suo
mandato, Gallardón è riuscito, fra le altre cose, a far approvare una legge che aumenta le
tasse giudiziarie, impedendo alle persone senza mezzi di poter fare ricorso. Ma la sua
contestatissima riforma del codice penale (che fra l’altro introduce l’ergastolo e indurisce le
pene per i manifestanti) è ancora parcheggiata in parlamento, così come altre norme di
funzionamento della giustizia molto criticate anche da avvocati e giudici. Gallardón ha
dichiarato nella conferenza stampa in cui annunciava le sue dimissioni che la decisione
era stata comunicata a Rajoy la settimana scorsa, ma che non voleva lasciare il ministero
18
prima di aver redatto il (futuro) ricorso contro la legge catalana per l’indizione delle consulte popolari.
del 24/09/14, pag. 2
Il Papa fa arrestare vescovo pedofilo
Shock in Vaticano, è la prima volta
È l’ex nunzio polacco Wesolowski, fedelissimo di Wojtyla. La Santa
Sede: “Caso grave da affrontare senza ritardi”
MARCO ANSALDO
CITTÀ DEL VATICANO .
È la prima volta nella storia che un prelato viene arrestato in Vaticano. Con il permesso,
anzi l’approvazione diretta, del Papa. Il monsignore è un arcivescovo di nazionalità
polacca, Joseph Wesolowski, 66 anni, ridotto già a giugno dalla giustizia vaticana allo
stato laicale. L’accusa: pedofilia.
Alle cinque del pomeriggio gli uomini della Gendarmeria guidati al comandante Domenico
Giani hanno preso in consegna il monsignore, e dopo avergli notificato l’atto di accusa
stilato dal promotore di giustizia pontificio, lo hanno accompagnato nei locali del Collegio
dei Penitenzieri, nel Palazzo del tribunale vaticano, dove resterà agli arresti domiciliari fino
al processo. A monsignor Wesolowski è stato risparmiato, per ragioni di salute, di essere
sbattuto in cella, come invece accadde al maggiordomo di Benedetto XVI, Paolo Gabriele,
poi processato nell’aula di giustizia che si apre nella stessa piazza dove si affaccia Santa
Marta, la casa di Papa Francesco. E così accadrà a breve anche per il vescovo polacco,
visto che l’ex monsignore aveva anche la cittadinanza vaticana, e che non esiste un
trattato di estradizione fra la Santa Sede e la Polonia.
La notizia è stata data ieri sera per prima dal telegiornale de La7. Il prelato polacco è
accusato di avere adescato alcuni ragazzini su una spiaggia di Santo Domingo, dove è
stato nunzio apostolico dal 2008 al 2013, pagandoli per fare sesso. Subito dopo è arrivata
la conferma da parte del portavoce del Pontefice, padre Federico Lombardi. L’arresto
dell’ex nunzio Wesolowski, secondo quanto ha comunicato il direttore della Sala stampa
vaticana, «è conseguente alla volontà espressa del Papa, affinché un caso così grave e
delicato venga affrontato senza ritardi, con il giusto e necessario rigore, con assunzione
piena di responsabilità da parte delle istituzioni che fanno capo alla Santa Sede».
Il caso era scoppiato lo scorso anno, quando un diacono di Wesolowski, suo ex
collaboratore, aveva riferito a un giudice di aver procurato al nunzio alcuni giovani per
consumare rapporti sessuali. Altri quattro testimoni avevano poi puntato il dito contro il
monsignore, indagato oltre che a Santo Domingo anche in Polonia dove, in base ad
accordi internazionali, Varsavia persegue anche i suoi cittadini per reati commessi
all’estero.
Nell’estate di un anno fa, l’arcivescovo era stato così richiamato in Italia. Nel frattempo, la
procura distrettuale di Varsavia chiedeva informazioni sul suo status legale. La risposta
giungeva dal Vaticano a gennaio: Wesolowksi gode di immunità diplomatica, e comunque
essendo cittadino vaticano non è estradabile poiché tra Santa Sede e Polonia non ci sono
accordi in tal senso. Il 26 giugno la Congregazione per la Dottrina della Fede (l’ex
Sant’Uffizio) aveva quindi processato il monsignore sotto la forma canonica, arrivando a
decretare la riduzione del vescovo allo stato laicale. Wesolowksi, nelle scorse settimane,
aveva quindi opposto appello alla sentenza.
19
Così il prelato polacco, ormai privo dell’immunità diplomatica, era tornato a Roma, dove
aveva trovato alloggio in un convento. Ma l’indagine penale dell’autorità vaticana,
autorizzata dal Pontefice, era intanto partita. Infine, due settimane fa, il vescovo ausiliare
di Santo Domingo, Victor Masalles, aveva notato Wesolowski passeggiare libero per una
via di Roma e ne aveva riferito ad alcuni mezzi d’informazione. Il caso era così piombato
sulla prima pagina del New York Times . Padre Lombardi era intervenuto precisando che
la «relativa libertà di movimento» concessa all’ex nunzio poteva decadere con i
provvedimenti che si attendevano. L’arresto, insomma, era una possibilità reale. E ieri
mattina Wesolowksi è stato convocato negli uffici del tribunale vaticano, dove è giunto
verso le 15. Notifica, formalità di rito, poi la detenzione nel Collegio alle 17, formalmente
agli arresti domiciliari.
Di recente il caso era stato al centro anche delle dure critiche da parte del Comitato Onu
contro la tortura nei confronti della Senta Sede. In più occasioni infatti il Comitato di
Ginevra aveva chiesto al Vaticano di garantire indagini immediate e imparziali sulla
condotta del nunzio a Santo Domingo. L’ultima richiesta delle Nazioni Unite risaliva allo
scorso maggio. A giugno la condanna allo stato laicale. Ora l’arresto.
Dopo l’ex maggiordomo di Papa Ratzinger è di nuovo il momento di un arresto clamoroso
in Vaticano. Il fermo di Gabriele, nel maggio 2012, e il processo per il furto dei documenti
dall’appartamento papale, con la successiva detenzione, avevano fatto il giro del mondo.
L’addetto di camera era stato poi graziato dallo stesso Benedetto XVI. Diversa la
situazione oggi, ma non minore il clamore. Con un nuovo processo, ora, dentro le Sacre
Mura. Questa volta, però, contro un religioso di altissimo rango.
20
INTERNI
Del 24/09/2014, pag. 2
81, la carta della sinistra
Austerità. Presentata alla Camera la proposta di legge di iniziativa
popolare per modificare la norma sul pareggio di bilancio in
Costituzione. Tra i promotori Sel, la minoranza Pd con Fassina e Civati,
la Fiom di Landini e vari giuristi. Rodotà: «Così rilanciamo i diritti
distrutti dal neo liberismo»
Massimo Franchi
<<I diritti fondamentali delle persone» vengono prima della finanza. Un concetto semplice
e al tempo stesso rivoluzionario in quest’epoca neoliberista in cui «l’economia comanda su
tutto». Un concetto che unisce per la prima volta un fronte di sinistra largo e plurale: da
Fassina a Landini, da tutta Sel a Civati, dal terzo settore all’associazionismo cattolico,
dall’Altra Europa di Tsipras a — chissà — perfino una parte del M5s. «Uno schieramento
politico — per dirla con le parole di Stefano Rodotà — che abbia la capacità di farsi
valere». E per farlo punta a cambiare l’articolo 81 — e altri — della Costituzione e quel
pareggio di bilancio che è «vulnus politico». Lo strumento scelto è quello della legge di iniziativa popolare, strumento finora spuntato — «in 15 anni da parlamentare non ne ho mai
discusso uno», ricorda sempre Rodotà — che dovrebbe essere rilanciato fortemente dal
nuovo regolamento della Camera: il parlamento dovrà obbligatoriamente discuterli in
tempi certi. Lunedì il testo che prevede di modificare anche gli articoli 97 — pubblica
amministazione — e 119 — autonomie territoriali — inserendo in entrambi la dizionecondizione «nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone» e di abrogare la parte della
legge Costituzionale 20 del 2012 che specifica i criteri di attuazione del pareggio di bilancio, è stato depositato lunedì in Corte di cassazione. Dal primo ottobre inizierà la raccolta
delle firme. La normativa vigente prevede che ne servano solo 50mila, l’obiettivo però
è molto più ambizioso: «entrare nel dibattito pubblico», come sintetizza il giurista Gaetano
Azzariti che materialmente ha scritto il testo. La rilevanza politica sta proprio nella presenza di molti esponenti della minoranza Pd. Al di là delle critiche comuni al Jobs act
e all’ulteriore modifica dell’articolo 18, la loro presenza segnala un quadro politico realmente modificato: «il cambiamento lo vogliono tutti ma va aggettivato, deve essere progressivo e non regressivo, con più diritti e non meno». Sentire ad esempio Stefano Fassina dire che «abbiamo bisogno di un radicale cambiamento di paradigma, serve ripoliticizzare l’economia, che non è una scienza neutra, astratta dalla politica», che «ci sono energie trasversali in Parlamento che vogliono cambiare in questo senso la politica», fa una
certa impressione. Se i deputati di Sel Giulio Marcon e Giorgio Airaudo rilanciano la loro
idea di «un Social compact che sostituisca il Fiscal compact», i veri mattatori della conferenza stampa di presetazione sono Rodotà e Landini. Il primo — che si autodefinisce
«maniaco dei diritti» — ricorda i «5 milioni e mezzo di firme raccolti da Sergio Cofferati e la
Cgil nel 2002 dopo la difesa dell’articolo 18» come esempio di «buona politica» che oggi
va declinata contro «la super Costituzione dettata dall’economia» che utilizza «un attacco
ai diritti che non è più neanche dissimulato». Per cambiare «la cultura politica del Paese»
va dunque detto con chiarezza che «quelle poche risorse esistenti vanno utilizzate per
tutelare i diritti», sennò si arriva ad «usarle per il ponte di Messina». Landini invece sottolinea come «l’iniziativa sia in continuità con “La via maestra” (che riempì piazza del Popolo
lo scorso ottobre, ndr) e cioé con l’idea di cambiare il paese attraverso l’applicazione della
21
Costituzione». Un argomento che si salda perfettamente con la manifestazione già convocata dalla Fiom per il 18 ottobre: «Offriamo quella piazza per parlare dell’iniziativa perché
se noi siamo tornati in Fiat lo dobbiamo alla Corte Costituzionale che ha sancito un diritto
e non alla politica». Quella politica che «oggi vuole riformare il paese con la contrapposizione, mentre noi vogliamo unirlo, allargare l’alleanza per cambiarlo davvero». I promotori
ci tengono poi a sottolineare come l’iniziativa non sia «assolutamente in contrasto» con
i quattro referendum abrogativi Stop austerità su cui si stanno ancora raccogliendo le
firme. Rodotà, Airaudo e gli altri promotori avevano avvertito della presentazione chi «ha
fatto una scelta diversa». La differenza sta nel fatto che i primi non credono che la Corte di
cassazione darà il via libera ai referendum e quindi hanno cercato «uno strumento
diverso». Se qualche velata accusa «di non essersi troppo impegnati nella raccolta delle
firme» traspare dalla Cgil, proprio il segretario confederale Danilo Barbi ci tiene a precisare
che «esiste una complementarità di senso fra le due iniziative». A giorni — entro il 30 settembre — si scoprirà se le 500mila firme necessarie saranno raggiunte — al momento
pare assai difficile — in ogni caso tutti assieme dal 1° ottobre si ricomincerà a raccoglierle
con lo stesso obiettivo: abbattere la cultura neoliberista imperante.
del 24/09/14, pag. 4
Autoriciclaggio soft dietrofront del governo
Critiche dalle procure
Il testo cambia dopo il sì del consiglio dei ministri su pressing dell’Ncd
Le richieste di Forza Italia. Cantone(Anticorruzione): non lo annacquerei
LIANA MILELLA
ROMA .
Aveva garantito il Guardasigilli Andrea Orlando, appena cinque giorni fa, dalla tribuna delle
Camere penali: «Non ci sarà nessuna marcia indietro sull’auto-riciclaggio ». Una
promessa che si sta rivelando dai piedi di creta. Che si spiaggia sui tavoli dei magistrati, in
testa quelli che ogni giorno hanno a che fare con i reati di evasione, quando finalmente,
dopo 25 giorni di attesa, arriva il testo del nuovo disegno di legge anti-corruzione, nel
quale, agli articoli 3, 4 e 5, sono contenute le nuove norme sull’auto- riciclaggio e sul falso
in bilancio. Chi ipotizzava una trattativa sotto banco tra Pd e Forza Italia, con lo zampino
decisivo anche degli alfaniani di Ncd, è convinto che quei sospetti si stiano rivelando
fondati. Perché il reato, atteso da anni, secondo quanto si sente nelle procure, rischia di
essere controproducente.
La ragione è semplice. Basta leggere il testo. Che prevede di colpire soltanto chi ha
commesso «un delitto colposo punito con la reclusione non inferiore nel massimo a 5
anni». Come spiegano subito le toghe, già in allarme, restano fuori i reati tipici dei
riciclatori, la truffa, l’appropriazione indebita, ma soprattutto l’infedele dichiarazione e
l’omessa dichiarazione dei redditi. Reati puniti nel massimo fino a tre anni. Quindi fuori dal
futuro reato di auto-riciclaggio. Si potrà fare una truffa, o fare una dichiarazione infedele, e
riciclare conseguentemente i proventi di quel reato senza che il magistrato possa fare
nulla.
Questa è la versione definitiva di un testo che, tra palazzo Chigi e ministero della Giustizia,
ha subito molte modifiche e nel quale hanno molto inciso i mal di pancia di Ncd, identici
nel contenuto a quelli di Forza Italia. I berlusconiani chiedevano ancora di più. Volevano
che il reato fosse contestabile soltanto qualora ci si trovasse di fronte ai delitti di mafia e di
22
traffico di stupefacenti. Via tutti gli reati, corruzione compresa. Questo braccio di ferro ha
bloccato il ddl anzione ti-corruzione per settimane. Alla fine ha prevalso un compromesso
che le toghe considerano però del tutto inaccettabile.
Alla fine viene fuori un reato a metà. Innanzitutto cala la pena rispetto alla previsione
originaria, doveva essere dai 3 agli 8 anni, ma il minimo si ferma a due. Verrà punito con
questa pena chi «sostituisce, trasferisce, ovvero impiega in attività economiche o
finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo
da ostacolare l’identifica- della provenienza delittuosa». Ma ci sarà il tetto a monte, se cioè
è stato commesso un reato che supera i 5 anni di pena.
Non solo. Al comma principale ne segue un secondo, nel quale si dice che «l’autore del
reato non è punibile quando il denaro o i beni vengono destinati all’utilizzazione e al
godimento personale». Una precisazione che, se non fa proprio danno, viene valutata dai
magistrati come una possibile fonte di confusione. Per intenderci, potrebbe avvenire quello
che è avvenuto con il famoso testo del voto di scambio tra politica e mafia, il 416-ter, che
per essere troppo dettagliato e arzigogolato, alla fine è caduto davanti alla Cassazione.
Dicono i pm che questa clausola dell’auto-ricioclaggio potrebbe portare a lunghe diatribe
con l’imputato con la necessità di dimostrare che effettivamente il denaro riciclato era o
non era usato per fini solo personali. Una fonte di confusione e non di vantaggio.
Ma il vero problema della norma è il suo uso immediato. Già oggi, nella commissione
Finanze della Camera, sarà utilizzata come emendamento del governo al testo sul rientro
dei capitali dall’estero che il governo, e il ministro Padoan in particolare, ha particolare
premura di approvare. Lì dentro c’è la voluntary disclosure, per cui chi si auto accusa di
aver portato fuori capitali, potrà godere di uno sconto nella sanzione. In commissione c’è
già una versione del reato di auto-riciclaggio, su cui aveva lavorato il procuratore aggiunto
di Milano Francesco Greco. Testo diverso da quello del governo e che non conteneva la
limitazione dei reati fino a 5 anni. Proprio su questo testo ci sono state le pressioni di
Forza Italia e Ncd per una versione più morbida. Il rischio adesso è che salti tutto,
rinviando ancora nel tempo l’entrata in vigore di un reato che ancora non esiste.
del 24/09/14, pag. 4
Consulta, tramontano Violante e Bruno.
Ipotesi Paniz
ROMA .
Finisce inesorabilmente in archivio la coppia Bruno-Violante. Per la Consulta bisogna
ripartire daccapo. Anche se il Pd continua ufficialmente a dire che Luciano Violante resta
l’unico candidato e che non ve ne sono e non ve ne saranno altri, i veti incrociati con Forza
Italia rivelano che la trattativa per i due giudici costituzionali va riscritta. Per i berlusconiani
ormai Donato Bruno è alle spalle, anche se oggi lo stesso Bruno andrà a Isernia, per
incontrare i magistrati che lo hanno iscritto nel registro degli indagati per l’inchiesta Ittierre.
Lui nega tutto, ma già ieri i vertici di Fi gli avevano consigliato di fare un passo indietro per
toglierli dall’imbarazzo. Lui è stato tetragono, all’insegna dell’«io non mollo».
Nel suo partito già si declinano i nuovi nomi. In pole c’è Maurizio Paniz, l’ex deputato che
in aula sostenne la tesi di Ruby nipote di Mubarak, avvocato a Belluno, difensore di
Lavitola a Napoli, ma anche di Zornitta accusato, ma poi scagionato, dall’accusa di essere
Unabomber a Venezia. La Lega lo voterebbe. Anche se il segretario Salvini ha lanciato il
costituzionalista di Verona Mario Bertolissi. C’è sempre l’ipotesi di Nicolò Zanon,
23
costituzionalista uscente dal Csm. Nomi sui quali FI vuole aprire subito una trattativa col
Pd.
E i Dem? Rinunciare a Violante è inevitabile. Ieri i due partiti si sono accordati per votare
scheda bianca. «L’abbiamo fatto per salvare Violante» dicono i vertici. Il quale resta a
quota 544 voti. Ma, caduto Bruno e dopo la rinuncia di Catricalà, Fi non vuole più votarlo.
Se ne riparla martedì prossimo, con nuovi nomi che potrebbero essere Augusto Barbera o
Stefano Ceccanti. O due politici oppure due tecnici. Esauriti i primi, tocca ai secondi. Qui
Paniz potrebbe avere difficoltà.
Aver chiuso la partita del Csm è servito per prendere tempo per la Corte. Ha tranquillizzato
il Quirinale, che già domani insedia sul Colle il nuovo Consiglio. Alla fine, con 521 e 525
voti, ce l’hanno fatta gli avvocati Paola Balducci per Sel e Pierantonio Zanettin per Forza
Italia. Furibondi gli M5s per lo “scippo” del posto andato a Balducci. «Uno scandalo» dice
Alfonso Bonafede. Il Pd li rimbrotta perché «con loro è impossibile siglare intese».
Chi diventerà vice presidente del Csm? Ecco la gara che si apre a palazzo dei Marescialli
dove si ipotizza un plenum già sabato o più probabilmente lunedì. Giovanni Legnini, del
Pd, sottosegretario uscente all’Economia, Giuseppe Fanfani, sindaco di Arezzo e anche lui
Pd, oppure Renato Balduzzi di Scelta civica, un costituzionalista arruolato da Rosy Bindi
alla Salute all’ufficio legislativo, divenuto a sua volta ministro? Mai come questa volta i 16
componenti togati (7 della sinistra di Area, 5 centristi di Unicost, 4 di Magistratura
indipendente, di cui tre “ferriani”) appaiono divisi. Oggi si riuniranno al Csm per cercare un
accordo, che deve comprendere gli 8 laici e i due alti magistrati della Cassazione. Ogni
candidato ha un “neo”. Legnini essere un uomo del governo, anche se non renziano ma
bersaniano; Fanfani essere renziano amico del ministro Boschi; Balduzzi lontano da
qualsiasi dibattito sulla giustizia, come lo stesso Legnini. Il Pd ha indicato Legnini che ieri,
sempre con la sua grande cartella, era alla Camera a votare. Previsioni? «Non ne faccio».
(l. mi.)
del 24/09/14, pag. 16
Renzi, altolà alla minoranza Pd “Pronto allo
scontro, se vogliono” E rispunta l’ipotesi del
decreto
L’opposizione interna presenta 7 emendamenti in difesa dell’articolo 18
L’attacco di Bersani: “Matteo governa con il mio 25%, mi deve rispetto”
ROSARIA AMATO GOFFREDO DE MARCHIS
ROMA .
«Così non ci sono le condizioni per mediare. Andiamo in direzione e ci contiamo. E se
tirano ancora la corda, userò l’arma del decreto legge». Da New York Matteo Renzi si
informa sulle riunioni delle minoranze con i suoi a Roma. Quello che considera un vero
gesto di sfida, «praticamente la nascita di un partitino parallelo », è il numero delle firme
sotto gli emendamenti presentati al Senato per difendere l’articolo 18. «Quaranta senatori?
Significa che non vogliono mediare. Pensano di costringerci a chiedere i voti di Forza
Italia, provocando la crisi di governo. Bersani e Bindi non guardano all’articolo 18, puntano
a riprendersi il partito. Ma si sbagliano».
Non è la giornata giusta per avviare una trattativa fra le anime del partito. Si ferma persino
il vicesegretario Lorenzo Guerini che pure non ha mai smesso di parlare con tutti: «Spero
24
che in quel campo prevalgano le posizioni di Speranza, Epifani, Maurizio Martina». Cioè,
che mettano in un angolo i frondisti più scatenati dei quali, a Largo del Nazareno, Bersani
viene considerato il capo. In effetti, l’ex segretario non sembra disponibile al
compromesso, neanche dopo le parole di Napolitano. «Un patto con Berlusconi sul
lavoro? Ma non esiste, non ha ragione d’essere né numerica né politica. Io non voglio il
partito unico destra-sinistra. Renzi stia più sereno, sul serio. E parli col suo partito». Dice
di più, l’ex segretario, ancora scottato dalla lettera di Renzi agli iscritti in cui lo si additava
come un cacciatore di rivincite: «Renzi governa con il mio 25 per cento. Dovrebbe avere
più rispetto».
I dirigenti più vicini al premier sono altrettanto scatenati: «È tornata alla carica l’alleanza
dei perdenti. Il primo effetto? Il Pd perde qualcosa nei sondaggi. È più forte di loro,
adorano perdere», scrive in un tweet il tesoriere Francesco Bonifazi. Renzi, giurano a
Palazzo Chigi, non l’ha fatto ma avrebbe volentieri retwittato, ossia condiviso il giudizio.
«Non accettiamo veti», avverte Debora Serracchiani. I toni sono quelli dello scontro finale.
Anche perché la riunione delle minoranze di ieri sancisce un tentativo di darsi un
coordinamento, di mettere insieme le forze per raggiungere percentuali vicine al 35-40 per
cento. Invece l’assemblea notturna dei bersaniani, orientata dai mediatori, vira verso il
dialogo. Restano i sette emendamenti al Jobs Act, che ne cambiano profondamente la
portata. Non solo si recede sull’abolizione di fatto dell’art.18, visto che il “nuovo” art.4 del
ddl parla di «pieno godimento» delle tutele del contratto a tempo indeterminato «vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge» a partire «dal quarto anno di
assunzione». Ma si attenua anche la possibilità di controllo a distanza, che diventa «sugli
impianti», e dunque non più sui lavoratori. Anche sul demansionamento c’è una parziale
marcia indietro, e si introduce inoltre una nuova disposizione che impegna il governo a
«promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato
come forma privilegiata di contratto».
Del 24/09/2014, pag. 1-3
Sette emendamenti e salvi l’articolo 18
Le proposte della minoranza Pd. Tutela piena dopo 3 anni, niente
videocamere e cambio mansioni concordato. Ben 350 le modifiche
proposte invece da Sel. Airaudo: serve chiarezza su tutto lo Statuto,
contro un Renzi «incendiario»
Antonio Sciotto
La piena tutela dell’articolo 18 per tutti i neoassunti dopo i primi tre anni di contratto
a tutele crescenti. È questo l’emendamento chiave dei sette che la minoranza Pd ha presentato al Jobs Act. Gli altri sei riguardano ugualmente l’articolo 4 della contestatissima
delega approntata al Senato, e toccano altri nodi importanti, come la videosorveglianza, il
demansionamento, gli ammortizzatori sociali. Molto più nutrito il pacchetto proposto da
Sel, con ben 350 emendamenti, a tutto il testo e non solo all’articolo 4.
Il primo emendamento chiede quindi di chiarire quanto nella formula scritta dai relatori
è stato lasciato volutamente ambiguo, non venendo citata mai la parola «reintegro».
Ponendo il limite temporale dei tre anni, prima che venga maturato l’articolo 18 (e sempre
che il datore di lavoro non ti abbia licenziato, potendolo fare, un giorno prima), ci si avvicina quindi alla proposta originaria del Pd, mutuata da Boeri-Garibaldi, che parlava però di
un contratto di inserimento (che avrebbe cioè dovuto essere affiancato all’attuale tempo
25
indeteminato, lasciandolo intatto). Bisognerà capire (se mai ce ne sarà occasione, dipende
dalla fortuna di questo emendamento) se il riferimento alle tutele «crescenti» per la minoranza Pd vorrà dire inserire un indennizzo economico durante i tre anni, direttamente proporzionale all’anzianità, che “sanzioni” in qualche modo anche il licenziamento avvenuto
prima della maturazione dell’articolo 18. Quanto alla videosorveglianza, si chiede che
avvenga solo sugli impianti, e non sui lavoratori. Demansionamento: si potranno cambiare
le mansioni di un lavoratore, in caso di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione
aziendale, ma solo sulla base di «parametri oggettivi» e comunque soltanto in presenza di
un accordo tra le parti, con contratto collettivo o aziendale. Per i voucher, o buoni lavoro, si
dà l’ok per continuare a utilizzarli, ma senza una liberalizzazione selvaggia: va confermato
il tetto di 5 mila euro di reddito all’anno, per evitare che questo strumento possa sostituire
rapporti di lavoro più strutturali. Ancora, per evitare che si smontino le tutele senza riformare in modo serio gli ammortizzatori, si chiede che i due pilastri siano contestuali: prima
la riforma degliammortizzatori, con tanto di specificazione delle risorse e l’individuazione
delle politiche attive – dice un emendamento – poi la revisione delle tipologie contrattuali.
La minoranza Pd chiede che il contratto a tempo indeterminato venga promosso come
«forma privilegiata di contratto di lavoro», rendendolo «progressivamentepiù conveniente rispetto agli altri tipi di contratti in termini di oneri diretti e indiretti». Si chiede poi di
verificare la rispondenza delle tipologie contrattuali all’attuale contesto del mercato, cancellando quelle «inutili». Infine, Laura Puppato propone di dare rappresentanza ai lavoratori nei Cda delle aziende con più di 50 dipendenti: «Una misura già prevista in Germania», dice la senatrice Pd. Gli emendamenti di Sel, spiega Giorgio Airaudo, sono molti di
più: «Perché vogliamo che il governo chiarisca tutta la delega: è troppo ampia e scritta in
modo generico. Mentre Renzi parla di “cambiamento violento”, con uno stile incendiario,
è un bene che si propongano emendamenti che spingano a svelare il suo piano». Quale
piano? Secondo il deputato di Sel, «Renzi sta portando avanti il programma conservatore
dell’austerity Ue, altro che innovazione». Sel propone un periodo di prova dai 6 mesi in
su («ma 3 anni ci sembrano eccessivi»), prima di maturare l’articolo 18. Dice no alle telecamere per controllare i lavoratori, al demansionamento («taglio dei salari sotto ricatto
della crisi») e chiede chiarezza, «ma soprattutto risorse», per ammortizzatori universali.
del 24/09/14, pag. 18
Il casting di Berlusconi cento nomi under 35
per rifare Forza Italia
Decisa la fusione tra i Club Forza Silvio e il partito L’ex Cavaliere: alla
gente bisogna offrire servizi
CARMELO LOPAPA
ROMA .
Silvio Berlusconi rade al suolo Forza Italia. L’aveva ricostruita dieci mesi fa. Dell’attuale
gruppo dirigente resterà poco o nulla. Dalle minacce si passa alla fase operativa. Marcello
Fiori dal primo ottobre diventerà coordinatore del partito, ieri pomeriggio al termine del
vertice di Palazzo Grazioli con i responsabili regionali dei club “Forza Silvio”, il leader lo ha
incaricato di coordinare la fusione degli stessi club con il partito. Dei parlamentari il capo
non vuole più sentir parlare. Tanto meno li vuole vedere. Dall’agenda è sparita la prevista
assemblea con i gruppi di Camera e Senato, onorevoli spariti dai radar.
26
È solo l’inizio. Entro la fine di ottobre a Villa Gernetto saranno presentati i cento giovani sui
quali Berlusconi scommette per il rilancio. Tutti rigorosamente under 35, amministratori,
professionisti, giovani imprenditori, comunque «non professionisti della politica». Sono
stati selezionati in gran segreto in queste settimane dal consigliere politico Giovanni Toti,
dall’ex sindaco di Pavia (under anche lui) Alessandro Cattaneo, da Deborah Bergamini.
Intanto, da oggi i seimila club Forza Silvio diventeranno altrettanti presidi del partito sul
territorio e i venti responsabili locali incontrati ieri da Berlusconi affiancheranno da vice i
coordinatori regionali forzisti. «Inutile, il partito dà segni di stanchezza, dopo vent’anni
aveva bisogno di rinnovarsi » ha spiegato l’ex Cavaliere piuttosto motivato al pranzo nella
residenza romana con Giovanni Toti, lo stesso Marcello Fiori, la responsabile
comunicazione Bergamini. La missione, come ripeterà poi nel pomeriggio ai giovani e
sconosciuti responsabili dei club, è semplice: «La gente non ne può più della vecchia
politica, se vogliamo riconquistarla dobbiamo aiutarla, fornire servizi». È la politica dei
club, appunto.
Appuntamento a breve a Villa Gernetto. Ma chi sono? Che fanno? Da dove vengono
questi ragazzi? I talent scout giurano che nella selezione l’aspetto estetico non ha influito,
ma certo vanta una presenza destinata a bucare il video Andrea Romizi, 35 anni, neo
sindaco di Perugia, come Mariachiara Fornasari, avvocato, trentenne, coordinatrice
forzista di Brescia. Federica De Benedetto, a dispetto dei suoi 29 anni ha conquistato 20
mila preferenze alle Europee nella circoscrizione Sud, dove Maria Tripodi, anni 32, di
preferenze ne ha raggranellati quasi 16 mila. Carlo Bagnasco, classe ‘77, è sindaco di
Rapallo, il suo collega Giacomo Massa primo cittadino di Gottolengo, provincia di Brescia,
di anni ne ha addirittura 28, professione: studente. Ma è un trentenne anche Pietro
Tatarella, neo capogruppo al Comune di Milano e Giorgio Silli, assessore a Prato e già
responsabile nazionale Immigrazione. Ma l’elenco è lungo. Ha 35 anni il sindaco di Avola
in Sicilia, Luca Cannata, Christian Leccese, imprenditore e vicesindaco di Gaeta ha 33
anni, è coordinatore dei club Forza Silvio del Lazio. Lo è della Campania il trentenne
Pietro Smarrazzo, 38 invece Stefano Balloch sindaco di Cividale del Friuli, a capo dei club
di quella regione, e poi Pietro Spizzirri, 32 anni calabrese. Nella magic list com- paiono
anche gli intraprendenti fratelli Luca e Andrea Zappacosta con la loro Azzurra libertà (1200
giovani iscritti) promotori di una manifestazione di partito giovedì a Perugia.
Tutto è in movimento. Atmosfera tetra tra i deputati forzisti ieri in Transatlantico. Tanto più
che Berlusconi lancia segnali sempre più concilianti verso Renzi: «Per lui il momento è
delicato, il Pd rischia di implodere, D’Alema e Bersani sono tornati, se la riforma del lavoro
ci convince, la votiamo» raccontava preoccupato all’incontro coi club. Francesca Pascale,
a La7, ieri sera non era da meno: «Di Renzi non diciamo, speriamo...».
Del 24/09/2014, pag. 5
La foto di Stefano Cucchi mostrata durante il
processo
Processo Cucchi, il Pg: «Condannare gli agenti»
La richiesta dell’accusa alla Corte d’Assise d’Appello di Roma: «Tutti
colpevoli». Per il procuratore generale Remus, Cucchi fu aggredito
dopo la convalida dell’arresto
27
«Tutti colpevoli, compresi poliziotti penitenziari e infermieri». Quasi un colpo di scena, la
richiesta del procuratore generale Mario Remus alla I Corte d’Assise d’Appello di Roma
che ieri ha riaperto il processo per la morte di Stefano Cucchi. Un ribaltamento della sentenza di primo grado che il 5 giugno scorso ha condannato per omicidio colposo solo cinque medici dell’ospedale Pertini – dove il giovane tossicodipendente romano morì
nell’ottobre 2009, sei giorni dopo essere stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Regina
Coeli – prosciogliendo invece tutti gli altri imputati. Perché, come motivò la III Corte
d’Assise di Roma, Stefano Cucchi venne sì pestato, come dimostrano le lesioni vertebrali
sul corpo del giovane, ma «plausibilmente» dai carabinieri che lo avevano in custodia
durante il suo arresto e non dagli agenti della penitenziaria. E invece il Pg Remus sostiene
che Cucchi fu picchiato dopo l’udienza di convalida del suo arresto, contrariamente a
quanto ipotizzato dalla stessa accusa durante il primo grado di giudizio. «Finalmente non
ci sentiamo soli in un’aula di tribunale, per la prima volta non ho sentito insultare mio fratello», è stata le reazione a caldo di Ilaria Cucchi. «C’è la prova che Stefano non avesse
segni di aggressione violenta prima di arrivare in udienza», ha detto il procuratore generale confermando quanto ipotizzato anche dalla famiglia della vittima. L’aggressione
«volontaria e intenzionale», secondo l’accusa, da parte «degli agenti della Polizia penitenziaria che lo avevano in custodia», è «avvenuta dopo l’udienza di convalida dell’arresto e
prima della sua traduzione in carcere». E infatti, Cucchi «in udienza ha battibeccato, si è
alzato più volte, ha scalciato un banco. Certo non avrebbe potuto farlo se fosse stato
fratturato».Di qui la richiesta di 2 anni di reclusione per lesioni personali aggravate per i
poliziotti penitenziari Menichini, Santantonio e Domenici, assolti in primo grado.
Ma secondo Remus anche gli infermieri del Pertini, al pari dei medici, fornirono all’uomo
cure inadeguate, con una «trascuratezza» che «appare ingiustificabile»: «Cucchi — ha
accusato il Pg – entra in stato di detenzione in condizioni cliniche già precarie, emaciato,
con poca massa muscolare; era un paziente fisicamente difficile che richiedeva cure particolari e non ordinarie». Perciò, ha aggiunto, «le condotte contestate agli infermieri dei
quali si chiede ora la condanna sono accomunabili a quelle dei medici, anche se per
entrambi non ci fu una deliberata volontà di non curare Cucchi». La richiesta del Pg è di
condannare per omicidio colposo medici e infermieri, con 3 anni di reclusione per il primario, Fierro; 2 anni ciascuno per i medici Corbi, Bruno, De Marchis Preite e Di Carlo; un
anno per gli infermieri, assolti in primo grado, Flauto, Martelli e Pepe; e la conferma di 8
mesi di carcere per falso al medico Caponetti. «Condivido ogni parola di critica espressa
dal Pg – ha commentato l’avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia Cucchi – Sono
rimasto colpito dall’efficacia del suo intervento. Ritengo che ci abbia aperto le porte per il
riconoscimento della nostra tesi dell’omicidio preterintenzionale». Di tutt’altro avviso ovviamente i difensori dei poliziotti penitenziari: «L’assunto accusatorio sostenuto finora è completamente caduto – ha sottolineato Diego Perugini, avvocato di uno degli agenti – Il Pg
non ci ha detto chi avrebbe picchiato Stefano tra i carabinieri che lo hanno portato nelle
celle e gli agenti, e sulla base di quale testimonianza può sostenere ciò che ha detto nella
sua relazione». Ma è ancora una volta Ilaria Cucchi ad alzare lo sguardo al problema
generale: «Il procuratore generale in udienza ha esordito descrivendo un vero e proprio
pestaggio di Stato e una grave compromissione e negazione dei diritti umani in danno di
mio fratello – scrive in una nota – Dedico queste parole al senatore Giovanardi e al signor
Capece che mi attaccano sistematicamente, ed al ministro della Giustizia che prenda
provvedimenti. Affinché si possa avere un sincero momento di riflessione sui terribili fatti
che hanno portato a morte Stefano. Penso anche alla tanto auspicata approvazione della
legge sulla tortura che il nostro Paese continua a rifiutarsi di adottare a dispetto dei moniti
che ci vengono rivolti dall’Onu».
28
RAZZISMO E IMMIGRAZIONE
Del 24/09/2014, pag. 1-15
Il 3 ottobre per non dimenticare
Luigi Manconi
Il Comitato 3 ottobre, nato subito dopo il naufragio che ha portato alla morte di almeno 366
migranti a poche miglia dalla costa di Lampedusa, ha tra i suoi obiettivi l’istituzione di un
Giorno della memoria e dell’accoglienza per gli stranieri. Qualche mese fa, ho presentato
un disegno di legge, sottoscritto da decine di senatori di diversi gruppi politici, il cui titolo
recita così: «Giornata nazionale per la memoria dei migranti vittime del mare»..
Una ricorrenza per promuovere, all’interno dell’opinione pubblica nazionale, la consapevolezza di quell’immane tragedia, rappresentata dalle stragi che si susseguono nel Mediterraneo da ormai un quarto di secolo.
Non va mai dimenticato, infatti, che prima e dopo quel maledetto 3 ottobre 2013 si sono
ripetuti naufragi e decessi. Prima, al ritmo di circa 6–7 morti per ogni giorno che Dio
manda in terra, e dopo — nonostante la benemerita operazione Mare nostrum — ancora
circa 2500, nel corso degli ultimi otto mesi. Anche da questa ragione, così dolente e crudele, e dalla proposta degli abitanti di Lampedusa e delle tante associazioni che, di immigrazione, si occupano quotidianamente, nasce il mio disegno di legge.
Si prevede che la Giornata nazionale per la memoria dei migranti venga dedicata non solo
al ricordo delle tante vittime, ma anche alla riflessione sul diritto inalienabile alla libera circolazione degli esseri umani, alla dignità di quanti cercano lontano dalla propria terra
un’opportunità di vita e di futuro e alla ineludibile necessità di tutelare i fuggiaschi, i richiedenti asilo, i rifugiati. Si dispone, inoltre, che Lampedusa — testimone accorata e partecipe di tante tragedie del mare — sia sede di una commemorazione annuale, che trasformi
la sofferenza in un impegno attivo e che solleciti politiche pubbliche adeguate, affinché
quanto è accaduto non abbia a ripetersi. Un atto simbolico, certo, ma riferito a un campo di
conflitti ideologici e di battaglie culturali, dove pregiudizi anti-immigrati e pulsioni xenofobe
tendono ad affermarsi e a diffondersi. E dove, di conseguenza, anche i gesti a forte intensità emotiva e i messaggi che trasmettono senso e valori giocano un ruolo importante.
Tanto più in un paese che ha dissipato — senza trasformarla in identità rivendicata e in
narrazione condivisa — la storia grandiosa e dolorosa di decine di milioni di italiani che,
nel corso di un secolo, sono emigrati in tutto il mondo.
In questa prospettiva la Giornata per la memoria dei migranti può avere una sua funzione.
Ed è, dunque, una prima piccola buona notizia il fatto che, proprio ieri, quella proposta è
stata assegnata alla Commissione Affari costituzionali. C’è solo da augurarsi che, alla vigilia dell’anniversario del naufragio, il Senato trovi il passo spedito per approvare tempestivamente quella legge. Certo, c’è tutto il resto da fare ed è qualcosa di enorme.
All’indomani del 3 ottobre, unitamente al sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini, abbiamo
elaborato un Piano di ammissione umanitaria: una proposta concretissima e ragionevolissima per arginare il ripetersi inesorabile di quelle morti nel Mediterraneo.
Il piano è stato presentato alle più alte cariche dello Stato, ai membri del Governo che
hanno competenza sulla materia, ai parlamentari italiani ed europei, alle principali organizzazioni internazionali e alle grandi associazioni umanitarie. Questi i punti essenziali:
l’urgenza di una politica comune europea per l’asilo e la necessità di tradurla in azioni condivise; l’urgenza di porre fine alla lunga teoria di morti nel Mediterraneo e di garantire a
migranti e richiedenti asilo viaggi legali e sicuri fino al continente europeo; l’urgenza di
29
distribuire in maniera più equa e razionale l’afflusso di fuggiaschi e profughi sull’intero territorio della Ue. Ciò può essere perseguito attraverso una strategia di
avvicinamento/anticipazione della richiesta di protezione internazionale in quei paesi dove
i movimenti di fuggiaschi e profughi si addensano e transitano (Algeria, Marocco, Tunisia,
Giordania, Libano, Egitto); e attraverso un sistema di presidi assicurato dalla struttura del
Servizio europeo per l’azione esterna, dalla rete diplomatico-consolare dei paesi
dell’Unione, dall’Unhcr e dalle organizzazioni umanitarie. Un Piano per l’ammissione umanitaria da affiancare ed eventualmente combinare e integrare con altre proposte, quale il
programma di re-insediamento, i progetti di corridoio umanitario, le misure di ingresso protetto e ricongiungimento, di cui si discute nel nostro paese e in Europa.
É un piano, ovviamente, che può essere modificato e migliorato, ma di cui pensiamo sia
essenziale ciò che ne rappresenta il cuore: ovvero l’avvicinamento/anticipazione della
richiesta di protezione internazionale nei paesi dove ciò sia oggi possibile; e la garanzia di
viaggi legali e sicuri che consentano di evitare quella trappola mortale che è ormai il cimitero sottomarino del canale di Sicilia. Realizzare questo piano è certamente un’impresa
ardua, ma la sua ragionevolezza e la sua concretezza dovrebbero indurci a farne oggetto
di battaglia politica. Ne vale la pena.
del 24/09/14, pag. 29
«Dovevamo salvarli»
Da «La scelta di Catia» il video degli immigrati naufraghi, oggi su
Corriere.it I marinai guidati dalla comandante: ributtavamo in mare i
morti per fare spazio ai vivi
Appena sotto il filo dell’acqua passa un cadavere, quasi nudo, il mare gli ha portato via
anche i vestiti, e dalle immagini non si capisce bene se è un uomo o una donna. Subito
dopo si vede il ragazzo che urla, non vuole lasciarlo andare, si aggrappa come fosse una
zattera a quel corpo che per noi rappresenta solo morte, con il gonfiore e il bianco malato
che rendono terribile la visione di un essere umano annegato. Ma per lui, per quel
ragazzo, dev’essere stato vita, carne e sangue, forse un padre, forse una madre. I militari
gli gridano di staccarsi, ma lui niente, e allora gli prendono le braccia, lo trascinano verso
la motovedetta che significa salvezza,e c’è un momento dove fuori campo si sentono le
urla sempre più disperate del ragazzo mentre in un angolo dello schermo quel povero
corpo scivola via, scompare, verso il fondo.
Ci sono immagini cariche di un dolore quasi insostenibile, che però è necessario vedere.
Certe volte dovrebbe essere proibito girarsi dall’altra parte. Lo sconvolgente filmato che
oggi vedrete sul sito del Corriere della Sera fa parte di quei documenti che non fanno
sconti, esigono il pagamento di un prezzo emotivo. L’allarme venne lanciato da un profugo
che si trovava a bordo del barcone e utilizzava il telefono satellitare dello scafista. Primo
pomeriggio dell’undici ottobre 2013, quel mese terribile.
Solo otto giorni prima una carretta del mare stracarica di migranti libici si era capovolta ad
appena mezzo miglio dall’imbocco del porto di Lampedusa. Aveva girato su se stessa per
tre volte, e si era inabissata. Quel 3 ottobre, era un giovedì, vennero ripescati 194 corpi, e
il dato, già abnorme di suo, era solo parziale. Proprio l’undici ottobre la Marina militare
fornì il bilancio definitivo, 366 morti accertati, altri venti presunti. Una delle più grandi
tragedie nella storia millenaria del Mediterraneo. Siamo abituati allo stillicidio di notizie che
arrivano da quell’isola bella e disgraziata in mezzo al mare, ma un’ecatombe del genere
30
non si era mai vista, non poteva e non doveva succedere di nuovo. E invece accadde
ancora,proprio quel giorno, a distanza di una settimana appena. Morirono altre 240
persone partite dalla Siria.
Cominciamo dall’alto, e da lontano. Agli occhi della giovane tenente di vascello Catia
Pellegrino, comandante della nave Libra della Marina militare, la scena si presenta come
la vedrete voi, una distesa illuminata dal sole calante dalla quale provengono voci, urla
indistinte. Ad aguzzare la vista si distinguono piccoli gruppi di persone che alzano le mani
dall’acqua per attirare l’attenzione. A questa distanza non si capisce bene, non si colgono
le dimensioni del disastro e dell’operazione di soccorso che sta per cominciare, che deve
cominciare, ogni minuto perso significa al momento dell’arrivo sul posto uno di quei puntini
all’orizzonte non ci sarà più. Da vicino è diverso, molto diverso. Da vicino è qualcosa che
non si può spiegare con le parole. E lo sappiamo che quelle scene le abbiamo raccontate
tante volte sui nostri giornali, ma sempre attraverso il filtro dei testimoni, con le parole degli
altri. Adesso le potete vedere per la prima volta, adesso possiamo capire cosa c’è dietro il
titolo «Tragedia in mare, si ribalta gommone al largo delle coste italiane», così frequente e
ripetuto da diventare facile pretesto per rifugiarsi nell’indifferenza dell’ineluttabile.
Non sono le immagini dei corpi adagiati sul fondale a comporre un cimitero sotto al mare,
anch’esse tremende ma in qualche modo definitive. Questo filmato fa entrare in un zona
dove la vita e la morte sono vicinissime, come spiega uno dei soccorritori. L’elicotterista
quasi supplica, fate in fretta, fate in fretta. Ci sono i bambini che non vogliono lasciare il
corpo ormai inerte dei genitori, le donne che non urlano per farsi issare a bordo, urlano di
disperazione perché accanto ci sono i loro bambini che ormai non sollevano più la testa. E
poi, anche a costo di sfidare la retorica: ci sono le donne e gli uomini della nostra Marina
militare. Gente con facce, vita e famiglie come le nostre. Costretti a immergersi per
raccogliere i corpi di quei bambini e poi abbandonarli nuovamente in acqua, perché sulla
motovedetta non c’è spazio sufficiente per i vivi e per i morti, bisogna fare una scelta.
Come quella, molto più facile, di mettersi davanti a uno schermo. E guardare. Tutto, senza
distogliere mai lo sguardo. Per capire, una volta per tutte.
del 24/09/14, pag. I (Cronaca di Roma)
VERTICE CON IL SINDACO, LA PROPOSTA DEL VIMINALE
“Immigrati ospitati dalle famiglie romane”
GIOVANNA VITALE
AL MOMENTO è solo una proposta. Di quelle tuttavia in grado di rivoluzionare il sistema
con cui il nostro Paese accoglie ogni anno migliaia di rifugiati in fuga da guerre e carestie.
Sarà il Viminale ad avanzarla: al tavolo nazionale sull’immigrazione convocato per oggi.
Ma discussa già ieri, durante l’incontro tra il sottosegretario Manzione e il sindaco Marino.
UN’IDEA che all’inquilino del Campidoglio è piaciuta molto. Al punto da dirsi subito
disponibile a tradurla in realtà, nella capitale, qualora dovesse partire in forma
sperimentale.
Perché, allo stato, di questo si tratta. Di un progetto tutto da verificare sul campo. Che
però prevede una nuova modalità di accoglienza dei disperati che approdano in Italia:
anziché ricoverarli nei “centri per rifugiati e richiedenti asilo” allestiti dai comuni in
collaborazione con il Viminale, come avviene oggi, ospitarli nelle famiglie. Offrendo loro la
possibilità di farsi carico dei minori stranieri (ma all’occorrenza anche degli adulti) in
cambio di un rimborso spese. Un’operazione che per lo Stato sarebbe a saldo zero: ogni
31
rifugiato costa infatti circa 30 euro al giorno, gli stessi soldi che verrebbero girati ai nuclei
familiari disponibili a far entrare in casa un extracomunitario.
Per Roma, visti i numeri, sarebbe una svolta. Dall’inizio del 2013 a oggi, infatti, la capitale
ha fornito assistenza a 3.900 ragazzi non accompagnati, mentre i 61 centri per richiedenti
asilo e rifugiati sparsi per la città (tre dei quali solo a Corcolle e dintorni) accolgono
attualmente circa 3mila adulti. Ecco perché il sindaco Marino si è subito mostrato
interessato. Una soluzione che potrebbe servire ad attenuare l’insofferenza montante
verso gli stranieri che si comincia a respirare in periferia. Non solo nel V municipio, dove
comunque ieri l’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Masini ha annunciato arriverà una
nuova caserma dei carabinieri.
Un progetto che il ministero dell’Interno ha intenzione di accompagnare alla riforma delle
procedure necessarie per chiedere lo status di rifugiato: l’intenzione è di snellirle e di dare
una bella accelerata per tagliare i tempi, che adesso tra istruttoria e rilascio del nulla osta
superano anche i due anni. Troppi. Pure in termini di costi: economici, visto che
l’assistenza è a carico dello Stato, ma anche sociali, con tutto quel che comporta per i
comuni (e le periferie) ospitare eserciti di disperati in lotta per la sopravvivenza.
Oggi si saprà se Roma potrà fare da capofila. Nel frattempo il sindaco ha già allertato le
strutture comunali. Dopo essersi a lungo confrontato con il prefetto Mario Morcone, capo
del Dipartimento Immigrazione del Viminale, che molti (a cominciare da Marino)
vorrebbero cooptare in giunta. Magari alle Politiche Sociali, al posto della sempre data per
uscente Rita Cutini.
32
SOCIETA’
del 24/09/14, pag. 47
Da quando è stato lanciato il programma universitario hanno visto la
luce 40 mila bebé all’anno È l’ultima frontiera dell’integrazione
Erasmus
Il “grand tour” degli studenti europei fa
nascere un milione di bambini
ANAIS GINORI
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE
PARIGI
«SONO come l’Europa, un casino ». Nel film L’apparta mento spagnolo lo studente Xavier
si accoppia e si scoppia freneticamente mentre trascorre l’anno di Erasmus a Barcellona.
La pellicola di Cédric Klapisch, uscita nel 2002, coglie una verità: i ragazzi europei non si
sono mai frequentati e amati tanto come negli ultimi anni. Almeno su un punto la faticosa
Unione c’è stata: tra ragazze e ragazzi di tanti paesi, alcuni dei quali si sono poi sposati e
hanno avuto figli, proprio come nel film francese.
Galeotto fu Erasmus. L’Ue come una gigantesca agenzia d’incontri. Un milione di bambini
nati grazie agli scambi universitari tra nazioni europee, ha calcolato la Commissione in un
rapporto appena pubblicato. Circa 40 mila bebè all’anno da quando è stato lanciato il
programma, nel 1987. In questi 27 anni, spiega lo studio, quasi un terzo degli studenti
(27%) ha incontrato all’estero un partner fisso. Il 33% delle coppie “erasmiane” è mista:
con un marito o una moglie straniera.
La “generazione Erasmus” esiste davvero. Matteo Renzi ne parla spesso e sente di
farvoro ne parte anche se non ha mai partecipato al popolare scambio all’estero durante
gli studi. I quarantenni di oggi erano studenti quando esordì il programma europeo, una
nuova frontiera per gli scambi tra atenei del continente. Uno dei simboli dell’integrazione
universitaria è la ministra degli Esteri Federica Mogherini, designata Lady Pesc, che ha
scritto la sua tesi di laurea sul rapporto tra religione e politica nell’Islam durante il suo
Erasmus a Aix-en-Provence. Mogherini, 41 anni, ha conosciuto poi il suo attuale marito a
Bruxelles.
Il baby boom provocato da Erasmus è solo uno dei punti di cui racconta il voluminoso
rapporto pubblicato da Androulla Vassiliou, commissaria all’Istruzione e la Cultura. Uno
studio realizzato attraverso interviste a oltre 80 mila studenti o ex studenti di tutti i paesi
dell’Ue. Il programma, conclude il rapporto, aumenta le probabilità di trovare lavoro.
Cinque anni dopo la laurea, il tasso di disoccupazione degli studenti Erasmus è inferiore
del 23%. Il 40% di chi ha vissuto questa esperienza si è trasferito in un altro paese dopo la
laurea, quasi il doppio di quel 23% che invece non ha seguito questo programma. Infine, il
93% dei ragazzi Erasmus non fa fatica a immaginare di vivere in futuro all’estero, 20% in
più rispetto a chi non ha mai studiato fuori. Un bel vantaggio a fronte delle richieste di un
mercato sempre più globalizzato.
Il paradosso è che uno dei simboli più apprezzati e di successo dell’Europa è ancora
fragile, sempre minacciato dai tagli al bilancio. Il rapporto presentato dalla Commissione
ha come obiettivo di dare nuovi argomenti ai difensori di Erasmus e scongiurare nuove
drastiche riduzioni. «In un contesto europeo segnato da livelli inaccettabili di
disoccupazione giovanile — sottolinea la commissaria Vassiliou — i risultati di questo
33
studio sull’impatto di Erasmus sono estremamente significativi ». Il rapporto dimostra che il
92% dei datori di la- cerca nei candidati i tratti della personalità che sono potenziati dal
programma: tolleranza, fiducia in se stessi, abilità a risolvere problemi. Prima dell’estate, la
Commissaria ha scritto a tutti i ministri della Cultura europei affinché spingano i rispettivi
paesi a evitare nuovi tagli. «È un problema costante, generale che coinvolge tutti»,
ammette Vassiliou. Due anni fa l’Erasmus rischiò addirittura di chiudere.
Ma mentre i partiti populisti ovunque in Europa, vogliono chiudere frontiere e rinegoziare
Schengen, i ragazzi sognano di passare un periodo di studi fuori dal proprio paese.
L’obiettivo dell’Ue per la mobilità degli studenti è di almeno il 20% entro il 2020. Oggi solo
il 10% dei giovani europei si forma all’estero, di cui il 5% con una borsa Erasmus. Nel
2012, ultimo dato disponibile, gli studenti Erasmus sono stati 253mila, di cui oltre 6mila
italiani. «Accanto al programma tradizionale — ricorda la Commissaria — esordisce il
nuovo Erasmus Plus che offrirà sovvenzioni Ue a 4 milioni di giovani entro il 2020, dando
loro la possibilità di sperimentare la vita in un altro paese con studi, formazione,
insegnamento o volontariato». E forse anche di di incontrare l’anima gemella.
34
BENI COMUNI/AMBIENTE
del 24/09/14, pag. 24
Clima, scontri a Wall Street: 100 arresti
La protesta del movimento ecologista contro il connubio “banchepetrolieri” nel giorno del vertice di New York all’Onu L’allarme di
Obama: “L’inquinamento è la minaccia numero uno del secolo. Il mondo
tagli subito le emissioni”
ALBERTO FLORES D’ARCAIS
NEW YORK .
È la minaccia “numero uno” del secolo. Non usa mezze parole Barack Obama, nel pianeta
Terra il clima sta cambiando più velocemente «dei nostri sforzi per affrontarlo», quella che
un tempo ci sembrava una minaccia lontana «è qui nel presente» e nessuno può pensare
di esserne immune. Dal palco delle Nazioni Unite, due giorni dopo che 300mila persone
sono sfilate nelle vie di New York nella più grande manifestazione ambientalista di
sempre, il presidente americano invita il mondo (Usa e Cina in primis) ad unirsi nella
principale sfida che attende il genere umano. Ma il movimento ecologista inscena lo
stesso una manifestazione di protesta a Wall Street, provocando tafferugli con la polizia.
«Quali che siano le sfide immediate cui cercheremo di dare una risposta in questa
settimana — terrorismo, instabilità, diseguaglianze, malattie — una marcherà i contorni di
questo secolo in maniera più spettacolare di tutte le altre: la minaccia urgente e crescente
del cambiamento climatico», afferma Obama. Dirlo nel giorno in cui la “coalizione” Usaaraba ha iniziato a bombardare l’Is nel nord della Siria, era un modo per rimarcare il fatto
che (almeno) una delle grandi promesse di “cambiamento” fatte a suo tempo dal
presidente Usa sarebbe stata rispettata.
Una sfida globale che potrà essere vinta solo «se si uniranno a noi tutti i paesi del mondo»
in modo da arrivare a un accordo «ambizioso, inclusivo, flessibile» per rispondere alla
minaccia «prima che sia troppo tardi». Il presidente Usa ha orgogliosamente rivendicato
(le critiche alla Casa Bianca anche su questo terreno non sono mancate) come negli ultimi
otto anni gli Usa abbiano ridotto l’inquinamento da carbonio «più di ogni altra nazione», ha
promesso di fare ancora meglio tagliando l’inquinamento da anidride carbonica del 17 per
cento entro il 2020.
Nessun paese deve rimanere in disparte nella lotta al riscaldamento globale, sostiene
Obama. Il “campanello d’allarme” continua a suonare, i cittadini continuano a marciare, ed
è tempo che «il mondo risponda alla chiamata», superando le divisioni. «Gli Usa hanno
fatto investimenti ambiziosi nell’energia pulita, chiedo agli altri paesi di unirsi a noi. Non il
prossimo anno, ma ora». Un invito rivolto in primo luogo alla Cina perché «come maggiori
economie e maggiori responsabili delle emissioni di gas serra, siamo i primi a dover
guidare questa sfida».
Con una mossa a sorpresa gli ambientalisti rilanciano Occupy Wall Street in chiave verde.
Dopo il successo della manifestazione di domenica, un migliaio di manifestanti ha
assediato Wall Street per denunciare il connubio “banche-petrolieri”. Con qualche
tensione, scaramucce e un centinaio di arresti.
35
Del 24/09/2014, pag. 8
Clima, solo emissioni di intenti
Il summit di New York. «Bisogna invertire la rotta», tutti d’accordo al vertice Onu sul
riscaldamento globale. Ma Obama ha le mani legate. Gli Usa, in pieno boom
petrolifero, non firmeranno trattati internazionali
Luca Celada
Nella time line dei summit ambientali quella di ieri a New York è stata una tappa più che
altro simbolica in attesa del vertice «di lavoro» in programma a Parigi a fine 2015 da cui
dovrebbe scaturire un vero programma. Dal quartiere generale Onu, allagato durante
l’uragano Sandy due anni fa, il segretario generale Ban Ki-Moon ha dichiarato che
è essenziale che il mondo diventicarbon-neutral entro la fine del secolo. Sul podio ieri si
sono succeduti oratori come il sindaco di New York Di Blasio, Al Gore e Leonardo di
Caprio, ognuno ha parlato degli effetti distruttivi ormai incontrovertibili di un clima in uno
stadio avanzato di mutamento e del tempo ormai in scadenza per agire.
Ma il summit sul clima ha visto il presidente degli Stati Uniti in una posizione fin troppo
consueta. Obama ha esortato i 125 capi di stato che hanno accolto l’invito del segretario
Ban Ki-Moon, a «intraprendere passi concreti» per limitare le emissioni serra, ribadendo
che non agire oggi sul riscaldamento globale equivarrebbe a un tradimento delle generazioni future. Purtroppo anche questa volta, come in tanti precedenti consessi, i leader in
platea hanno lecitamente potuto chiedersi da che pulpito è arrivata la predica.
Il fatto è che dalla disfatta di Kyoto la posizione americana sul clima è stata segnata
dall’impotenza se non dalla colpevole inerzia. Il protocollo di Kyoto venne sotto scritto nel
1997 da Bill Clinton ma non fu mai ratificato da un congresso ostile e fortemente influenzato dalle potenti lobby petrolifere Usa. A quella sconfitta ne seguì una incassata personalmente da Obama con il nulla di fatto a Copenhagen nel 2009, all’inizio del suo
mandato.
Le prospettive per Parigi non si profilano migliori. La firma di un accordo internazionale
vincolante richiede una maggioranza di due terzi nel parlamento americano. Impensabile
nell’attuale clima politico che fra meno di due mesi potrebbe addirittura vedere entrambe le
camere in mano a un partito che sposa ufficialmente il negazionismo climatico. Fra i principali ostacoli alle effettive riforme spicca quindi un sostanziale eccezionalismo americano
per cui gli Usa non hanno ad esempio mai sottoscritto i trattati internazionali contro la
discriminazione delle donne e per l’eliminazione della tortura, delle mine anti-uomo e delle
bombe a grappolo. In ognuno di questi casi l’argomento ufficiale è stata la tutela della pre
rogativa «indipendente» degli Stati Uniti.
Precedenti che non depongono certo a favore della battaglia contro le emissioni atmosferiche, dove sono in gioco miliardi di fatturati e profitti industriali. Obama ha quindi avuto un
bel esortare ma la realtà è che ha le mani legate. Eppure senza una piena partecipazione
americana non sono realistiche le prospettive per invertire la rotta. Il presidente Usa ieri ha
rimandato l’annuncio di nuovi obiettivi a lungo termine al 2015. John Podesta, segretario
per il clima e l’energia, ha confermato che bisognerà aspettare il primo trimestre del
prossimo anno Obama si è dunque limitato a dichiarazioni di generico intento e a ricordare
le sue recenti riforme come le normative varate a giugno per il contenimento delle emissioni e la riduzione del 30% entro il 2030 dell’inquinamento delle centrali termiche a carbone rispetto ai livelli del 2005. Un passo concreto che gli è valso l’aperta opposizione di
molti esponenti, anche democratici, degli stati in cui l’industria carbonifera è più forte.
E questo è il discorso emerso come centrale a New York. Tutti gli intervenuti hanno infatti
ripetuto che una efficace politica ambientale presuppone una effettiva riforma economica,
36
che non può esserci progresso sul clima senza una fondamentale revisione delle pratiche
industriali. Nelle manifestazioni popolari organizzate alla vigilia del summit Naomi Klein
aveva ribadito il concetto di sostanziale «incompatibilità ambientale» dell’imperante liberismo capitalista. Un concetto ripreso anche da molti relatori all’interno del palazzo di vetro,
come Leonardo Di Caprio. «Dobbiamo smettere di dare agli inquinatori la licenza che
hanno avuto nel nome del libero mercato — ha detto l’attore rivolto ai capi di stato — non
meritano i nostri contributi fiscali ma semmai il nostro attento scrutinio». Un idea ribadita
anche dall’ex presidente messicano Felipe Calderón che ha ricordato che globalmente il
comparto energetico gode ancora di 600 miliardi di dollari di sussidi e incentivi pubblici
rispetto ai soli 100 a favore delle energie rinnovabili.
È una realtà particolarmente evidente nel paese ospite. Nonostante i nuovi limiti imposti al
carbone infatti, gli Stati Uniti sono nel pieno del maggiore boom petrolifero dagli anni 40,
un enorme revival degli idrocarburi che ha il tacito appoggio di un’amministrazione che ha
autorizzato un numero record di esplorazioni off shore. Grazie a nuove tecniche di estrazione super inquinanti come il fracking, sono diventate accessibili enormi riserve di gas
e petrolio. Acqua e agenti chimici iniettati ad alta pressione hanno «liberato» metano profondo e petrolio. Nuovi oleodotti si snodano dai pozzi del Dakota e dalle sabbie bituminose
del Canada verso le raffinerie del Golfo del Messico. Il boom sta trasformando l’America
da importatrice a esportatrice netta di idrocarburi. Le importazioni infatti sono diminuite del
50% solo negli ultimi 7 anni e il paese sarebbe praticamente autosufficiente se non fossero le stesse compagnie petrolifere a non volerlo. È di gran lunga più lucroso gestire un
margine di scarsità, non saturare il mercato interno e ottimizzare invece quote di gas
e petrolio su quello internazionale. In queste condizioni si prevede un aumento del 60%
della domanda di idrocarburi nei prossimi 20 anni — l’esatto opposto di ciò che è stato
auspicato nei discorsi di ieri. In questa sbornia di carbonio, il ruolo politico è stato di colpevole acquiescenza nel nome di un imprescindibile ripresa economica. Ennesima conferma
che forse solo quando i danni economici del mutamento climatico — il calo dei consumi
nel vortice artico dello scorso inverno, ad esempio, o la drammatica siccità nel paniere
californiano — supereranno i rapidi profitti petroliferi, i politici ritroveranno la «lungimiranza». Salvo poi essere troppo tardi.
Del 24/09/2014, pag. 8
Evo Morales: «L’atto d’accusa dei popoli
indigeni»
Movimenti. I presidenti progressisti dell’America latina raccolgono le
istanze della piazza
Geraldina Colotti
<<Siamo inarrestabili, un altro mondo è possibile». Le manifestazioni che hanno accompagnato il vertice Onu sul clima, nei dintorni di Wall Street, hanno riempito di contenuto le
dichiarazioni di principio e le promesse non vincolanti, enunciate in buona o in cattiva fede.
«Bisogna collocare il mondo in una nuova direzione», ha detto il segretario generale delle
Nazioni unite, Ban Ki– moon. Per i movimenti, la direzione giusta implica un’inversione di
rotta rispetto allo sviluppo capitalistico e alle speculazioni finanziarie che subordinano
risorse umane e naturali ai diktat del profitto.
Le manifestazioni che si sono svolte domenica a livello mondiale e gli scontri scoppiati
a New York hanno messo in evidenza l’ampiezza di una nuova coscienza ambientalista:
37
legata al ripudio di un modello economico che «causa miseria, disuguaglianza e crisi ricorrenti» e rivolta contro quei «simulacri di democrazia» che demoliscono i diritti sociali e individuali e consentono l’ulteriore «concentrazione di ricchezza in poche mani, calpestando la
volontà popolare». Questo hanno scritto e gridato i movimenti mostrando il legame ineludibile tra l’ambito economico, politico e ambientale. Un’indicazione emersa dai 5 «blocchi»
in cui si è organizzata la marcia: «La prima linea della crisi, avanguardia del cambiamento», in cui hanno sfilato i rappresentanti dei popoli indigeni e altre comunità colpite
dall’estrazione di combustibili fossili e dagli effetti del cambio climatico; i sindacati dei lavoratori e degli studenti con lo slogan: «Possiamo costruire il futuro»; i gruppi in favore delle
energie alternative, gli alimenti sostenibili e l’acqua che dicevano: «Abbiamo le soluzioni»;
il blocco «Conosciamo i responsabili», che ha denunciato le imprese di combustibili fossili,
le banche e altri contaminatori. Gli scienziati e gli attivisti di diverse religioni con lo slogan:
«Il dibattito è finito». E infine il blocco «Per cambiare tutto, abbiamo bisogno di tutti». Movimenti cresciuti, in America latina, nel generale rinascimento che ha portato in sella governi
socialisti o progressisti. Il loro impegno al vertice, ha messo in luce quella maturità evidenziata dalle piazze: «Nel 2025, il 45% dell’energia prodotta in Cile sarà rinnovabile», ha promesso la presidente Cilena, Michelle Bachelet. «Il costo per affrontare il cambiamento climatico è elevato ma per i benefici che implica ne vale la pena», ha affermato la sua omologa brasiliana, Dilma Rousseff, manifestando il proposito di ridurre ulteriormente la deforestazione, già diminuita del 70%. «Chiedo ai giovani dei popoli indigeni di appropriarsi
degli strumenti internazionali per farli valere a livello nazionale», ha detto la Nobel guatemalteca, Rigoberta Menchu durante il Vertice dei popoli indigeni, facendo riferimento alla
dichiarazione Onu sui diritti dei nativi approvata nel 2007. Secondo la Cepal, in America
latina vi sono 826 popoli originari, per un totale di 45 milioni di persone: l’8,3% della popolazione complessiva della regione. I dati dell’Onu dicono che gli indigeni – il 5% della
popolazione mondiale – costituiscono un terzo dei 900 milioni di persone che vive in
povertà estrema nelle zone rurali. Ieri come oggi, dal Guatemala al Messico, sono quelli
che più scontano i costi del neoliberismo. Il primo presidente indigeno della Bovilia, Evo
Morales, ha accusato l’inconseguenza dei paesi sviluppati rispetto al protocollo di Kyoto.
«Se vogliamo cambiare il clima, dobbiamo cambiare il sistema», ha detto il suo omologo
venezuelano, Nicolas Maduro, riprendendo lo slogan dei movimenti ambientalisti. Ha ricordato che «il 20% dei paesi più ricchi del mondo consuma l’84% delle risorsei» ed ha accusato quei modelli predatori che parlano di energia verde. Da qui, l’impegno del Venezuela
per una società eco-socialista: «Il Venezuela – ha detto – sostiene il 70% della sua
domanda di energia con l’idroelettrica e ha posto nel 60% del suo territorio oltre 22 aree
protette, preservando 58 milioni di ettari di bosco, inclusi parchi, riserve della biosfera
e fauna».
38
INFORMAZIONE
Del 24/09/2014, pag. 14
Editoria al Fondo, giovedì conferenza stampa
alla Camera
Ri-Mediamo. La rubrica settimanale di Vincenzo Vita stavolta è dedicata alle
difficoltà dell'editoria. Il finanziamento pubblico è ormai ridotto a 40 milioni. Ma se le
risorse sono poche si possono distribuire meglio
Vincenzo Vita
Giovedì mattina alla Camera dei deputati si terrà una conferenza stampa sulla crisi
(finale?) dell’editoria promossa unitariamente da: Alleanza delle cooperative italiane della
comunicazione, Federazione della stampa, Federazione settimanali cattolici, Federazione
dei liberi editori, Associazione stampa online, Unione stampa periodica, Cgil, Articolo 21
e Mediacoop. Vuole essere un appello al Governo e al Parlamento per salvare il pluralismo dell’informazione nazionale e locale. Mentre, infatti, si ipotizzano Stati generali del
settore, riforme più o meno organiche, quaranta testate del mondo cooperativo e non profit
hanno già chiuso i battenti e altri mille professionisti hanno perso il posto di lavoro. Innumerevoli volte è stato denunciato un simile rischio, dopo i tagli costanti subiti dal Fondo
per l’editoria, pur rivisto negli anni recenti con un’opera di moralizzazione dei criteri di attribuzione dei contributi. Si è passati da 506 milioni di euro del 2007 agli attuali 140, comprensivi del debito con le Poste e della quota prevista per le convenzioni della Rai (non
poteva il Governo tagliare 100 e non 150 milioni all’azienda pubblica?).
Il fondo pubblico per l'editoria è passato dai 506 milioni del 2007 ai 50 del 2014
Quindi, ai giornali vanno solo 50 milioni, che diverranno sì e no 40 il prossimo anno. Per
arrivare alla linea di galleggiamento ne mancano una settantina. Mentre i cosiddetti «Over
the top» (Google e i suoi grandi fratelli) prosperano, la carta stampata muore. Il caso
recente de l’Unità e quello annunciato di Europasono le punte dell’iceberg di una desertificazione allarmante. La conclamata transizione alla diffusione on line e all’era digitale ha
effetti «collaterali» mostruosi: un cimitero piuttosto che un pranzo di gala.
Ecco, si chiede di vivere, di immaginare il definitivo passaggio alla stagione della rete
come un percorso da governare con sapienza; non come una resa incondizionata agli
«spiriti animali» del capitalismo. Quest’ultimo –prima che sia troppo tardi, ci ammonisce
Thomas Piketty nel suo straordinario recente volume — va controllato democraticamente.
Qui sta il punto. Se si dovesse verificare la moria delle testate meno inserite nel «libero»
mercato, sarebbe trafitta nelle fondamenta la costruzione dello Stato moderno. Altro che
innovazione. Senza una pluralità di voci e di espressioni culturali vincerebbe un terribile
pensiero unico, degno del passato più oscuro. Davanti a simile precipitazione della crisi
è doveroso un immediato intervento normativo, in attesa della riforma. Serve una normativa aggiornata del sistema dei media, figlia di una stagione di soggezione alla televisione
del conflitto di interessi. Che senso ha spezzettare l’iniziativa, intervenendo – ad esempio
— sul canone della Rai con un decreto legge (così parrebbe, almeno), lasciando in agonia
decine e decine di quotidiani e periodici? Si riveda una volta per tutte la natura Fondo
dell’editoria, trasformandolo in un vero e proprio Fondo per la libertà di informazione, in
grado di evitare la caduta agli inferi delle componenti fuori dal coro.
Dove si trovano le risorse? Si guardino i bilanci del settore integrato delle comunicazioni
e si vedrà che non è così difficile. E poi, un intervento dello stato –magari a termine–
39
rimane essenziale per contribuire al rilancio dell’informazione. O si preferisce un’Italia via
via marginalizzata e senza cultura? Lettrici e lettori stanno diminuendo pesantemente e un
giorno dopo l’altro – come cantava Luigi Tenco — l’editoria esce di scena, senza neppure
lacrime e pentimenti da parte di chi dovrebbe parlare, ma non dice e non decide.
40
CULTURA E SCUOLA
del 24/09/14, pag. 29
A San Gimignano va in scena l’ultimo schiaffo ai nostri Beni culturali.
Teloni di plastica ed erbacce coprono i mosaici
Per un fallimento il terreno degli scavi va all’asta e presto le ruspe
potrebbero seppellirli per sempre
Il tesoro ritrovato torna sottoterra così la
burocrazia uccide la villa romana
MAURIZIO CROSETTI
DAL NOSTRO INVIATO
SAN GIMIGNANO
IL tesoro giace sotto questi teli neri dell’immondizia, tra un fiore giallo solitario al centro del
campo e un cespuglio là in fondo. Dietro la rete di recinzione mezza divelta, oltre il cartello
(“Pericolo!”) che penzola nel vuoto, sotto la plastica trattenuta dai sassi e sfidata dal vento,
c’è una villa romana del terzo secolo dopo Cristo, una meraviglia di mosaici, sale,
padiglioni, marmi. C’è, ma tra poco potrebbe venire di nuovo coperta di terra per ordine
della Sovrintendenza ai beni architettonici. Sepolta, laggiù dov’è stata per milleseicento
anni. Incombe un possibile funerale dal valore altamente simbolico: officiante il rito, la
triste burocrazia italiana.
Il luogo è circondato dalla bellezza quasi insostenibile delle colline senesi, poco oltre San
Gimignano, frazione di Aiano-Torraccia di Chiusi. Qui, dal 2005 al 2012 è stato riportato
alla luce un sito archeologico di enorme valore, sette anni di lavoro per ridare vita alla
dimora di un nobile romano, probabilmente un proconsole dell’Impero. Una scoperta
monumentale e inattesa, intuita già negli anni Venti dal grande archeologo Ranuccio
Bianchi Bandinelli e svelata in parte all’inizio degli anni Settanta, qui, lungo la via
Francigena. Centinaia di persone hanno scavato a forza di pale, ripulito, restaurato,
inventariato un capolavoro accostabile alla Villa del Casale di Piazza Armerina, facendo
però i conti senza l’oste. Cioè senza il signor Leonardo Berti, pensionato e proprietario del
terreno. Vittima di qualche guaio finanziario, costui sta per essere dichiarato fallito dal
tribunale di Siena, e i suoi beni andranno all’asta. Tutti, compreso il campo dei miracoli:
10mila metri quadrati, di cui 2.500 scavati forse invano. Siccome non si può pagare
l’indennizzo di occupazione (una miseria, 500 euro l’anno) a chi è invischiato in un
fallimento, e non si può identificare legalmente il soggetto al quale versare la somma, da
quasi tre anni gli scavi sono fermi. E potrebbero non riprendere mai più.
Si mangiano il fegato non solo ricercatori e studiosi, ma anche gli sponsor: l’Università
cattolica di Lovanio, in Belgio (che ha la concessione dello scavo), la Fondazione Monte
dei Paschi, l’Università di Firenze e il Comune di San Gimignano. Finora hanno speso (o
sprecato) 220mila euro, e potrebbe finire anche peggio. «Per proteggere il sito dalle
intemperie, la Sovrintendenza può ordinare di ricoprirlo e a quel punto non ci sarebbero
più certezze sul destino della villa ». Il professor Marco Cavalieri, direttore scientifico della
missione e docente di archeologia romana proprio a Lovanio, rivela come in Belgio
definiscono tutta questa storia: «I miei colleghi la chiamano “la vicenda della repubblica
delle banane”, e c’è davvero da vergognarsi. Questa è l’immagine che dà l’Italia di se
stessa, di come non sappia o non voglia tutelare i tesori culturali».
41
Dietro le vetrate del suo piccolo ufficio, guardando dall’alto i giapponesi che fotografano
ogni millimetro di San Gimignano, il sindaco Giacomo Bassi si sbraccia come un vigile
urbano. «Ma io dico, come possiamo fermare questa umiliazione? La Sovrintendenza non
è cattiva, ci mancherebbe, anzi potrebbe dare quell’ordine solo per salvare la villa: però
sarebbe una sconfitta per tutti. Abbiamo stanziato 40mila euro per l’acquisto del terreno
ma il giudice non risponde, è tutto fermo. Siccome siamo in presenza di un fallimento,
anche la procedura di esproprio per pubblica utilità non è applicabile. Insomma, siamo
bloccati». In barba a vincoli e tutele.
Il paradosso, uno dei molti in questa assurda storia, è che un eventuale acquirente che
non fosse un ente pubblico non potrebbe farsene proprio nulla, dell’area del signor
Leonardo. Perché mica puoi costruire una casa, un centro commerciale o un parcheggio
sopra un sito archeologico. Il Comune ha proposto al tribunale di Siena il frazionamento
della proprietà, per poter acquisire solo il terreno e non mandare tutto a monte. Come
risposta, per ora, un profondo silenzio. «Qui si rischia non solo una monumentale
figuraccia in mondovisione, ma un danno culturale incalcolabile ». Il dottor Giacomo
Baldini, ragazzone allampanato con gli occhi consumati dai libri ma ancora accesi
dall’entusiasmo, è il direttore dello scavo di Aiano. L’uomo che ha tolto il tesoro dalla terra
non vorrebbe davvero vederla precipitare di nuovo, rovesciata dalle ruspe. Sarebbe,
anche, la dolorosissima tumulazione di un sogno. «Questa villa racconta almeno quattro
secoli di storia, può dirci se fosse solo una nobile residenza per l’otium, oppure un
caposaldo del potere romano in Val d’Elsa. Ma dopo tre anni di cantiere bloccato, la
pioggia e le erbacce ucciderebbero tutto questo: ecco perché potrebbe esserci ordinato di
interrare. Ci vorrebbero altri 20mila euro e una settimana di tempo, mentre è più difficile
quantificare il danno per la comunità. Secondo me, incalcolabile ».
Il funerale della villa coprirebbe la stanza trilobata a pianta esagonale, le esedre
dell’ambulatio che la racchiudeva, gli 80 metri quadrati dello splendido mosaico bianco e
nero, le losanghe e i cerchi, la treccia decorativa e il cratere fiorito. Fa male al cuore
immaginare la nuda terra che si abbatte su tutta questa meraviglia e la soffoca, forse per
altri duemila anni o per sempre. Dopo il passaggio delle ruspe, le malepiante e il maggese
diventerebbero gli unici padroni della conca, ora che il vento e le api la ingentiliscono nel
silenzio del pomeriggio. Nessuno potrebbe più ricostruire la storia ancora misteriosa di un
luogo e di un tempo, forse svelata dallo scavo, se solo potesse proseguire. Invece il finale,
quello sì rimarrebbe chiarissimo: dopo i Romani vennero i barbari, e sono ancora qui.
del 24/09/14, pag. 45
Tre piccole produzioni con un tema in comune: che cosa significa
nascere e crescere in una realtà magnifica e feroce
Napoli
Sullo schermo arriva la città che non ha paura
CONCITA DE GREGORIO
NAPOLI
«SE domani accadesse qualcosa ce lo pigliamo, come ci siamo sempre presi tutto», dice
la ragazza nel film. Parla del Vesuvio, se il vulcano erutta che possiamo fare. Ma non si
tratta solo della lava. Lei dice: tutto. Ci siamo sempre presi tutto, senza paura.
Napoli racconta Napoli e lo fa come nessun altro può fare: le voci, i volti, le storie
esemplari di persone qualsiasi che dicono in pochissime parole, spesso solo con gli
42
sguardi e i silenzi, cosa vuol dire nascere e crescere in una città magnifica e feroce.
«Adesso dimmi delle cose belle che ti vengono in mente», chiede il regista — un altro
regista — alla ragazzina. «Le cose belle, le cose belle… » risponde lei cercandone una
con gli occhi che si alzano, poi tace, poi cerca ancora, poi sorride come a chiedere scusa.
Non sa dire. A tutto volume la canzone che cantano tutti: Maria dov’è, Maria non si chiama
più Maria.
A pochi mesi da “L’arte della felicità”, l’animazione di Alessandro Rak partita pianissimo,
sottovoce, e arrivata in tutto il mondo (ora candidata agli Oscar europei nella categoria
miglior cartoon), ecco altri due film delicati e magnifici che mostrano Napoli. Due piccole
produzioni. “Le cose belle” di Agostino Ferrente (“L’orchestra di piazza Vittorio”) e
Giovanni Piperno è uscito a giugno e da tre mesi resiste nelle sale grazie a un passa
parola formidabile. È diventato un fenomeno, come accadde anni fa per “Il vento fa il suo
giro” di Giorgio Diritti. Lo chiedono nei paesi i cineforum, le arene estive, i piccoli festival.
Lo premiano ovunque. Passa di sala in sala nelle grandi città (l’elenco ogni giorno
rinnovato sul sito www.lecosebelle.eu), cammina e cresce. Un’immensa fatica produttiva,
pochissima pubblicità, quasi niente, nessun nome di richiamo nel cast. Solo la forza di
un’idea, con poetica ostinazione realizzata: tornare a cercare tredici anni dopo i quattro
bambini protagonisti di un documentario realizzato dagli stessi autori alla fine degli anni
Novanta, “Intervista a mia madre”. Adele, Enzo, Fabio e Silvana avevano allora 13, 14
anni. I sorrisi e la forza di ragazzini che dicono «sono bocciata quattro volte perché sono
coraggiosa, non mi sono mai fatta comandare ». E che cantano con la chitarra nei locali,
ballano nel soggiorno con la tv sempre accesa e dicono farò la modella, da grande. Farò il
calciatore. Le immagini di allora e quelle di oggi, negli stessi luoghi. Loro, tredici anni
dopo, cosa fanno e come sono diventati. Napoli tutto attorno, le macchine e l’immondizia,
la Madonna e la processione, il mare, il mare e la musica che suona ovunque.
Neomelodici, Maria dov’è.
Cantante neomelodica è anche Yole, una delle voci principali di “Sul Vulcano” di
Gianfranco Pannone, Blue film produzione, in uscita ad ottobre. Yole canta alla Madonna,
in una delle scene più intense del film, mentre la processione resta ferma davanti
all’immagine sacra. Il mare e il Vesuvio. La minaccia che domina, paesaggio dei giorni.
«Se succede, mi dico, dove scappo? Sempre spero che la catastrofe sia dolce», dice
Matteo, che con la cenere fa quadri bellissimi. Una catastrofe dolce. «Qui è difficile stare»,
dice Maria. È difficile, ma si vive e si resta. Le immagini straordinarie dell’Istituto Luce, in
bianco e nero, delle eruzioni si accompagnano alle parole di Curzio Malaparte, Norman
Lewis, Fabrizia Ramondino, Plinio il giovane e poi a quelle — oggi — di Yole, Maria,
Matteo e tanti delle migliaia di “vesuviani” che vivono tra ville pompeiane diroccate, strade
luride e giardini magnifici, adolescenti che sgommano in moto, reclute della camorra,
ragazze che si tagliano i capelli a zero e poi siedono sulle panche della chiesa a parlare, lì
in pace, fra loro. Qui è difficile stare, e «non dobbiamo avere paura», questa la formula
sciamanica. La paura, la paura da attraversare per farla diventare coraggio. Perché non è
il vulcano, il vulcano fa il suo mestiere. Non è la natura che fa paura a chi ci vive accanto,
è tutto il resto. Una vita piena solo di quello che manca, da riempire di speranza
irragionevole, necessaria. Come i bambini di “Le cose belle”, che quando ridono e ballano
sono fatti di luce e poi il tempo passa e gli occhi si spengono ma la musica resta. Identica,
sempre daccapo, Maria dov’è?, identica la processione della Madonna e la partita di altri
bambini al pallone, bambini nuovi. Perché, dice Enzo che da piccolo cantava ai tavoli e ora
vende contratti del telefono su per le scale dei condomini, «forse il tempo è solo una
credenza popolare. Una scaramanzia, un trucco, una superstizione ». Se chiudi gli occhi e
canti, a Napoli, il tempo e la paura non esistono. Infatti per strada, guarda, un altro bimbo
proprio adesso segna un gol.
43
ECONOMIA E LAVORO
del 24/09/14, pag. 23
Le principali voci del dissenso sono arrivate dai settori più esposti alla
crisi economica: il Nord, le categorie dell’industria, i pensionati
Una leadership al capolinea tra malumori,
lettere anonime e la fine della concertazione
LUISA GRION ROBERTO MANIA
ROMA .
La Cisl ha mollato Bonanni. Può essere paradossale in un’organizzazione governata per
anni con pugno di ferro dal sindacalista abruzzese di Bomba, ma è successo. «Il mio
tempo è finito», ha detto ieri il segretario uscente ai microfoni del Tg1. Ma che il suo tempo
fosse finito glielo avevano detto, dopo anni di totale unanimismo, proprio i suoi. Nell’ultima
riunione dell’Esecutivo nazionale, nelle riunioni territoriali, qua e là con tante contorsioni in
sindacalese anche in qualche documento serpeggiava il dissenso. Bonanni, classe 1949,
ne ha preso atto. E ha deciso di accelerare il ricambio, di passare il testimone nelle
prossime settimane alla genovese, cinquantaseienne, Annamaria Furlan, prima donna
candidata a guidare il sindacato d’ispirazione cattolica, il secondo per numero di iscritti
dopo la Cgil. Tutto così, se non ci saranno incidenti di percorso. Perché ora nella Cisl non
c’è più niente di scontato. Anche Bonanni sarebbe dovuto andarsene tra sei mesi, e
invece ha lasciato prima.
È dall’inizio dell’anno che il malumore ha cominciato ad emergere nel sindacato di Via Po.
E non v’è dubbio che pure l’arrivo di Matteo Renzi a Palazzo Chigi abbia contribuito alla
perdita di leadership del segretario generale. Bonanni si è ritrovato più debole senza più
l’arma della concertazione. Ha cercato in tutti i modi di “conquistare” un tavolo di confronto
con il nuovo governo, ma è stato respinto con perdite. È stato costretto a giocare di
rimessa: da una parte con l’esecutivo di Renzi, dall’altra con la Cgil di Susanna Camusso,
se non addirittura la Fiom di Maurizio Landini impegnati in una partita politico- sindacale
dalle diverse sfaccettature, comunque in grado ancora di mobilitarsi. L’immobilismo della
Cisl bonanniana ha invece rimesso in discussione la sua linea. L’irrilevanza sulla scena
politica è diventata incompatibile con una leadership che sempre ha scommesso su
rapporti privilegiati con i governi, in particolare con quelli del centro-destra. E non è un
caso che le prime voci del dissenso siano nate nelle aree più esposte nella crisi: le regioni
del Nord, le categorie dell’industria, i pensionati. E la Sicilia. Il nocciolo duro dei
bonanniani è rimasto quello costituito dalle categoria del pubblico impiego, area un tempo
di tradizionale forte insediamento cislino ma nella quale oggi prevale la Cgil, sia negli
iscritti sia nei voti per le Rsu.
Da oggi, dopo la formalizzazione da parte di Bonanni della sua decisione, bisognerà
seguire le mosse di Gigi Bonfanti, segretario dei pensionati, medico, sindacalista di lungo
corso. Da lui sono arrivare anche le poche critiche alla linea Bonanni. Si muove con il
pacchetto pesante di voti dei pensionati. E si dovrà seguire pure Gigi Petteni, segretario
della Lombardia (780 mila iscritti) capace di coalizzare il malessere delle categorie
dell’industria che con il processo di riorganizzazione voluto proprio da Bonanni sono
destinate inevitabilmente a contare di più rispetto al centro burocratico di Roma. Da questi
movimenti potrebbe emergere l’alternativa alla Furlan, soprattutto tra i quarantenni che
scalpitano e ora vedono un’opportunità da poter sfruttare.
44
Che la stagione di Bonanni volgesse al termine si è capito nelle ultime settimane quando
hanno ricominciato a girare nei corridoi vecchi veleni, dossier e lettere anonime. Al leader
si sono fatti i conti in tasca. Sono sembrati troppi i 4.800 euro netti di pensione (circa 7
mila lordi) maturati nel retributivo poco prima che entrasse in vigore la riforma Fornero. Le
accuse di essersi aumentato lo stipendio per aumentare l’importo dell’assegno sono state
respinte facendo notare che gli anni di contributi sono 47. Ma quando i corvi volano
lasciano il segno.
Del 24/09/2014, pag. 4
La carica di Joseph Stiglitz contro l’austerity
Incontri. Lectio magistralis dell'economista premio Nobel alla Camera
dei deputati di Roma
Benedetto Vecchi
Un argomentato j’accuse contro le politiche di austerità che dominano la scena europea
e non solo, quello che ieri Joseph Stiglitz ha svolto in un incontro alla Camera dei deputati.
Indice puntato dunque contro il dogma della economia fondata sull’offerta e non sulla
domanda, perché se non c’è una inversione di rotta, le già allarmanti disuguaglianze
sociali rischiano di essere esplosive. Per fare tutto questo, occorre una riforma radicale
dell’Unione europea. Joseph Stiglitz ha archiviato da anni la sua esperienza alla Banca
mondiale, organizzazione abbandonata per dissensi sulla «doppia morale» lì dominante
che consentiva ai paesi forti di fare cose impedite ai paesi nel Sud del mondo. Premio
Nobel per l’economia del 2001 ha scritto volumi assunti dai liberal statunitensi come una
sorta di bibbia nella critica al neoliberismo, mentre al di fuori dei confini nazionali sono stati
invece assunti da parte delle sinistre cosiddette radicali e ambientaliste come testi imprescindibili nell’analisi del capitalismo contemporaneo. Strano destino per un economista
che radicale proprio non si può definire. Sta di fatto, però, che nella lectio magistralis ha
svolto il ruolo del riformista radicale che chiede un’inversione di rotta all’Unione europea,
mentre molti dei discussant non sono riusciti ad accogliere fino in fondo le «provocazioni»
dell’economista, lamentando la distanza esistente tra le teorie critiche dell’austerità e le
politiche dell’Unione europea che vedono una sostanziale convergenza tra il centro destra
e il centro sinistra. Eppure le persone chiamate a discutere con Stiglitz, in particolare
i deputati, i senatori e la stessa presidente della Camera, sono spesso considerati «fuorilinea» rispetto ai propri partiti. Coinciso Giorgio Airaudo di Sel che è partito dalla crescente
disoccupazione per ricordare che in Italia non esiste una politica industriale, senza la
quale sarà difficile vedere una luce in fondo al tunnel della crisi, che ha portato i redditi
individuali e delle famiglie ai livelli di 25 anni fa. Airaudo ha preferito parlare di manifattura,
argomento assente nel discorso di Stiglitz, che auspicava il fatto che i paesi europei percorrano l’ultimo miglio che li separa dall’economia della conoscenza.
Fuori fuoco l’intervento di Francesco Boccia (pd), che ha ricordato le compatibilità dettate
dalla troika europea. Proprio quelle compatibilità che Stiglitz invitava se non a rompere,
almeno a forzare. Boccia però a messo involontariamente al centro la subalternità della
politica all’economia. Una subalternità che rischia di accentuare gli effetti autolesionisti
dell’austerity. Per uscirne fuori la presidente della Camera Laura Boltrini vede necessario il
ripristino dell’autorevolezza del sistema politico nel definire regole e convenzioni sociali
condivise. Ma se il sovrano ha perso lo scettro, non è detto che possa ritrovarlo in una
generica riforma della politica, come auspicato da Laura Castelli del Movimento Cinque
Stelle: l’unico intervento interrotto da un applauso.
45
Se Stiglitz può passare, suo malgrado, come un riformista radicale, una sponda alle sue
tesi non è certo venuta dal riformismo «timido» e «perbene» di Stefano Fassina (pd), che
ha più volte lamentato il fatto che la politica ha le mani legate e che forse spetta agli accademici di proporre una vision alternativa a quella dominante. Strano approdo per un politicy maker che vorrebbe la ripresa di autonomia della politica, ma poi ne affida le sorti a un
accademico. L’unico esponente politico a suo agio è Giulio Tremonti, che cita come funesta l’idea dominante che ha formato l’Unione Europa: quello di uno sviluppo lineare, progressivo dell’economia europea. A Bruxelles e a Strasburgo la crisi economica è piombata
come un evento inatteso, trovando le istituzioni comunitarie impreparate. E ancora adesso
c’è una certa difficoltà a fare i conti con players globali come la Cina o i fondi di
investimento. Quando la parola ritorna agli studiosi, sembra di scendere dalle stelle alla
terra. Tutto diventa chiaro. La siprale distruttiva del neoliberismo (Giovanni Dosi), la
necessità di ridurre le disuguaglianze sociali (Mauro Gallegati), le nuove politiche economiche e industriali (Mario Pianta) danno misura di quel movimento di ridiscesa sulla terra
invocato da Goethe nel «Faust» che il sistema politico non sembra riuscire a fare.
46