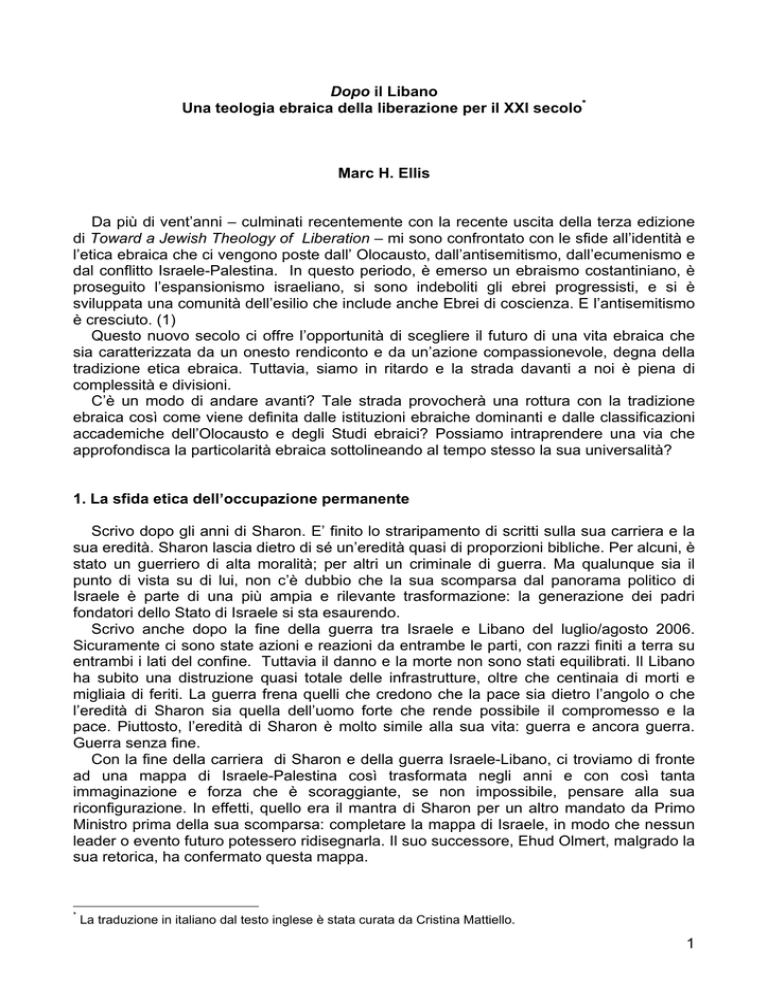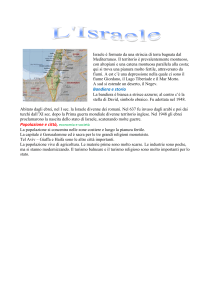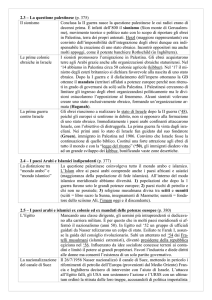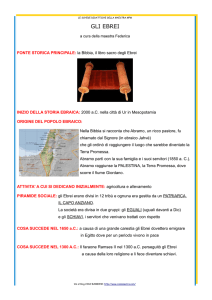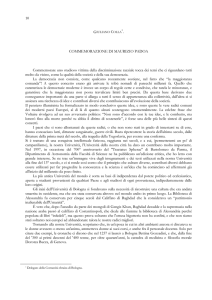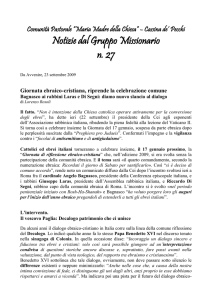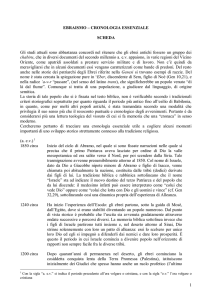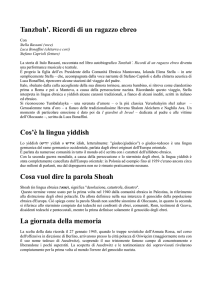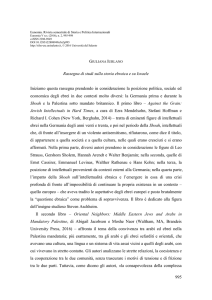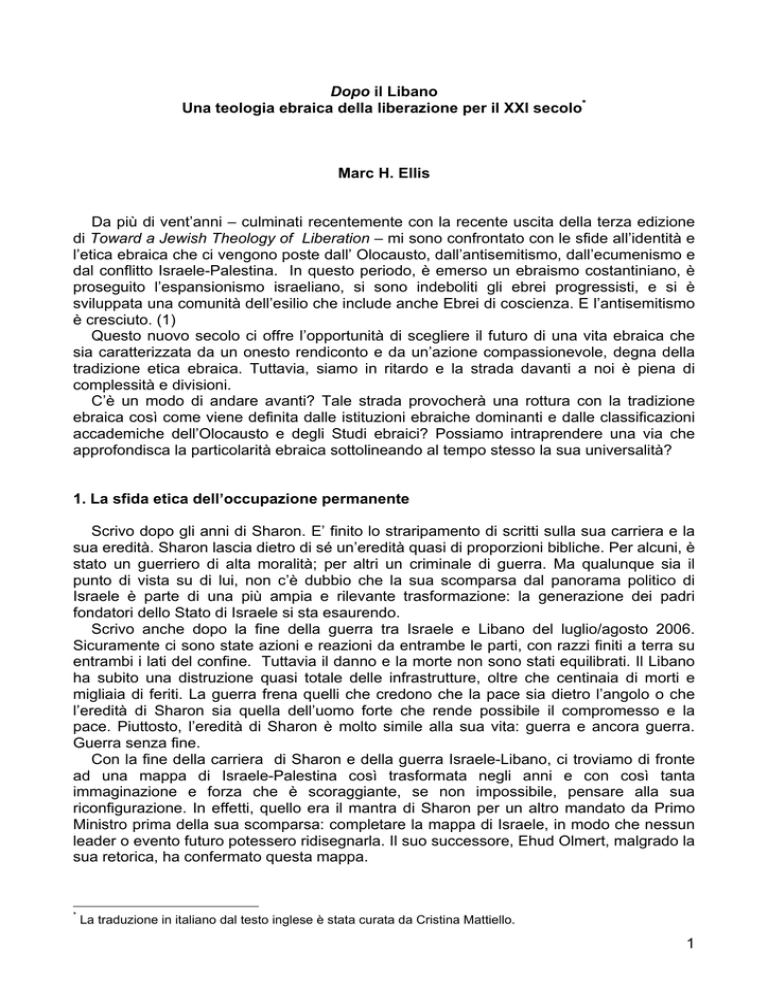
Dopo il Libano
Una teologia ebraica della liberazione per il XXI secolo*
Marc H. Ellis
Da più di vent’anni – culminati recentemente con la recente uscita della terza edizione
di Toward a Jewish Theology of Liberation – mi sono confrontato con le sfide all’identità e
l’etica ebraica che ci vengono poste dall’ Olocausto, dall’antisemitismo, dall’ecumenismo e
dal conflitto Israele-Palestina. In questo periodo, è emerso un ebraismo costantiniano, è
proseguito l’espansionismo israeliano, si sono indeboliti gli ebrei progressisti, e si è
sviluppata una comunità dell’esilio che include anche Ebrei di coscienza. E l’antisemitismo
è cresciuto. (1)
Questo nuovo secolo ci offre l’opportunità di scegliere il futuro di una vita ebraica che
sia caratterizzata da un onesto rendiconto e da un’azione compassionevole, degna della
tradizione etica ebraica. Tuttavia, siamo in ritardo e la strada davanti a noi è piena di
complessità e divisioni.
C’è un modo di andare avanti? Tale strada provocherà una rottura con la tradizione
ebraica così come viene definita dalle istituzioni ebraiche dominanti e dalle classificazioni
accademiche dell’Olocausto e degli Studi ebraici? Possiamo intraprendere una via che
approfondisca la particolarità ebraica sottolineando al tempo stesso la sua universalità?
1. La sfida etica dell’occupazione permanente
Scrivo dopo gli anni di Sharon. E’ finito lo straripamento di scritti sulla sua carriera e la
sua eredità. Sharon lascia dietro di sé un’eredità quasi di proporzioni bibliche. Per alcuni, è
stato un guerriero di alta moralità; per altri un criminale di guerra. Ma qualunque sia il
punto di vista su di lui, non c’è dubbio che la sua scomparsa dal panorama politico di
Israele è parte di una più ampia e rilevante trasformazione: la generazione dei padri
fondatori dello Stato di Israele si sta esaurendo.
Scrivo anche dopo la fine della guerra tra Israele e Libano del luglio/agosto 2006.
Sicuramente ci sono state azioni e reazioni da entrambe le parti, con razzi finiti a terra su
entrambi i lati del confine. Tuttavia il danno e la morte non sono stati equilibrati. Il Libano
ha subito una distruzione quasi totale delle infrastrutture, oltre che centinaia di morti e
migliaia di feriti. La guerra frena quelli che credono che la pace sia dietro l’angolo o che
l’eredità di Sharon sia quella dell’uomo forte che rende possibile il compromesso e la
pace. Piuttosto, l’eredità di Sharon è molto simile alla sua vita: guerra e ancora guerra.
Guerra senza fine.
Con la fine della carriera di Sharon e della guerra Israele-Libano, ci troviamo di fronte
ad una mappa di Israele-Palestina così trasformata negli anni e con così tanta
immaginazione e forza che è scoraggiante, se non impossibile, pensare alla sua
riconfigurazione. In effetti, quello era il mantra di Sharon per un altro mandato da Primo
Ministro prima della sua scomparsa: completare la mappa di Israele, in modo che nessun
leader o evento futuro potessero ridisegnarla. Il suo successore, Ehud Olmert, malgrado la
sua retorica, ha confermato questa mappa.
*
La traduzione in italiano dal testo inglese è stata curata da Cristina Mattiello.
1
La visione che aveva Sharon di Israele nel futuro è vicina al compimento. Il Muro
costruito intorno a Gerusalemme e nei Territori palestinesi, variamente descritto con
attributi come “sicurezza”, “apartheid”, e perfino “ghetto”, è quasi finito. I coloni israeliani
nella parte annessa di Gerusalemme e nella West Bank sono attualmente più di 400.000
e, anche se nei media e nelle discussioni politiche sono in genere descritti come aderenti,
su basi religiose, a dottrine fondamentaliste estreme, sono prevalentemente laici e
interessati ad avere ambienti appropriati e comodi, case economiche e passaggi brevi per
affari e divertimenti. Ne deriva che gli “estremisti” della società israeliana sono per lo più
israeliani medi, che cercano quello che cerca la gente dovunque e che molte società,
inclusa la nostra, hanno raggiunto, in qualche momento della loro storia, attraverso
l’espulsione della popolazione indigena.
È così anche con Sharon e Olmert. L’elezione e la rielezione come Primo Ministro di
Sharon e la vittoria di Olmert come suo successore dovrebbero provare a quelli che
scrivono la storia di Israele che, contrariamente a quanto affermano, Sharon e la sua
politica sono stati al centro della politica israeliana per decenni. E continua ad essere così.
Come ha riportato il New York Times, nell’ultima riunione di Gabinetto prima della caduta
del governo, Sharon si è rivolto a Shimon Peres e ha detto che li attende il mandato della
loro vita, stabilire i confini finali. E li attende ancora: ma c’è bisogno di confini quando il
potere è saldamente in mano a Israele?
Peres, in quanto ‘faro’ del partito laburista, veniva prima considerato l’arcinemico di
Sharon in politica. Come nel caso della confusione sui coloni, che separa il presunto
Israele “reale” del compromesso e della compassione dal radicalismo dei coloni
fondamentalisti, il legame condiviso tra Sharon e Peres veniva negato e, là dove era
evidente, come nella partecipazione di Peres al governo Sharon, minimizzato. Ed è ancora
così, nonostante la formazione e il successo elettorale del nuovo partito Kadima, un partito
che unisce ancora una volta il successore di Sharon e Peres. (2)
Tuttavia, come nel caso dei coloni, il rapporto tra Sharon e Peres è stato più complesso
e istruttivo. La storia che raccontano gli ebrei liberali americani – Elie Wiesel, ad
esempio, ma anche Arthur Hertzberg, Michael Walzer, Emil Fackenheim e il Rabbino
Irving Greenberg, e anche gli accademici ebraici liberali e i loro amici cristiani – è stata a
sua volta viziata nella sostanza. Come hanno documentato gli architetti israeliani Rafi
Segal e Eyal Weizman nel loro libro sulla politica dell‘architettura israeliana, gli
stanziamenti dei coloni sono parte di un piano burocratico, tecnologicamente sofisticato e
sponsorizzato dallo Stato per far espandere in modo permanente Israele e creare così una
occupazione civile sostenibile dei territori palestinesi. A tal fine, sono state coinvolte quasi
tutte le istituzioni israeliane – economiche, professionali e governative. Anche la classe
politica israeliana, di entrambe le parti, compresi gli eroi di Peace Now.
Quello che emerge in A Civilian Occupation è che il movimento di colonizzazione non è
definito mediante un’arringa polemica o una proclamazione messianica – e l’operazione
risulta più dolorosa per l’assenza di tali elementi. Piuttosto, la difficoltà di vedere la
collusione tra chi vuole l’espansione e l’opportunità - i professionisti governativi e civili che
forniscono le competenze necessarie - e i narratori che coprono questa espansione con la
retorica dell’innocenza e della sicurezza è l’assoluta prevedibilità del processo, e il fatto
che, in qualche modo, tutto ciò non è stato visto da molti di noi, o è stato liquidato come un
discorso autolesionista o antisemita mascherato. (3)
Ho sperimentato spesso queste accuse quando, nel 1987, è stato pubblicato per la
prima volta Toward a Jewish Theology of Liberation. Mentre il libro andava in stampa, mi
sono ricordato di Michael Walzer, il celebre studioso ebraico di etica, che mi aveva rivolto
queste accuse in seguito ad una conferenza da me tenuta quello stesso anno nello
Shalom Hartman Institute, a Gerusalemme. Da allora, specialmente durante la rivolta
2
palestinese degli anni 1987-1993, critici e coordinatori di dibattiti mi hanno spesso
rinnovato queste accuse.
Sono passati molti anni dalla prima edizione. E la situazione è solo peggiorata.
Sull’onda della pubblicazione del mio terzo libro, nel 2004, la retorica del ripudio non ha
fatto che crescere, insieme con la Lega Anti-diffamazione ed altre importanti associazioni
ebraiche che si sono unite al coro.
In questi vent’anni ho appreso molto sulla realtà di Israele nei confronti della storia
ebraica e della sua stessa storia. In questo periodo si sono affermati i Nuovi storici di
Israele; le loro opere sono difficili da leggere per un ebreo cresciuto nella tradizione etica
ebraica. Meron Benvenisti, editorialista del Jewish Israeli e già vice-sindaco di
Gerusalemme, ha descritto la creazione di Israele e l’espulsione dei palestinesi nel 1948
come “pulizia etnica”. Quel termine mi era sconosciuto quando ho scritto per la prima
volta di una teologia ebraica della liberazione. Che essa potesse essere applicato ad un
comportamento ebraico era, almeno per me, impensabile. (4)
Tuttavia, dovremmo chiamarla in un altro modo? Questa definizione sembrerebbe
discutibile a nessuno di noi, se venisse usata per descrivere una qualsiasi altra storia e
non quella con cui ci identifichiamo? Come studiosi di etica ebrei ci inventeremmo
ragionamenti viziosi per mitigare o negare quella realtà in una qualunque situazione che
non fosse Israele? Io, o qualunque altro ebreo, saremmo accusati di autolesionismo se
definissimo l’incontro tra i nativi americani e gli europei come conquista e pulizia etnica?
Verrebbe sollevata questa accusa se parlassi della società sudafricana degli anni ’80
come di un regime di apartheid?
Anche i nostri amici cristiani sono avvisati. Il dialogo ecumenico è stato caratterizzato
dalla confessione e dalla trasformazione da parte loro, e va bene. Molti hanno riconosciuto
che l’antisemitismo non è, almeno storicamente, estraneo alla storia cristiana. Molti di loro
hanno impegnato la loro vita a liberare le credenze, i rituali e l’insegnamento cristiano dalle
formulazioni antisemitiche. L’Olocausto, come culmine di quella storia, è visto giustamente
da ebrei e cristiani come evento spartiacque nella storia delle relazioni ebraico-cristiane.
L’assoluta ostilità, la logica contorta, la mancanza di segnali di attenzione e la generale
apatia che hanno afflitto la comprensione, da parte dei cristiani, degli ebrei e dell’ebraismo
sono state analizzate nei dettagli, e hanno ispirato una serie di confessioni, almeno
potenzialmente in tutte le principali chiese cristiane. Allora, perché questi cristiani
dovrebbero stare sempre all’erta quando parlano di Israele e dei palestinesi? Perché
dovrebbero stare sulla difensiva quando criticano la politica di Israele? Perché il pensiero
critico, quando è rivolto all’ebraismo contemporaneo, alle sue istituzioni, viene
costantemente redarguito? Perché esistono limiti posti ai dissidenti cristiani ed ebrei?
Hanno paura di essere bollati come anti-semiti, l’etichetta corrispondente a quella di ebreo
autolesionista?
2. La lotta per definire l’identità ebraica
Toward a Jewish Theology of Liberation, nelle sue varie edizioni, e gli altri miei scritti
non parlano della politica di Israele, o addirittura in particolare del conflitto israelianopalestinese. Io scrivo come ebreo, e mi pongo le domande che derivano dalla nostra
tradizione di pensiero e azione etici alla luce dell’Olocausto e della nostra conseguente
istituzionalizzazione in America e in Israele.
Che cosa dobbiamo pensare e fare ora? Una teologia ebraica della liberazione, allora e
adesso, si basa sulla fedeltà. Che cosa significa essere fedeli come ebreo alla fine del XX
secolo e, ora, nel XXI? Secondo alcuni si insiste troppo su questo punto – il problema di
Israele e della Palestina: ci sono altre questioni che gli ebrei devono affrontare, nel XXI
3
secolo. Ciò è senza dubbio corretto, ma in ogni generazione c’è un punto chiave, un
evento formativo, che apre una varietà di altri temi, tutti di per sé importanti, ma quasi
insignificanti se il problema centrale resta senza risposta..
Un esempio è il femminismo ebraico. Nelle diverse edizioni di Toward a Jewish
Theology of Liberation mi sono rivolto al femminismo attraverso la voce delle donne
ebraiche; dalla prima edizione a oggi queste voci si sono moltiplicate. Non voglio
rivendicare l’importanza del mio scritto in relazione al tema del femminismo, ma per me è
chiaro che il femminismo, pur importante di per sé, non troverà un posto centrale nel
sovvertire il dominio patriarcale se la spinta dominante nella comunità resterà il sostegno,
o il silenzio, di fronte alla conquista e alla sottomissione di un altro popolo. Il femminismo
potrebbe anche riuscire a trovare il giusto posto nell’ebraismo costantiniano del nostro
tempo, ma difficilmente lo si potrebbe vedere come un elemento liberatorio. (5)
Negli ultimi decenni l’Olocausto e gli Studi ebraici hanno costituito un importante
movimento nei Colleges e nelle Università, negli Stati Uniti e non solo. Basta confrontare
le attuali possibilità di studiare l’ebraismo e la vita ebraica con le possibilità che c’erano
durante la mia giovinezza negli anni ’50 per riconoscere un cambiamento epocale nella
vita ebraica americana. La possibilità per gli studenti, ebrei e non, di entrare in contatto
con il pensiero, la religiosità e la cultura ebraiche negli anni della loro formazione favorisce
un apprezzamento positivo dell’ebraismo e degli ebrei. Fornisce agli ebrei un forum dove
sviluppare l’identità ebraica nella sua sfera; ai cristiani offre un modo di scandagliare la
propria identità attraverso i contenuti ebraici, sia antichi che contemporanei.
Anche gli studenti musulmani possono trovare l’opportunità di ampliare la loro
sensibilità rispetto agli ebrei e all’ebraismo. Nel migliore dei mondi possibili, si arriva a una
reciproca esplorazione ed interazione di studenti e professori ebrei, cristiani e musulmani.
In questo modo si prepara un cammino che va oltre la separazione e la divisione, un
cammino che un giorno potrebbe irradiarsi all’esterno sulle comunità stesse, sia qui in
America che altrove.
Purtroppo troppo spesso si perde questa opportunità, che non era disponibile negli anni
della mia infanzia. Le ragioni sono molte e complesse, ma una è sicuramente la messa in
gioco delle passioni nel controllare o impedire la discussione sui temi legati al Medio
Oriente. Anche se ciascuna comunità avverte costantemente il bisogno di rivalutare sul
campo la proiezione della propria identità, la comunità ebraica si confronta con sfide
particolari. Negli ultimi decenni Hillel è diventata una delle principali forze in campo nel
paese per la “difesa” dell’identità ebraica contro le critiche, riscontrabili sia all’esterno che
all’interno della comunità ebraica, in merito al rapporto tra Israele e i Palestinesi. Secondo
me, non hanno colto nel segno adottando un atteggiamento prima difensivo, poi
aggressivo, che svaluta il pensiero critico e la capacità degli ebrei ragionevoli di applicare
l’etica negli anni formativi dello sviluppo della loro identità ebraica.
In particolare, sull’onda della prima intifada palestinese, ho visitato i campus in giro per
il paese e ho trovato molti ebrei impegnati e sensibili che lavoravano con studenti
palestinesi per promuovere dibattiti congiunti su Israele/Palestina, che spesso lavoravano
nelle redazioni dei giornali universitari o semplicemente parlavano tra loro di un futuro al di
là dell’impasse attuale. Ho ammirato questi studenti ebrei e palestinesi: rischiavano
entrambi, nelle rispettive comunità.
In troppi di questi campus, però, i giovani ebrei non avevano il supporto dei docenti
ebraici. Alcuni di loro riconoscevano le preoccupazioni e il desiderio di dialogo dei loro
studenti, ma tacevano per paura di ripercussioni all’interno della comunità ebraica.
Temevano anche loro di essere attaccati da Hillel o da altri rappresentanti istituzionali
ebrei come ebrei autolesionisti. Spesso, i rabbini Hillel contattavano le famiglie di questi
studenti e anche i loro rabbini di famiglia. L’idealismo dell’età del college è una cosa;
contestavano invece il proseguimento di questa collaborazione tra ebrei e palestinesi. Non
4
avrebbe portato i giovani ebrei ad identificarsi con coloro che minacciano lo stato ebraico?
Il romanticismo giovanile poteva condurre fuori strada, provocando così ulteriori attriti e
assimilazione.
In questi anni ho subito una varietà di attacchi da parte dei rabbini stessi. E accade
ancora. Ma la domanda che continuo a pormi è se questo attacco alimenta una positiva
identificazione ebraica. Gli ebrei che lavorano con i palestinesi cercano di uscire dalla loro
“ebraicità” o piuttosto stanno tentando di esprimerla in modo maturo e significativo? Ci
sono altri bisogni collegati allo sviluppo di un’identità ebraica, ma, di nuovo, Hillel e
l’atteggiamento difensivo e/o il silenzio delle istituzioni universitarie promuovono queste
discussioni attaccando il pensiero critico sul problema Israele/Palestina?
La mia personale sensazione è che questi studenti ebrei esprimano il centro intuitivo
dell’identità ebraica praticando un’etica che attraversa i confini e cerca la giustizia e la
riconciliazione. Questi studenti vogliono un’identità ebraica che non abbia al centro
l’esperienza della violenza, sia essa contro gli ebrei o degli ebrei contro altri.
Anche questo, di nuovo in modo intuitivo, sembra esprimere il desiderio di curare il
trauma dell’Olocausto. È certo che gli ebrei non possano essere curati da questo trauma
violando un altro popolo. Per questi giovani ebrei la semplice affermazione dell’innocenza
ebraica non è stata e non è abbastanza. Pur non essendo esperti di Medio Oriente, ne
sanno abbastanza per capire che ebrei e palestinesi meritano la possibilità di vivere una
vita normale qui e in Israele/Palestina.
Nei miei viaggi ho trovato che i giovani ebrei non considerano il conflitto
Israele/Palestina irrisolvibile, marginale, o persino in primo luogo politico. Mentre la loro
religiosità non è manifesta nella sua espressione, è invece molto sviluppata la loro
sensibilità interiore ebraica. Sentirla attaccata è una forma di violenza: loro la sentono
così. Riconoscono anche una sostanziale ipocrisia negli insegnamenti della loro gioventù
e nell’atteggiamento degli adulti. In generale agli ebrei viene insegnato a rispettare e
sostenere chi lotta per la giustizia. Una delle lezioni dell’Olocausto è che gli ebrei non
dovrebbero soffrire mai più. Un’altra lezione è che non dovrebbero far soffrire gli altri.
L’attacco contro l’applicazione di questa lezione ai palestinesi è così formulato: la loro
sensibilità intuitiva, unita all’educazione ebraica ricevuta, ha dato forma a un paragone tra
l’Olocausto e la sofferenza dei palestinesi; oppure la solidarietà con la lotta palestinese è
un esempio di politica male orientata e di autolesionismo. Ma è questo attacco che è male
orientato e sbagliato sul piano etico. Questi studenti traggono le giuste conclusioni dalla
storia e dalla tradizione etica ebraiche. Ciò che non capiscono è che la comunità ebraica,
almeno nei suoi rappresentanti istituzionali e nelle autorità, ha scelto una via diversa – una
via costantiniana in cui ha la meglio la politica del neo-conservatorismo e la sensibilità
ebraica intuitiva deve essere disciplinata e trasformata.
Tutto questo lo analizzo sul piano concettuale nel mio lavoro su una nuova teologia
ebraica della liberazione e l’ho sviluppato ulteriormente sull’onda della rivolta palestinese
in Beyond Innocence and Redemption: Confronting the Holocaust and Israeli Power. I
teologi dell’Olocausto –il mio maestro Richard Rubenstein, ma anche gli altri grandi teologi
dell’Olocausto, Elie Diesel, Emil Fackenheim e il rabbino Irving Greenberg – hanno
contribuito a orientare il pensiero dominante ebraico verso un neo-conservatorismo che ha
in più la qualità di mascherare la destinazione. Cioè, il neo-conservatorismo di Diesel,
Fackenheim e soprattutto Greenberg è ripiegato nella retorica del liberalismo, tanto che
neanche loro capiscono la trasformazione che hanno subito. (6)
In una conferenza sull’Olocausto nel 1988, feci presente al rabbino Greenberg che la
sua percezione di sé come liberale era in contraddizione con le sue posizioni politiche
neo-conservatrici. Non riconoscendo tale dicotomia, si arrabbiò molto alla mia
affermazione. Ma quale etichetta politica si può dare ad una persona che, negli anni ’80,
ha descritto le Nazioni Unite e i Concili nazionali e mondiali delle Chiese come inclini
5
all’antisemitismo perché sollevavano il problema dei diritti palestinesi? Che etichetta
dovremmo dare a chi sostiene i contras in Nicaragua e la collocazione di missili americani
in Europa – in sintesi l’interventismo militare americano – e al tempo stesso fa
raccomandazioni a ebrei e cristiani troppo critici della politica di Israele nei confronti dei
palestinesi sostenendo che possono preparare il terreno per un altro Olocausto?
Oggi ci sono molti leaders e accademici ebrei che vogliono semplicemente liquidare
insieme la discussione sull’Olocausto e quella su Israele. In troppi attaccano le immagini
attribuite a Israele. Tuttavia, la dicotomia che è emersa in tutta la sua floridezza negli anni
’80 è diventata quasi la norma. Contemporaneamente la maggior parte degli studenti ebrei
e degli ebrei in generale che ripudiano tale dicotomia sono di fatto perduti per la comunità
ebraica. La guerra recente, con la sproporzionata risposta di Israele alla provocazione
degli Hezbollah, accelererà sicuramente queste perdite.
Vengono proposti continuamente studi allarmanti sull’assimilazione. Tuttavia il problema
resta. Chi ha assimilato? Sono gli ebrei che non si identificano con il pensiero dominante?
O è questo stesso il pensiero ebraico dominante? L’identità ebraica è diventata una via di
assimilazione per il potere e lo stato?
L’ebraismo costantiniano è assimilazionista nei valori e nelle strutture. Ma l’ebraismo
costantiniano è l’ebraismo del nostro tempo? (7)
3. Appello per una politica ebraica
Nel 1941, Hanna Arendt, appena uscita dalla sua prigionia in Francia e vivendo a New
York, scrisse un saggio in cui esortava alla creazione di un esercito ebraico per
partecipare alla lotta contro Hitler e il regime nazista. La Arendt credeva – e questo dalla
sua esperienza come ebrea tedesca – che gli ebrei non sarebbero stati difesi dagli statinazione con una minoranza ebraica al loro interno. E anche che gli ebrei non sarebbero
usciti fuori dalla guerra, ammesso che Hitler sarebbe stato sconfitto, come entità politica
con una meritata autostima, se gli ebrei non si fossero organizzati e non avessero
combattuto al fianco delle forze Alleate. La stessa forza sarebbe stata organizzata per
difendere la Palestina come “parte della lotta per la libertà del popolo ebraico”. L’esercito
ebraico avrebbe marciato sotto la bandiera ebraica e sarebbe stato composto da volontari
ebrei provenienti da tutto il mondo. (8)
Per la Arendt l’esercito ebraico avrebbe posto una richiesta agli ebrei, e avrebbe
accompagnato una nuova e più positiva comprensione di sé da parte degli ebrei di ogni
luogo. Si sarebbe posto come l’espressione concreta di una politica ebraica in evoluzione,
che combatteva l’antisemitismo e promuoveva il benessere degli ebrei in tutto il mondo.
Già nel 1948, la Arendt deplorava che la politica ebraica fosse sfociata in un settarismo
auto-espansivo e che fosse caratterizzata, invece da un maturo senso del mondo, dal
sentimentalismo e da un esagerata sensazione di isolamento. La questione che diede
l’avvio alla sua critica della sua posizione fu quella della Palestina e dello Stato d’Israele,
da poco fondato. La Arendt era sionista, ma nella modalità di Martin Buber e Judah
Magnes: un sionismo fondato sull’idea di una patria bi-nazionale, che de-enfatizzava la
dimensione di Stato e cercava il coinvolgimento con gli arabi della Palestina e in generale,
del Medio Oriente.
Nel saggio “Salvare la patria ebraica: c’è ancora tempo”, del 1948, il suo commento
sulla rinuncia della politica israeliana alla ricerca di una dimensione di Stato ha risonanze
ancora attuali:
“È venuto il momento di avere tutto o niente, la vittoria o la morte. Le rivendicazioni delle arabe ed
ebraiche sono inconciliabili e solo una decisione militare può risolvere la questione; gli arabi – tutti gli arabi –
sono nostri nemici e accettiamo questo dato di fatto; solo i liberali fuori moda credono nei compromessi, solo
6
i filistei credono nella giustizia e solo gli idioti preferiscono la verità e il negoziato alla propaganda e ai
cannoni. L’esperienza ebraica degli ultimi decenni – o degli ultimi secoli, o degli ultimi duemila anni – ci ha
infine fatto svegliare e ci ha insegnato a badare a noi stessi. Questa sola è la realtà, tutto il resto è stupido
sentimentalismo. Sono tutti contro di noi […]; in ultima analisi non possiamo contare che su noi stessi;
insomma, siamo pronti a combattere e considereremo un traditore chiunque si frapponga sulla nostra strada
e una pugnalata alle spalle qualunque cosa fatta per ostacolarci.”
Attuali sono anche le sue previsioni su dove avrebbe portato tale analisi:
“La terra che nascerà sarà qualcosa di diverso dal sogno del ‘mondo ebraico’, sia sionista che non
sionista. Gli ebrei vittoriosi vivranno circondati da una popolazione araba interamente ostile, segregati
all’interno di confini sempre minacciati e assorbiti da un’isterica autodifesa, al punto da sommergere tutti gli
altri interessi e attività. La crescita della cultura ebraica non sarà più un interesse di tutto il popolo; gli
esperimenti sociali dovranno essere scartati come lusso impraticabile; il pensiero politico sarà centrato sulla
strategia militare; lo sviluppo economico sarà determinato unicamente dalle necessità della guerra. Tutto ciò
sarà il destino della nazione che – non importa quanti abitanti potrà assorbire e quanto potrà estendere i suoi
confini (l’intera Palestina e la Transgiordania è la folle richiesta dei Revisionisti) – resterà ancora un popolo
molto piccolo, di gran lunga superato nel numero da vicini ostili.” (9)
È questa, a grandi linee, la realtà attuale di Israele. E’ in larga misura svanita la
speranza iniziale per quello che avrebbe potuto essere una patria ebraica. Quella
speranza non è più articolata nella svettante retorica di Abba Eban o anche dei più ardenti
sostenitori attuali di Israele. Aliyah è sopito e prevale il contrario: c’è un continuo esiliarsi
da Israele stesso. Le università in Gran Bretagna e negli Stati Uniti registrano un afflusso
di accademici israeliani, e l’esodo degli israeliani in tutti i campi professionali imporrà alla
fine una ridefinizione della diaspora ebraica.
Tuttavia le previsioni della Arendt, già messe alla prova durante la sua vita, svolgono la
funzione di un monito alla prudenza. Già negli anni ’60, soprattutto dopo la pubblicazione
di Eichmann a Gerusalemme, venne screditata e, in pratica, espulsa dalla comunità
ebraica. La sua morte nel 1975 le risparmiò la preoccupazione futura sul fronte di Israele.
Come ad altri luminari ebrei, come Abraham Joshua Heschel, che morì nel 1972, alla
Arendt furono risparmiati il bombardamento israeliano di Beuirut, i massacri di Sabra e
Chatila, la repressione della rivolta palestinese tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni
’90. Le venne anche risparmiato il continuo esproprio della terra palestinese a
Gerusalemme e nella West Bank, e con quello la demolizione di migliaia di case
palestinesi e la costruzione continua di insediamenti che, a tutti gli effetti, sono città in fase
di sviluppo; l’uso di elicotteri da combattimento e missili telecomandati per distruggere la
leadership palestinese, e la pratica definita dal sociologo israeliano Bauch Kimmerling del
“politicidio”, per contrastare la stessa possibilità di essere delle aspirazioni nazionali
palestinesi (10).
La Arendt previde l’abbandono della politica che lei, invece, aveva sostenuto nella
creazione di un esercito israeliano. Il suo appello per un esercito israeliano non era un
desiderio di rivitalizzare la tradizione militare nella vita ebraica; era un passo necessario in
una nuova politica che potesse difendere, e, cosa allora più importante, reintegrare gli
ebrei come una forza positiva per il mondo. La Arendt accennò alle conseguenze
dell’abbandono, da parte ebraica, della politica, una realtà che oggi appare ovvia: come
possono gli arabi palestinesi e altri paesi del Medio Oriente praticare una politica di
compromesso e integrazione quando così larga parte del discorso di Israele e degli ebrei
fuori da Israele non è su questa linea? (11)
Il pensiero di Hannah Arendt qui è importante non per offrire una soluzione al conflitto
Israele-Palestina, né come sostitutivo di un’analisi sulle complessità politiche dei decenni
seguiti al suo appello per una politica ebraica. Il punto è piuttosto la quasi totale assenza
di riflessione oggi sull’impegno di Hannah Arendt all’interno del mondo ebraico del suo
7
tempo e la riduzione al silenzio del suo contributo significativo e critico alla storia ebraica.
Questo priva gli ebrei e la comunità ebraica della rilevante saggezza necessaria per
andare avanti, come per cogliere il momento giusto, così come continuano ad essere
esiliate dal mondo ebraico altre voci, di cui si sente disperatamente il bisogno.
Gli esempi della perdita del pensiero critico vanno ben oltre la Arendt, così come il ruolo
che la sua riscoperta potrebbe giocare nell’approfondire la nostra visione di una alternativa
futura. Prendiamo in considerazione l’affermazione provocatoria sul futuro dei rapporti tra
ebrei e cristiani, “A Jewish Statement on Christian and Christianity” (Una presa di
posizione sul cristianesimo e sui cristiani), pubblicata come presa di posizione pubblica sul
New York Times ed altri importanti giornali nel settembre 2000. Inteso dai suoi autori, in un
certo senso correttamente, come riconoscimento della riconciliazione rivoluzionaria tra
ebrei e cristiani dopo l’Olocausto, il saggio manca anche di sensibilità critica a causa di
alcune idee che gli autori del documento o non conoscevano o avevano reticenza a
riconoscere o consideravano oltre il confine di un’autentica identità ebraica. (12)
Dopo aver riconosciuto che ebrei e cristiani adorano lo stesso Dio e che cercano
l’autorità nella stessa Bibbia, che gli ebrei chiamano Tanakh e che i cristiani chiamano
Antico Testamento, essi arrivano ad un’altra affermazione: “I cristiani possono rispettare la
rivendicazione della terra di Israele da parte del popolo ebraico”. Segue questa breve
spiegazione: “L’avvenimento più importante per il popolo ebraico dall’Olocausto in poi è
stato il ristabilirsi di uno stato ebraico nella Terra Promessa. Come appartenenti ad una
religione fondata sulla Bibbia, i cristiani riconoscono che Israele fu promesso – e dato –
agli ebrei come centro fisico del patto tra loro e Dio. Molti cristiani appoggiano lo Stato
d’Israele per ragioni più profonde della mera politica. Come ebrei plaudiamo a questo
appoggio. Riconosciamo anche che la tradizione ebraica richiede la giustizia per tutti i
non-ebrei che risiedono nello Stato ebraico”.
Le affermazioni su Israele sono interessanti e pertinenti, anche se si prestano a varie
interpretazioni. Il libro che accompagna tali affermazioni, Christianity in Jewish Terms,
curato da accademici prestigiosi come David Novak, Peter Ochs e Michael Signor, include
importanti saggi di intellettuali ebrei e risposte di teologi cristiani. Però, in nessuna delle
sezioni viene menzionato o analizzato lo Stato di Israele – Israele come entità politica.
Come accade per lo Stato di Israele, neanche i Palestinesi, gli Arabi e perfino il Medio
Oriente contemporaneo vengono mai menzionati. In un libro di più di quattrocento pagine,
l’Islam è nominato tre volte, e due riferimenti su tre hanno a che fare con le Crociate e la
storia medievale.
L’assenza di discussione su Israele e di qualsiasi discorso su questo tema indebolisce
gravemente la pretesa di spiegare e promuovere Il cambiamento rivoluzionario che viene
sostenuto. In realtà, è l’opposto: gli autori evitano il pensiero critico in merito ai
cambiamenti nella comunità e nella tradizione ebraica dai tempi dell’Olocausto e della
istituzionalizzazione degli ebrei in America e in Israele. Insomma, la presa di posizione e i
saggi ignorano gli aspetti negativi che hanno accompagnato anche l’assunzione del potere
da parte degli ebrei. L’effetto complessivo è che gli ebrei si congratulano con i cristiani,
ma al tempo stesso frappongono una distanza tra loro stessi e i loro abusi di potere.
Paradossalmente, è esattamente dell’applicazione del pensiero critico alla tradizione
cristiana e al suo abuso di potere nei confronti degli ebrei che ha consentito alla comunità
crisitana di riconsiderare il suo modo di intendere il rapporto con gli ebrei e l’ebraismo. Noi
ebrei possiamo evitare l’uso di questo stesso pensiero critico in relazione alla comunità
ebraica e ai palestinesi, plaudendo agli altri quando la loro trasformazione è a nostro
vantaggio?
Non è che siamo privi di pensatori di questo tipo, che sono tutti assenti dalle
dichiarazioni e dal libro. L’omissione di Israele, dei palestinesi, degli arabi e dell’Islam è
affiancata dall’omissione di qualunque menzione di filosofi, scrittori, attivisti ebrei del
8
passato con questo approccio, come la Arendt, Buber, Magnes o Henrietta Szold.
Vengono anche ignorati pensatori viventi, come Noam Chomsky, Meron Benvenisti, Jeff
Halper, Baruch Kimmerling, Avi Shalim, Amira Hass, Sara Roy e altri simili. Manca l’intera
tradizione del dissenso ebraico su Israele e i palestinesi. (13)
Ci sono invece moltissimi esempi della forza del dissenso ebraico contemporaneo e
della sua capacità di offrire un’analisi critica – coniugando le discussioni sulla moralità e la
collusione istituzionale. Un esempio recente è quello del reporter israeliano di Ha’aretz,
Amira Hass. Nel gennaio 2006, Hass ha registrato il suo resoconto con il titolo “Non sono
ulivi”:
C’è qualcosa di molto umano in questi tronchi di ulivi, centinaia e centinaia di bordi, con i rami amputati
rivolti al cielo come in cerca d’aiuto. Venerdì scorso, a Tawana, nel sud delle colline di Hebron, 120 alberi; a
Burin, a sud di Nablas, all’inizio di questa settimana, circa 50 alberi; altri 100 o giù di lì a Burin il 24
dicembre; e 140 alberi, ancora a Burin, il 14 dicembre.
La polizia ha contato 733 alberi sradicati nel 2005. Secondo la lista (incompleta) dei 29 incidenti di
sabotaggio agricolo documentati dal gruppo per i diritti umani Yesh Din e B’Tselem da marzo a dicembre,
un totale di 2.616 alberi sono caduti sotto il sabotaggio: divelti, rubati, fatti a pezzi, segati. Solo a Salem, per
quattro volte sono stati sradicati 900 alberi. Anche se quelli che tengono il conto degli alberi danneggiati
esagerassero, entrambe le parti ammettono che è Israele che danneggia vigne e piantagioni.
L’accumulazione negli ultimi mesi di immagini di alberi distrutti ‘da individui ignoti’ è stata abbastanza
traumatizzante da indurre il procuratore generale ad attaccare l’inefficacia delle autorità, e il Ministro
Gideon Ezra a partecipare ad un incontro straordinario durante il quale si è deciso di concentrare gli sforzi
per il rispetto della legge ‘in quegli insediamenti riconosciuti come problematici’.
Il trauma, però, è selettivo. Le Forze delle Difesa israeliane hanno sradicato migliaia di olivi e alberi da
frutta, terreni coltivati e serre e continuano a farlo – per rendere sicure le strade che utilizzano e accrescere
la visibilità dei soldati; per costruire torrette di osservazione, posti di blocco e staccionate di separazione; per
asfaltare sempre più strade e costruire recinti di sicurezza intorno agli insediamenti.
Solo nel villaggio di Qafeen, ad esempio, sono stati sradicati 12.600 ulivi per fare una staccionata di
separazione. Altre migliaia di alberi – forse decine di migliaia – e migliaia di ettari della West Bank sono
intrappolati dietro ai muri e ai recinti e alle zone cuscinetto protette che circondano gli insediamenti. Solo a
Qaafen, 100.000 alberi sono imprigionati dietro la staccionata, e per la maggior parte dell’anno ai proprietari
viene impedito di raggiungerli. Possono solo guardare l’abbandono da lontano. I motivi che vengono addotti
sono motivi di “sicurezza”, naturalmente, ma per qualche ragione i motivi di sicurezza finiscono sempre con
la razzia di fatto di altra terra palestinese a vantaggio degli insediamenti vicini, o allo scopo di ampliare e
sfumare la Linea verde e l’annessione della terra a Israele.
Chi si sente traumatizzato ignora il fatto che i campi a Salem e Tawana sono vicini alle strade chiuse al
traffico palestinese in quanto vie di collegamento tra gli insediamenti. Sono le Forze della Difesa israeliane
che chiudono e bloccano queste strade, come centinaia di chilometri di eccellente asfalto attraverso la West
Bank, anch’esse chiuse al traffico palestinese.
Lo sradicamento di 100 alberi è un sabotaggio contro la possibilità di mantenersi di un’intera famiglia. La
chiusura delle strade è un sabotaggio contro la vitalità economica dell’intero popolo palestinese. Le Forse
della Difesa parleranno naturalmente della necessità di proteggere i cittadini israeliani. Perché dunque tutti
sono traumatizzati quando quegli stessi cittadini israeliani continuano a prolungare la logica del controllo di
Israele sui territori occupati?
Secondo quella logica, Israele ha il diritto di istituire un doppio standard giuridico nei territori occupati: uno
per gli ebrei e un altro per i palestinesi. Diritti illimitati per gli ebrei nella costruzione di case, nella libertà di
movimento, nel modo di vivere, nelle infrastrutture, nell’uso dell’acqua, contro un sistema organizzato di
privazione dei diritti umani e civili per i palestinesi. Secondo quella logica, i palestinesi devono accontentarsi
di ‘cellule di terra’ sempre più piccole, di cui possono dimostrare la proprietà privata. L’area più vasta, la cui
proprietà non è registrata con l’Amministrazione della terra israeliana appartiene automaticamente a
“Israele” e ai Consigli degli insediamenti.
Non sono i coloni che fanno questa politica: loro ne sono il risultato. Vivono tutti in pace e senza pungoli
di coscienza di fronte a centinaia di comunità impoverite che sono state di fatto trasformate in prigioni, per
permettere alle Forze per la Difesa israeliane di continuare a proteggere le imprese statali israeliane:
controllare più terra possibile, cacciare più palestinesi possibili. Una minoranza di israeliani non aspetta le
Forse della Difesa e lo Stato per distruggere: lo fanno da soli. E’ facile essere traumatizzati da una
minoranza e dimenticare la responsabilità di tutti. (14)
9
Rendere il dissenso come quello invisibile di Hass, come A Jewish Statement of
Christians and Christianity vuol dire seppellire la chiave che potrebbe aprire un futuro
ebraico orientato alla giustizia e alla compassione. Questa tradizione di dissenso parla di
un’altra possibilità in Israele/Palestina, di una patria che ha in sé le preghiere e i sogni di
migliaia di anni di storia ebraica. Non ci può esser un ritorno indietro all’era pre-statale, un
periodo in cui il presidente dell’Università ebraica e fondatore di Hassah – così come uno
dei più eminenti studiosi e filosofi ebrei del XX secolo – propugnava con forza una vita
integrata per entrambi i popoli in Palestina. Tuttavia, queste voci possono essere utili
come punto di vista critico per far leva, nell’affrontare il problema di come cominciare a
trasformare la vita nello Stato allargato di Israele che include una popolazione di ebrei e
palestinesi che è quasi uguale nel numero ma che vive in due mondi quasi completamente
diversi.
Queste figure storiche, insieme agli ebrei dissidenti contemporanei, offrono una
coscienza intelligente che pone gli ebrei del XXI secolo di fronte a questioni essenziali:
dove sono diretti gli ebrei come popolo? Per il cambio di direzione che si rende
necessario, di quali risorse – culturali, politiche, religiose ed etiche - hanno bisogno gli
ebrei e quali sono disponibili, libere dal legame con lo stato e con il potere? Queste
risorse, gli ebrei come le tengono imbrigliate e come possono essere applicate oltre il
confine, in modo che gli ebrei stessi siano in conversazione attiva con la tradizione etica
che abbiamo ereditato?
Abbiamo bisogno di cogliere il momento per esigere un cambiamento dell’ebraismo
costantiniano che informa e sostiene gran parte della vita ebraica contemporanea. Incluse
la Lega anti-diffamazione da un lato e l’AIPAC dall’altro. Il bello e costoso Hillel che
costella la mappa universitaria in America deve essere chiamato al suo compito. Le
istituzioni ebraiche, che spesso agiscono come controllo difensivo per l’ebraicità nella
cultura più ampia, devono cominciare a capire che non si può più sostenere il rispetto per
noi e un acquisito rispetto per gli altri cercando di seppellire le politiche di Israele
attraverso la commemorazione dell’Olocausto, o, come sta accadendo ora, cercando di
oltrepassare insieme l’Olocausto e Israele. Qui ci si dovrebbe confrontare con il
movimento di Analisi testuale nell’ambito degli Studi ebraici per il suo rifiuto di lavorare sui
temi difficili dell’Olocausto e di Israele, e il suo ignorarli di fatto – come se i nostri testi
canonici potessero essere letti e interpretati oggi senza riferimento alla storia in
movimento del nostro popolo.
Parlare di Israele in modo critico fa correre il rischio di censura presso quella stessa
comunità che conferisce cattedre sull’Olocausto e gli Studi ebraici. Per la carriera è un
disastro. Questo è vero anche per i rabbini che considerano allo stesso modo il dissenso.
Ma come possiamo parlare con correttezza di una miriade di temi – dal femminismo
all’etica medica e oltre – se, per paura, rimaniamo in silenzio nell’unica area del mondo
per la quale siamo direttamente e indissolubilmente responsabili? Se falliamo questo test
fondamentale, possiamo aspettarci che gli altri ci ascoltino su altri temi o che ascolteremo
perfino noi stessi, e ancor meno i nostri studenti e i nostri figli?
Il ragionamento che deriva dall’avere famiglia e amici in Israele o dal vedere Israele
come ampliamento della famiglia ebraica è un rimedio che, se mai è stato applicato
prima, non può più certo essere usato oggi. Israele opera come stato-nazione all’interno e
a volte all’esterno del sistema internazionale. Il suo apparato militare è sofisticato e spesso
viene utilizzato in varie circostanze. E anche se desideriamo che tutti ovunque stiano
bene, specialmente quelli che si sentono intrappolati in situazioni che possono procurare
sofferenze o la morte, è finito il tempo della perorazione speciale per Israele. Troppo
spesso abusata, la perorazione speciale ora minaccia di sovrastare la stessa tradizione
etica che gli ebrei pensavano avrebbe reso Israele diverso dalle altre nazioni.
10
Questo fallimento è istruttivo nelle difficili sfide etiche che oggi ci troviamo di fronte.
Approssimativamente, lo Stato ebraico di Israele non è né migliore né peggiore di altri
stati-nazione. La sua costituzione è avvenuta, più o meno, come quella di molti altri Stati:
costruita sull’espulsione di altre popolazioni. Poiché questo dato è costante, noi come
ebrei abbiamo difficoltà a sostenere la differenza, che è invece così cruciale per l’identità
storica ebraica. Si è mai parlato di ebraicità senza differenza?
Il nostro fondarci come popolo, il nostro lungo soggiorno attraverso la storia, la nostra
sofferenza recente nell’Olocausto, corrono tutti il pericolo di essere ridotti alle nazioni che
ci circondano. Forse è questa la realtà che, semplicemente, va riconosciuta. Tuttavia, di
nuovo, la somiglianza è una modalità in cui, in ultima analisi, si può sostenere e
abbracciare l’identità ebraica?
4. Dopo Sharon e il Libano. La sfida della liberazione all’interno
dell’istituzionalizzazione
In questo periodo preciso, dopo Sharon e dopo la guerra libanese-israeliana, che cosa
significa cogliere il momento giusto? Quali sono le linee generali di una teologia della
liberazione ebraica per il XXI secolo? Che cosa significa, oggi e negli anni che verranno,
essere fedele come ebreo?
La mappa sulla cui base operiamo mostra Israele come uno Stato ebraico sicuro e
stabile. La conquista della Palestina è completa. L’estensione di Israele a Gerusalemme
Est e nella West Bank è stata compiuta. L’occupazione militare è anche occupazione
civile. Qualunque cosa si pensi di uno Stato ebraico e delle discussioni sull’emergenza e
sulla sua necessità, qualunque cosa si pensi dei suoi anni dell’emergenza e
dell’espansione, una volta che era stata raggiunta la sicurezza, al popolo palestinese è
stato fatto un grande torto. Vedere il recente ritiro da Gaza come un tentativo di riparare a
questa ingiustizia è semplicistico. In realtà è l’opposto: tagliando le perdite di un
movimento di colonizzazione fallito a Gaza e rendendosi conto della pressione del tema
“demografico” sul lungo periodo, Sharon ha deciso di consolidare la presa su
Gerusalemme e la West Bank. Il Muro attesta questo consolidamento, in quanto diviene il
confine permanente di un Israele allargato. Dopo Sharon, continueremo su questa strada?
Passare sopra al torto fatto ai palestinesi analizzando l’opposizione araba al neo-Stato
di Israele, indugiando ossessivamente sull’atteggiamento, la corruzione e gli errori della
leadership palestinese, o seppellendo la formazione dello Stato di Israele e l’espulsione
dei palestinesi come semplice nota storica a fondo pagina è un tentativo di eludere le
problematiche etiche che gli ebrei si trovano di fronte in relazione a questa ingiustizia
storica, che continua nel tempo. Così anche l’appello solenne all’unità ebraica durante
questo recente conflitto. Non sono stati fatti appelli al dissenso, se era necessario. La
distruzione totale del Libano è stata correttamente definita un crimine.
Sono indiscutibili l’opposizione araba alla formazione dello Stato di Israele o il fallimento
della leadership palestinese in molti campi e in molte occasioni. In particolare, soprattutto
la recente forma di rivolta caratterizzata da attentati suicidi all’interno di Israele pone
problemi sul piano morale e strategico. Ma poiché la situazione è ampiamente
determinata, almeno sul versante ebraico, da uno Stato che rivendica come sua raison
d’être la storia di Israele e il cui destino è nelle mani degli ebrei, le questioni etiche non
possono essere più chiare.
Quali sono le nostre responsabilità per la storia del conflitto Israele- Palestina e che
cosa bisogna fare attualmente? L’aspetto etico è sempre legato a quello politico e
entrambi sono stati mobilitati per decenni nella vita ebraica istituzionale, religiosa ed
11
accademica. Non c’è modo di asserire una base etica nella vita ebraica contemporanea
senza un’analisi rigorosa degli effetti della costruzione dello Stato e dell’occupazione.
I teologi dell’Olocausto affermano correttamente che gli avvenimenti fondanti della vita
ebraica contemporanea ruotano intorno all’Olocausto e a Israele. Questi elementi restano
il centro dell’identità ebraica oggi. In particolare il rabbino Irving Greenberg sottolinea la
natura religiosa del ricordo e dell’istituzionalizzazione; anche Emil Fackenheim li ha definiti
religiosi nel suo ampiamente riconosciuto 614esimo comandamento.
Con i problemi più attuali di etica ebraica, si sono dovute sempre aggiungere un’aperta
articolazione religiosa e le argomentazioni tratte dalla tradizione: ad esempio, le decisioni
in sostegno dei diritti delle donne, incluso il loro diritto alla scelta e alla piena
partecipazione al rito e all’autorità religiosi, l’inclusione di ebrei gay e lesbiche in una
piena integrazione nella vita ebraica, o il sostegno alle politiche governative di protezione
e promozione dei più deboli. Anche se tutte queste decisioni vengono elaborate da
commissioni rabbiniche all’interno di un quadro denominazionale e da ricercatori del
campo degli Studi ebraici, la complessità e la pressione insite questo processo vengono
sperimentate soprattutto nella ricerca di un precedente e di un’influenza accettabile del
cambiamento culturale, al fine di espandere l’inclusione all’interno di una cornice ebraica.
La lotta intorno all’Olocausto e Israele si colloca in un’altra dimensione. E’ più difficile e
viscerale, contiene più incertezze e pericoli, è più rischiosa e monitorata e perciò ha
implicazioni per l’interno viaggio del popolo di Israele. Si muove nel cuore della definizione
di sé del nostro popolo come nessun altro tema.
Paradossalmente, o forse intenzionalmente, è su questo punto che la giuria non ha
ancora dato il suo verdetto e che le nostre risorse etiche sono più deboli. Su questi altri
temi – uguaglianza, inclusione e protezione del debole e del vulnerabile – la storia e il
tempo sono dalla nostra parte. Sulla questione Israele/Palestina, è il contrario: sono
assicurati la politica e la forza per un Israele sicuro; gli “Ebrei di coscienza” stanno
perdendo e in un breve lasso di tempo, se non è già successo, il dibattito morale ed etico
all’interno e all’esterno della comunità ebraica sarà risolto in negativo.
Se buttiamo via tutto questo – il gergo accademico, le affermazioni istituzionali, il
racconto e la memorizzazione emotivi dell’Olocausto, perfino l’antisemitismo che spesso
getta un’ombra sul nostro viaggio – non c’è modo di articolare l’ebraicità senza una
vigilanza costante sulla giustizia, la compassione, il perdono e la riconciliazione. Ed è la
stessa fede nella Torah che consiglia questa vigilanza, anche se mettiamo per il momento
tra parentesi la sua espansione naturale fino ad includere i profeti.
I fallimenti sono molti, emergono continuamente le complessità. La giustizia per Israele
non sempre è la giustizia per le altre nazioni. Anche all’interno di Israele, si discute la
questione della giustizia, si prova l’ingiustizia, il compimento viene dilazionato o addirittura
negato. Se Dio sia giusto, che cosa esattamente possa voler dire questo, si può discutere
a lungo e rimane costantemente incerto. Da Abramo a Mosé e oltre, si discute sulla
giustizia di Dio.
Tuttavia, troviamo nella Torah, anche prima che negli scritti profetici, che la giustizia è il
cuore del patto. In quale altro modo ci possono essere discussioni con Dio? Potrebbe
essere che i temi dell’uguaglianza e dell’ inclusione – l’espansione del fondamento stesso
del patto – siano al centro dei dibattiti sulla vita del patto nella vita ebraica contemporanea,
ma che i palestinesi ne siano in qualche modo lasciati fuori. Tuttavia è difficile vedere
come un esperto di etica ebraica, in buona coscienza, possa oggi sostenere che quelli che
si trovano dall’altra parte rispetto al potere ebraico non hanno spazio in quella espansione
del patto. Così, con Fackenheim, forse abbiamo bisogno di un altro comandamento, il
615esimo: “L’autentico ebreo di oggi, per essere fedele alla tradizione etica e agli obblighi
del patto, deve sostenere la dignità, il destino e la sovranità politica del popolo
palestinese”.
12
Il comandamento di Fackenheim “All’autentico ebreo d’oggi è vietato offrire a Hitler
ancora un’altra vittoria, postuma” eleva la sopravvivenza ebraica ad un imperativo
religioso. Ciò è corretto, ma solo se permeato, anche attraverso le rovine e fra molte
contraddizioni e controversie, dalla costante ricerca della giustizia, della compassione e
della riconciliazione. Senza il 615esimo comandamento, la forza di Fackenheim diventa
una licenza, un’ipocrisia che mina alla radice gli stessi progressi reali compiuti dagli ebrei
dall’Olocausto in poi.
Cogliere l’attimo giusto è affiancare questi due comandamenti come shock per la nostra
identità, secolare e religiosa, è imporre una rivalutazione dei parametri accettati del
pensiero che riflette su una varietà di temi. Se la politica d’Israele nei confronti dei
palestinesi è viziata alla base, se veramente l’obiettivo finale del gioco d’Israele con i
palestinesi è un’entità palestinese decurtata, murata e connessa solo in modo tenue ad
un’entità palestinese, e se quelle critiche da parte delle agenzie internazionali e di altre
nazioni non sono campate in aria - se veramente è alle critiche politiche che dobbiamo
rivolgere la nostra attenzione – allora deve essere riesaminato il nostro concetto di
antisemitismo. Invece di valutare semplicemente le critiche senza riflettere, o vedendole
solo nel contesto delle memorie storiche, potremmo dare ascolto ad altri aspetti del
messaggio che viene trasmesso.
La storia innegabilmente informa il presente, perciò i toni e il simbolismo sono
importanti. All’interno del messaggio politico, possono annidarsi aspetti antisemiti; i più
recenti commenti del presidente dell’Iran sull’Olocausto e lo Stato d’Israele costituiscono a
questo proposito un caso importante. Tuttavia, anche se respingiamo questi commenti
ridicoli e odiosi, voltare le spalle ai temi del momento vuol dire rifiutare il nostro stesso
bisogno di pensiero critico e seppellire la nostra più profonda sensibilità intuitiva.
Accrescendo la nostra retorica, ci giochiamo anche la possibilità di passare al vaglio
quella retorica analoga che troviamo così offensiva. In merito all’anti-semitismo, la
differenza essenziale tra allora e oggi è che oggi noi abbiamo veramente un’espressione
concreta di potere, un’espressione di potere che può essere usata e abusata, che può e
dovrebbe essere giudicata politicamente e da diverse angolature. Tutte le critiche a Israele
e alla vita ebraica potrebbero essere espressione di anti-semitismo; più probabilmente, a
causa della storia, spesso sono in funzione un’amalgama di politiche e di pregiudizi.
Dobbiamo negare la verità di tutto ciò che è stato detto, quando il seme della verità
potrebbe portare ad una discussione matura della politica e dell’antisemitismo?
Se non affrontiamo l’uso del potere ebraico per il bene e il male e non sviluppiamo una
portata etica che consenta l’onestà e il dibattito, il nostro futuro sarà forgiato entro una
struttura di potere costantiniana e una vita intellettuale guidata dagli apologisti? Deridiamo
gli apologisti cristiani. Ma noi siamo tanto diversi, oggi?
La moderazione politica – la promozione della soluzione dei due Stati per il conflitto
israelo–palestinese – può essere invocata come un modo per iniziare la trasformazione
del ciclo di violenza e atrocità che ha infettato il Medio Oriente per decenni. Tuttavia i fatti
sul campo hanno ridotto questa moderazione a uno slogan che è improbabile che venga
realizzato. Troppo spesso esso diventa uno scudo per eliminare la discussione. Ciò che
oggi si discute con forza è il fatto che c’è una sola entità – lo Stato di Israele – che
controlla l’area Israele/Palestina, con milioni di palestinesi all’interno. La soluzione
dell’unico Stato incombe su di noi attraverso l’occupazione permanente della terra e la
crescita degli insediamenti, in modo che non si può più tenere nascosta la sfida dietro la
bandiera dei due Stati – almeno, se proviamo a cogliere l’attimo con onesta audacia. In
questo senso ha trionfato la visione di Sharon. Ma per quegli ebrei che vivono dopo
Sharon, è questo il futuro che vogliamo lasciare ai nostri figli?
13
Perciò, ora, invece di lavarcene le mani coprendoci dietro l’intransigenza palestinese e
l’antisemitismo internazionale, dobbiamo ragionare all’interno della nostra legittimazione
in Israele e in America. La difesa d’Israele e il discorso ad essa correlato ha fuorviato in
gran parte la nostra analisi della politica internazionale: esempi ne sono stati l’Iraq e la
guerra americana al terrore. La difesa d’Israele e il discorso ad essa correlato conducono
spesso ad un approccio acritico all’interventismo americano nel mondo, e suscitano negli
ebrei diffidenza di fronte alla crescita dell’Islam negli Stati Uniti e al numero crescente di
musulmani, organizzati e assertivi, nelle associazioni studentesche nei campus
universitari. Serve anche a stornare il discorso afro-americano, quando esso affronta
questo tema.
L’isolamento crescente avvertito dalle istituzioni ebraiche e che gli ebrei a livello
individuale sentiranno sempre di più, è reale. Tuttavia, la mentalità da stato d’assedio è
ingiustificata, controproducente e deleteria. Ammettere la complessità della forza ebraica,
invocare contemporaneamente il 614esimo e il 615esimo comandamento, con passione,
onestà e pensiero critico potrebbe avviare improvvisamente un processo che attualmente
si sta alimentando a partire dalle qualità positive e dal rispetto. Potrebbe aiutare la nostra
gioventù ebraica a sviluppare e parlare con orgoglio di un’identità ebraica profondamente
interiorizzata, caratterizzata dal pensiero critico e capace di discutere con gli altri in un foro
sempre più vario di identità. Gli ultimi decenni hanno segnato il culmine dell’ascesa degli
ebrei in America, ma i cambiamenti delle dinamiche demografiche in America e nel mondo
non lasciano intravedere per noi un futuro analogo.
Ma qui si rende necessaria la cautela contro la strategia. È proprio questa strategia –
una protezione degli interessi ebraici in campo pubblico, una protezione del nostro status
di fronte ai mediatori del potere della nostra comunità, un discorso difensivo che si
sviluppa dalla storia ed è funzionale all’auto-promozione – che crea questa impasse.
Cogliere l’attimo giusto rappresenta una vera rottura nella storia, una riaffermazione
rivoluzionaria del pensiero critico ebraico e fa apparire molte delle affermazioni
ecumeniche documenti conservatori che sono funzionali allo status quo invece che
sfidarlo. Cogliere l’attimo ora rompe l’approccio ecumenico che permette agli ebrei di
criticare la storia cristiana – senza che vi sia alcuna risposta cristiana alla vita ebraica
contemporanea – e promuove invece nel presente una gestione congiunta che relega ai
margini l’approccio profetico in entrambe le comunità.
Dopo Sharon e Olmert, dopo la guerra Israele-Libano, perché non gettiamo via la
cautela e utilizziamo l’istituzionalizzazione ebraica come strumento liberatorio per noi
stessi e per gli altri? Perché non guardiamo ad una lotta interdipendente che fa andare
avanti la comunità globale e vede l’identità come qualcosa in continua evoluzione, che si
mescola, senza una destinazione nota, un’identità che si mette in discussione e a volte
implica sofferenza?
Il 614esimo comandamento di Fackenheim non prevede la possibilità della sofferenza
nel futuro ebraico, e sicuramente la sofferenza non va ricercata e esibita. Trovando la sua
strada all’interno e all’esterno, la sfida di Fackenheim deve proseguire, per sfidare la
compiacenza di una comunità ebraica post-Olocausto e il mondo esterno che forse vede
con simpatia l’essere vittime, ma vede anche il poter ebraico come una sfida alla propria
egemonia. Il 615esimo comandamento è una sfida interna all’affermazione acritica della
forza, il comandamento di Fackenheim ha portato noi e il giudizio contro coloro, fuori della
comunità ebraica, che interagiscono criticamente con il potere ebraico e israeliano.
Il 615esimo comandamento reintroduce veramente la voce profetica nella realtà di
Israele allargato e post-Olocausto. Venendo da fuori, ma anche se viene da chi sta
all’interno, la voce profetica ebraica ci annuncia che deve essere riconsiderata la
collocazione, recentemente formulata, al centro del potere politico, economico e culturale
in America e in Israele.
14
Con questa lettura, e con tutta la nostra ricercatezza e accettazione, torniamo all’inizio,
alla Torah e ai profeti. Perché è stato qui che è stato predetto il nostro destino e si sono
manifestate le voci persistenti della liberazione profetica, prima quando Israele ha lavorato
nella schiavitù, poi quando ha formato delle società caratterizzate dall’ingiustizia e dallo
sfruttamento. Queste voci devono informare le nostre decisioni e le nostre azioni anche
ora, se la nostra tradizione etica deve vivere e avere respiro.
Per chi crede che i giorni dei profeti siano storia, è così. Ma chi crede che quelle voci
siano solo nella storia, si sta difendendo, con successo, anche se solo per il momento, da
un risveglio che è sicuramente doloroso e destabilizzante. Dopo Sharon e il Libano,
cogliere l’attimo giusto è quel risveglio, dopo l’Olocausto e Israele, che lascia intravedere
un futuro profondamente ebraico e, al tempo stesso, profondamente umano.
NOTE
1. La prima edizione fu pubblicata nel 1987 da Orbis Books, la seconda uscì nel 1989, con
il sottotitolo The Uprising and the Future. La terza edizione ha il sottotitolo The Challenge
of the 21st Century.
2. Cfr. Steve Erlanger, “Sharon Planning to Leave Party: Seek Elections,” New York
Times, 21 Novembre 2005.
3. Cfr. Rafi Segal e Eyal Weizman (a cura), A Civilian Occupation: The Politics of Israeli
Architecture, London, Verso, 2003. Cfr. Anche un saggio sul conflitto continuo correlato a
questo tema: Nicolai Ouroussoff, “A Line in the Sand,” New York Times, I Gennaio 2006.
4. Meron Benvenisti, Sacred Landscapes: The Buried History of the Holy Land Since
1948, Berkeley, University of California Press, 2001.
5. Mi occupo di questo e dei seguenti punti relative ai limiti del post-femminismo e al
doppio standard nell’accademia in relazione al dissenso ebraico nel mio “Post-Holocaust
Jewish Identity and the Academy: On Traveling the Diaspora and the Experience of the
Double Standard,” in Jose Cabezon e Shelia Davaney (a cura) Identity and Politics of
Scholarship in the Study of Religion, London, Routledge, 2004, pp. 163-182.
6. Cfr. Beyond Innocence and Redemption: Confronting the Holocaust and Israeli Power,
San Francisco, HarperSanFrancisco, 1990. Parti del libro sono state ora incluse nella
terza edizione di Toward a Jewish Theology of Liberation, op. cit.
7. Per una discussione sull’ebraismo costantiniano e la Guerra civile all’intreno della
comunità ebraica, cfr. il mio “Jewish Civil War,” Tikkun 16, July/August 2001, pp.24-28.
8. La Arendt sviluppa quest idea di un esercito ebraico in “Die judische Armee - der Beginn
Einer Judisch Politik?”, Aufbau 7, November 14, 1941, pp. 1-2.
9. Hannah Arendt, “To Save the Jewish Homeland: There is Still Time,” in Ron Feldman (a
cura), The Jewish Pariah: Jewish Identity and Politics in the Modern Age, New York:
Grove Press, 1978, pp. 178-192.
15
10. Baruch Kimmerling, Politicide: Ariel Sharon’s War Against the Palestinians, London,
Verso, 2003.
11. In una conferenza del 1997 a Gerusalemme su Hannah Arendt, Amnon RazKrakotzkin della Ben-Gurion University fece un’altra osservazione sull’uso delle critiche di
Arendt al sionismo nell’Israele di oggi. Per Raz-Krakotzkin, anche se l’opzione binazionale non è più praticabile nel modo in cui lo era negli anni ’40, il suo significato per
un cammino verso la riconciliazione con i Palestinesi oggi, e anche come alternativa di
ragionevole sensibilità, ricorda agli ebrei lo scopo di una nuova presenza ebraica in Terra
santa. Sostenendo che il problema non è solo prevenire l’espulsione dei palestinesi, a
anche come assicurare diritti civili e nazionali palestinesi, Raz-Krakotzkin ritiene che ciò
possa essere raggiunto nel quadro di una soluzione con due Stati o uno Stato solo, ma in
ogni caso il “concetto di binazionalismo è essenziale per il processo di riconciliazione. In
entrambe le soluzioni, la definizione nazionale dipenderebbe dal riconoscimento dell’altro,
inclusi i diritti dei rifugiati palestinesi e la consapevolezza della questione ebraica. In
entrambi i casi, è necessario stabilire procedure che assicurino l’uguale distribuzione di
beni come la terra e l’acqua. Ogni altra soluzione mantiene lo stato attuale dei palestinesi
come gruppo inferiore, così come il processo di apartheid. Il principio di binazionalismo è
perciò il punto di partenza per immaginare e sviluppare diverse politiche alternative. Non è
necessariamente una soluzione fissa, ma almeno è una direzione che favorisce la
resistenza alla situazione attuale”. Cfr. Amnon Raz-Krakotzkin, “Binationalism and Jewish
identity: Hannah Arendt and the Question of Palestine,” in Steven Aschheim (a cura),
Hannah Arendt in Jerusalem, Berkeley, University of California Press, 2001, pp. 165-180.
12. Christianity in Jewish Terms, a cura di Tikva Frymer-Kensky, David Novak, Peter
Ochs, David Fox Sandmel e Michael Signer, Boulder, Colorado, Westview, 2000, pp. xvii-i.
13. Ho scritto della tradizione del dissenso ebraico nei confronti di Israele in Beyond
Innocence and Redemption, facendo l’ipotesi che questa ora veda la distruzione della
Palestina all’interno della liturgia ebraica della distruzione. Entrambi i capitoli sono stati
pubblicati e aggiornati nella terza edizione Toward a Jewish Theology of Liberation.
14. Amira Hass, “It’s Not the Olive Trees,” Ha’aretz, 11 Gennaio, 2006.
16