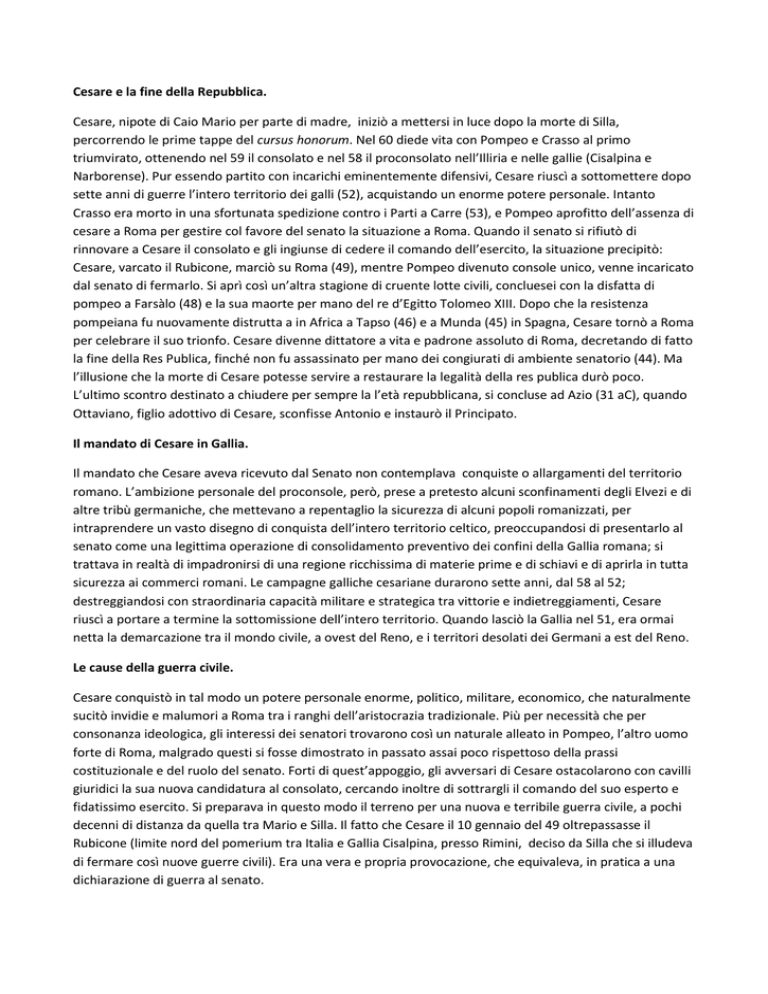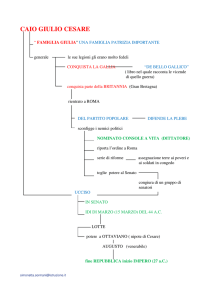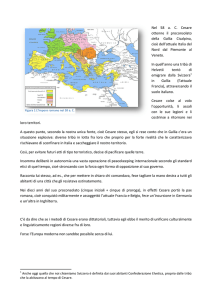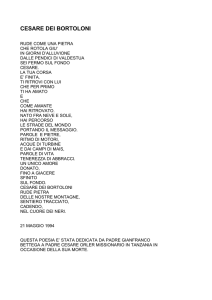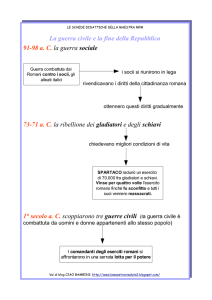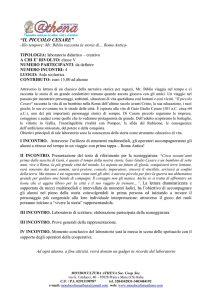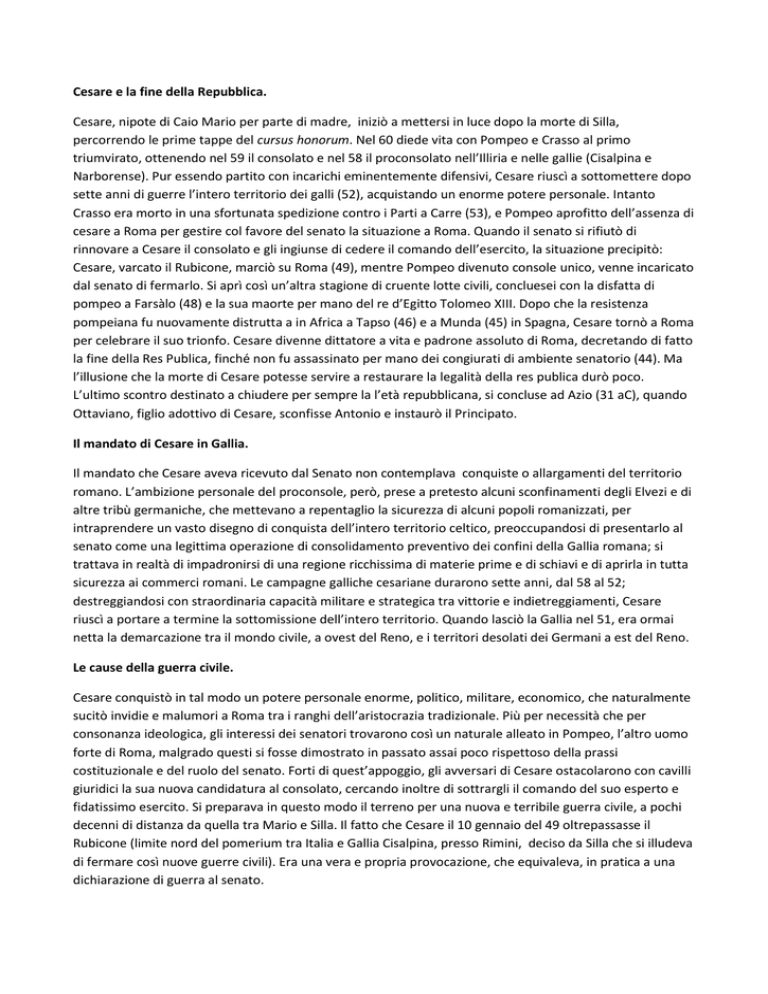
Cesare e la fine della Repubblica.
Cesare, nipote di Caio Mario per parte di madre, iniziò a mettersi in luce dopo la morte di Silla,
percorrendo le prime tappe del cursus honorum. Nel 60 diede vita con Pompeo e Crasso al primo
triumvirato, ottenendo nel 59 il consolato e nel 58 il proconsolato nell’Illiria e nelle gallie (Cisalpina e
Narborense). Pur essendo partito con incarichi eminentemente difensivi, Cesare riuscì a sottomettere dopo
sette anni di guerre l’intero territorio dei galli (52), acquistando un enorme potere personale. Intanto
Crasso era morto in una sfortunata spedizione contro i Parti a Carre (53), e Pompeo aprofitto dell’assenza di
cesare a Roma per gestire col favore del senato la situazione a Roma. Quando il senato si rifiutò di
rinnovare a Cesare il consolato e gli ingiunse di cedere il comando dell’esercito, la situazione precipitò:
Cesare, varcato il Rubicone, marciò su Roma (49), mentre Pompeo divenuto console unico, venne incaricato
dal senato di fermarlo. Si aprì così un’altra stagione di cruente lotte civili, concluesei con la disfatta di
pompeo a Farsàlo (48) e la sua maorte per mano del re d’Egitto Tolomeo XIII. Dopo che la resistenza
pompeiana fu nuovamente distrutta a in Africa a Tapso (46) e a Munda (45) in Spagna, Cesare tornò a Roma
per celebrare il suo trionfo. Cesare divenne dittatore a vita e padrone assoluto di Roma, decretando di fatto
la fine della Res Publica, finché non fu assassinato per mano dei congiurati di ambiente senatorio (44). Ma
l’illusione che la morte di Cesare potesse servire a restaurare la legalità della res publica durò poco.
L’ultimo scontro destinato a chiudere per sempre la l’età repubblicana, si concluse ad Azio (31 aC), quando
Ottaviano, figlio adottivo di Cesare, sconfisse Antonio e instaurò il Principato.
Il mandato di Cesare in Gallia.
Il mandato che Cesare aveva ricevuto dal Senato non contemplava conquiste o allargamenti del territorio
romano. L’ambizione personale del proconsole, però, prese a pretesto alcuni sconfinamenti degli Elvezi e di
altre tribù germaniche, che mettevano a repentaglio la sicurezza di alcuni popoli romanizzati, per
intraprendere un vasto disegno di conquista dell’intero territorio celtico, preoccupandosi di presentarlo al
senato come una legittima operazione di consolidamento preventivo dei confini della Gallia romana; si
trattava in realtà di impadronirsi di una regione ricchissima di materie prime e di schiavi e di aprirla in tutta
sicurezza ai commerci romani. Le campagne galliche cesariane durarono sette anni, dal 58 al 52;
destreggiandosi con straordinaria capacità militare e strategica tra vittorie e indietreggiamenti, Cesare
riuscì a portare a termine la sottomissione dell’intero territorio. Quando lasciò la Gallia nel 51, era ormai
netta la demarcazione tra il mondo civile, a ovest del Reno, e i territori desolati dei Germani a est del Reno.
Le cause della guerra civile.
Cesare conquistò in tal modo un potere personale enorme, politico, militare, economico, che naturalmente
sucitò invidie e malumori a Roma tra i ranghi dell’aristocrazia tradizionale. Più per necessità che per
consonanza ideologica, gli interessi dei senatori trovarono così un naturale alleato in Pompeo, l’altro uomo
forte di Roma, malgrado questi si fosse dimostrato in passato assai poco rispettoso della prassi
costituzionale e del ruolo del senato. Forti di quest’appoggio, gli avversari di Cesare ostacolarono con cavilli
giuridici la sua nuova candidatura al consolato, cercando inoltre di sottrargli il comando del suo esperto e
fidatissimo esercito. Si preparava in questo modo il terreno per una nuova e terribile guerra civile, a pochi
decenni di distanza da quella tra Mario e Silla. Il fatto che Cesare il 10 gennaio del 49 oltrepassasse il
Rubicone (limite nord del pomerium tra Italia e Gallia Cisalpina, presso Rimini, deciso da Silla che si illudeva
di fermare così nuove guerre civili). Era una vera e propria provocazione, che equivaleva, in pratica a una
dichiarazione di guerra al senato.
Tra documentazione e drammatizzazione storica.
Nei due Commentarii Cesare descrive rispettivamente il proprio operato nei sette anni di campagne galliche
(58-52) e nella guerra civile contro Pompeo e il senato (49-48). Nella loro qualità di testi apologetici i
Commentarii cesariani possono essere letti a una lettura su più livelli. Il primo livello è quello della
documentazione quasi ufficiale. Molto spesso in Cesare, soprattutto nel De bello gallico, si trova traccia di
lettere al senato, di relazione dei legati al comandante in capo, di descrizioni geografiche e topografiche e
di testi tecnici (descrizioni della costruzione di ponti, di strade, di fortificazioni), di dati ufficiali, persino di
espressioni burocratico-militari. Da questo punto di vista i Commentarii, non sono volti solo alla costruzione
di un personaggio o di una forma di vita esemplare secondo i dettami del genere della biografia ufficiale, e
nemmeno di un’immagine da tramandare ai posteri, secondo la tradizione aristocratica romana, quanto a
intervenire direttamente nella vita politica di Roma con l’intento di giustificare razionalmente l’operato del
generale, quasi a opporre ai violenti attacchi degli avversari l’eloquenza dei fatti. Il modo di scrivere di
Cesare, letterario quanto si vuole, deriva dallo stile della cancelleria e dei rapporti dei comandanti militari.
Basta a provarlo l’uso molto esteso dell’ablativo assoluto e del discorso indiretto, caratteristico di un uso il
quale tendeva alla brevità e alla densità informativa. Un altro livello di lettura è quello che riguarda la
natura del testo letterario messo a confronto con la tradizione storiografica, frutto dell’elaborazione del
pensiero storico greco e giunta inalterata fino a Roma, che riguardava i contenuti (la guerra, la politica e
anche l’etnografia), i metodi ( lo storico si confronta con la verità, non con il favoloso, e quindi preferisce la
storia contemporanea e a lui vicina perché verificabile) e soprattutto le forme. Infatti sin dall’epoca del
padre della storia Erodoto, la storia è opus oratorum maximum e quindi appartiene di diritto alla
letteratura. Lo storico ha pertanto tutto il diritto di fingere, cioè di plasmare e deformare la materia
secondo determinati scopi retorici. La finzione, cioè la ricostruzione del materiale, muove in tre direzioni:
può alterare l’ordine dei fatti e crearne uno artificiale; può introdurre dei discorsi che lo storico non ha mai
sentito, e che forse non sono mai stati pronunciati, può introdurre le figure retoriche in direzione di uno
stile drammatico.
Ora, pur nella loro obiettiva nudità, le opere di Cesare operano uno scarto nei confronti del genere del
commentario: infatti in Cesare non manca nessuna delle forme retoriche degli antichi storici. Per esempio
Cesare usa la terza persona, come artificio retorico per staccarsi appunto dalla materia e renderla più
oggettiva, lontana dalla sua persona: era disdicevole per un uomo aristocratico celebrare in prima persona i
propri successi. A partire dagli ultimi libri del De bello gallico, poi, cominciano a comparire i discorsi in
oractio recta, prima brevi poi sempre più elaborati come quello di Critognato che postula di cibarsi dei corpi
di chi non è più adatto alla difesa di Alesia.
L’apologia dell’operato di Cesare.
Quando descrive Vercingetorige come una sorta di Catilina, quando mostra le leggerezza dei Galli o la
crudeltà del germano Ariovisto, quando deforma la realtà delle battaglie con omissioni e slittamenti
cronologici, quando fa di Pompeo, il suo avversario nella guerra civile, un personaggio piuttosto incolore,
quando supera con i mezzi che abbiamo detto la sobria sintesi dei memoriali e della documentazione
ufficiale, Cesare persegue finalità ben precise. Noi sappiamo, infatti, da Cesare stesso e da altre fonti, che
mentre combatteva in Gallia, il suo operato era oggetto di feroci critiche: Catone Uticense si spinse
addirittura nel 55 a proporre di consegnare la persona di Cesare a Tencteri e Usipeti come espiazione del
bellum iniustum intrapreso contro queste popolazioni germaniche. A maggior ragione dopo l’inizio della
guerra civile egli fu tacciato di illegalità, avendo contravvenuto il divieto di entrare in Italia con truppe. Egli
fu costretto quindi a salvaguardare il proprio operato e quindi la propria dignita di magistrato di fronte
all’opinione pubblica. A chi si rivolge Cesare? Non certo al Senato come istituzione, al quale erano
indirizzate le relazioni ufficiali, e non certo ai circoli aristocratici, ma ai ceti che aspiravano a
quell’allargamento della base politica dello stato romano che ormai non si poteva più rinviare per
l’ampiezza che aveva già acquisito l’impero: il ceto militare, i cavalieri o pubblicani, cioè gli speculatori più
direttamente interessati alle conquiste, i commercianti, gli homines novi che ben presto avrebbero
sostituito in senato al vecchia aristocrazia agraria, o anche i singoli aristocratici mossi da ambizioni simili
alle sue. Testimoniano questa pluralità di destinatari anche l’assenza di un lessico troppo specialistico e la
costante preoccupazione di spiegare le istituzioni della Gallia o di tradurre in termini comprensibili i nomi
gallici. In questo punto addirittura, al termine della campagna contro gli Elvezi, Cesare sembra allargare il
pubblico alla nobiltà gallica che vedeva nel dominio di Roma un fattore di equilibrio contro l’instabilità
endemica degli spostamenti tribali e delle guerre intestine; se così fosse egli sarebbe il primo degli storici
romani ad accorgersi del nuovo ruolo delle province e dei loro ceti dirigenti e della necessità del loro
consenso. E’ probabile che la sottolineatura delle origini rivoluzionarie anche in senso sociale della
ribellione di Vercingetorige e la crudeltà e l’efferatezza della rivolta non siano estranee a questo scopo. La
conoscenza di imprese tanto grandi è lo scopo di Cesare. E’ lo scopo programmatico desunto dall’epica, di
tutti i più grandi storici antichi, greci e romani: impedire che le imprese degli uomini finiscano nell’oblio. Le
imprese che Cesare descrive hanno dunque un destinatario che deve ricordarle e la finalità di giustificare
agli occhi di quest’ultimo l’operato di chi le ha compiute.
L’aspetto geoetnografico del De Bello Gallico.
Molti capitoli del primo commentario di Cesare sono dedicati alla descrizione dei popoli della Germania,
della Gallia e della Britannia. Le pagine etnografiche del De bello gallico, cioè quelle dedicate a usi e
costumi, siti geografici etc. soddisfacevano una curiosità che a Roma era vivissima. Nella propria descrizione
Cesare rielabora notizie preesistenti, provenienti, per esempio, dal geografo e filosofo greco Posidonio di
Apamea e da Polibio; altre ne fornisce di prima mano, mosso anche dallo scopo pratico di favorire la
penetrazione dei mercati presso le pavie popolazioni. Cesare conosce assai meglio di Polibio le popolazioni
oggetto dei suoi scritti e quindi può chiamare le diverse civitates (tribù) con il proprio nome, fornendo della
Gallia una mappa geoetnica molto accurata. E se caratterizza i galli in modo non dissimile da Polibio,
rilevando il loro coraggio e la passione per la guerra, la facilità ad accendersi come a perdersi d’animo, la
franchezza ed il gusto per l’esibizione al limite della millanteria, la passione per i monili e gli ornamenti
d’oro, egli muta però profondamente, rispetto alle sue fonti, la prospettiva, il punto di osservazione, che
nasce in lui da un interesse specifico e non solo descrittivo. L’indubbia curiosità e l’attenzione di Cesare per
il mondo celtico non sono cieche e indifferenziate, ma si muovono secondo parametri ben precisi. Egli deve
infatti spiegare ai ceti interessati alla conquista le potenzialità economiche del paese e, d’altro canto, allo
scopo di giustificare le proprie imprese, deve spiegare come i galli rappresentino un pericolo costante per
Roma; così, dei galli, da un lato sottolinea gli elementi che più li fanno simili ai romani, dall’altro le loro
inclinazioni fiere e bellicose. La scoperta della distinzione tra popolazioni celtiche e germaniche è un merito
della ricognizione etnografica di Cesare e segna un grande progresso nello studio delle due grandi
tradizioni. Ma la volontà di conoscere di Cesare non è oggettiva in assoluto, non è esente da schemi mentali
e da pregiudizi. L’analisi dei costumi di vita dei galli dimostra che il punto di osservazione di Cesare è il
mondo greco-romano: a mano a mano che ci si allontana dal mondo “civile” il tasso di civiltà diminuisce. La
situazione che Cesare delinea è questa: il mondo celtico è in evoluzione almeno da un secolo verso forme di
cultura materiale e strutture sociali più simili a quelle del mondo greco-romano (urbanizzazione,
propensione al lusso e ai piaceri tipici di una società evoluta, rigida divisione delle classi sociali tra sacerdoti,
cavalieri e plebei, la presenza dell’istituto della clientela, una continua faziosità tra le varie comunità); i
germani hanno tratti completamente primitivi (una religione naturalistica che divinizza i fenomeni naturali
e senza sacerdoti di professione, forme di sostentamento arcaiche come la caccia e la guerra, il culto della
fatica e della forza fisica, la temperanza sessuale, la gestione comunitaria delle terre, l’assenza della
proprietà privata e una relativa uguaglianza economica, l’assenza di forme statuali se non in tempo di
guerra); in Britannia le popolazioni della costa, di fatto tribù celtiche imparentate con i belgi del nord della
Gallia, sembrano più civili di quelle rozze dell’interno. Facendo emergere l’indole primitiva dei britanni e
quella dei germani rispetto ai costumi più evoluti dei galli, Cesare vuole indicare al pubblico che una politica
di conquista di questi territori è ancora prematura e che comunque le classi più interessate allo
sfruttamento delle province (affaristi, militari ecc) non dovevano aspettarsi alcun profitto da territori
vergini e abitati da popolazioni bellicose e ostili al commercio. I pregiudizi di Cesare nei confronti di forme
di civiltà diverse nasce naturalmente dal significato che il mondo greco-romano aveva sempre dato al
termine “barbaro” cioè lo straniero, colui che non parla la lingua. “Barbaro” è in primo luogo chi non abita
in città cinte da mura, chi non può disporre di acqua corrente (fontane, terme, acquedotti), chi non
frequenta edifici pubblici come portici, fori, teatri, biblioteche, chi preferisce la caccia e la raccolta
all’agricoltura (vino, cereali, legumi), chi pratica il baratto invece che il commercio con l’uso della moneta,
chi ha regole di convivenza improntate alla legge del più forte, chi non ha istituzioni organizzate in
assemblee. E’ barbaro chi sembra disprezzare la vita umana, chi venera divinità naturali praticando spesso
sacrifici umani, chi non partecipa alla vita pubblica. Barbaro implica anche una demarcazione geografica.
Per i greci prima e per i romani poi, i popoli che minacciavano la loro civiltà stavano all’esterno di precisi
confini, tracciati sulle carte geografiche e, in età imperiale, protette da una serie di fortificazioni (il limes
germanico-retico tra Reno e Danubio, il vallo di Adriano, che teneva lontane le bellicose tribù della Scozia,
le fortezze nel deserto siriaco, a sud di Palmira o verso la Mesopotamia) che segnavano una frontiera netta
tra chi viveva nell’oikuméne, il mondo abitato, e chi era fuori del mondo, in terre spesso ignote.
La curiosità dei romani verso le altre popolazioni era dettata sì da una normale tendenza alla conoscenza,
ma anche da fini pratici: capire il nemico, fronteggiarlo e sottometterlo. L’interpretazione degli altri era
fortemente romanocentrica. Spesso la curiosità di Cesare lo porta a formulare dei giudizi negativi dettati
dal motivo della paura che provoca l’istinto dell’autodifesa e quindi l’ostilità preconcetta. Già dal mondo
antico si era delineata una netta differenza tra dispotismo orientale persiano e mondo libero occidentale,
una distinzione destinata a diventare uno dei motivi cardine del nostro pensiero etico-politico. Un secolo e
mezzo dopo Cesare, Tacito, scrive un’opera interamente etnografica, l’unica giuntaci dal mondo antico, la
Germania (De origine et situ Germanorum). Egli fa mostra di entrambi gli atteggiamenti sopra menzionati,
lasciandoci una descrizione disinteressata di popoli che vivevano al di là del Reno, e, al tempo stesso,
avvertendo i suoi concittadini della pericolosità dei barbari. Si tratta anche, però, di uno sguardo
moraleggiante, tipico della storiografia di età imperiale: il mondo germanico, descritto come vivo e
incorrotto, diventa uno strumento per comprendere la decadenza di quegli antichi mores che avevano reso
grande Roma.
Il Commentario.
Le più antiche forme della storiografia romana sono i fasti e gli annali: i primi registravano gli elenche dei
magistrati annuali, dei sacerdoti e dei tronfi dei generali; gli annales erano le brevi notizie (guerre, portenti,
disastri) che i pontefici aggiungevano agli elenche dei magistrati eponimi (quelli che davano il nome
all’anno) scritti su una tavola bianca e poi pubblicati intorno al 130 aC. I Commentarii (memorie, diari)
erano invece forme di espressione più individuali e non necessariamente pubbliche, che confluivano spesso
come documentazione ufficiale negli archivi dei collegi sacerdotali. Il termine commentarius ritorna in
epoca tardorepubblicana per qualificare un genere di memorialistica autobiografica: oltre a Cesare autore
degli unici commentarii a noi giunti, ne scrissero Silla, Cicerone e Augusto. Il contenuto del commenrtarius
poteva variare da una sorta di prova che precedeva la pubblicazione di materiali grezzi, alla stesura di idee
personali e di fatti privati., con l’aggiunta non tassativa di figure retoriche. Potevano essere i materiali di cui
si sarebbe servito successivamente uno storico ufficiale che avesse bisogno di documenti di prima mano. Al
di là del suo impiego successivo, il commentarius rivestiva un importante interesse e significato pubblico in
quanto era indirizzato alla difesa della dignitas del magistrato in carica, identificata con la dignitas della
repubblica e con le ragioni dell’imperium di Roma: a Roma il magistrato non dava il resoconto del suo
operato alla fine del suo mandato, e quindi era spesso attaccato in sede giudiziaria, una volta che il suo
lavoro poteva dirsi concluso. Opere di memorialistica servivano quasi come autodifesa personale. Una
prova convincente che i memoriali non erano sentiti come storiografia ufficiale, ma come armi politiche,
può venire proprio dall’alto livello politico e sociale dei vari autori di commentarii. Va considerato che la
stesura di opere storiografiche richiedeva applicazione e tempo, e dedicare tempo all’otium letterario era
ritenuto lesivo della dignitas dell’aristocratico impegnato nella politica attiva. Egli poteva fare un’eccezione
per l’inferiore e meno impegnativo genere del Commentarius. La storiografia ufficiale romana è infatti
opera di uomini politici di secondo piano, come i primi annalisti, di magistrati ritiratisi dalla politica come
Sallustio, o di intellettuali lontani dalla politica attiva, come Tito Livio.
La clemenza di Cesare.
Un discorso sulla clementia di Cesare, ovvero sul suo programma politico di ricerca di consenso dopo la
vittoria nella guerra civile, può trovare uno spunto interessante in una lettera di Cesare del 49, durante la
marcia verso Roma, dopo che a Corfinio un’intera guarnigione pompeiana si era a lui arresa e Cesare
l’aveva lasciata andare via libera. In essa Cesare dice di volersi dimostrare il più moderato possibile e di
voler cercare la riconciliazione con Pompeo. Cesare riflette che coloro che sono risultati vincitori in una
contesa civile con la violenza non sono riusciti ad evitare l’odio popolare (Mario), tranne uno solo, Silla, che
però lui non vuole imitare. Cesare propone un nuovo metodo per gestire la vittoria basato sulla
comprensione e sulla generosità. Al momento Cesare afferma di non sapere bene come realizzare questo
programma, ma porta un esempio: ha appena catturato Numerio Magio, un prefetto di Pompeo, e l’ha
liberato. Sono infatti numerosi i passi del De bello civili in cui Cesare elenca le proposte di pace da lui
avanzate per scongiurare la guerra civile. Nel contempo sa dimostrare per antitesi come gli avversari non
abbiano mai applicato la clementia, nelle situazioni a loro favorevoli. Cesare era convinto di aver scelto la
carta vincente praticando la clemenza, ma non per bontà astratta, ma per scelta politica. A Cesare non
sfugge la grande efficacia propagandistica di una tale condotta, e quindi l’estrema utilità di essa ai fini di
quello che a lui appare come il vero obiettivo: il consenso delle masse. Cesare si è posto sin da subito,
appena aperte le ostilità, il problema dei problemi: come si esce da una guerra civile. O meglio come si esce
politicamente da una guerra civile. E la sua scelta è stata agli antipodi di Silla. Il termine clementia e
l’atteggiamento da esso definito di ricerca del consenso ebbero fortuna durante la storia dell’impero, in
particolare grazie alla riflessione di Seneca, che si rivolge alle speranze suscitate dal giovane Nerone che
sale al trono con un trattato dal titolo De clementia. Con Seneca il termine conosce uno spostamento
dall’ambito politico a quello filosofico-morale: la virtù della clemenza è una qualità del rex iustus, cioè il
sovrano che governa con la giustizia e non con il dispotismo: la clemenza è la capacità di moderare l’animo
avendo il potere di punire o la mitezza di uno che è superiore verso uno che è inferiore nello stabilire le
punizioni. (De clementia II, 3, 1)