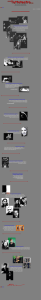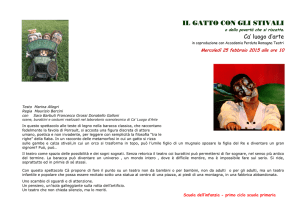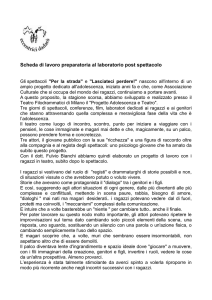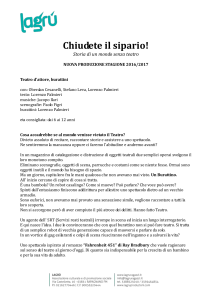2. LA GLOBALIZZAZIONE A TEATRO
LA NUOVA SCENA SUDAMERICANA
MASSIMO MARINO
Odore crudele di carne bruciata. Il teatro di Rodrigo García1
Modena, Teatro delle Passioni — È arrivato in Italia Rodrigo García, uno dei protagonisti
più acclamati della scena europea. In realtà è passato veloce come una stella cadente, con
una permanenza di soli due giorni al Teatro delle Passioni di Modena. In attesa che
qualcun altro decida di richiamarlo (e l’impresa merita assolutamente, perché ci troviamo
di fronte a spettacoli capaci di rovistare a fondo nella nostra squassata e autocompiaciuta
società divoratrice), proviamo a raccontare il suo teatro sconvolgente, quotidiano, trash,
politico. Niente a che vedere con quello che da noi passa per teatro politico o civile: non
c’è scavo nella memoria, che si suppone azzerata, nessuna pretesa di agitare, di
ricostruire fatti e misfatti e neppure semplicemente di rovesciare le apparenze per istillare
una diversa coscienza. Nessuna speranza. Nessun sogno palingenetico. Nessuna liturgia
partecipativa. Il vuoto della nostra condizione di consumatori, l’ebbrezza di una realtà
dove tutto è vendita, tutti siamo in vendita. Come in una canzonetta tutto è salita e caduta,
spreco senza senso, vertigine del vuoto. Rimane densa solo la puzza immonda di un
hamburger di un qualche Mac, che alla fine invade la sala, con la polpetta condita e
abbrustolita sulla piastra, lasciata a fumare, a bruciare, fra ketchup e senape. Parole e
corpi: testi letterari detti senza molti artifici teatrali su una scena spoglia, con qualche
sedia, qualche tavolo, qualche poltrona, qualche oggetto accumulato alla rinfusa; un
parlare, blaterare in luci rosse o da sala operatoria, verdognole, verdine, verdastre, e poi
lo scatto in una posa, dentro un’attitudine mascherata, un gioco con gli oggetti che
associa senza enfasi l’alienazione — esibita come uno scarto della realtà, della nostra al
mondo in cui viviamo, al modo in cui lo viviamo.
La serata modenese comprendeva due lavori di questo argentino emigrato in Spagna,
scrittore e regista che ama costruire gli spettacoli come quadri e, insieme, come
performance: rigorosi e predefiniti e ogni volta come nuovi, capaci di nutrirsi del
momento, fuori dal cliché, dalla ripetizione. Crudeli e senza consolazioni. García, dal
1986, ha scritto più di trenta testi; nel 1989 ha fondato La Carneceria Teatro (Macelleria
Teatro), gruppo col quale è stato accolto come una urticante rivelazione nei maggiori
festival europei, in particolare al Kunsten di Bruxelles e ad Avignone. La prima pièce,
Creo que no me habéis entendido bien (Credo che non mi abbiate capito bene ) sembra la
predica di un adulto a un ragazzo. È un monologo sordido, losco, in cui da subito ci si
rende conto che la morale che il grande, occhiali scuri, capello corto, faccia da gangster,
fa a un dodicenne o giù di lì, sono consigli su come meglio vendere il proprio corpo. La
rivelazione sarà flagrante alla fine, dopo tante sigarette, tanti ricordi d’infanzia e tanto
filosofeggiare a buon mercato: le foto da fare sono foto porno, internet è l’autostrada, il
corpo fresco è il capitale da far fruttare. La vita in ogni immoralità fino ai quindici anni
permetterà di godersela poi, di “grattarsi le palle”. In fondo, è peggio abusare dei bambini
o mandarli a scuola perché altri ne abusino? Le luci sono spesso rosse, le proiezioni non
1
Dalla rivista on-line «Tuttoteatro.com», Anno IV, n. 5, 8 febbraio 2003.
mancano, come una televisione dalla quale occhieggiano varie scene, come un’aria di
normalità assolutamente non rassicurante.
I piani scivolano, confondendosi, in una realtà di finzioni. La denuncia sta
nell’accumulare materiali dal nostro giornaliero degrado e nella normale assenza di ogni
possibilità e volontà di denuncia. Come in After sun, spettacolo manifesto, un colpo allo
stomaco, un’opera che nega ogni teatralità per enfatizzare il vuoto stordente nel quale
trasciniamo piccoli mondi senza speranza. Come in altre opere di questo autore si parte
da un mito classico, il folle volo di Fetonte sul cocchio del sole, e la rovinosa caduta
conseguente. E poi tante altre sfide e precipizi, a cominciare da Maradona, «voglio una
vita come quella di Maradona», o le corse in moto o in macchina sulle strade, o i
grattacieli rimasti in piedi dopo l’11 settembre, o le morti, come tonfi, di John Fitzgerald
Kennedy, Marylin Monroe, ma anche di Cristo sul Golgota, e dei ladroni, e di un uovo
fritto che si allarga nella padella, e la tristezza degli italiani per la morte di Agnelli, e la
Ferrari vincente, e l’anoressia come futuro della specie, la ricerca della taglia zero, e la
morte di Pasolini, quella di Buñuel che dice alla moglie di continuare a fare la vita di
sempre, l’altezza e l’improvviso arresto cardiaco, cadute senza eroismo e senza
redenzione, la noia e le affastellate mitologie mediatiche, l’incapacità di trovare una
felicità e il riempirsi di cose, di desiderio di sensazioni. La nostra condizione di voraci
consumatori o anoressici attoniti, un diluvio di parole, salti fra mondi diversi, mentre i
corpi parlano e all’improvviso scattano in pose che aggiungono violenza con pose
crudeli, colpi dell’attore all’attrice e viceversa, tendere la mano per aiutare a pisciare
addosso, tormenti inflitti a due conigli dopo essersi mascherati, una danza con un’altra
maschera grottesca, una corsa sul posto col casco da motociclista, una danza sfrenata con
le scarpe inchiodate al tavolo, rovinare in una torta alla panna con le candeline accese...
Accumulo, delirio, sofferenza. La tensione e lo spasimo. Improvvisazioni, filosofemi sul
nulla, spogliarsi, pensare mettendosi le mutande in testa, in culo, in bocca. Questo rimane
della riflessione occidentale, della nostra coscienza. Uno sberleffo, un gioco crudele,
quell’odore di hamburger, di carne bruciata, che alla fine pervade tutto lo spazio, le nostre
narici, come fuori, nelle città dove trasciniamo le nostre cadute.
ANTONELLA CHINI
Contro la globalizzazione. Intervista a Rodrigo García2
Nei tre spettacoli che ha presentato l’estate scorsa al festival d iAvignone, Prometeo,
Creo che no me habeis entendido bien e After sun, si nota un percorso drammaturgico
che da una certa ricercatezza e referenzialità letteraria giunge a una scrittura in presa
diretta con la realtà, con il quotidiano. Da cosa deriva questo spostamento?
Perché per me il teatro è molto più che letteratura. È vero, all’inizio della mia carriera
scrivevo testi molto più letterari, ma nel tempo questo tipo di scrittura mi è sembrato
sempre più noioso. Il teatro mi offriva delle possibilità dì costruzione drammaturgica
molto più ampie, come giocare con la luce, con lo spazio, con il pubblico. Il testo è
progressivamente passato in secondo piano. Oggi scrivo molto meno e lavoro molto di
più con la messinscena, con gli attori. Il testo nasce contemporaneamente alle prove, è un
mix di scrittura, immagini, azione.
2
Da «Art’o – rivista di cultura e politica delle arti sceniche», n. 13, primavera 2003.
Dopo questi spettacoli, gli ultimi due presentati anche in Italia, lei ha scritto altri tre
nuovi lavori. Ce ne può parlare?
Uno si intitola Ho comprato una pala alI’Ikea per scavarmi la fossa, un altro La storia di
Ronald i1 pagliaccio di MacDonald’s e l’ultimo Giardineria umana. Parlano del fatto
che siamo immersi nel consumismo, nella mercificazione di ogni valore e sentimento.
Non ci sono più molti spazi di libertà individuale, ci assomigliamo tutti, facciamo le
stesse cose, desideriamo le stesse cose. Le definirei opere contro la globalizzazione,
contro l’omologazione dei modelli di vita. Sono lavori più politici dei precedenti, più
diretti, più sporchi e brutali. Alla fine degli spettacoli la scena è ridotta a un porcile, pieno
di cibo calpestato. Sono opere dove tutto si deteriora e si distrugge.
Per quale motivo questa distruzione? Che energia sprigiona?
Vengono distrutti tutti materiali di consumo. Metto l’accento sul fatto che i supermercati
sono stipati di beni che non considero affatto naturali, sono prodotti artificiali, indotti.
Infatti in scena i miei attori agguantano questi prodotti come se fossero delle scimmie o
dei primitivi che vedono per la prima volta una cosa, come una scatola di cereali Kellogs,
e la guardano come se non sapessero che farsene. È un modo per dire che molti beni che
appaiono come normali, in realtà non lo sono affatto. Non è normale mangiare prodotti
congelati, precotti, colorati, artificiali. Così come non è normale comprare e mangiare
quattro volte più del necessario, mentre il resto del mondo muore di fame.
Le piacerebbe essere definito un autore no-global?
Penso di sì. A me non piace come è strutturato oggi il pianeta, la distribuzione
assolutamente sbilanciata delle ricchezze...
Una cosa però l’avvicina in qualche modo al sistema del consumismo, la considerazione
che ha per le sue opere del passato. Da consumare nel momento della rappresentazione e
poi buttare via…
No, è una cosa diversa. Si tratta di un’evoluzione artistica. Io cambio e cambia il mio
modo di vedere e rappresentare la realtà.
Non esistono valori universali nell’opera d’arte?
Per me, assolutamente no. Considero un concetto molto tradizionale l’idea di un artista e
di un’opera che trascendano la realtà, che permangano nel tempo. È vero, in questo caso
preferisco fare un teatro di consumo, o meglio che si consuma mentre si fa. Né mi
preoccupo di affrontare temi molto concreti, legati al nostro presente, che magari tra due
anni nessuno ricorderà... Io voglio realizzare opere per la società di oggi, legate ai
problemi del momento. Dare una risposta diretta alle cose, una funzione più sociale,
politica del teatro.
Un po’ come la pensava Brecht? Crede alla possibilità di muovere, se non proprio la
lotta di classe, almeno le coscienze, dalle tavole del palcoscenico?
Sì. Il problema è che quando Brecht pensava a questa possibilità, non esisteva ancora la
televisione, o l’intero sistema della comunicazione globale. Il teatro oggi occupa uno
spazio minoritario. Forse proprio per questo è un luogo di maggiore riflessione,
espressione e potenzialità di cambiamento.
Qual è la molla principale che la spinge a scrivere? La rabbia, l’indignazione, l’amore,
il sogno…
Di solito sono sentimenti negativi, legati alla contestazione del nostro modo di vivere
oggi. Mi basta aprire un giornale, o guardarmi intorno. È da lì che parto. Però il mio non
è un teatro pessimista, la mia critica è incentrata sul cambiamento.
Infatti nei suoi spettacoli si ride anche molto... –
Sì, io credo che l’umorismo sia fondamentale per non prendersi troppo sul serio, per non
essere pedanti, didattici.
Pur vivendo un momento storico così buio, non crede che si stia riaccendendo nel mondo
il desiderio del sogno, delle grandi utopie?
Sì, credo di sì. C’è molta gente a cui non piace il mondo che ci si prospetta e che sta
combattendo per mutarlo, pensiamo ai movimenti no-global, alla contestazione di un
certo sistema politico, alla rinuncia alle deleghe passive e al desiderio di partecipare
direttamente alla gestione della propria vita... Sono numeri esigui, perché la maggior
parte delle persone si preoccupa unicamente del proprio benessere personale, del
presente. Ma qualcosa si sta muovendo...
Quanto conta la sua origine argentina nella sua attività artistica e nel suo modo di
vivere?
Per me è fondamentale essere nato e vissuto in Argentina perché è un paese poverissimo.
Venire a vivere in Europa per poter lavorare con il teatro, mi ha fatto prendere coscienza
del benessere di cui gode solo una piccolissima parte del pianeta. Se penso che oggi in
Argentina si muore di fame, che il paese è al tracollo, il mio teatro si fa, di conseguenza,
sempre più combattivo. È come se avessi conosciuto le due facce della medaglia, non
posso dimenticarmene. Mi sorprende sempre il fatto che posso mangiare tutti giorni
quello che voglio, o che posso tenere una conversazione del genere con te, senza che
nessuno per questo ci imprigioni, o ci uccida addirittura, perché nella maggior parte del
mondo correremmo questo rischio… Il benessere, la democrazia, io li vivo come
qualcosa di anormale...
E non ha paura che il successo la possa, alla lunga, allontanare da un contatto diretto
con la realtà, con la strada?
No. Perché è vero che in questo momento i miei lavori hanno molto successo in tutta
Europa, ma ho trentanove anni, ci sono arrivato tardi e faticando molto, non credo che
nulla possa più cambiarmi. Quello che mi piace del successo è che ho più pubblico a cui
comunicare le mie idee.
Dove ricarica la sua energia?
È una domanda difficile. Perché sono tre anni che non smetto di lavorare un giorno.
Credo che l’energia si ricarichi quando finisci di scrivere un’opera e non ti soddisfa del
tutto e allora senti l’impulso a farne subito un’altra che sia più chiara e diretta della
precedente. O anche quando leggo sui giornali quello che accade nel mondo, vedi che è
tutto uno schifo e ti viene voglia di dire il tuo no. O ancora il gruppo che lavora con me,
siamo tutti amici, ci stimoliamo a vicenda...
I1 suo lavoro non può prescindere da quello sull’attore. Ma non è facile forse trovare
attori che siano disposti a farsi mettere così letteralmente a nudo, dal suo teatro...
Sono in molti a chiedere ai miei attori se si sentono a disagio o addirittura torturati in
scena... In realtà sono felici di lavorare con me. lo lavoro per gli attori, sono la mia
materia. Ognuno con la sua fisicità, la sua personalità. Vogliono lavorare con me, perché
condividono le mie idee, le mie critiche sociali, e hanno voglia di esprimerle. Con questa
complicità, si supera la difficoltà d’interpretare scene molto crude o violente o disgustose,
dove magari ti si chiede di mangiare e vomitare sul palco o di denudarti e simulare un
coito...
A proposito della durezza, dell’estremismo delle sue immagini, anche se lei non ama il
termine “provocazione”, però è un elemento costante del suo teatro.
Il nostro quotidiano è immerso nella violenza. La differenza sta nel fatto che la maggior
parte della gente non lo ammette, o non lo vuol vedere. Comunque a me non interessa
fare un teatro bello e buono, un teatro estetico... Nei miei spettacoli non ci sono decori,
ma un palco nudo che man mano si deteriora, si sporca sempre di più. Mi piace lavorare
sulla distruzione dello spazio, così come degli oggetti di consumo o sui prodotti
alimentari. Sono gli elementi della mia poetica.
Da cosa si chiama fuori Rodrigo García?
Per quanto riguarda il teatro, da una certa tradizione della rappresentazione. Io preferisco
vedere un attore che realmente corre o si stanca o mangia o grida, non una finzione... Né
mi interessa un teatro di svago, di divertimento.
Cosa vorrebbe provocare nel pubblico con i suoi spettacoli?
Riflessione. C’è gente che pensa che viviamo nel miglior mondo possibile. Il mio teatro
cerca di porre interrogativi del tipo: tu probabilmente vivi bene, ma altri no; oppure: forse
tu non vivi così bene come credi, o anche non sei così libero come pensi…
RODRIGO GARCÍA
Il pagliaccio del MacDonald’s3
Non so cosa ho più sconvolto, se la testa o lo stomaco.
Per le cose che mi passano per la testa, mi dico: hai la testa più sconvolta di tutti.
E per le scoregge che faccio mi dico: nessuno ha lo stomaco così sconvolto.
E invece no.
Io lo so che è più sconvolto la mia testa dello stomaco perché un mio pensiero è
infinitamente più insopportabile di una mia scoreggia.
Faccio una scoreggia, la annuso e dico: si può sopportare.
Analizzo un mio pensiero e dico: questo sì che non lo sopporta nessuno.
Un mio pensiero è più schifoso della peggiore scoreggia che puoi fare sotto il piumone.
Quelle scoregge che d’inverno servono a riscaldare il letto. Che riscaldano il letto meglio
di un camino!
3
Da Rodrigo García, La storia di Ronaldo il pagliaccio del MacDonald’s, in Id., Sei pezzi di teatro in tanti round, Ubulibri,
Milano 2003.
La gente pensa che gli eschimesi peschino facendo un buco nel ghiaccio e che si nutrano
di quello che pescano.
E invece no.
Gli eschimesi mangiano fave tutto il giorno e la notte si riscaldano i letti a suon di
scoregge, cazzo.
Non fanno un buchino nel ghiaccio e si siedono con la canna a pescare. Aprono scatolette
di fabada asturiana e se la trangugiano a cucchiaiate. Sono eschimesi che cuociono nelle
loro scoregge.
Come gli europei che cuociono nelle loro chiacchiere borghesi. Come gli americani che
cuociono nella loro ignoranza.
Come i politici che cuociono nelle loro promesse.
Per questo mi interessa tanto la relazione tra ciò che si mangia e ciò che si pensa.
La relazione stomaco-testa è sostanzialmente gassosa: si instaura tramite il rutto, quel gas
che va dalla pancia alla testa, che esce dalla bocca. Si riconosce dall’alito e dalle
scoregge.
Ma soprattutto, dal puzzo delle orecchie.
Puoi capire perfettamente se una persona è marcia dal puzzo delle sue orecchie.
Forse non lo sapete ma uno degli odori peggiori del corpo esce dalle orecchie.
Succede quando si decompone qualcosa nel cervello.
Per colpa del mangiare o meglio, per colpa del rutto che mette in comunicazione stomaco
e cervello.
Una scoreggia, in confronto al puzzo delle orecchie marce, è un profumo. Di peggio, non
c’è niente.
La gente dice: per conoscere il cuore di una persona io la guardo fissa negli occhi.
Io ti dico: se vuoi conoscere il cuore di una persona, annusale l’orecchio. In un secondo
capisci se è marcio o non è marcio.
Grazie alla comunicazione dei gas.
C’è qualcosa in certi cibi che fotte il cervello.
Io faccio il pagliaccio al McDonald’s.
Do ai bambini gli Happy Meal. Con navi spaziali, dinosauri e roba da mangiare.
Se un bambino mangia questo, è chiaro che rutta questo.
Perché il rutto è la comunicazione più diretta tra l’apparato intestinale e il cervello, dato
che nasce nella pancia ed esce dalla bocca, cioè dalla testa.
Dunque uno pensa a seconda di quello che mangia. O meglio, di quello che rutta, che è in
sintesi quello che mangia.
(Non ho niente contro il popolo americano.
Studio solo la relazione tra i gas e la comunicazione dei gas con il cervello tramite i rutti.
E le deformazioni del pensiero e del comportamento.)
Ho pensato veramente di avvelenare gli Happy Meal dei bambini. Con un pesticida.
Perché è meglio che muoiano alla svelta, quella domenica, invece di andare avanti tutta la
vita con una testa che è diventata uno schifo e che butta fuori schifezze, cioè butta fuori
pensieri che fanno schifo, cazzo.
E le cose che io penso, occhio... le faccio.
La cosa più normale è che una persona pensi molto e non faccia niente. O che pensi cose
terribili e poi finisca sempre per fare cose più o meno corrette.
Pensano di ammazzare il capo e gli servono il caffè.
Pensano di scavalcare la sbarra della metro e comprano un biglietto da dieci corse.
Pensano di picchiare un poliziotto, fino a lasciarlo tramortito sul marciapiede e poi vanno
a chiedergli il nome di una strada.
Pensano di abortire e poi decidono di partorire.
Pensano di bruciare vivo un barbone e gli fanno l’elemosina.
Pensano di votare per l’estrema destra e quella domenica restano a dormire.
Pensano alla fine di essere omosessuali o almeno bisessuali e dormono tutta la vita fica
contro cazzo.
Questo è un Happy Meal.
Analizziamolo.
Qui ci sono i surrogati della lattuga, i surrogati del pomodoro e soprattutto questo coso
ovale duro e marrone, che vorrebbe spacciarsi per un pezzo di carne vera.
A questo vengono aggiunti dei sughini gialli e rossi, che non hanno niente a che vedere
con la senape o col pomodoro.
La mescolanza esplosiva di tutti questi elementi nella scatolina prodigiosa chiamata
Happy Meal, provoca una grande quantità di gas nocivi al bambino che la ingerisce, con
evidenti ripercussioni rutto-cerebrali.
Chi mangia una cosa così, mai più nella vita potrà tornare a pensare in modo corretto.
E questo posso dimostrarlo scientificamente.
Per questo la cosa migliore è mettere del pesticida nell’Happy Meal e in cos’altro c’è.
E dato che quello che penso, ripeto, io lo faccio; ho comprato trenta chili di pesticida e li
ho caricati nel bagagliaio della macchina. Mi sono messo il vestito da Ronaldo, il
pagliaccio del McDonald’s e dietro nel bagagliaio avevo il pesticida.
Ma mi sono pentito per strada, cazzo.
Mi sono detto che bisogna essere più positivi, porca puttana: meglio mangiare una cosa
così che succhiare cazzi.
Perché un bambino che sta mangiando un Happy Meal non sta succhiando un cazzo.
Se hai nove anni e vivi a Lisbona, vai al McDonald’s tutte le domeniche.
Se hai nove anni e vivi a Cuba, vai a succhiare il cazzo a un turista italiano.
Se hai nove anni e vivi a Bruxelles, vai al McDonald’s tutte le domeniche.
Se vivi in Bolivia, vai nelle miniere per i gringos.
Se hai nove anni e vivi a Firenze, vai al McDonald’s tutte le domeniche.
Se vivi in Africa, cuci i palloni per la Nike.
Se hai nove anni e vivi a New York, vai al McDonald’s tutte le domeniche.
Se hai nove anni e vivi in Tailandia, te lo devi far mettere nel culo da un australiano.
Poi, due aerei si portano via due grattacieli e la gente si meraviglia. Le questioni religiose
sono una menzogna in più.
Credete alla propaganda politica come credete alla pubblicità del Danone.
Una nazione crede di poter radere al suolo Hiroshima e restare impunita.
Di poter distruggere economicamente l’Argentina e restare impunita. Di poter
bombardare qualsiasi pezzo di terra e restare impunita.
E fanno propaganda alla condizione opposta: dicono di essere loro il popolo ferito.
Truppe di soldati, truppe di Donnuts, truppe di Big Mac, truppe di Levi’s, truppe di
Philips, truppe di Hollywood...
Che stronzi!
Ti ricordi della Performance Art?
Ti ricordi del Fluxus, degli Happening?
Ti ricordi delle torture in Argentina?
Ti ricordi di qualche botta presa dai tuoi genitori?
Ti ricordi del giorno in cui hai voluto morire?
Ti ricordi di qualche notizia sul giornale?
Quale?
Il genoma umano? Un’altra guerra?
Quello che ha la testa foderata di giornali, fa finta...
Cioè: non è niente di che.
Fa finta di soffocare.
E si guadagna lo stipendio.
Ti ricordi di Hiroshima?
Ti ricordi di Auschwitz?
Quali corpi ti vengono in mente?
Alla memoria storica dobbiamo aggiungere tonnellate di propaganda.
Ti ricordi di Jorge Rafael Videla, di Suárez Mason?
Ti ricordi di Grotowski, di Bob Wilson, di Pina Bausch?
Ti ricordi di qualche stampa di Goya ora?
Ci hanno guadagnato tutti, pensaci.
Tutti erano pagati.
Tutti.
Io non credo a niente.
Ti ricordi del teatro?
Che senso ha?
E che senso ha, in generale, tutto questo?
Guadagnare.
Fino a 23 anni ti credi un artista.
A partire dai 26, hai bisogno di soldi tutti i giorni.
A 27, hai già fallito.
Fai di tutto, ma a scartamento ridotto.
E ti siedi ad aspettare che le cose ti piovano dal cielo.
Mi Buenos Aires querido4
Il teatro è diventato un pensiero triste che si balla.
Da qualche stagione la scena indipendente argentina ci offre una ricchezza e una qualità
sorprendenti. Forse non è un caso. Sotto la cappa di una situazione economica disperante,
che si trasforma in crisi anche sociale e culturale, senza sbocchi politici in vista, emerge
una giovane generazione di artisti capace di dar voce al disagio di tutti, da Daniel
Veronese con lo storico gruppo Periferico de obietos a Beatriz Catani o Federico León.
Sintomatico di questo stato d’animo uno spettacolo come Suicidio, in cui Veronese e il
Periferico evocano il destino della vacca quale metafora o sintomo di una condizione
esistenziale, contenuta a fatica da un titolo disturbante. Giacché dietro l’assunzione di un
tema tabù, oggetto di una vera e propria rimozione sociale, emerge una tensione
individuale e collettiva all’autodistruzione. Dietro l’animale che si lascia trascinare
quietamente al macello, elevato però a figura familiare nell’immaginario del popolo
argentino poiché cardine un tempo di un’economia florida, traspare l’immagine di una
4
Ibidem.
cultura spinta sempre più sull’orlo della dissoluzione. C’è voglia di dire, di raccontarsi.
L’oggetto più importante, nel più recente Open house di Veronese, è il microfono posto
in primo piano. A turno gli interpreti si fanno avanti, sgomitando un poco, per
conquistarsi lo spazio dove raccontare le proprie storie. Storie comiche e tristi,
naturalmente. Storie di solitudini, di separazioni violente e figli contesi, di impulsi di
abbandono insoddisfatti. Di incapacità di fare. Tentativi di suicidio, anche qui. La
mancanza di amore che uccide, la prossimità dell’amore alla morte. E “nonostante tutto la
vita è un paradiso tropicale”. La contraddizione va accettata.
È uno sguardo crudo, senza commiserazione, quello che ci viene da Buenos Aires. Di chi
ha messo in bilancio anche la possibilità dell’esilio.
Da Buenos Aires viene anche Rodrigo García, scrittore, regista e scenografo, trentanove
anni, da quindici vive in Spagna. Il nome del suo teatro, La Carniceria, significa
macelleria e riassume bene la sua poetica; la fisicità della sua scrittura, inscritta nel corpo
degli interpreti, e la crudezza del suo linguaggio, in presa diretta con i problemi del
presente. I suoi spettacoli sono un elettrizzante, inquieto e violento, esilarante e grottesco
invito alla rivolta. Una drammaturgia contro, quella di García, ad azzerare ogni filtro
estetico e moralistico della comunicazione; una poetica della provocazione, a sfidare i
limiti di reazione del pubblico, pescando a piene mani nella quotidianità, per trasformare
la scena in un’esperienza vitale e travolgente, grazie anche all’energia brutale e
contagiosa dei suoi attori. Un teatro, il suo, che si prende gioco di tutto, come, in
Aftersun, l’esilarante elenco di tutti i modi di morire, o le perversioni sessuali di un
accoppiamento con due conigli vivi sul palco, o ancora i modelli distruttivi dell’anoressia
negli esperimenti pseudoscientifici di riprodurre nella realtà la taglia della bambola
Barbie o ancora il mito di Maradona a divorare la vita oltre ogni limite, a incendiare,
come i cheeseburger che gli attori cuociono sulla scena, ogni simbolo della società
globalizzata. Non ama il termine di provocatore, Rodrigo García, ma non disdegna quello
di autore no-global, a smascherare con il suo teatro, l’umanesimo riduttivo generato dal
fondo monetario internazionale.
GIANNI MANZELLA
La contraddizione necessaria. Intervista a Daniel Veronese5
Prima di questo Apocrifo 1: EI Suicidio il Periodico de objetos era già venuto in Italia
qualche anno fa, con una messinscena di Hamletmaschine di Heiner Müller, a Roma, al
teatro Valle...
Teatro meraviglioso, però sentivamo che non era il teatro per il nostro spettacolo, non
passava nulla al pubblico. Noi di solito lavoriamo in luoghi non tradizionali, senza
divisione fra scena e spettatori.
All’origine del gruppo c’erano però esperienze di teatro di marionette, e ancora oggi gli
oggetti occupano un posto importante nel vostro teatro.
Il gruppo si è formato tredici anni fa, nel 1989, a Buenos Aires. Lavoravamo all’interno
del teatro San Martin, uno dei più grandi del Sud America. Sentivamo che il teatro degli
oggetti poteva avere un pubblico adulto. Non avevamo visto molte cose di teatro di
marionette per adulti, invece noi sentivamo che era un bel terreno di ricerca. Abbiamo
5
Ibidem.
cominciato allestendo Ubu re di Jarry. Ma ci interessa fare spettacoli sempre diversi dai
precedenti. Ognuno deve essere un salto nel vuoto per noi come creatori ma deve esserlo
anche per il pubblico. Vedo il teatro come un luogo dove condividere delle idee e
inoltrarsi nel vuoto. È il luogo sociale per eccellenza, dove si possono esporre i propri
fantasmi. Il pubblico può non comprendere ma deve percepire questo sentimento che non
può essere la sua vita quotidiana.
Nel vostro lavoro c’è una forte componente fantastica ma sembra sempre condurre a una
realtà concreta.
È importante demistificare il teatro. Provenendo da un teatro degli oggetti, sappiamo che
gli oggetti producono un incantamento nel pubblico, lo spettatore prima guarda l’oggetto
e poi l’attore. Ma gli oggetti sono un’arma a doppio taglio. Noi mostriamo sempre il
meccanismo teatrale della loro manipolazione, mettiamo in mostra qual è il trucco, in
modo che la gente guardi con tranquillità lo spettacolo. Quando vedo un teatro di
rappresentazione, mi dico che gli spettatori che sono lì credono che tutto sia verità e
invece non è verità. La mia principale preoccupazione è che la gente veda che non c’è
inganno. Ovviamente c’è sempre inganno nel teatro. Ma c’è un altro tipo di verità nel mio
teatro e questa verità ha qualcosa a che vedere col fatto di mostrare il manipolatore che
manipola l’oggetto. È una verità svelata, lo spettacolo si muove continuamente fra verità
e finzione.
Avete avuto un grande successo nei festival teatrali europei. Come è accolto invece il
vostro teatro in Argentina?
Il successo all’estero ci ha dato un riconoscimento. In Argentina succede che se qualcuno
ha successo in Europa, esce dalla porta di servizio e rientra dalla porta principale. Buenos
Aires guarda continuamente all’Europa. In realtà ai nostri primi spettacoli venivano in
pochi, ma noi siamo molto tenaci. Non ci importava il pubblico, non ci importava se non
veniva la stampa, ci piaceva quello che facevamo. Poi la gente ha cominciato a venire a
vederci ma credo che si possa fare teatro per poco pubblico. Noi lo facciamo per noi
stessi, per tirar fuori i nostri fantasmi, per cambiare. Io sento che mi modifica e se anche
il pubblico viene modificato è meraviglioso. Può sembrare uno sguardo egoistico però
non penso al pubblico. Mi interessa il pubblico ma non ci penso, vorrebbe dire esere più
condiscendenti, mentre si deve pensare alle proprie contraddizioni.
In questa vostra creazione “apocrifa”, EI suicidio, c’è però molto della situazione
argentina.
Abbiamo scelto il tema del suicidio perché sentiamo che la gente non ama parlarne e sta
bene che non ami parlarne: è un tema difficile, si parla non solo della morte ma della
possibilità di anticipare la morte Non abbiamo cercato il macabro di questo tema, non ci
interessava fare l’apologia del suicidio. Abbiamo voluto parlare di ciò di cui la gente non
ama parlare. Ci sentiamo vicini da un punto di vista artistico a Romeo Castellucci e alla
Societas Raffaelo Sanzio, vogliamo avere uno spazio che non ha niente a che fare con la
realtà quotidiana ma è in connessione diretta con l’emozionale.
C’è un rapporto “politico” con l’attualità?
Per due o tre mesi abbiamo pensato a come affrontare i problemi dell’Argentina, e sono
problemi che risalgono a molto tempo addietro. Sentivamo che non potevamo impedire
che la realtà argentina entrasse nello spettacolo perché il tema è la vita. Non potevamo
fare uno spettacolo sul suicidio e non parlare dell’Argentina, possiamo dire che il nostro è
un paese che si suicida molto, che va dritto al mattatoio come fa la vacca, sapendo cosa
l’aspetta ma che non ci sono altre possibilità. Però si può pensare la morte di un processo
come un modo per accedere a un altro processo. Perciò non parlo della morte solo come
finale della vita ma anche come finale di qualcosa che prepara qualcosa di nuovo. Ma lo
spettacolo sta piantato nella sua forma, non offre una soluzione. Il teatro espone la
preoccupazione, lo spettacolo si rifà a un universo caotico. La situazione argentina è
difficile da comprendere. Non c’è fiducia in nulla, o forse c’è più fiducia nell’arte che
non nella politica. Il pensiero artistico mostra un tipo di verità che per me è più
importante. La politica tende al consenso, deve mentire per attrarre. Il teatro per me non
deve attrarre ma deve produrre aperture nella mente degli spettatori. Questo per me è il
teatro necessario oggi in Argentina.
Ci sono altri gruppi che lavorano in questa direzione, avete dei rapporti con loro?
Non ci sono molti gruppi in Argentina o si sono sciolti. Il nostro è un gruppo molto
speciale. Siamo in tre, con Anna Alvarado e Emilio García, che lavoriamo insieme dai
primi spettacoli. Altre tre persone ci accompagnano da parecchi anni ma non stanno sul
versante ideativo del lavoro. Sento che per noi è un luogo di riflessioni sulla vita non solo
a livello artistico. Non c’è egocentrismo, non c’è necessità che si privilegi un’idea
sull’altra. È un luogo di discussione molto aperto, quando c’è una differenza d’idee non si
vota, si cerca il comune denominatore delle diverse idee. Forse dipende dal fatto di venire
da un teatro degli oggetti, perché quando uno lavora con gli oggetti pone il suo interesse
egocentrico al di fuori del proprio corpo, mentre l’attore può invece metterlo solo in uno
specchio.
Gli oggetti li costruite voi?
Al principio sì ma oggi non più. Lavoravamo molto con vecchie bambole, di cartapesta,
di porcellana, un universo molto sinistro, bambole con la testa rovinata. Davano un
aspetto molto particolare alla nostra estetica. Adesso gli oggetti sono disegnati ma non
realizzati da noi. Il nostro lavoro ha molto a che fare con l’universo visuale, è difficile
lavorare con uno scenografo esterno, con un’idea di scenografia che non venga
direttamente dalla scrittura. Direi che la scenografia sorge dallo spettacolo.
Siete un collettivo. Come nasce un lavoro? C’è una divisione dei compiti fra di voi?
La direzione generale è mia e mi piace molto scrivere i testi, mentre le idee di
messinscena sono discusse sempre tra noi tre, le scelte estetiche sono sempre condivise.
L’idea iniziale a volte è solo il titolo: vogliamo parlare del suicidio. In generale vuol dire
mettersi in un’idea senza sapere dove stiamo andando.
E con gli attori come lavorate? Usate delle improvvisazioni?
All’inizio chiedevo agli attori che sensazioni provavano rispetto al suicidio. I primi due o
tre mesi gli attori ballavano e parlavano e improvvisavano sul suicidio, poi sono entrate
nel gruppo altre due ragazze e ha cominciato a nascere lo spettacolo. Questo è il primo
spettacolo in cui lavoriamo con attori che vengono da fuori, sono attori molto speciali che
posso n sopportare il vuoto, poiché vogliamo creare un oggetto nuovo dal nulla. Non
sono attori di una scuola speciale, non sono attori psicologici. Se un attore mi chiede: da
dove vengo? gli rispondo che quel che importa è che si trova qui sulla scena e deve
camminare da un punto all’altro e niente più. Se mi dice che gli serve un retroterra
psicologico, io come spettatore non ne ho bisogno. Ho bisogno che entri in una
coreografia che è l’opera, non mi interessa quel che sente l’attore, mi interessa quel che
sente il pubblico quando vede muoversi l’attore.
Anche con una componente di violenza?
Siamo coscienti di quello che produce lo spettacolo. Per me EI Suicidio non è uno
spettacolo violento, a confronto di altri nostri lavori, è più intriso di malinconia. Credo
che a teatro due più due può fare cinque. Non c’è una ricetta. Un medesimo spettacolo
produce un’emozione per uno spettatore e un’altra per un altro, quando è vivo il teatro
produce dissenso. Il pubblico non è una massa omogenea, sono individualità che ricevono
in diversa maniera. Se piace a tutti, non è un teatro che mi interessa. Il teatro deve far
uscire dalla sala diversi da come si è entrati e credo in questa necessità di produrre
dissenso. Ma se tutto il teatro fosse come il mio, farei altre cose.
MASSIMO MARINO
Due spettacoli di César Brie e del Teatro de los Andes
In Bolivia il pubblico abituale del Teatro de los Andes è fatto di minatori, di campesinos,
di donne che allattano, di bambini che non stanno fermi, di vecchi, di giovani, perfino di
deputati. Quattro-cinquecento persone per volta, nei villaggi, nelle città. La scena è
spoglia, veloce da montare, qualche oggetto, qualche fondale. Ma le invenzioni sono
sorprendenti. César Brie, quando fondò questo teatro nel più povero dei paesi
dell’America Latina, a Yotala, vicino Sucre, aveva in mente di formare un “attore-poeta”,
che con il corpo e con l’azione sapesse dare profondità a storie capaci di parlare a tutti.
Brie, argentino di nascita, veniva da anni di esilio in Europa, nella Milano dei centri
sociali anni Settanta e poi all’Odin Teatret.
Arrivò sulle Ande nel 1991, in uno dei paesi più espropriati dalla dittatura e dalla
globalizzazione, quello stesso che da poco ha lanciato un segno di speranza, eleggendo
come presidente della repubblica un indio, Evo Morales. Brie ha lasciato la sua fattorialaboratorio per dedicarsi alla campagna elettorale: di notte girava con un pennellone a
cambiare le gigantesche scritte murali della destra, “PODEMOS”, in “ROBEMOS”:
bastavano due tratti di vernice bianca, sulla P e sulla D.
Per lui l’attore con l’arte deve professare la verità, deve affrontare le grandi questioni
senza rinunciare alla visione personale, affettiva. In questa direzione vanno i due
bellissimi spettacoli con i quali ha debuttato al Teatro delle Passioni di Modena, in Italia
fino alla fine di maggio (in questi giorni all’Elfo a Milano, poi a Vicenza, Mira, Parma,
Faenza, Lecce, Napoli). Fragile è un lavoro corale sull’adolescenza. Ne è protagonista
Maria Teresa Dal Pero, insieme a tre attori sudamericani formatisi alla scuola di Brie.
Licia cresce davanti ai nostri occhi, coccolata e incompresa dagli adulti, chiusa in un
proprio mondo, emblematizzato da un baule dove confinarsi per fuggire. Tra atti
quotidiani e sogni, pesante è il conflitto con i genitori e fortissimo il legame con un nonno
dai lineamenti indi, che vive come in un altro tempo, in un altro mondo. Spettacolo
delicato, conquista lo spettatore grazie a interpreti capaci di evocare sentimenti e paure
comuni con trattenuto dolore e comicità sottile.
L’altro spettacolo è un capolavoro: Otra vez Marcelo porta in scena un intellettuale e
uomo politico boliviano, Marcelo Quiroga Santa Cruz, la sua lotta per la sovranità del
Paese, contro le multinazionali e contro lo sfruttamento delle risorse di tutti da parte di
pochi. Racconta la sua vita attraverso i ricordi della moglie, in un’atmosfera lunare, in un
dialogo incessante con un fantasma che appare vivo. Marcelo fu fatto sparire dal regime
del generale Banzer nel 1980: sulla scena, nella memoria è presente, nelle idee e
nell’amore delicato per la moglie, rivissuti con grandissima commozione, con rara
capacità di trasformare nodi storici e politici in immagini indimenticabili da Brie e Mia
Fabbri. Con questo spettacolo il Teatro de los Andes inaugurerà i lavori del nuovo
parlamento democratico boliviano, con la coscienza che il paese sta cambiando, anche se
le vecchie oligarchie non lasceranno facilmente il potere reale.
Il 3 aprile alle 21 al teatro di Mira (VE) Brie discuterà con Gianni Minà della nuova
situazione politica dell’America del Sud.
FERNANDO MARCHIORI
L’obbligo morale e l’impegno per la bellezza. Conversazione con César Brie6
Dopo l’Iliade (2000) e Dentro un sole giallo (2004), il nuovo spettacolo di César Brie,
Otra vez Marcelo, conclude la trilogia più politica del Teatro de los Andes, tornando alla
tragedia dei desaparecidos attraverso la vicenda di Marcelo Quiroga Santa Cruz. Un
personaggio ancora tutto da scoprire, vincitore del premio Faulkner con il romanzo Los
desahabitados, ma anche estensore del Decreto di nazionalizzazione del petrolio che ne
fa un precursore della lotta alle multinazionali e all’esclusione sociale. Sul Marcelo e
sull’altra nuova produzione del gruppo boliviano, Fragile, in tournée in Italia fino a
maggio, abbiamo rivolto alcune domande al regista argentino.
Chi era Marcelo Quiroga Santa Cruz?
Il più importante intellettuale boliviano del XX secolo, uno scrittore raffinato e un
politico integerrimo, parlamentare e ministro, ucciso durante il 1980 con il colpo di stato
di García Mesa. Aveva accusato l’ex dittatore Banzer, al potere dal ’71 al ’77, di 220
delitti, di ognuno dei quali mostrava le prove. Con un discorso in Parlamento che durò tre
giorni e fu trasmesso in diretta alla radio e alla televisione nazionali – nello spettacolo
scandisce le scene della sua tortura e dell’occultamento del suo cadavere – ottenne il
processo contro di lui. È per bloccare quel processo che si giunse al colpo di stato, il cui
primo atto fu proprio l’assassinio di Quiroga.
Ne avevi già onorato la memoria nell’Iliade, in una scena indimenticabile nella quale tre
donne vestite di nero narravano la fine di alcuni eroi omerici destinati a rimanere senza
sepolcro. Ai nomi antichi si aggiungevano quelli di Quiroga Santa Cruz e dei sindacalisti
Walberto Vega e Carlos Flores, trucidati nella sede della Central Obrera Boliviana di La
Paz. «Di loro rimangono i nomi e la memoria, ma non la tomba», intonavano le donne
mostrando le foto in bianco e nero delle vittime. Perché hai voluto tornare su Marcelo e
raccontarne la vita e il pensiero?
Per riscattarne la figura. E perché tutti i temi del dibattito attuale in Bolivia, quelli sui
quali il paese è andato alle elezioni portando alla vittoria, poco più di un mese fa, il fronte
popolare, sono i temi di cui si occupava Quiroga Santa Cruz.: il superamento delle
disuguaglianze, la sovranità popolare, la nazionalizzazione degli idrocarburi, la lotta
contro la corruzione, l’integrità morale. Il mio problema era come fare poesia con
6
Da «Hystrio», n. 2, 2006.
l’economia. Mi sono costretto a trovare un modo di affrontare i discorsi politici senza
cadere nel retorico.
Di nuovo, come in Dentro un sole giallo che il pubblico italiano ha visto l’anno scorso e
che raccontava il terremoto del 1998 e gli episodi di corruzione e furti che
accompagnarono la ricostruzione, siamo di fronte a un lavoro che nasce dall’obbligo
morale di dire, ma che vuole dire rimanendo fedele a un linguaggio artistico, senza
rinunciare al teatro, come invece accade spesso anche in Italia nel cosiddetto “teatro di
narrazione”.
A me piace moltissimo il teatro di narrazione, come mi interessano tante altre forme e
sperimentazioni linguistiche. Ma cerco la mia propria strada. Ho cercato di costruire un
modo di raccontare e rivelare attraverso l’abbinamento di testi epici e lirici ad azioni
metaforiche e allegoriche. Questa ricerca l’avevo iniziata con Il mare in tasca. Spero che
adesso si sia evoluta.
E la moglie di Marcelo, Cristina?
È un personaggio che mi è cresciuto tra le mani mentre scrivevo, andando a intervistare
parenti e amici di Marcelo, ricostruendo la sua vita. Così la parte che avevo inizialmente
pensato per Mia Fabbri, una parte da servo di scena, che mi aiutasse a creare delle
coreografie e dei “paesaggi” sui quali muovere un mio monologo, è diventata quella di
un’attrice comprimaria. Cristina ha cercato il corpo di Marcelo per 25 anni e continua a
cercarlo. Non ha bisogno di ricordarlo, perché è come se fosse lì con lei, ne è abitata. La
loro straordinaria storia d’amore è diventata l’altro binario su cui procede lo spettacolo,
accanto a quello politico. È quasi un Romeo e Giulietta alla rovescia. Se la storia raccolta
da Shakespeare è un inno all’impazienza, quella vissuta da Cristina e Marcelo è un inno
alla perseveranza. Oggi Cristina è una signora anziana che per l’artrite si muove
appoggiandosi al deambulatore. Ma con le sue battaglie è riuscita a ottenere che il diretto
responsabile dell’uccisione del marito, il generale García Mesa, dopo un processo durato
dieci anni fosse condannato e messo in galera.
Banzer, invece, è tornato al potere “democraticamente” quando è stato eletto alla
Presidenza della Repubblica, carica che ha mantenuto fino al 2001.
Contro di lui non c’erano prove. Lo spettacolo lascia intuire le sue responsabilità, ma non
può lanciare accuse esplicite.
Come sta cambiando il tuo modo di fare teatro? Ci si può aspettare che, conclusa la
trilogia, l’urgenza civile lasci più spazio a una ricerca artistica meno condizionata da
intenti documentari e pedagogici?
La dimensione politica farà sempre parte dei miei lavori. Ma adesso voglio finalmente
affrontare dei classici. Cechov e Shakespeare, ma anche Cervantes e nuovamente Omero.
Non so mai quale sarà il punto di arrivo e non procedo con tesi aprioristiche quando
inizio un lavoro. Cerco di scoprire strada facendo cos’è che mi attira dell’argomento,
come affrontarlo e le forme da utilizzare. Oggi, più che raccontare delle storie, cerco di
costruire delle mappe. Il presente rannicchiato nei ricordi intimi, l’universale raccontato
nelle vicende degli uomini. Per quello voglio tornare a lavorare con dei giovani.
Marcelo Quiroga Santa Cruz, come già Padre Espinál nei Sandali del tempo, è un
personaggio che interpreti, almeno apparentemente, con una immedesimazione totale. È
evidente che sono entrambe figure nelle quali ti riconosci, che senti come uomo prima
che come attore, e che hanno i tratti della passione rivoluzionaria e del sacrificio. Non
sono poi molto diverse da un’altra figura che ti è cara fin dall’adolescenza, quella di
Ernesto Guevara. Hai mai pensato di costruire uno spettacolo su di lui?
L’ho pensato ma non ne ho il coraggio. Il Che è stato così grande e complesso. E poi il
prossimo anno se ne faranno decine di spettacoli, dato che ricorreranno i quarant’anni
dalla sua morte, e io sono restio alle celebrazioni. Preferirei affrontarlo “fuori epoca”,
fuori moda. Comunque, se ci lavorassi, partirei dalla visione che del Che si ha in Bolivia.
Uno dei pochi bianchi di cui, nel giorno dei morti, molti indigeni chiamano l’anima per
brindare insieme. Espinál e Marcelo li ho riscattati da un oblio indignante e ingiusto. Il
Che non è stato dimenticato, molti intellettuali di valore si sono occupati di lui. Nel
giorno dell’insediamento Evo Morales ha chiesto alla folla un minuto di silenzio in onore
di tutti gli indigeni vittime dell’ingiustizia dalla Conquista a oggi, ma ha poi nominato
Tomás Katari, padre Espinál, Marcelo Quiroga e appunto il Che. Scelta che ha fatto
discutere, perché contro il Che l’esercito boliviano ha vinto una battaglia di cui va fiero.
Ma in Bolivia accade anche che nell’anniversario dell’uccisione del Che l’esercito
festeggia la vittoria mentre qualche isolato più in là la gente festeggia l’anima del
guerrigliero.
Dicevo dell’apparente immedesimazione totale, perché ovviamente in scena tu mantieni il
controllo assoluto sulle differenti partiture attorali, anche su quelle, per niente facili,
della meno esperta Mia Fabbri, al suo debutto come attrice. Come hai lavorato con lei?
È stata la danza la chiave per entrare nel personaggio e per dare forma drammatica alla
storia d’amore di Cristina e Marcelo?
Ho chiesto a Mia di essere naturale e sincera. Ho risolto il problema della sua emissione
vocale usando dei microfoni finché è cresciuta abbastanza per non averne più bisogno nei
teatri con buona acustica. La danza l’ha accomunata ad un attività giovanile del suo
personaggio. E poi, lei come ballerina aveva dentro una grande saggezza rispetto allo
spazio e al corpo. L’ho aiutata e poi mi sono sorpreso vedendola sbocciare in modo
naturale e con molta umanità.
Spettacoli, collaborazioni con la radio e la televisione, impegno politico militante nel
clima euforico del primo governo indigeno, ricerca artistica dei singoli attori, grandi
tournée in America Latina e in Europa: il Teatro de los Andes è una realtà sempre più
articolata.
Ma continua anche il lavoro con la popolazione, che è stato fin dall’inizio una delle
ragioni e insieme una delle fonti del nostro fare teatro. Jorge Jamarilli, quando ha
lasciato il nostro teatro, ha lavorato a Potosì in una scuola che si trova dentro una miniera,
a duecento metri sotto terra, dove i bambini seguono le lezioni mentre i genitori lavorano.
Gonzalo Callejas, l’ultimo suo lavoro per esempio lo ha fatto in un pueblo dove non c’è
neanche la corrente elettrica. Ha portato i giornali per fare la cartapesta e il primo giorno,
mentre sta per strapparli e metterli a macero, capita che gli adulti dicano: “Aspetta un
attimo, prima li leggiamo”, perché lì non arrivano notizie. In queste situazioni Gonzalo
crea con le comunità degli spettacoli che avranno una vita breve ma sono degli eventi
straordinari.
E il progetto di una vera e propria scuola di teatro?
Vorrei fare una scuola “intermittente”, con giovani scelti attraverso dei seminari.
Lavorare con allievi nei quali vi sia un’armonia tra talento e solidarietà. Vorrei da un lato
insegnare loro le tecniche e dall’altro portarli subito in scena con degli spettacoli che
possano allestire in giro da soli e con i quali possano sostenersi economicamente. Per poi
ritornare da noi e continuare ad imparare. Così, penso che insieme alla scuola aiuterei a
creare dei gruppi nuovi.
In Italia in questi mesi è in tournée anche il gruppo con il nuovo spettacolo intitolato
Fragile.
In realtà Fragile non è l’ultimo spettacolo del gruppo. L’avevamo già cominciato prima
di Dentro un sole giallo, ma l’abbiamo interrotto perché Maria Teresa Dal Pero, la
protagonista, ha scelto di prendersi un anno “sabbatico” e di fare un’esperienza fuori dal
Teatro de los Andes.
Tra l’altro in Messico, dove ha preso parte a uno spettacolo del regista Valdes Kury
vincendo – lei italiana, da quindici anni in Bolivia – il premio 2004 come miglior attrice.
Sì, e il fatto ha suscitato anche un certo scalpore, perché è la prima volta che il
riconoscimento va a un’attrice non messicana. Abbiamo ripreso Fragile l’anno scorso, sia
per volontà di Maria Teresa sia per l’interesse suscitato in me da un libro particolare
come Nascita e morte della massaia di Paola Masino. Un libro con una storia curiosa –
censurato dal fascismo, riscritto poco prima della guerra, pubblicato negli anni Cinquanta
e finalmente scoperto solo con la riedizione negli anni Ottanta – dal quale in realtà
abbiamo tratto solo l’idea iniziale, quella di una ragazzina che non vuole diventare grande
e si rifugia in un baule, il suo mondo diventa questo baule dal quale i genitori cercano di
farla uscire. Fragile è dunque uno spettacolo sulla fine dell’infanzia, su che cosa significa
diventare grandi senza troppi compromessi con l’etica interiore, con le urgenze, con quel
modo di vedere il mondo che spesso hanno gli adolescenti e che non dovremmo mai
perdere di vista.
L’ultima volta che hai accettato di lavorare con degli allievi esterni al Teatro de los
Andes ne è nato Il cielo degli altri, uno spettacolo di grande intensità ed energia sul tema
dell’immigrazione, che il Teatro Setaccio ha portato in giro con successo per l’Italia.
Con alcuni di quei giovani attori e con altri raccolti intorno a un nuovo progetto
artistico, questa volta dedicato a Cechov, torni ora a farti carico di un impegno
pedagogico e di un’avventura teatrale che speriamo di vedere presto in scena. Puoi dirci
qualcosa?
Non parlo mai di quello che non ho fatto, ma posso soltanto dirti che cercheremo di
mettere in scena Zio Vanja.
LA NUOVA SCENA EUROPEA
MASSIMO MARINO
Globalizzazione ad Avignone7
7
Da «Lo Straniero», n. 52, ottobre 2004.
È possibile un teatro politico nella società dello spettacolo generalizzato? Un teatro non
banalmente ideologico, né predicatorio, che non sia neppure una rivisitazione nostalgica o
necrofila dell’agit prop o di classici ormai anestetizzati alla Brecht? Al festival di
Avignone 2004 sono andati in scena il fallimento della Swissair, la chiusura della
Daewoo in Lorena, il lavoro in affitto nell’era degli iperdiscount, la Mcglobalizzazione e
l’urlo dell’individuo ferito da un potere profondo, ramificato e radicato. È un teatro
contemporaneo che cerca di penetrare i meccanismi economici e di produzione del
consenso, che parla molte lingue e esplora diverse pratiche sceniche, d’autore e collettivo,
gridato e pensato, fisico, grottesco, formalmente acuminato. Rinuncia al “piccolo è bello”
che va tanto di moda da noi in Italia e attacca frontalmente i grandi problemi, con una
furia, una capacità di divertire e di analizzare che lascia felicemente stupiti.
Molte delle opere presentate sono nate in importanti centri di produzione: il programma,
su invito dei nuovi direttori del festival Hortense Archambault e Vincent Baudriller, è
stato elaborato da Thomas Ostermeier, regista trentacinquenne direttore della
Schaubühne, autore di incursioni devastanti in grandi classici e di messe in scena di testi
contemporanei che non lasciano respiro. Per lui le questioni cui rispondere sono chiare:
«Qual è il ruolo del teatro nella nostra società? Dove si situa la necessità del teatro?
Come reagire al mondo che ci circonda?». Ostermeier, presente con quattro regie, ha
aperto la manifestazione nel cortile d’onore del palazzo dei papi con un Woyzeck
ambientato fra palazzoni di un’odierna periferia metropolitana, davanti a una discarica,
dove si trascinano vite sospese fra la violenza, l’oppressione, l’inconsistenza sociale, il
sogno di evasione. Il protagonista non è più un soldato ma un senza casa, un senza voce
che si muove in una terra di nessuno. Con attori formidabili il testo, visto tante volte,
diventa un viaggio nella desolazione delle nostre città-caserma, un disperato poema
dell’hinterland e delle braci che covano sotto apparenti quotidiani equilibri.
Ostermeier ha invitato il vecchio maestro Frank Castorf, direttore della Volksbühne, alle
prese in Kokain nientemeno che con Pitigrilli, una danza sulle rovine di un’Europa
decadente. Ma ben più interessanti sono lavori come L’histoire de Ronald, le clown de
Mc Donald’s di Rodrigo García, la globalizzazione che invade e ricopre corpi nudi in
forma di dilaganti ketchup, farina, birra, cocacola che inondano, travolgono, trasformano
la scena in un lago di miasmi, mentre gli attori raccontano le loro vite attraverso le
emozioni provate a un fast food.
Spicca, in questo teatro neo-politico, un monologo come Deux Voix, una magistrale prova
d’attore di Jeroen Willems, con la regia di Johan Simons e del gruppo olandese ZT
Hollandia. Lo spettatore si trova davanti a una tavola ingombra con i resti di un ricco
banchetto: soprattutto bottiglie e bicchieri, pieni, vuoti, semivuoti. Willems personifica in
successione, con una sapienza teatrale vorticosa e controllatissima, i quattro personaggi di
una parte di Petrolio di Pier Paolo Pasolini: il pranzo fra un dirigente dell’Eni, un agente
di collegamento con la mafia, un altro che cura i rapporti con la chiesa e un intellettuale,
rivelando con accenni, piccole trasformazioni fisiche, leggeri travestimenti, distanza,
immedesimazione e ironia, i legami fra i personaggi e soprattutto fra le loro funzioni di
potere. Ma il punto centrale della pièce sono i discorsi di un ex presidente del consiglio
d’amministrazione della Shell, Cor Herkströter, che racconta con il sorriso sulle labbra la
politica di rapina delle multinazionali nel terzo mondo, la valorizzazione delle peculiarità
locali, delle divisioni per dominare, lavorando per l’avvenire (del profitto) senza curarsi
del cambio di regimi, badando ad assicurare la continuità dello sfruttamento. Parla con
pacatezza suadente di cogliere tutte le occasioni che portano sviluppo, senza preoccuparsi
di altro, enunciando la morale del villaggio globale, confortata dal calo dell’opposizione
conseguente alla caduta del comunismo. È il vero burattinaio che muove altri fili di servi
o funzionari mediocri e voraci, rappresentati dall’unico attore con uno scatto fisico, un
dettaglio, una mano che entra in un paio di calze di nylon facendoci vedere uno stupro, un
volteggiare dell’intellettuale pronto a servire, a cambiare natura e costume. Un balletto
macabro che parte dal grande capitale e gira intorno al deforme mafioso, che tutti riesce a
controllare con una violenza fatta di sguardi, di controllate assenze, di (metaforiche)
prestazioni sessuali umilianti ottenute con feroce comando. E il tutto è accenno stilizzato,
salto fisico, gioco di trasformazioni.
Se Pippo Delbono nel suo Urlo, che ha debuttato nelle cave dove nacque il Mahabharata
di Peter Brook, racconta i nervi oscuri del potere, quelli che si diramano fin dentro
ognuno di noi, con un montaggio di immagini danzanti, di voci e suoni che vogliono
colpire fantasia ed emozione, ancora i tedeschi analizzano fatti e fenomeni del mondo che
ci circonda creando opere montate in modo collettivo, basate su lunghi processi di
improvvisazione, di una lucidità pungente.
Sono spettacoli che tornano a far innamorare del teatro, delle sue possibilità di
conoscenza, della sua capacità di strappare i veli della visione normalizzata, omologata.
Questo è il miglior teatro politico: quello urlato allo spasimo di René Pollesch, sospeso
fra immagine riprodotta, dichiarazioni dirette e irruzione dei corpi negati nella finzione
dell’opera e nella realtà del neoliberismo, e quello danzato come un’opera dada che mette
in mutande le menzogne del potere di Christoph Marthaler. Entrambi provano ad
affrontare il grande argomento rimosso, nascosto, del dominio: il denaro, i suoi flussi, gli
spostamenti, i rivolgimenti, i fallimenti e le devastazioni umane che provoca. Le banche e
la finanza come nuovo, lontano, “misterioso” destino. Guardano dentro, sotto la realtà,
incidendo e incrinando i simulacri, trascinando nell’isteria o nella deformazione di un riso
feroce, senza compiacenze o complicità.
Pablo in der Plusfiliale (Pablo all’ipermercato) di René Pollesch, direttore del Prater, un
teatro-studio della Volksbühne, nasconde gli attori alla vista e li rivela solo attraverso
frenetiche riprese video. Chiusi in due carrozzoni danno vita a un surreale reality show di
lavoratori in affitto rinchiusi in un iperdiscount Lidl. Precari, stranieri, indigeni, donne,
uomini, omosessuali, vecchi, giovani, completi di data di scadenza segnata da un
computer sulla loro immagine, tutti si agitano per denunciare, per sfuggire da una
condizione che li inchioda a vendersi, a vendere i corpi, all’oppressione dell’uomo sulla
donna, merci della “nuova economia” che avvelena ogni relazione sociale, senza scampo.
La rabbia, che proclama l’atto terroristico come liberatorio, l’isteria di corpi compressi,
l’ironica o avvilita rassegnazione irrompono sul palco con incursioni di attori di
formidabile presenza, per poi tornare immagine, finzione più vera del vero, avviluppante,
acida superficie, prestazione totale, proclama di liberazione che gira a vuoto in uno
schermo mentre all’interprete vivo non resta che ripetere le parole di un allucinatorio,
consolante karaoke. Questo spettacolo chiude una trilogia che fonde la telenovela e la
denuncia politica, le tecniche di ripresa della televisione verità con l’urgenza di
liberazione di corpi e anime dannate dai meccanismi dell’accumulazione.
Groundings di Christoph Marthaler è un atterraggio forzato, un varietà corrosivo, una
denuncia politica schiumante allegra ferocia. Un intrattenitore pianista che sembra
Groucho Marx: nell’entrare, subito cade. Alcuni uomini in grisaglia con grandi valigie, in
una sala d’aspetto lievemente demodé e ansiogena concepita da Anna Viebrock. Una
insinuante hostess che si trasformerà in sadica guida di una liquidazione fallimentare e in
finale guru di un’evasione mistica. Sotto i piedi la piantina di Zurigo: bisogna alzarsi i
calzoni quando si finisce nel canale o nel lago; alle spalle la fine della compagnia aerea di
bandiera dopo la crisi seguita all’11 settembre e la brutale chiusura dell’esperienza
artistica di Marthaler nel teatro stabile di Zurigo.
Un gruppo di funzionari, come in Stunde Null o in Spezialisten, è bloccato a terra da un
ritardo. Di trentacinque secondi, annuncia il pianista, poi di dieci ore, di dieci anni… Il
ritardo è il fallimento della Swissair, emblema di puntualità, un coltello nel cuore del
paese della precisione. Uno sgretolamento della fiducia bancaria, un tentativo di
salvataggio, o riciclaggio, rappresentato con balletti e canzoncine interpretate da clown
sbilenchi in abiti da funzionari, con riunioni precarie su quelle valigie, con confessioni su
poltrone che schizzano via sfondando i muri della scena, mentre gli altri salutano
compunti cantando un vecchio coretto della vecchia Svizzera profonda. Si parla di
“nuova economia” con un’ironia che scarnifica: i personaggi sono costruiti dai
fenomenali attori di Marthaler con le caratteristiche dei componenti del consiglio di
amministrazione dello Schauspielhaus di Zurigo, il teatro che lo ha licenziato con
l’accusa di spese eccessive e, soprattutto, di un programma troppo “avanzato”, che non
attirava il pubblico tradizionale.
Un attore invita il pubblico ad alzarsi, a pregare, perché la borsa risalga, perché i teatri si
riempiano... L’etica è il “come” del profitto. La soluzione è decentrare, la produzione, i
teatri, con gli aerei, gli attori, tutti in affitto. La globalizzazione diventa surreale lezione,
defenestrazioni continue, sbracata vigilia notturna con petting violenti e possessivi. Si
trasforma in respirazione d’emergenza ai manichini contenuti nelle valige, rivestiti con
gli abiti degli uomini rottamati, pronti a possederli, a farsi possedere, in un carnevale
macabro, irresistibile, dell’uomo-oggetto. E si chiude sulle note di Mr. Tamburine man
con una fuga in un altro mondo, molto new age, con il ritorno dei funzionari ai sogni
cullanti di quando erano giovani ribelli, un vero e proprio anticlimax sconsolato e
grottesco. Si esce storditi, pensando a chi mai, in Italia, fra i grandi registi, avrebbe il
coraggio di trattare con tanto divertente veleno la crisi della Fiat e della Parmalat. O
almeno quella dell’Alitalia.
MASSIMO MARINO
Rimini Protokoll: dentro la cornice del reale8
Per i Rimini Protokoll il teatro mantiene qualcosa dell’irriducibile forza dei fatti, delle
azioni vere. Se ormai viviamo in un’immensa Disneyland, e anzi proprio i parchi di
divertimento sono costruiti per illudere che altrove si conservi qualche traccia di realtà,
forse qualche nocciolo di esperienza si può ritrovare attraverso le schermaglie di una
finzione teatrale che lascia trasparire dense scorie di cose e di persone. Sono guerriglieri
urbani e teatrali i Rimini Protokoll: provano a ricercare le tante lingue, i tanti volti del
mondo che ci circonda. Li mettono in scena, incorniciano vite vere nella finzione di un
palcoscenico che si dilata fino a trasferirsi in scenari metropolitani, in aule di tribunale, in
sale di museo.
Tre artisti tedeschi costituiscono questo gruppo, Helgard Haug, Stefan Kaegi, Daniel
Wetzel. Si sono formati presso l’Istituto di Scienze Teatrali Applicate di Giessen.
Operano da soli, in duo o in trio in particolarissime, anomale creazioni che trasferiscono
in forme teatrali aspetti della vita contemporanea, spesso usando come attori gli stessi
individui che hanno agito o subito certi fatti, a volte molto quotidiani.
8
Da «Art’o – rivista di cultura e politica delle arti sceniche», n. 18, autunno 2005.
In Italia sono arrivati solo di recente, sulla scia di una presenza costante alle ultime
edizioni del Kunsten Festival des Arts di Bruxelles, una manifestazione che scopre artisti
e li cura, fornendo loro le occasioni per realizzare ulteriori progetti e sogni. Due anni fa i
Rimini Protokoll organizzavano ogni sera The Midnight Special Agency, un breve evento
di circa un quarto d’ora nel centro di ritrovo del festival, a mezzanotte in punto.
Lavoravano tutto il giorno, un po’ da giornalisti, un po’ da artisti, per scovare casi da
esibire in quel siparietto come “ready-made” in carne, ossa, desideri e perplessità.
Cercavano, nella città e nei suoi sobborghi, persone che potessero rendere l’idea
dell’umanità vera che conduceva la sua normale esistenza intorno a quel grande evento
rappresentativo dedicato alle arti della contemporaneità. E al rintocco dell’ora fissata, tra
fumi e musiche tipo telegiornale, presentavano venditori di pappagalli, collezionisti di
aeromodelli, astrologhi, insegnanti di corretta pronuncia, giocatori di scacchi, pulitori di
vetri di grattacieli, interpreti simultanei lievemente sciroccati da cortocircuiti linguistici,
fabbricanti di fuochi pirotecnici e altri rappresentanti di una vita varia come il cangiante
paesaggio e le molte parlate di una grande città. Queste persone, trasformate
consapevolmente in “personaggi”, secondo le più assodate regole della società dello
spettacolo, si raccontavano, diventando per virtù di quella esibizione che li ritagliava
dall’anonimato casi emblematici delle diversità, delle tensioni, dei conflitti della
metropoli.
C’era nella scelta qualcosa, sempre, di estremo, di provocatorio: parlare di modellini di
aerei collezionati per anni in una casa nei pressi di un aeroporto in crisi, con la compagnia
di bandiera sbaraccata per un fallimento causato dalla globalizzazione e dal ricorso al
decentramento produttivo, era mostrare l’aspetto intimo di una tragedia nazionale. Così il
mago astrologo diceva di non essere mai interpellato per risolvere problemi politici, ma
solo questioni di cuore, dolori e illusioni di esistenze ai margini; il venditore di uccelli
della bottega di fronte alla sede del festival parlava di come i suoi pappagalli imitano i
clienti, moltiplicando i giochi di specchi della riproduzione teatrale; il prete raccontava di
come cercava di parlare della realtà e di cambiarla; il pirotecnico dimostrava come i suoi
festosi apparati simulavano, in realtà, la guerra.
I casi diventavano metafore, piccole o grandi metafore di un quotidiano di solitudine, di
chiusura, di alienazioni vissute spesso inconsapevolmente, nella ripetizione di atti coatti,
di giochi disincantati o di manie (apparentemente) innocenti, di sottili malattie.
Da questi esprimenti è nato lo spettacolo visto al Teatro Festival di Parma 2005,
Sabenation. Go home and follow the news, andate a casa e sentite il telegiornale, per
scoprire di essere stati licenziati, perché non è vero che «Con Sabena siete in buone
mani», perché un bel giorno il colosso aeronautico belga, orgoglio di un impero piccolo
ma crudele e supponente, in un disfacimento che ha lasciato il posto agli appetiti voraci
delle multinazionali, ha dichiarato finiti i sogni di grandeur e ha annunciato la chiusura,
mandando a casa senza complimenti tutti i dipendenti, precedentemente opportunamente
fidelizzati.
Raccontata così, sarebbe una pièce di teatro politico. Invece nel lavoro di Rimini
Protokoll c’è qualcosa d’altro, di più. Gli attori sono vecchi dipendenti della compagnia
di bandiera belga, persone che hanno vissuto i fatti sulla propria pelle: l’ironia, pur
presente, lascia il posto alla testimonianza senza lamento né compiacimento, al dolore di
una crisi che ha messo sul lastrico persone reali, quelle che vediamo di fronte a noi
spettatori come rappresentanti di tanti altri.
Ognuno racconta la propria storia, di come è arrivato a quel lavoro, magari da diverse
parti del mondo, di come ha creduto all’orgoglio d’azienda, di come si è lascito sedurre
per poi esser buttato via come un ferro vecchio. Scorrono dati e filmati, palline da ping
pong vengono sparate con ritmo continuo o piovono come grandine sulla scena. Le
informazioni si incrociano con i desideri, le rabbie, le illusioni degli interpreti, che
ripercorrono la formazione, il loro investimento umano e professionale e quello
economico della ditta, gli hobby, le piccole occupazioni o fissazioni di ogni giorno,
finendo nel vuoto di disoccupazioni che devono trovare altre strade per permettere di
sopravvivere. Allora si parla di prepensionamenti, di impiegati finiti a impacchettare
antidepressivi alla catena di montaggio o a fare la controfigura del re o di altri personaggi
famosi. È il nuovo mercato della precarietà continua, delle ore bruciate nell’ansia di
un’attesa. È la sospensione, il vuoto dell’esistenza, uno schianto che ha l’aspetto di un
lento smottamento, di un inesorabile sprofondare.
Si racconta, con trattenuta partecipazione e intelligenza, il crollo di un mondo che
appariva certo e che le leggi del capitale hanno sconquassato, una rottamazione umana
che colpisce di più in quanto sembra una confessione, sempre trattenuta, dei protagonisti
veri della tragedia, con quella loro aria comune, un po’ sciatta, un po’ sostenuta per
ultimo guizzo di dignità, un po’ perdutamente sbandata.
Rimini Protokoll lavora sui bordi poco esaltanti della vita quotidiana e della politica che
travolge le persone, sul desiderio di evasione e sulla costrizione, sul senso comune, sulla
sua necessità e sulle sue perfide trappole. Un’altra performance di questo gruppo porta in
scena adolescenti con armi da fuoco; un’altra ancora medici e paramedici che parlano del
loro rapporto con la morte. Siamo in un insidioso reality show, vasto come la nostra
realtà, dove il vuoto si rappresenta in tentativi di mettere qualche puntello narcisistico a
un io sempre più esploso e devastato. Il parlare a vanvera, l’inconsistenza, il disperato
tentativo di autorappresentarsi vengono lievemente spostati con qualche artificio teatrale
o massmediologico appena appena sottolineato: grazie alla coscienza di recitare per un
pubblico teatrale diventano più lancinanti. Forse così si può cercare una strada per uscire
dal labirinto della rappresentazione come falsa coscienza, come invenzione di una realtà
consolatoria e totalmente irreale.
Un’altra esperienza dei Rimini Protokoll consiste in un giro per Berlino guidato
attraverso un telefono cellulare. Basta collegarsi con un numero e lasciarsi portare, in
quello strano spaesamento che ognuno di noi può provare quando attraversa una strada o
cammina per la città con il suo portatile attaccato all’orecchio, parlando con qualcuno
lontano. Qui, in Call Cutta, chi guida il viandante è veramente distante, dall’altra parte
del mondo: da un call center presso il Goethe Institut di Calcutta, India, conduce in un
viaggio di un’ora negli angoli segreti di una città tedesca.
Il mondo è un unico scenario per replicanti, sembrerebbe. Replicanti sospesi tra mass
media e presenza come tutti noi; esseri mutanti che cercano di scalfire simulacri sempre
più avvolgenti perché prendono le fattezze di verità, di mondo tangibile, mentre
rimangono illusioni, inganni che rendono quei replicanti – noi – semplici merci, puro,
astratto valore di scambio.