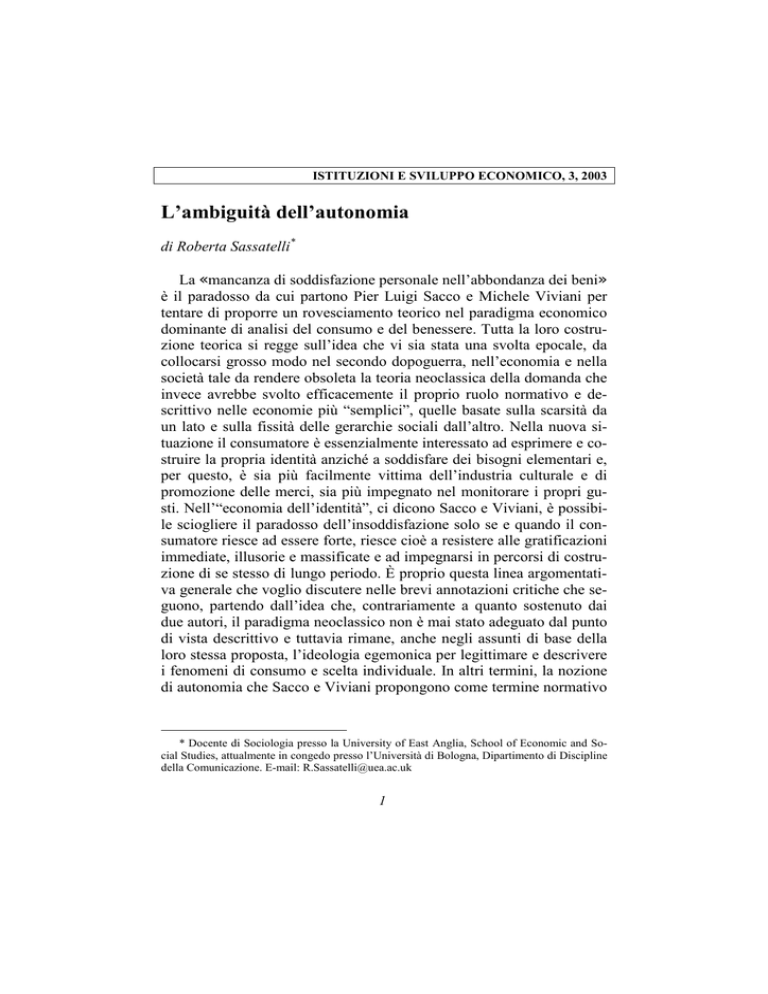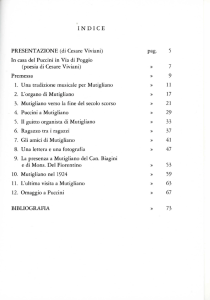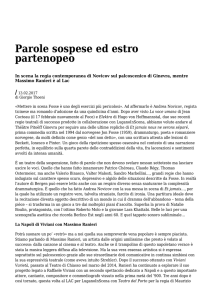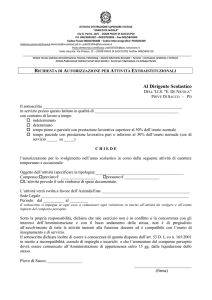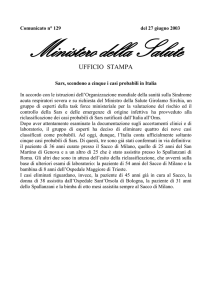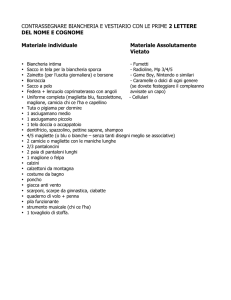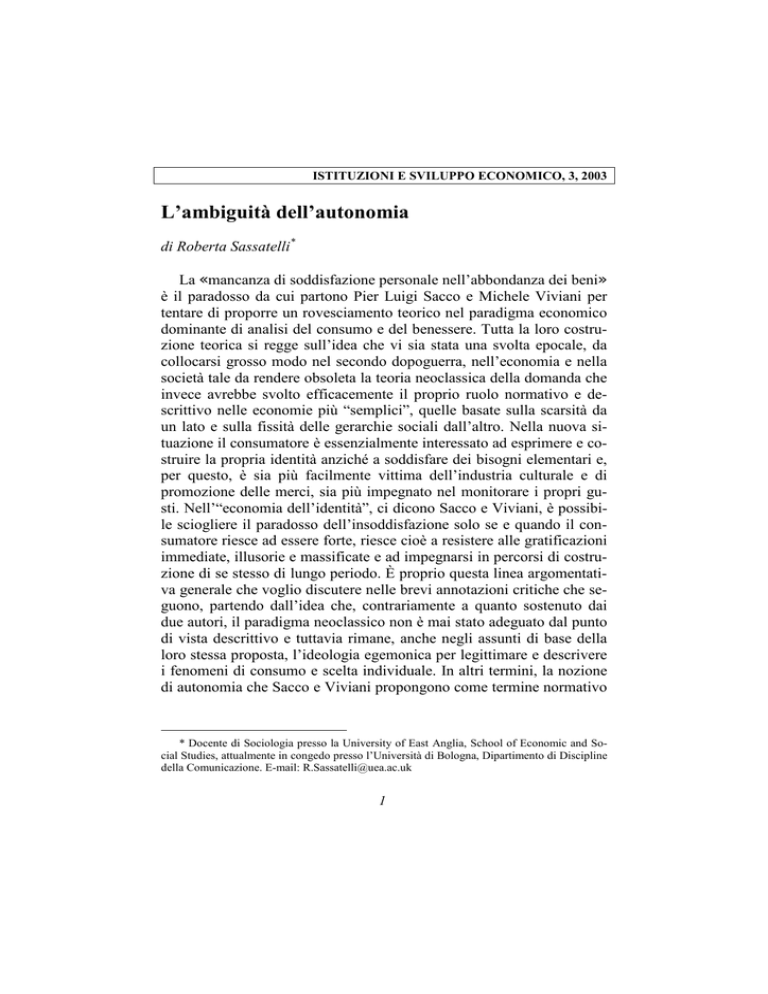
ISTITUZIONI E SVILUPPO ECONOMICO, 3, 2003
L’ambiguità dell’autonomia
di Roberta Sassatelli*
La «mancanza di soddisfazione personale nell’abbondanza dei beni»
è il paradosso da cui partono Pier Luigi Sacco e Michele Viviani per
tentare di proporre un rovesciamento teorico nel paradigma economico
dominante di analisi del consumo e del benessere. Tutta la loro costruzione teorica si regge sull’idea che vi sia stata una svolta epocale, da
collocarsi grosso modo nel secondo dopoguerra, nell’economia e nella
società tale da rendere obsoleta la teoria neoclassica della domanda che
invece avrebbe svolto efficacemente il proprio ruolo normativo e descrittivo nelle economie più “semplici”, quelle basate sulla scarsità da
un lato e sulla fissità delle gerarchie sociali dall’altro. Nella nuova situazione il consumatore è essenzialmente interessato ad esprimere e costruire la propria identità anziché a soddisfare dei bisogni elementari e,
per questo, è sia più facilmente vittima dell’industria culturale e di
promozione delle merci, sia più impegnato nel monitorare i propri gusti. Nell’“economia dell’identità”, ci dicono Sacco e Viviani, è possibile sciogliere il paradosso dell’insoddisfazione solo se e quando il consumatore riesce ad essere forte, riesce cioè a resistere alle gratificazioni
immediate, illusorie e massificate e ad impegnarsi in percorsi di costruzione di se stesso di lungo periodo. È proprio questa linea argomentativa generale che voglio discutere nelle brevi annotazioni critiche che seguono, partendo dall’idea che, contrariamente a quanto sostenuto dai
due autori, il paradigma neoclassico non è mai stato adeguato dal punto
di vista descrittivo e tuttavia rimane, anche negli assunti di base della
loro stessa proposta, l’ideologia egemonica per legittimare e descrivere
i fenomeni di consumo e scelta individuale. In altri termini, la nozione
di autonomia che Sacco e Viviani propongono come termine normativo
* Docente di Sociologia presso la University of East Anglia, School of Economic and Social Studies, attualmente in congedo presso l’Università di Bologna, Dipartimento di Discipline
della Comunicazione. E-mail: [email protected]
1
di valutazione del consumo non risulta abbastanza distante dal modello
di azione e di attore sociale implicito nella teoria neoclassica.
Pur passando per Sen, Inglehart e Ainslie, le osservazioni di Sacco e
Viviani sembrano ricalcare le note affermazioni di Kenneth Galbraith
(1958) secondo cui, con lo sviluppo delle grandi società commerciali, il
mercato si trasformerebbe da meccanismo consumer-driven a sfera di
manifestazione della capacità dei produttori di assimilare alle proprie
esigenze la reattività dei consumatori mediante opportune azioni commerciali. La pubblicità e il marketing sarebbero cioè estremamente efficaci nei loro sforzi di persuasione, e questo anche perché i consumatori
sono ormai così lontani dal bisogno materiale che non sanno più ciò che
vogliono. Simili posizioni ci ricordano che le varie istituzioni della promozione svolgono oggi una cruciale funzione di collegamento tra produzione e consumo e si connotano come un sistema altamente specializzato, con le sue norme e i suoi principi di funzionamento, prevalentemente dedito all’elaborazione simbolica e alla diffusione di immagini
che sappiano “conquistare” il maggior numero di consumatori. Tuttavia, il potere si esprime nelle relazioni di consumo in forme più strategiche e diffuse di quanto non lasci credere il paradigma della manipolazione che implicitamente sottende le ultime pagine del testo di Sacco e
Viviani. Questo anche perché il rapporto tra produzione e consumo
tramite il sistema promozionale va considerato come essenzialmente
interattivo (Leiss, Kline e Jhally 1991, Schudson, 1984). Ciò è bene illustrato, tra gli altri, da un noto studio di Dick Hedbige (1988) sulla diffusione della Vespa in Inghilterra. Hebdige mostra che tale diffusione seguì percorsi non immaginati e non controllabili dai pubblicitari che avevano il compito di promuoverla. Pubblicizzata come un veicolo femminile, comodo ed elegante, la Vespa divenne un oggetto di culto tra la sottocultura giovanile Mod, che raccoglieva giovani uomini i quali, anche attraverso la Vespa, poterono opporre la propria maschilità raffinata ed esteticizzante a quella più tradizionale dei motociclisti rockettari. Lo studio
di Hedbige dimostra non solo che le industrie devono leggere il mercato
per differenziare gli oggetti in base a divisioni sociali già esistenti, ma anche che la trasformazione di questi oggetti e dei loro significati nelle pratiche di consumo nei diversi mercati nazionali o locali può dare impulso
alla creazione di nuovi gruppi sociali che creano se stessi mediante gli usi,
a volte originali, di certi oggetti. In quest’ottica, il consumo è una pratica
di riassorbimento della cultura che si realizza secondo una varietà di
2
logiche non pienamente svincolate ma neppure direttamente riportabili
a quelle che hanno governato la produzione e la distribuzione delle
merci; anziché promuovere omogeneizzazione, le pratiche di consumo
generano diversità, perché beni che sono identici al momento
dell’acquisto possono essere ricontestualizzati da diversi gruppi sociali
in un’infinita varietà di modi.
Più problematico è tuttavia il fatto che Sacco e Viviani facciano propria un’impostazione dualistica che contrappone ontologicamente natura e cultura, società tradizionali e società moderna, riproducendo così
una fallacia che proprio quella tradizione antropologica e sociologica
cui sembrano fare ricorso ha smascherato. Quando scrivono che «la
creazione del gusto, come l’interiorizzazione delle norme, non sono elementi critici del comportamento economico in una società in cui i gusti sono fissi ed associati direttamente alla classe sociale in quanto
l’identità è univocamente formata e non elaborabile individualmente»,
o che «la felicità estraibile dalle merci non dipende più dalla loro capacità di soddisfare un bisogno specifico tramite i loro caratteri merceologici, ma di contribuire alla costruzione dell’identità individuale», essi
postulano una cesura che non ha alcun riscontro nella letteratura antropologica, storica e sociologica. Così facendo essi non escludono che
possa esistere un consumatore capace di percepire autonomamente i
propri bisogni e di rispondervi razionalmente, ma relegano tale figura
in un passato quasi mitico fatto di semplicità e “bisogni”. In questo
modo si adombra l’esistenza di un consumo naturale, guidato dal valore
d’uso delle cose, da opporre ad una situazione in cui una “artificiale”
attribuzione di valore simbolico diviene operazione inevitabilmente
manipolante. Si corre così il rischio di sostenere che possiamo evitare
di essere schiavi delle merci solo se restiamo schiavi della natura o di
gerarchie sociali rigide, che possiamo essere davvero noi stessi finché i
nostri desideri rimangono semplici e riferibili a necessità che precedono
la nostra volontà e la nostra capacità di attribuire significati simbolici al
mondo. Tale impostazione trascura, come prodotto della manipolazione
o espressione dell’irrazionalità, tutta la dimensione storica e culturale di
concetti quali “bisogno” o “scarsità” messa in evidenza dagli studi antropologici proprio sulle società più semplici (Sahlins, 1974), e che lo
stesso Sen (1984), nei suoi lavori sulle carestie, ha mostrato avere radici politico-sociali. Anche per bisogni che ci appaiono fondamentali,
3
come ripararsi dal freddo, mangiare o bere non possiamo tornare indietro ad un supposto “stato di natura”: persino nelle società preistoriche
ciò che conta non è la pura sopravvivenza ma come ci si ripara, cosa si
mangia e con chi si beve. Più in generale, l’antropologia del consumo, a
partire quanto meno dai celebri studi di Claude Levi-Strauss (1964),
Marshall Shalins (1974), Mary Douglas e Baron Isherwood (1979), ha
mostrato chiaramente che anche nelle società tribali i beni sono parte di
un sistema essenzialmente simbolico e servono per sottolineare le identità (sebbene si tratti di identità con caratteristiche diverse da quelle
moderne). In altri termini, il consumo non «si è trasformato in una attività culturale», come sostengono Sacco e Viviani, lo è sempre stato. In
altri termini, una struttura esogena delle preferenze non è coerente con la
condizione di deprivazione in cui si troverebbero i membri delle società
tribali o tradizionali per il semplice fatto che il gusto è un fenomeno radicalmente sociale (Bourdieu, 1979).
Va indubbiamente apprezzata un’impostazione economica che recepisce alcune delle nozioni su cui da tempo insistono sociologia e antropologia e, su tutte, l’idea che le gratificazioni siano apprese – pensiamo
ai classici studi del noto sociologo Howard Becker (1963) sui fumatori
di Marijuana – mediante processi di interazione che sono “faticosi” e,
in un linguaggio più economico, costano. Le preferenze però possono
venir modellate come variabili endogene anche mantenendo un modello antropologico guidato dalla razionalità strumentale, come ha fatto tra
gli altri l’economista Gary Becker (1996) nel suo recente tentativo di
rendere le dinamiche del gusto in chiave neo-classica. In questo contesto, Sacco e Viviani perdono l’occasione di affrontare direttamente e
tentare di superare il presupposto neo-classico della razionalità strumentale. Ciò d’altra parte richiederebbe una problematizzazione di
quella nozione di autonomia individuale che essi pongono invece come
base normativa della propria proposta teorica. I due autori sembrano
sostituire l’orientamento strumentale allo scopo con una logica del dovere: “sono contento perché ho fatto il mio dovere rispetto a me stesso”
è il motto che ci permetterebbe di “valutare” il consumo. L’autonomia
individuale, intesa essenzialmente come fedeltà ad un progetto di sé e
di consumo, è opposta alla gratificazione immediata intesa come eteronomia, ovvero incapacità di resistere alle facili seduzioni di un mercato
massificato. In realtà, in questa impostazione, la logica strumentale è
4
ancora viva e viene reintrodotta nel modello mediante una implicita riproposizione di diversi ordini di desideri: quelli immediati (falsi) e
quelli di lungo periodo (autentici), quelli per i beni di massa (banali) e
quelli per i beni colti (autentici). Consumando correttamente il soggetto
massimizza la propria identità e trae gratificazione da tale massimizzazione che si esprime essenzialmente in una forma di autocontrollo e sacrificio.
Sacco e Viviani sembrano trascurare l’ambiguità e l’ambivalenza
della nozione di autonomia che hanno scelto di sposare. I moderni –
anche nelle loro letture delle opere classiche – sono indubbiamente affascinati dall’idea di spogliare il soggetto di ogni bene o tecnologia per
arrivare all’essenza dell’essere umano: ecco quindi la costante attualità
della figura del naufrago articolata, a partire innanzi tutto dal celebre
Robison Crusoe di Defoe in avanti, come una lotta per liberarci dalle
nostre abitudini di consumo (Cruise, 1999). Come hanno mostrato, tra
gli altri, Richard Sennett (1976) e Charles Taylor (1979), lo sviluppo
della società capitalistica ha consolidato e reso popolare una nozione di
soggetto assai particolare: si tratta di un attore non solo autonomo e
compiuto in se stesso, ma anche in crescente distanza dalle cose. Le cose sono cioè sempre più viste come radicalmente altre dalle persone,
dagli esseri umani, e a questa crescente distinzione tra la natura o la sostanza delle persone da una parte e degli oggetti dall’altra si accompagna l’idea che gli oggetti possano inficiare l’umanità delle persone piuttosto che farla crescere e completarla. Vi è una fondamentale contraddizione nel modo di concepire l’identità moderna: un paradosso che
tocca soprattutto il rapporto del soggetto con le cose e chiede al soggetto di articolare idealismo e materialismo, segnando la propria identità
come differenza dalle merci servendosi di loro. Atteggiamenti materialisti e acquisitivi nei confronti delle cose permettono di sostenere, paradossalmente, una visione idealistica del soggetto: in effetti, a differenza
di molte culture tribali dove le persone diventato gli oggetti attraverso
cui vengono fissati i valori di una cultura, nella nostra cultura è alle cose e non alle persone che è stato deputato il fondamentale ruolo di oggettificare le categorie culturali, di fissarne tangibilmente significati e
valori (Appadurai, a cura di 1988; Miller 1987). Le osservazioni sul
post-materialismo della contemporaneità scambiano quindi la maggiore
visibilità del carattere simbolico dei beni – certo legata alla minore stabilità sociale e culturale e all’individualizzazione – con un superamento
5
di quel materialismo che è invece uno dei due poli espressivi
dell’identità che è via via divenuta egemonica con il progredire della
modernità.
La configurazione dell’identità moderna è non solo paradossale, ma
ha anche degli effetti paradossali proprio nella sfera del consumo. Si
tratta di paradossi che non possono essere facilmente risolti facendo riferimento a quella cornice normativa che è, almeno in parte, generativa
dei paradossi stessi. Questo è invece ciò che propongono di fare Sacco
e Viviani, dimenticando che i gusti individuali si costruiscono non solo
nelle pratiche di consumo, ma anche in relazione a visioni normative
del sé che sottolineano forme addomesticate di edonismo. Anche nella
vita di tutti i giorni una gran quantità di energia viene spesa per scongiurare il dubbio che i soggetti non siano più in grado di governare il
mondo delle cose, che siano piuttosto schiavi degli oggetti e dei loro
ritmi. Nelle moderne culture liberali, siamo abituati a considerare che il
consumatore possa e debba scegliere ma debba anche e soprattutto essere
autonomo, e cioè padrone della sua scelta. Il consumatore è sovrano del
mercato solo se è sovrano di se stesso, solo se è padrone della propria volontà (Sassatelli, 2000, 2001). La sovranità del consumatore è quindi una
sovranità a doppio taglio: la ricerca del piacere deve infatti essere temperata da varie forme di distacco che sottolineano la capacità dell’attore di
guidare tale ricerca, di dosare i piaceri, di non divenirne schiavo, di essere, in una parola, riconoscibile come uno che può e sa scegliere autonomamente. Proprio perché il consumo si deve configurare come un luogo
di espressione della libera volontà individuale, cresce la preoccupazione –
l’ansia direbbero Ulrich Beck (1992) e Anthony Giddens (1990) – circa
l’effettiva capacità dei consumatori di esercitare sempre e comunque la
propria libera volontà. Per quanto siano diverse tra loro, le pratiche di
consumo che sono viste come “normali” hanno in comune il fatto di apparire allo stesso tempo come la realizzazione e il contenimento dei desideri: sono presentate e regolate come campi morali che rispondono a soggetti autonomi. Le pratiche “devianti” dal canto loro sono presentate ed
appaiono come potenzialmente o effettivamente capaci di traviare e dominare il soggetto. Non bisogna quindi preoccuparsi solo della capacità
– dei media e della pubblicità – di indurre i consumatori a consumare
determinati beni – responsivi ai supposti interessi produttivi – ma anche
e soprattutto considerare come i modi di consumare vincolino il soggetto ad una ricerca di autonomia spesso frustrante, soprattutto per quegli
6
attori sociali (donne, bambini, minoranze etniche, poveri) le cui scelte
risultano meno legittime. Quelli che vengono riconosciuti come i mali
del consumo moderno sono in effetti tutte forme di eccesso e di eteronomia – dal consumo compulsivo al binge eating – a loro volta prodotti dalla forte richiesta di disciplinamento di sé che la costruzione di percorsi identitari personali e gratificanti mediante le merci domandano. Per ovviare a questo è forse importante non dimenticarsi del ruolo svolto dalla libertà negativa nella costruzione sociale e identitaria propria delle nostre
culture: la possibilità di rifiutare percorsi di scelta, prodotti, visioni normative del piacere e del sé, la possibilità stessa di rifiutare di dimostrare
identità totalizzanti o persino coerenti è un’arma potente di liberazione
dalle costrizioni che la libertà positiva, come capacità di disciplinare se
stessi per raggiungere un obiettivo coerente e di lungo periodo, può finire
per produrre.
Ciò è tanto più vero quanto più si introducono elementi normativi di
valutazione delle selezioni compiute dai soggetti per la costruzione di
traguardi di lungo periodo. Sacco e Viviani sostengono che è “facile”
sostenere che i mercati contemporanei incentivano una “strategia di
consumo basata sulla gratificazione immediata” che si esplica
nell’acquisto di “sotto-prodotti culturali” come le Soap Operas o di
prodotti dal “contenuto simbolico semplice” come le autovetture. Eppure anche le Soap vengono consumate in modo tutt’altro che irriflessivo
e arrivano a fornire lo spunto per l’acquisizione di competenze critiche
(Ang, 1985); nella vita quotidiana poi le autovetture richiedono capacità e offrono opportunità (di movimento, manutenzione, “fai da te”,
ecc.) assai più complesse e articolate di quanto non indichi un facile riferimento alla competizione per lo status (Dant e Martin, 2001). In effetti, Sacco e Viviani accettano come non problematica la distinzione
tra cultura alta e cultura bassa che è da tempo fortemente criticata nella
ricerca sociologica (Crane, 1992, Gans, 1999). Forse anche per questo
l’apprezzabile tentativo di Sacco e Viviani di tenere conto delle differenze qualitative tra i beni, ancorché diverso dall’impostazione di autori
come Lancaster (1991), è poco ricettivo rispetto ai più recenti sviluppi
della teoria sociologica. Tra questi ricordiamo soprattutto il lavoro di
Daniel Miller (1997) che ha chiaramente messo in luce che oggetto e
soggetto si costituiscono insieme, che il consumo è un atto creativo che,
per così dire, “finisce” le merci e le porta a compimento come cultura.
Non ha quindi senso parlare di automobili, vestiti o strumenti musicali
7
in quanto tali, ma degli usi a cui sono posti, usi che possono fornire
spazi di costruzione di sé e dei significati non pienamente sovrapponibili alle supposte caratteristiche oggettive dei beni stessi.
Questa concettualizzazione consente di considerare il consumo una
pratica di mutua costituzione di oggetto e soggetto. Mettendo di fatto
sullo stesso piano Baudrillard e Bourdieu, usando come se fossero interscambiabili le diverse nozioni di comunicazione e rituale e, in definitiva,
sposando un approccio semiotico-comunicativo che ha ricevuto non poche critiche nella più recente sociologia del consumo, Sacco e Viviani
tendono a perdere l’opportunità di superare in modo netto il modello
strumentale che è proprio degli approcci economici. La sociologia del
consumo odierna sta compiendo il tentativo di sottolineare il carattere
pratico, non solo simbolico ma anche situato e incorporato, del consumo
(Sassatelli, 1995, cfr. soprattutto Bourdieu, 1979, De Certeau, 1984). Più
che un agire strategico e orientato al futuro – e quindi il prodotto di un
attore già pienamente definito e compiuto – l’agire di consumo è un agire pratico: ovvero una serie di atti improvvisazionali portati a termine
da attori che di volta in volta, con maggiori o minori pretese di legittimità, traducono e portano a termine il mondo sociale e la cultura materiale. In quest’ottica, le condizioni di scarsità nella creazione di gusti
complessi di cui si preoccupano Sacco e Viviani non dipendono solo o
principalmente dai beni e dalle loro caratteristiche o strutture “oggettive”, ma dalle modalità di consumo le quali, a loro volta, si innestano
sulle differenti culture e istituzioni del consumo di cui dispongono attori sociali differenti (per genere, etnia, status, educazione, sessualità, età,
professione, ecc.).
Certo gli studi sui consumi contemporanei mostrano che le dinamiche del gusto seguono logiche sempre più complesse, che non sono state pienamente messe a fuoco dall’ottica gerarchica di autori come
Bourdieu e Douglas ma che non sfuggono pienamente alla dinamica
della distinzione e della riproduzione delle differenze sociali. A questo
proposito Sacco e Viviani avrebbero potuto far opportuno riferimento
agli studi sul “consumatore onnivoro”. Si tratta di ricerche empiriche su
consumi diversi come il cibo o la musica, che individuano strategie di
consumo che anziché realizzarsi in un solo genere, stile o gusto, si realizzano nella mescolanza di stili e prodotti diversi, nella varietà, nella
diversità dei generi, del “basso” e dell’“alto” (Peterson, 1992, Peterson
e Kern, 1996, Warde et al., 1999). Lo stile onnivoro dà valore alla va8
rietà in quanto tale, riconducendo la raffinatezza e la sofisticazione culturale all’esperienza della maggior varietà possibile di cose. Questa
strategia fornisce innanzi tutto la possibilità di scegliere tra le diverse
merci sul mercato laddove l’infinitesimale differenziazione delle opzioni rende particolarmente difficile formulare degli stili esteticamente
coerenti. Essa inoltre consente di “tenersi al passo” con il numero più
ampio possibile di gruppi sociali, accrescendo così le proprie chances
di essere riconosciuti come persone esteticamente competenti e di buon
gusto. Ora, ciò che è interessante notare nel contesto di una valutazione
del “benessere” del consumatore e della sua “soddisfazione” è che il
consumo onnivoro rifiuta di essere ridotto ad una precisa e univoca identità di consumo, gioca su molteplici identità locali, si avvale di prodotti semplici in modo complesso e di prodotti complessi in modo semplice, di prodotti salva-tempo e di altri che richiedono capacità e sforzi
notevoli. I consumi onnivori mostrano chiaramente l’ambivalenza del
nostro rapporto con il mondo delle cose: se l’apertura alla varietà apre
anche spazi niente affatto scontati di tolleranza e scambio culturale, il
controllo della varietà funziona indubbiamente come una strategia di
formazione del capitale sociale e simbolico che può riprodurre, di nuovo, le differenze sociali.
Riferimenti Bibliografici
Ang I. (1985), Watching Dallas: Soap Opera and the Melodramatic Imagination, Methuen, London.
Appadurai A. (a cura di) (1986), The Social Life of Things. Commodities in Cultural
Perspectives, Cambridge University Press, Cambridge.
Beck U. (1992), Risk Society, Sage, London, [tr. it.: La società del rischio, Carocci,
Roma, 1998].
Becker G. S. (1996), Accounting for Tastes, Harvard University Press, Cambridge
(Mass.).
Becker H. S. (1963), Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance, The Free Press,
New York.
9
Bourdieu P. (1979), La distinction: critique sociale du jugement, Minuit, Paris, [tr. it.:
La distinzione: critica sociale del gusto, Il Mulino, Bologna, 2000].
Campbell C. (1987), The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism,
Basil Blackwell, Oxford, [tr. it.: L’etica romantica e lo spirito del consumismo
moderno, Lavoro, Roma, 1992].
Crane D. (1992), The Production of Culture, Sage, London, [tr. it.: La produzione culturale, Il Mulino, Bologna, 1997].
Cruise J. (1999), Governing Consumption. Needs and Wants, Suspended Characters
and the “Origins” of the Eighteenth-Century English Novel, Blackwell, Oxford.
Dant, T. e P. J. Martin (2001) “ByCar: Carrying Modern Society”, in Warde A. and
Gronow J. (a cura di), Ordinary Consumption, Routledge, London.
De Certeau M. (1990), L’invention du quotidien, Arts de faire, ditions Gallimard, Paris, [tr. it.: L’invenzione del quotidiano, Edizioni Lavoro, Roma, 2001].
Douglas M. e Isherwood B. (1979), The World of Goods. Towards and Anthropology
of Consumption, Basic Books, New York, [tr. it.: Il mondo delle cose. Oggetti, valori, consumo, Il Mulino, Bologna, 1984].
Featherstone M. (1991), Consumer Culture and Postmodernism, Sage, London, [tr.
it.: Cultura del consumo e postmodernismo, Seam, Roma, 1994].
Galbraith J. K. (1958), The Affluent Society, Andre Deutsch, London, [tr. it.: La società opulenta, Comunità, Milano, 1959].
Gans H. (1999), Popular Culture and High Culture. An Analysis and Evaluation of
Taste, Basic Books, London.
Giddens A. (1990), The Consequences of Modernity, Standford University Press,
Standford, [tr. it.: Le conseguenze della modernità, Il Mulino, Bologna 1992].
Hebdige D. (1988), Hiding in the light: On images and things, Comedia, London, [tr.
it.: La lambretta e il videoclip, Edt, Torino, 1991].
Lancaster K. (1991), Modern Consumer Theory, Edward Elgar, Aldershot.
Leiss W., Kline S. and Jhally S. (1991), Social Communication in Advertising : Persons, Products and Images of Well-Being, MacMillan, NewYork.
Levi Strass C. (1964), Le cru e le cuit, Libraire Plon, Paris, [tr. it.: Il crudo e il cotto,
Il Saggiatore, Milano, 1998].
Miller D. (1987), Material Culture and Mass Consumption, Basil Blackwell, Oxford.
Peterson R. (1992), “Understanding Audience Segmentation: from Elite and Mass to
Omnivore and Univore”, in Poetics, 21, pp. 243-258.
Peterson R. and Kern R. (1996), “Changing Highbrow Taste: from Snob to Omnivore“, American Sociological Review, 61, pp. 900-907.
Sahlins M. (1972), Stone Age Economics, Aldine, Chicago, [tr. it.: Economia dell’età
della pietra, Bompiani, Milano, 1980].
Sassatelli R. (1995), “Processi di consumo e soggettività”, Rassegna Italiana di Sociologia, 36, n. 2, pp. 169-205.
Sassatelli R. (2000), “From Value to Consumption. A Social-Theoretical Perspective
on Simmel’s Philosophie des Geldes”, Acta Sociologica, 43, n. 3, pp. 207-218.
Sassatelli R. (2001), “Tamed Hedonism: Choice, Desires and Deviant Pleasures”, in
Warde A. and Gronow J. (a cura di), Ordinary Consumption, Routledge, London.
10
Schudson M. (1984), Advertising, the Uneasy Persuasion. Its Dubious Impact on
American Society, Basic Books, New York.
Sen A. K. (1985), Commodities and Capabilities, Elsevier, Amsterdam.
Sennett R. (1976), The Fall of Public Man, Cambridge University Press, Cambridge,
[tr. it.: Il declino dell’uomo pubblico, Bompiani, Milano, 1977].
Taylor C. (1989), The Sources of the Self. The Making of Modern Identity, Cambridge
University Press, Cambridge.
Warde A., Martens L. e Wendy O. (1998), “Consumption and the Problem of Variety.
Cultural Omnivorousness, Social Distinciton and Eating Out”, in Sociology, 33, n.
1, pp. 105-127.
11