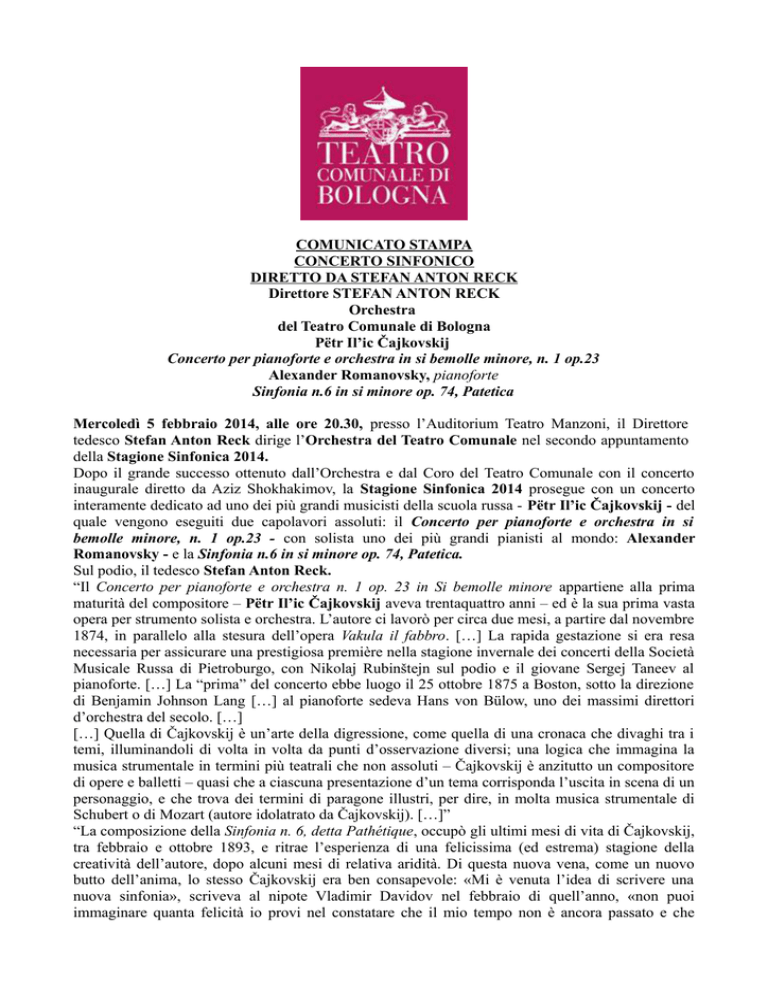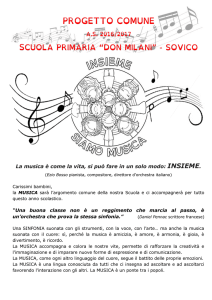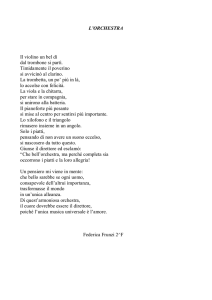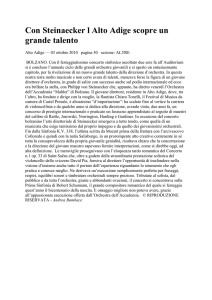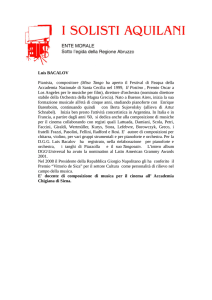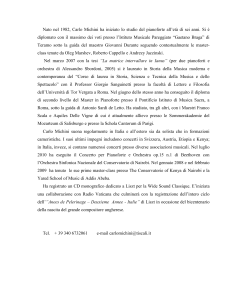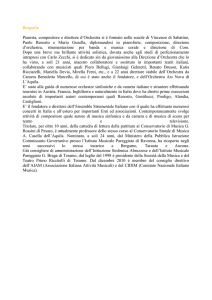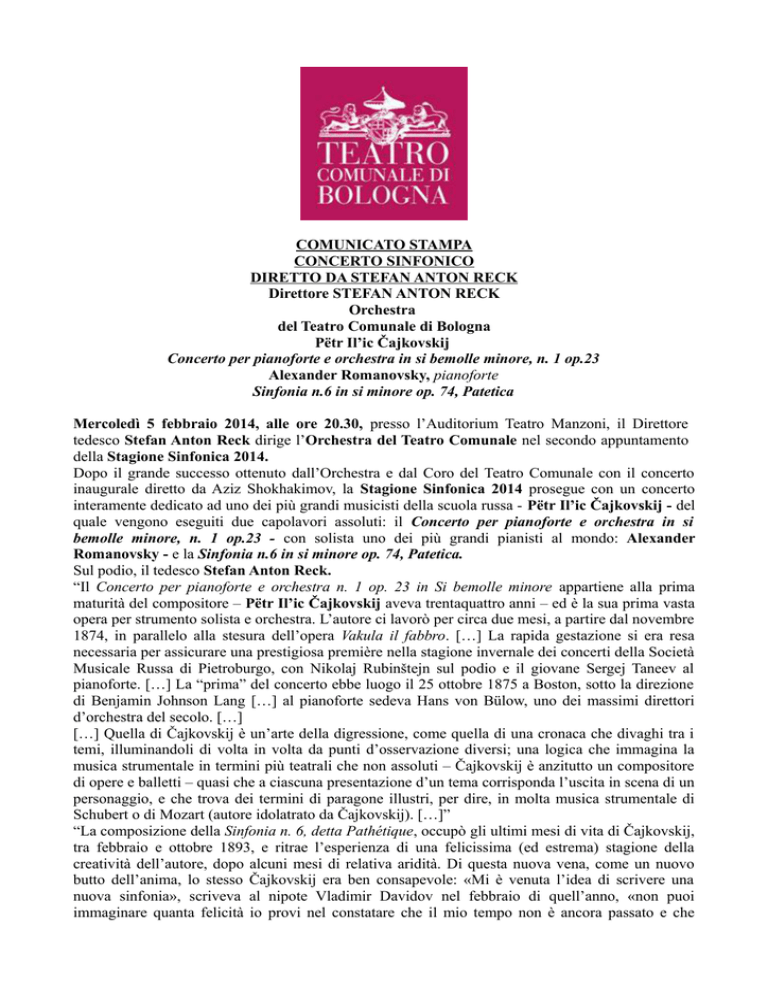
COMUNICATO STAMPA
CONCERTO SINFONICO
DIRETTO DA STEFAN ANTON RECK
Direttore STEFAN ANTON RECK
Orchestra
del Teatro Comunale di Bologna
Pëtr Il’ic Čajkovskij
Concerto per pianoforte e orchestra in si bemolle minore, n. 1 op.23
Alexander Romanovsky, pianoforte
Sinfonia n.6 in si minore op. 74, Patetica
Mercoledì 5 febbraio 2014, alle ore 20.30, presso l’Auditorium Teatro Manzoni, il Direttore
tedesco Stefan Anton Reck dirige l’Orchestra del Teatro Comunale nel secondo appuntamento
della Stagione Sinfonica 2014.
Dopo il grande successo ottenuto dall’Orchestra e dal Coro del Teatro Comunale con il concerto
inaugurale diretto da Aziz Shokhakimov, la Stagione Sinfonica 2014 prosegue con un concerto
interamente dedicato ad uno dei più grandi musicisti della scuola russa - Pëtr Il’ic Čajkovskij - del
quale vengono eseguiti due capolavori assoluti: il Concerto per pianoforte e orchestra in si
bemolle minore, n. 1 op.23 - con solista uno dei più grandi pianisti al mondo: Alexander
Romanovsky - e la Sinfonia n.6 in si minore op. 74, Patetica.
Sul podio, il tedesco Stefan Anton Reck.
“Il Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 op. 23 in Si bemolle minore appartiene alla prima
maturità del compositore – Pëtr Il’ic Čajkovskij aveva trentaquattro anni – ed è la sua prima vasta
opera per strumento solista e orchestra. L’autore ci lavorò per circa due mesi, a partire dal novembre
1874, in parallelo alla stesura dell’opera Vakula il fabbro. […] La rapida gestazione si era resa
necessaria per assicurare una prestigiosa première nella stagione invernale dei concerti della Società
Musicale Russa di Pietroburgo, con Nikolaj Rubinštejn sul podio e il giovane Sergej Taneev al
pianoforte. […] La “prima” del concerto ebbe luogo il 25 ottobre 1875 a Boston, sotto la direzione
di Benjamin Johnson Lang […] al pianoforte sedeva Hans von Bülow, uno dei massimi direttori
d’orchestra del secolo. […]
[…] Quella di Čajkovskij è un’arte della digressione, come quella di una cronaca che divaghi tra i
temi, illuminandoli di volta in volta da punti d’osservazione diversi; una logica che immagina la
musica strumentale in termini più teatrali che non assoluti – Čajkovskij è anzitutto un compositore
di opere e balletti – quasi che a ciascuna presentazione d’un tema corrisponda l’uscita in scena di un
personaggio, e che trova dei termini di paragone illustri, per dire, in molta musica strumentale di
Schubert o di Mozart (autore idolatrato da Čajkovskij). […]”
“La composizione della Sinfonia n. 6, detta Pathétique, occupò gli ultimi mesi di vita di Čajkovskij,
tra febbraio e ottobre 1893, e ritrae l’esperienza di una felicissima (ed estrema) stagione della
creatività dell’autore, dopo alcuni mesi di relativa aridità. Di questa nuova vena, come un nuovo
butto dell’anima, lo stesso Čajkovskij era ben consapevole: «Mi è venuta l’idea di scrivere una
nuova sinfonia», scriveva al nipote Vladimir Davidov nel febbraio di quell’anno, «non puoi
immaginare quanta felicità io provi nel constatare che il mio tempo non è ancora passato e che
riesco ancora a lavorare». Čajkovskij ammetteva perfino: «Il lavoro è proseguito così in fretta e
furia che sono riuscito a completare [l’abbozzo del] primo movimento in meno di quattro giorni, e
gli altri movimenti sono già chiaramente delineati nella mia testa. Il terzo movimento è per metà
pronto. Vi saranno molte innovazioni in questa sinfonia per quanto riguarda la forma – tra l’altro il
finale non sarà un fragoroso Allegro, bensì per la maggior parte un protratto Adagio». Le
innovazioni prefigurate da Čajkovskij, d’altronde, si riferiscono non soltanto alla forma della
composizione, ma investono profondamente lo stile, che qui esibisce diversi tratti di eccentricità e,
al contempo, di sconvolgente modernità. Certo, un movimento lento posto a conclusione della
sinfonia non era un’audacia da poco, sebbene l’idea vantasse qualche illustre precedente (si pensi
all’ultimo movimento della Sesta di Beethoven, la Pastorale); e possiamo ritenere che non fu solo
questa ragione a giustificare la titubante reazione del pubblico alla “prima” dell’opera, avvenuta a
Pietroburgo tra il 18 e il 25 novembre 1893 sotto la direzione dell’autore (tra il pubblico c’era
l’undicenne Igor’ Stravinskij). […] L’orchestrazione čajkovskiana compenetra e vivifica questi
fattori in una sola dimensione sonora, mirando a rimuovere dalla scrittura orchestrale una certa
patina decorativa ed esteriore, se non addirittura sensuale; patina, questa, ancora riconoscibile nella
composizione più nota dell’autore, il balletto Lo schiaccianoci, completato l’anno prima. Questo
rinnovamento costò non poca fatica a Čajkovskij. Terminato velocemente l’abbozzo, passò
all’orchestrazione, come da prassi, ma l’operazione fu completata con una certa lentezza, soltanto
alla fine dell’estate […]”
Dal programma di sala a cura di Michele Chiappini
Stefan Anton Reck è’ stato direttore musicale dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo dal 1990 al
1994, direttore principale dell’Orchestra Regionale del Lazio dal 1994 al 1998, e direttore musicale
del Teatro Massimo di Palermo dal 1999 al 2003. Ha ricevuto una borsa di studio dal Tanglewood
Music Center per gli anni 1987 e 1990, per il suo lavoro con Seiji Ozawa e Leonard Bernstein.
Dal 1997 al 2000 è stato assistente di Claudio Abbado. Numerosi i concerti da lui eseguiti alla guida
della Gustav Mahler Jugendorchester e della Mahler Chamber Orchestra. Stefan Anton Reck è
spesso invitato a dirigere importanti nuove produzioni operistiche in tutto il mondo. Numerose le
collaborazioni con compagini quali l’Orchestre National de France di Parigi, l’Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI di Torino, la Tokyo Symphony Orchestra, l’Orchestra dell’Accademia di Santa
Cecilia a Roma e le Orchestre del Teatro Comunale di Bologna e del Maggio Musicale Fiorentino.
Stefan Anton Reck è riconosciuto a livello internazionale quale profondo conoscitore della musica
di Gustav Mahler e della Seconda scuola di Vienna (Berg, Schönberg, Webern).
Alexander Romanovsky ha vinto il primo premio del Concorso Internazionale “Ferruccio Busoni”
di Bolzano, all’età di diciassette anni. Hanno fatto seguito tre CD sull’etichetta Decca che sono stati
altamente acclamati dalla critica internazionale. Alexander Romanovsky è recentemente apparso da
solista sia con la New York Philharmonic Orchestra diretta da Alan Gilbert sia con la Chicago
Symphony Orchestra diretta da James Conlon, come anche con la Mariinsky Orchestra diretta da
Valerij Gergiev, la Russian National Orchestra diretta da Mikhail Pletnev, la Royal Philharmonic
Orchestra, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Filarmonica della Scala e la
Simon Bolivar Youth Orchestra. E’ stato invitato dai maggiori festival europei, tra i quali La Roque
d’Anthéron in Francia, il Klavier-Festival Ruhr in Germania, il White Nights Festival di San
Pietroburgo, il Chopin Piano Festival a Varsavia ed il Festival di Stresa. Dal 2013 Alexander
Romanovsky è direttore artistico del "Concorso Internazionale Vladimir Krainev" per giovani
pianisti. Tra gli impegni futuri un tour con la NHK Symphony Orchestra e Gianandrea Noseda in
Giappone e con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e Antonio Pappano nonché
recital in numerosi paesi d’Europa. Nato in Ucraina nel 1984, Alexander Romanovsky inizia lo
studio del pianoforte all’età di cinque anni. A tredici si trasferisce in Italia per studiare
all’Accademia Pianistica “Incontri col Maestro” di Imola con Leonid Margarius. Nel 2009 ha
conseguito l’Artist Diploma presso il Royal College of Music di Londra (classe di Dmitry Alexeev).