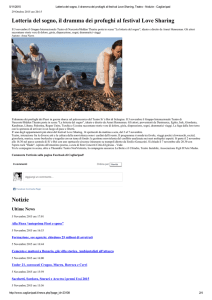Anno 1 Numero 21b - 28.05.2008
Bomba (che cura l’allestimento), Simona Sala (in
scena), Luca Pancetta (immagini luminose) e Silvio
Marino (suoni) ci propone nell’angusto ingresso
della Villetta – l’ex sede Pci che ospita la parte
conviviale di Teatri di Vetro.
Le immagini di una danza da discoteca sfrenata, in
stile «Footloose» (anche la musica è decisamente
anni Ottanta), si alternano con quelle
repentinamente silenziose di una goccia che cade,
forse di sangue, ma di un sangue viola. Il resto è
una narrazione per suoni e immagini, fatta di
simboli e visioni che si avvicendano con la
sapienza di un teatro d’ombre cinese realizzato
con gusto contemporaneo: mani insanguinate, un
corpo senza testa, il rumore dei passi. Frasi
appena percettibili ci riconducono alla dinamica
della storia (“sono sicura d’averlo ucciso”,
“bacerò la tua bocca”) finché due volti si
guardano, in una simmetria da far pensare che
uno si specchi nell’altro. Che forse l’uno è
soltanto il riflesso dell’altro. E che la danza
autistica in cui si chiude il piccolo cerchio di
Sineglossa possa non essere altro che la stanza dei
giochi di una solitaria principessa contemporanea,
che vive la sua gloria e il suo dramma nel cono
d’ombra della sua testa.
Remembering games
Le stanze dei giochi di Sineglossa e Katharina
Trabert
di Graziano Graziani
La visione che ci propone Sineglossa in Pneuma è
un gioco d’ombre che si sviluppa nello spazio di
una porta. Si entra otto per volta, al buio,
distribuiti su una rampa di scale, a osservare dal
basso verso l’alto l’alternarsi delle immagini e dei
suoni ascoltati in cuffia. Il breve spettacolo si
riconnette a un lavoro più ampio, Pleura, che il
gruppo di Bologna ha sviluppato a partire da una
riflessione sul personaggio di Salomè, per poi
distanziarsene. Perché Salomé è un personaggio
che non c’è (nella bibbia non compare mai il suo
nome) e una vicenda che non esiste; ma allo
stesso tempo è una delle storie più
universalmente conosciute, di quelle che si
raccontano di generazione in generazione. È per
questo che la si riconosce istintivamente nelle
immagini che la lanterna magica di Federico
Sempre nello spazio della Villetta, stavolta nella
tenda, si svolge la performance di Katharina
Trabert dal titolo liebesgeSCHICHTEN, gioco di
parole in tedesco in cui si fondono le storie
(geschichten) e gli strati (schichten) d’amore
(liebe). La performance comincia nel tardo
pomeriggio e va avanti per ore, sviluppandosi
lungo una struttura aperta che come scrive
Katharina – danzatrice e performer tedesca
trapiantata nella provincia di Rieti – “non si potrà
mai concludere”. Perché le storie e le dinamiche
che racconta, in una sorta di stanza dei giochi
piena di oggetti e ninnoli dall’apparenza
insignificante ammassati su un tavolo, si sommano
a strati appunto, l’una sopra l’altra, in un gioco di
variazioni sul tema e accumulazione che ricorda
molto da vicino il lavoro di artisti contemporanei
come Sophie Calle.
personaggi letterari e di film; un percorso che
sporca di autobiografia i nessi e le considerazioni
dei capitoli, anche qui secondo lo schema
documentaristico e antidiaristico caro ad artisti
concettuali come la Calle. In mezzo, momenti tra
l’assurdo e la poesia, tra lo scolarsi l’acqua dei
fiori e il ballare timido di bambina.
Difficile e anche pleonastico raccontare tutte le
immagini che scorrono e nascono nell’arco di più
di tre ore di performance, che Katharina Trabert
costruisce e porta avanti con un’incredibile
presenza scenica, sospesa tra il naif e l’ironia.
Eppure a volte la performance sembra condensarsi
e sprigionare tutto il mondo che descrive per
strati in un’unica, poderosa immagine. Come
quando Katharina, a terra, disegna con il gesso il
perimetro del suo corpo, per poi compiere
nuovamente l’operazione mentre “abbraccia” la
sua sagoma precedente. Gli amanti stilizzati che
restano al suolo sembrano un mostro con quattro
gambe e due teste – come gli uomini primigenei di
Platone, che conoscevano l’unità prima di essere
divisi da Zeus in due metà. O, forse, come il
mostro dell’ossessione amorosa, del fondersi
totalmente con l’altro, che solo nel corso
dell’adolescenza sa sprigionarsi in modo
dirompente e leggero a un tempo.
Un’altra Antigone in un altro Calderon
Il Pasolini immemoriale di Triangolo Scaleno
di Attilio Scarpellini
Introdotti con un diaproiettore da capitoli
numerati, gli “strati” d’amore si sommano l’uno
sull’altro, creando pian piano una realtà a parte
dove l’avvicendarsi delle storie supera la sua
somma. Katharina racconta, gioca con i pupazzi
presi dal tavolo, fa delle pause, canta appresso
alle musiche – anche qui come un’adolescente
nella sua stanza – mentre le ascolta con un i-pod,
a volte le posa davanti a un microfono e le fa
ascoltare al pubblico. Tutto si somma per delicate
intuizioni e analogie. Racconta di come tra
adolescenti non ci si bacia subito, ma bisogna
creare un gioco che ti consenta di avvicinarti
all’altro; canta sussurrando «Voglio il tuo
profumo» di Gianna Nannini; poi ci fa sprofondare
in una storia bizzarra dove una donna cerca di
ricreare l’odore di nicotina della mano del suo
amante stringendo le mani dei fumatori che
incontra. (Per un caso singolare, mentre
nell’edificio accanto scorrono le ombre di Salomè,
in una delle storie dice che “non ci si può fidare di
uno che si chiama Giovanni”…). È un gioco di
possibilità e ricordi, personali, di amici, di
Forse non ci saranno altri luoghi in cui svegliarsi. E
neppure sogni da confondere con la realtà. O
incubi da cui destarsi con un finale diverso da
quello che invece ebbero. Forse, quella lunga
declinazione della lotta tra la diversità e
l’omologazione che è il Calderon di Pier Paolo
Pasolini non poteva suscitare altro nel pubblico
d e l Pa l l a d i u m c h e l ’ a p p l a u s o p i e n o d i
riconoscenza, ma soprattutto di stupore che ha
suggellato la messinscena di Roberta Nicolai: le
parole di questo poema snervato, grondante dove
anche la citazione, il nome proprio – Barthes e
Picasso, Brecht e Machado – rotolano nel vento di
una nostalgia più che inguaribile, ormai senza
rimedio, sono così lontane da noi che a renderle
vicine può essere soltanto il sogno, o il teatro.
Pasolini ci parla e nel momento in cui scatta la
consapevolezza che le sue parole – una finta
profezia del Maggio ’68 divenuta la vera
descrizione di quel che stiamo vivendo solo ora:
ora che il genocidio della povertà sta per essere
ultimato – si voltano dall’ombra in cui erano
immerse (assieme al mito dello “scrittore
sacrificato” di cui ogni tanto il teatro ci ripropone
il feticcio della voce registrata) per rivolgersi a
noi, in quel momento vecchi e giovani si ritrovano
impegolati in una commozione che non prevede
più confini tra chi ricorda e chi per la prima volta
sente.
E’ inutile – e sarebbe facile – pensare che
quell’ultimo sogno detto da Tamara Bartolini con
la fragilità di una bambina in sottoveste che scava
con la voce una notte senza stelle noi non
l’abbiamo sognato a nostra volta, solo perché quel
brechtismo grave che Michele Baronio incarna così
bene lo respinge come un’assurdità tra i vani
sospiri delle anime belle (solo perché così “deve
essere” come, fin da Shakespeare, comanda la
ragione). E’ talmente
evidente, invece, che
proprio nell’anacronismo degli operai spagnoli con
il fazzoletto rosso che irrompono nel lager per
liberare gli ebrei si nasconda il segreto meno
confessabile del fallimento del movimento
comunista - che molti spettatori abbandonano il
teatro rimasticandone l’enormità visionaria come
se appartenesse a un sogno che hanno fatto in
proprio e che l’intemperanza sentimentale del
teatro ha finalmente rivelato. Ma è altrettanto
evidente che quel sogno non ci si poteva limitare
ad ascoltarlo compitato nella retorica asciutta, da
oratorio laico, che il suo autore voleva assegnare
a un “nuovo teatro” (equidistante dall’urlo
pregrammaticale delle avanguardie e dalla
chiacchera borghese): bisognava dopo tanti anni
avere il coraggio di restituirgli un corpo. Bisognava
poterne distillare i colori sontuosi – “tra il rosso, il
rosa e il viola” - che la sua poesia smodata non
riesce a trattenere, a costo di stilizzare
l’immaginario barocco di una Spagna né vecchia
né nuova, ma semplicemente immemoriale
(cattolica e rivoluzionaria, franchista e
antifranchista) di cui la Lupe di Marzia Ercolani è
la disperata rappresentante. Roberta Nicolai ha
“spazializzato” il Calderon – tutto all’opposto del
gesto con cui Latella schierò il concerto di Bestia
da stile sul proscenio - in una danza di geometrie
familiari dove gli attori sono sempre in scena
perché, di sogno in sogno, i loro ruoli si
ridefiniscono, senza mai riuscire a morire:
lancette su un orologio che si deforma, corpi che
la velocità di modificazione del Potere lascia feriti
e senza memoria, fino a ridurli all’evanescenza di
un fantasma. Così la Torre di Sigismondo in La vida
es sueno, da cui parte il Calderon, proprio come la
casa mutante di certi incubi, diviene lo spazio di
una trasformazione senza rotture: magione
pretenziosa e altolocata di una nobiltà decaduta
nel fascismo, baracca proletaria, appartamento
borghese, lager. Un interno sfoderato nell’esterno
della Storia che lo determina, lo maschera, lo
illumina, vestendo e spogliando i suoi hidalgo e le
sue damigelle, fasciandone i corpi con la voluta di
un drappo rosso che, ritirandosi come un’onda,
lascia scoperta la desolazione di un tavolo usato
come letto nel tugurio di una prostituta.
Immagine è ciò che sale dal fondo: con il suo
contrappunto di immagini, la scrittura scenica
della Nicolai risponde al testo di Pasolini senza
mai commentarlo, cioè senza piegare la libertà
della poesia in quella del teatro, ma andando
dall’intensità all’evidenza, come nella scena più
smagliante dello spettacolo, quella in cui
Francesca Farcomeni, Marzia Ercolani e Tamara
Bartolini avvicinano e allontanano dai propri volti
tre specchi riccamente incorniciati (e nel fondo di
quella visione i loro volti si stagliano e si
confondono al riflesso scuro, luttuoso che viene
dalla sala, ma è difficile non intravedervi anche
un altro riflesso dove lo sguardo di Pasolini si
incrocia con quello di Foucault sul famoso
specchio mimetizzato tra i quadri in Las Meninas
di Velazquez).
La recitazione si spartisce tra i gruppi umani che
compongono e scompongono i quadri dello
spettacolo come l’unico punto fermo
nell’incessante modificazione delle identità: ma
più che dividere gli individui, distingue i generi
del sogno calderoniano. Negli uomini, a
cominciare da Enea Tomei – che nella prima parte
del Calderon riporta la figura autobiografica del
poeta traditore della propria classe che campeggia
anche in Bestia da stile insiste il tono di
un’animosità dialettica condannata a tornare su se
stessa (esemplare la partita a ping pong dove al
posto della rete c’è una fila di calici), più aspra
nei ruoli paterni e maritali di Baronio, più sfumata
in quelli curiali e dottorali di Antonio Cesari. Nelle
donne prevale l’incertezza fisica di chi la Storia
(questa ossessione negativa che Pasolini ha
condiviso con tutto il Novecento) non la fa, ma la
subisce, anche quando come donna Lupe
(Ercolani) la sfrutta nella forma di una devozione
alla terra sempre umiliata o vi si adatta come le
figure sororali cui dà vita la Farcomeni, un’Ismene
rassegnata all’esistente e alle mode che da una
parte spalleggia dall’altra scoraggia i risvegli
allucinati della sua Antigone. Perché è questo la
Rosaura interpretata da Tamara Bartolini, un’altra
Antigone in un altro Calderon, e dunque un’altra
infanzia, perennemente sospesa tra la realtà e il
sogno – trubsinnig per usare la parola con cui
Holderlin definisce Antigone che va alla morte:
“confusa fino alla demenza” – ma refrattaria a
dissolvere nell’ultimo risveglio la memoria di tutte
le vite che la attraversano. Non la lucida memoria
politica, ma la traccia sensibile e dubbiosa delle
diversità che siamo quando sognando incontriamo
in noi stessi gli altri, quel poetico corpo di corpi
che il presente eternizzato del neocapitalismo si
appresta a seppellire nella più vasta e
inattaccabile delle prigioni. Ieri, negli anni di
Pasolini e del Calderon. Oggi, quando il teatro ci
fa sentire il lontano che avvicinandosi ci sfiora –
per ricordarci che anche noi un tempo abbiamo
sognato il sogno che non si può più sognare.
quadro), mentre l’ombra è immensa, cangiante,
moltitudinaria, come se del corpo avesse
ereditato tutta la libertà e la sofferenza, la
disperata volontà di continuare a essere oltre i
confini che lo inchiodano nello spazio della
Storia. Come l’ombra staccata di Peter Schlemil
che nel racconto di Chamisso se ne va errante e
solitaria in cerca del proprio corpo. Come
l’ombra dell’amato che la fanciulla di Corinto
trattiene sul muro dove la luce di una lanterna
l’ha proiettata, riempiendola di creta, un
racconto di fondazione sull’origine della pittura
che in (a+b)3 rivela apertamente il suo carattere
reliquiale (se non addirittura di evocazione
magica) nel momento in cui Claudia Sorace
ritaglia, accartoccia e nasconde, nel suo seno, la
figura fissata sulla tela della testa del fidanzato
(Riccardo Fazi)
che poi nell’ultima scena si
premerà sul viso. Veronica o mandylion, statua
dolorosa o maschera estrema di bellezza e
comunque “vera icon” che non sopravvive al suo
modello perché, ombra che riveste la pelle,
finalmente, lo incarna: come tutte le storie
d’amore che si rispettano, anche quella dei Muta
Imago celebra la propria impossibilità nella
volontà di aderire al corpo dell’altro, di essere
non più davanti ma teatralmente dentro
un’immagine… E qui sta, per così dire, il segreto
della sua animosa trasformazione visuale: non
nell’immagine, come sempre, ma nel tempo che
la rompe e la scandisce, non nella theoria – che
viene dalle pagine sull’ombra di Victor Stoichita
come potrebbe venire da quelle di JeanChristophe Bailly – ma nella istorié che la permea
e la drammatizza e, per quanto la
contestualizzazione romanzesca di (a+b)3 sia un
leggero arabesco - un’aria delicatamente
anacronistica soffiata sui corpi e sulle cose - la
traduce nella tragica singolarità di un destino.
Il corpo e l’ombra
I Muta Imago e il “discorso della guerra”
di Attilio Scarpellini
Ripubblichiamo in occasione di Teatri di Vetro
2008 la recensione di (a+b)3 dei Muta Imago già
apparsa sul numero 16 di questa rivista
Cosa dicono i Muta Imago? E soprattutto cosa
raccontano le immagini che senza posa si
compongono e si scompongono, affiorano e si
ritraggono nel cineteatro del cubo magico di (a
+b)3? Anche volendolo, non c’è tempo per
indovinare il “prestigio” di questo alto
illusionismo che trasforma una storia semplice –
la più semplice possibile: quella di due amanti
separati dalla guerra – in un balletto di
apparizioni dove il corpo è in un luogo e l’ombra
in un altro: dove il corpo è piccolo, raccolto in
una scorza di luce assediata dalla notte,
composto in un’immaginetta come quella,
accurata fino ad essere leccata, della cena a due
(con quel vino color rubino che gorgoglia e
ipnotizza, attraendo e nel contempo deviando lo
sguardo dalla sensualità discreta dell’intero
La guerra è l’altro di questo spettacolo e cioè il
suo ritmo, la musica di una modificazione
continua e inesorabile, l’onda d’urto che fa
rotolare il piccolo mondo dei protagonisti sulla
china rovinosa di una precoce rivelazione del
dolore. E la guerra che si riversa nel cubo di (a
+b)3 come un liquido di contrasto che espande la
sua macchia è anch’essa (al pari del “mito” della
fanciulla di Corinto) una guerra immemoriale
tutta giocata sulla parallasse e sulla
riconoscibilità dei suoi anacronismi: le immagini
che scorrono su un televisore che occupa
visibilmente il posto delle radio anni ’40 sono
quelle dei combat film angloamericani della
seconda guerra mondiale, ma le parole solenni
della propaganda che le sostiene, alternandosi
alle note di It’s long way to Tipperary, sono
quelle con cui George Bush Junior ha lanciato
l’operazione enduring freedom. Così l’unica
parola articolata che penetra l’aria fredda della
scena è una parola destinata a dire, in ogni
senso, il falso e a produrre due corto-circuiti
retorici: il primo, sicuramente consapevole, è di
restituire un’immagine di continuità tra le guerre
novecentesche e le presunte operazioni di polizia
internazionale che le hanno rimpiazzate negli
anni’ 90. Vista dal basso, mentre il buon soldato
interpretato da Riccardo Fazi avanza sul posto
sferzando l’aria con una lampadina, percepita
nel tuffo al cuore degli scoppi di granate che non
si sa da che parte arrivino e nell’intermittenza
dei bengala che tracciano la notte, la guerra non
è mai cambiata. Fu proprio il presidente Bush del
resto – ed è il secondo corto-circuito – a
giustificare le offensive militari dopo l’11
settembre del 2001 come una ripetizione
ideologica dello scontro tra civiltà che aveva
opposto le potenze democratiche al nazifascismo
nella guerra del ‘40. Ed è per questo che le sue
parole (false) suonano così credibili
sovrapponendosi alle immagini d’epoca. Quando
la storia si ripete, come diceva Marx, molto
spesso si ripete in farsa. Ma il paradosso è che
proprio nel suo essere identica a sé, prigioniera
di un anacronismo e di una retorica che si
ripetono – con gli aerei che si alzano in volo e le
città rase al suolo - la guerra “aeropolitica” di (a
+b)3 si iscrive indifferentemente nel nostro
passato e nel nostro futuro, è prima e dopo di
noi. La guerra è l’altro dell’amore perché essa è
l’altro del desiderio e dell’immagine: ci volevano
degli artisti di venti anni per distillare di nuovo la
sua essenza immemoriale dall’alambicco delle
banalizzazioni geopolitiche e farci ripensare
l’arte dell’ultimo secolo come il lungo tremito di
dissoluzione del volto umano nello specchio delle
guerre.
Il campo
Da quello di concentramento a quello di calcio nei
lavori di Proyecto JDPL e Biancofango
di Mariateresa Surianello
Due fili di ferro spinato sono tesi sul boccascena e
sul pavimento altri pezzi arrotolati ne delimitano
pericolosamente lo spazio. Dietro questa barriera
concentrazionaria si muovono sei figure di nero
vestite, avanzando minacciose verso il pubblico.
Ma nei suoi cinquanta minuti di svolgimento Carne
non porterà mai gli spettatori nella zona di
pericolo, lo scontro resterà chiuso oltre la barriera
spinata. In assenza di parola, la danza assume già
nell’incipit una cifra fortemente narrativa, si fa
linguaggio descrittivo di azioni ripetute all’infinito
pur nella loro variazione coreografica. Presentato
sul palco del Palladium da Proyecto JDPL,
acronimo di Juan Diego Puerta Lopez, coreografo
e regista colombiano che, trasferitosi in Italia alla
metà degli anni 90, sembra aver portato con sé il
pesante bagaglio delle feroci dittature militari che
hanno sconvolto di sangue le società dell’intero
continente sudamericano. Puerta Lopez mostra la
cultura della violenza fascista assunta come unica
possibilità di relazione, per giungere alla
sopraffazione degli uni sugli altri, in una
marmellata indistinta di individualità omologate.
Con i suoi undici quadri, Carne però non è
costruito per raccontare una storia compiuta, non
c’è un inizio, uno svolgimento e una fine, quello
che accade è sempre una sequenza di attacchi alla
persona, spesso a mani nude e talvolta con
manganelli, in un continuo scambio di ruolo
carnefice/vittima. Un effetto spirale, nel cui
gorgo si consuma la carne e l’anima. Tra colpi
fracassanti e il collasso dei corpi, il movimento
per qualche istante assume tratti classici e
disegna un’attitude, allungata poi in arabesque,
su una musica che sfonda le note bachiane per
approdare al suono sintetico, all’indistinto
stridore e al pauroso scricchiolio della corrente
elettrica.
Dall’immediatezza del messaggio di Proyecto
JDPL, si passa allo scavo introspettivo di
Biancofango, che lentamente dispiega
l’incapacità di vivere del personaggio, Mastino. En
plain air prende forma In punta di piedi, nel Lotto
16 della Garbatella, luogo ideale per trovare
refrigerio dallo scirocco che ha infuocato la città
all’improvviso. Basta una panchina e una linea
bianca, che Andrea Trapani traccia come prima
azione dello spettacolo, per definire lo spazio
scenico. Due elementi essenziali alla scansione
della scrittura drammaturgica e al disegno
registico, ritornanti nella seconda parte della
trilogia dedicata all’inettitudine (ha debuttato
qualche giorno fa, nel romano Teatro Colosseo, La
spallata, costruita su “una sola” memoria dal
sottosuolo di Dostoevskij), inaugurata nel 2006
proprio da questo In punta di piedi, scritto e
diretto da Trapani con Francesca Macrì. Un
interessante progetto che si concluderà intorno a
Il soccombente di Thomas Bernhard.
Se l’ispirazione dostoevskiana è servita alla coppia
di autori per analizzare la giovinezza, nel primo
lavoro la compagnia analizza la condizione del
perdente nel momento dell’adolescenza,
impiantando l’azione in un luogo e in un tempo
topici per l’esistenza giovanile, un campo di calcio
nel corso di una partita. Zona franca in cui dare
sfogo agli istinti più bassi, alla competizione
spinta fino alla sopraffazione e all’annientamento
dell’avversario. «L’unico grande rito del nostro
tempo» – diceva Pasolini già nel ’70 (ricordano i
due autori). Qui incontriamo Mastino di tutto
punto abbigliato, con scarpini tirati a lucido ma
destinati a restare intonsi, ai piedi di colui che
entrerà in campo solo per dimostrare a se stesso e
ai compagni la sua totale incapacità di giocare con
la palla. Siamo in un campetto terroso alla
periferia di Firenze, città d’arte, elegante e
cosmopolita che degenera spesso in un
provincialismo chiuso e competitivo. Città che
presta la sua lingua, quella sboccata della strada,
al monologo di Trapani, regalando dei momenti di
forte comicità.
Seduto sulla panchina l’attore è bravo a cambiare
passo alla recitazione, dai toni spavaldi del mister
a quelli pacati e remissivi di Mastino. Su quella
panchina il flusso del dialogo scorre in parallelo
alla partita che si sta giocando, con gli esilaranti
commenti dell’allenatore ai suoi uomini, i
rimbrotti e la spietata ironia nei confronti del
giovane in panchina. Invece quando il protagonista
si alza e oltrepassa la linea bianca si entra in un
tempo sospeso, quello dello sguardo verso
l’interno, il momento della sofferta solitudine. Ma
forse, sono proprio questi quadri poetici a
rallentare il ritmo di uno spettacolo ben scritto e
ottimamente interpretato, in cui il flusso verbale
è coniugato a un incessante movimento, quasi una
partitura coreografica di finti palleggi e lanci di
palla. Forse, andrebbero asciugate un po’ queste
scene, ne guadagnerebbe d’intensità il lavoro.
Quando si dice le regole…
“Opera” di Vincenzo Schino ci ricorda che in
teatro niente è scontato
di Gian Maria Tosatti
Forse bisogna leggere gli appunti di Vincenzo
Schino alla fine della sua Opera. Bisogna ricorrervi
perché si esce con un senso di smarrimento non
tanto emotivo, quanto logico. Sulla scena si sono
susseguite diverse immagini, appartenenti sì ad un
immaginario unico e visivamente coerente, ma
nella loro natura piuttosto eterogenee. Manca il
nesso, e allora bisogna andarlo a cercare negli
appunti di regia, ma il nesso non c’è. Negli
appunti c’è proprio la volontà di costruire una
specie di rassegna sospesa di esplosioni emotive
che si richiamano a questioni del profondo, come
il rapporto fra essere e apparire, fra il sé e l’altro.
Punti critici sulla cima dei quali compiere
un’acrobazia artistica per avere il pretesto di
puntarvi sopra un occhio di bue e mostrarne tutto
il delicato tremore.
Per fare questo Schino ricorre ad una metafora
condivisa, quella del circo, che da sempre è assai
più di uno spettacolo viaggiante, è un mondo
parallelo, un mondo in cui ci si strappa le
maschere dei volti abituali per trovarvi sotto la
faccia del clown interiore, che appunto non è che
un essere umano in potenza, il bambino atavico
che vive dentro ognuno di noi.
Se dunque alla fine del lavoro sembra mancare il
“nesso”, non è per via di una leggerezza nel modo
di pensare il proprio discorso e il sentimento
espanso – che nelle note di regia scandite da date
non può che farsi sentimento del tempo – di cui si
vuol essere amplificatori. E a dirla tutta Schino sa
anche che il teatro esiste appunto per amplificare
le sensazioni di tutti quei nervi scoperti che nella
vita quotidiana non servono a niente, ma senza i
quali non esiste una “vita” quotidiana, quei nervi
che sono scoperti perché sono i fili annodati e
attorcigliati del burattino che siamo, appeso
appunto alle corde del cuore. Il cuore, che - come
diceva Butor citando Giacometti (presente in
scena con un richiamo piuttosto esplicito) – di cui
«vorrei tradurre tutti i rallentamenti e le
accelerazioni, il cuore che vorrei cogliere tra i
palmi delle mani per accarezzarlo, calmarlo,
guarirlo».
Eppure manca il “nesso”. L’universo dei
sentimenti è chiaro e chiara è anche la metafora
che si vuole metateatrale. E allora, appunto, ci si
sorprende che il nesso mancante sia proprio una
delle regole fondanti di quel teatro che Schino
vuole utilizzare come lingua ed immaginario
archetipo. Una dopo l’altra si susseguono
immagini che esprimono una grande
consapevolezza visiva, alcune decisamente belle,
come quella del clown che piange davanti al
microfono o quella dell’altro pagliaccio che ride
triste, singhiozzando contro la porta chiusa del
fondo palco. Sono belle, ma non riescono ad
essere forti, perché sono tagliate ai margini, gli è
tagliato il respiro.
La prima regola della composizione teatrale (che
poi è regola dell’arte se non che nel teatro essa si
relaziona direttamente con l’elemento tempodurata) è che ogni immagine deve avere una
preparazione. Ad ogni immagine bisogna arrivare.
Maestro ne è il Nekrosius degli Shakespeare e la
scuola russa in genere. L’immagine è una
questione d’amore. E’ forte se si passa per il
corteggiamento, per i momenti stentanti che
preludono l’amplesso. Ma se si salta tutto e ci si
trova di fronte ad un corpo nudo che si offre non è
affatto scontato che qualcosa si consumi.
Schino fa questo errore. Espone l’ultima stilla del
sangue, quella che fa vibrare, è vero, ma che
senza il lungo e sofferto dissanguamento non è
che una goccia come tutte le altre, senza epica.
Questo è quanto si può dire di Opera, un lavoro
che somma lampi di un immaginario complesso
che al suo interno avrebbe tutto quel che serve
per essere catartico, ma che nel portarsi in scena
decide di lavorare per estratti anziché per sintesi.
I misteri dei giardini del Lotto numero 16
Sabrina Broso: cronaca di una fugace apparizione
di Attilio Scarpellini
Una figurina liberty smarrita in un parco, una
fata caduta da un albero che fatica a rimettersi
in piedi: questa è Sabrina Broso. Fin quando
aderisce al blocco di pietra su cui ha posato la
testa, sotto il grande ulivo del Lotto numero 16,
le sue lunghe chiome sembrano anch’esse
pietrificate come quelle di certe sculture che
ancora si vedono nei cimiteri monumentali di
mezza Europa. E’ quel che più profondamente
vuole essere: una musa addormentata priva di
uno scultore. Il pubblico raccolto in un cerchio di
sedie bianche sistemate nel giardino la attende
con il cuore sospeso, si chiede che farà ora, dopo
i primi minuti di immobilità, come si evolverà
quella che anche i più sprovveduti, i più
innocenti, hanno compreso sarà una
metamorfosi. Ma una volta che la musa è a terra,
rannicchiata, poi stesa con le spalle al pubblico, i
più maliziosi, i più sprovveduti, i meno innocenti,
non riescono a non fissare le spalle nude e i
fianchi ben formati (da viola di Man Ray) che si
disegnano sotto la tunica attillata: essere acqua,
come recita il titolo della performance, vuol dire
anche non riuscire più a nascondersi, emergere in
una trasparenza. Così comincia il giro lento,
straziante di un corpo che si contorce, si
accovaccia, striscia sulla terra, finisce a gambe
all’aria come Gregor Samsa nel racconto di
Kafka, nel tentativo di cancellarsi, di esalare
un’anima virginale ed appartata nella materia
che lo circonda, ma alla quale – per statuto – non
appartiene del tutto perché tra sé e il primordio
liquido in cui vorrebbe scomparire c’è pur
sempre lo sguardo degli altri.
C’è l’attenzione protesa e piena di rispetto delle
due anziane signore sedute accanto a me,
composte e un po’ accaldate – ma ora un lieve
alito di vento fa rabbrividire l’ombra scura degli
alberi placando un po’ il ronzio delle televisioni
accese che soffiano più calore nel giardino – forse
le due persone al mondo che, in questo
momento, esprimano maggior fiducia nell’arte
contemporanea e nella capacità di Sabrina Broso
di portare, se non più senso nelle loro vite, più
meraviglia nei loro occhi. Ma la danzatrice dai
lunghi capelli corvini – che sono un altro corpo e
raccontano persino un’altra storia – si limiterà a
miniaturizzare un immane sforzo per ritrovare la
posizione eretta per mimetizzarsi tra le edere
del muretto lungo il quale si srotola la sua
performance con le ombre che le istoriano il
volto come nella peggiore immagine del peggior
Peter Greenway. Per poi fermarsi, voltarsi un
momento verso il pubblico, lanciargli uno
sguardo in tralice, un po’ timido e un po’ falcato,
e sparire dietro l’angolo. Tutta qui la “tensione
sospesa” che, tra “fumi vegetali e segrete ossa
profumate di nulla” si avviava “verso lo svanire”
in un tempo variabile e indefinito: il tempo di
registrare il passaggio di uno strano animale – o
fate voi: dell’assolutamente altro – insieme
troppo lento e troppo fugace, troppo remissivo e
troppo altezzoso. Come l’albatro di Baudelaire,
Sabrina Broso non può condividere la stessa terra
del nostro filisteismo. Dalla bocca socchiusa di
una delle signore si libera un piccolo sospiro, una
specie di gemito involontario. L’arte è difficile e
la critica troppo facile per non diventare
difficilissima, qui nei giardini di Compton House.
la differenza
settimanale di cultura
on-line su www.differenza.org
direttore responsabile
Gian Maria Tosatti
in redazione
Graziano Graziani, Attilio Scarpellini,
Mariateresa Surianello.
La rivista è finanziata nell'ambito del progetto
Scenari Indipendenti, promosso dalla Provincia di
Roma in collaborazione con il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio.