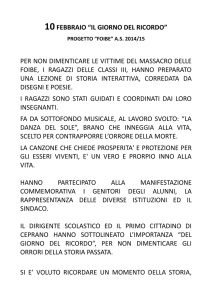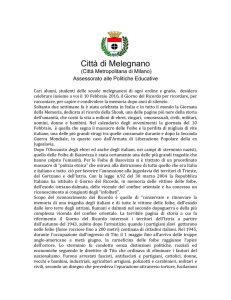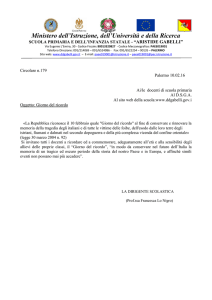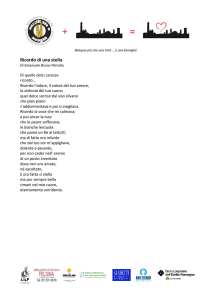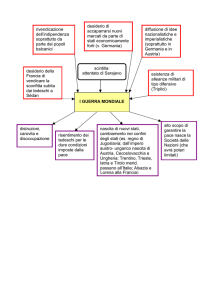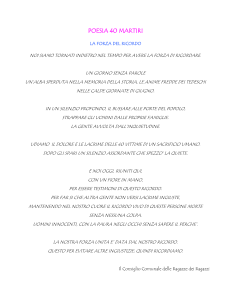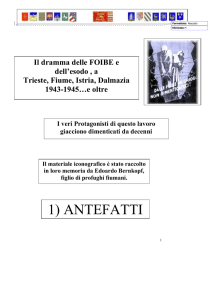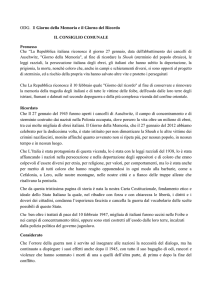10
FEBBRAIO
Il giorno del ricordo
Francesco Maria Feltri
CONSAPEVOLEZZA
MEMORIA
Cittadinanza
CONSAPEVOLEZZA
MEMORIA
Cittadinanza
Percorsi e temi di storia, per sentirsi cittadini
in Europa, in Italia e in Emilia Romagna
A cura di
Francesco Maria Feltri
Elenco dei volumi
Modulo 1: 1° maggio, La festa del movimento operaio
Modulo 2: 4 novembre, La memoria della prima guerra mondiale
Modulo 3: 28 ottobre 1922, La marcia su Roma
Modulo 4: 8 settembre, Fascismo, guerra e armistizio
Modulo 5: 8 maggio, La fine della seconda guerra mondiale
Modulo 6: 25 aprile, La festa della liberazione
Modulo 7: 27 gennaio, La giornata della memoria
Modulo 8: 2 giugno, La nascita della Repubblica
Modulo 9: 10 febbraio, Giorno del ricordo
Modulo 10: 8 marzo, La festa della donna
Modulo 11:
25 novembre, Giornata internazionale
per l’eliminazione della violenza contro le donne
INTRODUZIONE GENERALE
Un nuovo inizio per la comunità:
gli eventi frattura radicale
All’inizio del XVI secolo, Niccolò Machiavelli era convinto che
la storia fosse una specie di grande illusione, un errore di prospettiva. I continui rivolgimenti, che investono il mondo della
politica, potrebbero indurci a pensare che il mutamento sia l’aspetto più vero ed ultimo della vicenda umana; per il pensatore
politico fiorentino, al contrario, in ultima analisi non c’è alcun
cambiamento davvero sostanziale. Siamo di fronte a increspature provvisorie, prive di conseguenze radicali, non ad autentiche e decisive fratture storiche.
Per Machiavelli, la storia non è molto diversa dalla realtà naturale: certo, ogni estate, nel campo si raccolgono spighe differenti da quelle degli anni precedenti. Il procedimento, però,
è sempre quello, ciclico e ripetitivo, e non c’è spazio per alcuna significativa novità. Per usare un’altra metafora, si potrebbe pensare ad un palcoscenico: cambiano gli attori e le prime
donne; mutano i fondali e le ambientazioni. Eppure, la commedia rappresentata è sempre la stessa: e per di più, secondo Machiavelli, non è una commedia, bensì una tragedia, i cui ritmi e
movimenti sono dettati dalla spietata natura degli esseri umani,
decisamente più inclinata verso il male che verso il bene.
Nel corso del XIX secolo, comunità nazionali, Stati e associazioni politiche di diversa natura incominciarono ad appropriarsi
del tempo. Fino ad allora, il tempo era stato monopolio della
Chiesa, che lo aveva strutturato secondo un preciso calendario
liturgico. A scadenze periodiche, il fedele incontrava delle precise ricorrenze e festività (Natale, Pasqua, Pentecoste…), che
gli permettevano di fare memoria dei principali eventi della vita
di Cristo o della Chiesa delle origini, e quindi di riscoprire con
rinnovata freschezza la propria identità di cristiano.
A partire dall’Ottocento, mentre si affermava la Nazione, come
II
INTRODUZIONE GENERALE
nuova fonte di valori e destinatario di fedeltà assoluta (fino al
martirio), accanto al calendario liturgico cristiano – e in certi
casi contro di esso, in precisa e polemica alternativa – si impose
una serie di festività civili, che scandivano l’anno e spingevano
l’individuo a riflettere sulla sua identità di cittadino e/o di membro di una comunità nazionale.
Sia la Chiesa che le moderne comunità nazionali del XIX-XX
secolo si ispiravano ad una concezione della Storia e del tempo
diametralmente opposta a quella di Machiavelli. Pur focalizzando la loro attenzione su questioni molto diverse, autorità
ecclesiastiche e intellettuali sensibili al tema della nazione erano
convinti che nella storia si producessero alcuni eventi frattura
radicale, capaci spezzare l’opaca omogeneità della vicenda
storica. Le comunità umane che avevano fatto esperienza di
uno o più di tali eventi, da essi uscivano radicalmente trasformate. Proprio per questo, avevano bisogno di una festa, che ne
conservasse la memoria. Potevano essere esperienze traumatiche o felici, drammatiche o gioiose: comunque, non potevano
e non dovevano essere più dimenticate, perché era grazie a
quelle sconfitte o quelle vittorie, a quelle passioni o quelle resurrezioni, che la comunità si definiva nella propria identità più
autentica e duratura.
Ma la festa, civile o religiosa che sia, nel momento in cui spinge
a fare memoria, mette in moto un meccanismo che è diverso e
molto più forte del puro non dimenticare. Nel suo sforzo di essere efficace di fronte alla vicenda storica decisiva, la memoria
diventa attualizzante. In effetti, se l’evento ricordato è capace
di spezzare la storia, esso continua ad agire per sempre: la sua
onda lunga raggiunge anche noi, che viviamo anni o secoli
dopo l’evento. Insomma, tra comunità (religiosa o civile) e Storia si crea un circolo: per definire se stessa, la comunità deve
andare al passato e riscoprire l’importanza di quell’evento;
l’obiettivo, però, non è puramente archeologico: al contrario,
III
INTRODUZIONE GENERALE
grazie alla riflessione sul passato, si tratta di agire sul proprio
presente, illuminandolo di nuova luce, o meglio di speranze
e valori capaci di superare il tempo, di parlare ad ogni generazione e di ispirarne anche oggi l’azione, religiosa, morale o
politica.
Memoria e cittadinanza attiva
Diritti e democrazia non sono affatto qualcosa di ovvio, di normale, di scontato. Per certi versi, anzi, nel terribile panorama
della storia sono l’eccezione: realtà fragili che sono state conquistate dopo innumerevoli sforzi e che, soprattutto nel Novecento, sono state infrante da progetti totalitari di vario tipo e di
vario genere.
Malgrado tutte le difficoltà, le sconfitte e i ritorni all’indietro,
non è vero che nella storia non è mai cambiato nulla. Anche se
i grandi progetti utopici, di qualunque matrice ideologica, sono
tutti falliti, dopo avere provocato milioni di morti e disastri materiali incalcolabili, non è stato tutto inutile. La storia non è solo
un computo di vittime, di un tipo o dell’altro. Senza indulgere
ad alcun facile ottimismo, o cedere all’ingenua concezione secondo cui saremmo giunti alla fine della Storia e al migliore dei
mondi possibili, è comunque vero che i cittadini e le cittadine di
oggi possono condurre un’esistenza più libera e ricca di opportunità, rispetto a coloro che sono vissuti in altre epoche storiche.
Nulla va dato per scontato o per definitivamente acquisito.
Diritti e democrazia – lo ripetiamo – sono conquiste fragili e
deteriorabili. Proprio per questo, a nostro parere, necessitano
di una sempre maggiore consapevolezza, che a sua volta può
emergere solo dalla memoria, cioè dalla riflessione storica.
Anche ai giorni nostri, tale memoria tende ad organizzarsi intorno a degli eventi di forte impatto emotivo e simbolico; le
celebrazioni ufficiali, però, talvolta li ricoprono di retorica e li
rendono distanti dai cittadini. Paradossalmente, insomma, le ri-
IV
INTRODUZIONE GENERALE
correnze possono ottenere l’effetto opposto, rispetto al fine originario per cui sono nate. La riflessione storica vorrebbe essere
più sobria, più obiettiva, più scarna; proprio per questo, forse,
riuscirà a far emergere di nuovo il significato di svolta epocale
di questo o quell’evento.
Se non si trasforma in spregiudicato strumento ideologico (è
questo, infatti, il principale limite del cosiddetto uso pubblico
della Storia), la conoscenza storica può rendere il cittadino
pienamente consapevole dei propri diritti e dei propri doveri,
nella misura in cui la riflessione sul passato aiuta a comprendere quanto i diritti stessi e la democrazia (in tutti i suoi aspetti,
regole comprese) sono il frutto di complesse (e quindi, spesso,
persino contraddittorie) vicende storiche, di lotte e di tragedie,
vissute (e subite) da chi ci ha preceduto. Sotto questo profilo,
il dovere morale e civile di fare memoria, per mantenere viva
l’importanza di tutte le libertà e le opportunità che ci è concesso
di vivere come cittadini, oggi è ancora più necessaria che nei
secoli passati.
Moduli per riflettere su storia
e cittadinanza
Il lavoro che proponiamo consisterà in alcuni moduli, ognuno
dei quali avrà la stessa struttura di base, anche se potrà variare
la quantità di materiale da cui verrà costituito.
Ogni modulo (materialmente, un libretto di un centinaio di pagine) tratterà un tema, o un problema, importante per la costruzione dell’identità collettiva e di una comune cittadinanza.
Il principio di base che informa l’intero lavoro è lo sforzo di intrecciare costantemente tre piani d’analisi: la dimensione internazionale (l’Europa e, talvolta, il mondo intero), la dimensione
nazionale (l’Italia), la dimensione locale (l’Emilia Romagna). Per
ogni tema, ai tre livelli citati, si cercherà di individuare almeno una vicenda significativa, che si è impressa nella memoria
V
INTRODUZIONE GENERALE
collettiva e che per un gruppo di cittadini è stata epocale, cioè
decisivo, nel caratterizzare la loro esistenza.
Scendendo in dettaglio, ogni modulo avrà la seguente struttura
ideale:
Dimensione internazionale
Scheda 1
Scheda 2
Scheda 3
Scheda
Dimensione nazionale di apertura:
Introduzione
ad un tema
Scheda 1
Scheda 2
Scheda 3
Dimensione regionale
Scheda 1
Scheda 2
Scheda 3
Anche se, in linea di principio, ogni modulo è autonomo, autosufficiente, concluso in se stesso, ciascun elemento ovviamente
dialoga con gli altri dai quali riceve ulteriore chiarezza e forza
di significato.
Buona lettura, a tutti i cittadini e le cittadine che vorranno seguirci nel nostro percorso.
F. M. F.
VI
Indice
Introduzione3
Dimensione internazionale:
La politica della pulizia etnica nel ‘900
La seconda guerra mondiale in Jugoslavia
17
I progetti razziali nazisti
28
Turchi, Russi, Polacchi e Tedeschi
40
Dimensione nazionale:
Il confine orientale italiano
Italia e Jugoslavia nel primo dopo guerra
63
Repressione italiana e occupazione tedesca
72
Trieste, Tito e le foibe
88
Dimensione regionale:
L’esodo dei profughi verso l’Italia
Sospetti e diffidenze nei confronti dei profughi
109
Il villaggio San Marco a Fossoli
118
alla
De Gasperi parla
ce
Pa
Conferenza della
10 FEBBRAIO
Il giorno del ricordo
Introduzione
N
el 1945, l’Italia uscì sconfitta dalla seconda guerra mondiale. L’impegno delle forze partigiane e quello delle truppe regolari del Regno d’Italia, che il 13 ottobre 1943 aprì
formalmente le ostilità contro la Germania, non cancellarono,
agli occhi degli Alleati, le responsabilità del governo fascista,
che era sceso in campo contro Francia e Inghilterra il 10 giugno 1940. La conferenza di pace che avrebbe dovuto definire
i nuovi confini dell’Italia e precisare varie altre questioni (comprese quelle relative alle colonie e alle eventuali riparazioni di
guerra) sì aprì nel maggio 1946, al palazzo del Lussemburgo,
ma entrò nella sua fase più importante e decisiva il 29 luglio.
De Gasperi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, prese la parola il 10 agosto 1946, di fronte ad
una platea di delegati freddi e sostanzialmente ostili, con l’unica
eccezione del Segretario di Stato americano James Francis Byrnes, il solo dei presenti a stringergli la mano dopo l’intervento:
<<Volevo fare coraggio – scrisse Byrnes nelle sue memorie – a
quest’uomo che aveva sofferto nelle mani di Mussolini, ed ora
stava soffrendo nelle mani delle Nazioni alleate>>. La valutazione storica delle decisioni prese a Parigi dalle grandi potenze deve tener conto in primo luogo dell’eccezionale peso che
l’URSS poteva ancora esercitare e del fatto che Jugoslavia e
Unione Sovietica erano ancora in ottimi rapporti, per cui le pretese e le richieste dell’una erano pienamente sostenute dall’altra, perfettamente soddisfatta del fatto di poter spingere ulteriormente verso occidente la propria sfera di influenza in Europa.
La completa sintonia di vedute e di prospettive tra Mosca e Belgrado ebbe notevoli e importanti risvolti politici all’interno dell’Italia. Il PCI, infatti, in quella prima delicata fase del dopoguerra,
3
10 FEBBRAIO
sulla sua stampa e nei suoi interventi parlamentari, anche se le
sinistre rivestivano ancora importanti incarichi nel governo italiano, non sostenne le proposte di De Gasperi, finalizzate a contenere il più possibile le cessioni territoriali sul confine orientale,
bensì il punto di vista russo-jugoslavo. In particolare, la stampa moderata e conservatrice commentò in modo molto ostile
l’incontro diretto di Togliatti con Tito, verificatosi nel novembre
1946. Durante questo vertice, il leader comunista italiano convinse quello jugoslavo a rinunciare a Trieste, offrendo in cambio Gorizia; sui giornali anticomunisti, la mediazione diretta di
Togliatti fu duramente criticata, mentre la sua offerta fu bollata
con l’infamante epiteto di <<nefasta proposta di baratto>>.
Solo sulla questione del confine al Brennero Mosca assunse
una posizione più favorevole all’Italia; infatti, mentre Inghilterra,
Francia e Stati Uniti erano disponibili a sottrarre all’Italia l’Alto Adige, per concederlo all’Austria, il ministro russo Molotov
si oppose categoricamente a questa ipotesi: non voleva certo,
con un simile gesto, tendere una mano all’Italia (che agli occhi
dei sovietici si era macchiata dell’imperdonabile colpa di aver
collaborato con Hitler all’invasione dell’URSS), ma piuttosto punire l’Austria e impedire un suo rafforzamento. L’unico risultato
che il ministro inglese Bevin riuscì a ottenere fu una clausola
che imponeva all’Italia di trovare un accordo con l’Austria per
la tutela delle minoranze di lingua tedesca presenti all’interno
del territorio nazionale italiano.
Anche la Francia dimostrò precisi intenti punitivi nei confronti
dell’Italia, esigendo i territori attorno ai due villaggi di Tenda
e di Briga e la zona intorno al Moncenisio. Inutilmente, il governo italiano fece notare che le centrali idroelettriche presenti
in quelle zone fornivano energia a gran parte delle industrie
liguri e piemontesi, oltre a garantire il 60 per cento del fabbisogno complessivo di Torino. Quanto alla sovranità, la Francia fu irremovibile; i territori in questione, dunque, divennero
4
IL GIORNO DEL RICORDO
francesi, anche se all’Italia fu concesso un ampio diritto d’uso
delle risorse energetiche. Quanto alle colonie, l’Italia rinunciò
spontaneamente alle isole del Dodecanneso (conquistate nel
1912, durante la guerra italo-turca, ed ora cedute alla Grecia)
e all’Etiopia, invasa da Mussolini nel 1935. De Gasperi sperava
di poter conservare almeno l’Eritrea, la Somalia e la Libia (cioè
le colonie del periodo pre-fascista), ma il trattato di pace obbligò invece l’Italia a concedere loro, sia pure in tempi più lunghi,
e con la mediazione dell’ONU, la completa indipendenza.
Il problema più spinoso era quello del confine orientale. Il trattato di pace, firmato il 10 febbraio 1947, sancì la sovranità
italiana su Gorizia e sull’area di Monfalcone, ma la cessione
alla Jugoslavia delle province di Pola, Fiume e Zara, insieme
alle isole di Cherso e Lessino. L’area tra Duino e il fiume Quieto
fu denominata Territorio libero di Trieste e divisa in due parti,
denominate Zona A e Zona B: l’amministrazione della prima
fu assegnata, in via provvisoria, agli Alleati, mentre la gestione
della seconda fu data all’armata jugoslava. Più tardi, il 5 ottobre 1954, un Memorandum d’intesa siglato a Londra assegnò
la Zona A (comprendente anche la città di Trieste) all’Italia e
la Zona B alla Jugoslavia. Solo nel 1975 (trattato di Osimo,
firmato il 10 novembre) l’Italia avrebbe comunque riconosciuto
in via definitiva il nuovo confine di Stato.
L’esodo degli italiani (e di altri soggetti, non italiani, ma decisi a
non vivere sotto un governo comunista come quello jugoslavo
di Tito) in realtà avvenne a tappe. Un primo importante flusso
di profughi (almeno 250.000) si registrò nel 1947, dai territori
assegnati alla Jugoslavia con il trattato di pace del 10 febbraio
1947; un secondo gruppo se ne andò dalla Zona B nel 1954.
D’altra parte, non bisogna dimenticare che numerosi italiani erano già fuggiti da Zara nel corso del 1944 (soprattutto a causa
dei pesanti bombardamenti alleati) e da Fiume, nella primavera
del 1945, all’arrivo del vittorioso esercito comunista jugoslavo.
5
, Parigi
10 Agosto 1946
aury
Palazzo Luscembr
IL GIORNO DEL RICORDO
Legge 30 marzo 2004, n. 92
Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime
delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del
confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati
Art. 1.
1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del
ricordo» al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo
dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.
2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per
diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di
istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e
dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende.
Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume
e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo
sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità
istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all’estero.
3. Il «Giorno del ricordo» di cui al comma 1 è considerato solennità civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 maggio 1949,
n. 260. Esso non determina riduzioni dell’orario di lavoro degli
uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno
di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni
7
10 FEBBRAIO
ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo
1977, n. 54.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 2.
1. Sono riconosciuti il Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata, con sede a Trieste, e l’Archivio museo storico di Fiume,
con sede a Roma. A tale fine, è concesso un finanziamento
di 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004 all’Istituto
regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI), e di
100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004 alla Società
di studi fiumani.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari
a 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza,
ai congiunti fino al sesto grado di coloro che, dall’8 settembre
1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle provin-
8
IL GIORNO DEL RICORDO
ce dell’attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati,
nonché ai soggetti di cui al comma 2, è concessa, a domanda e
a titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica
con relativo diploma nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 7, comma 1.
2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi
e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse zone, sono stati
soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati. Il riconoscimento può essere
concesso anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la
vita dopo il 10 febbraio 1947, ed entro l’anno 1950, qualora la
morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione
e prigionia, escludendo quelli che sono morti in combattimento.
3. Sono esclusi dal riconoscimento coloro che sono stati soppressi nei modi e nelle zone di cui ai commi 1 e 2 mentre facevano
volontariamente parte di formazioni non a servizio dell’Italia.
Art. 4.
1. Le domande, su carta libera, dirette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, devono essere corredate da una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio con la descrizione del fatto, della località, della data in cui si sa o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del congiunto, allegando ogni documento
possibile, eventuali testimonianze, nonché riferimenti a studi,
pubblicazioni e memorie sui fatti.
2. Le domande devono essere presentate entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo
il completamento dei lavori della commissione di cui all’articolo
9
10 FEBBRAIO
5, tutta la documentazione raccolta viene devoluta all’Archivio
centrale dello Stato.
Art. 5.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita
una commissione di dieci membri, presieduta dal Presidente del
Consiglio dei ministri o da persona da lui delegata, e composta
dai capi servizio degli uffici storici degli stati maggiori dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri,
da due rappresentanti del comitato per le onoranze ai caduti
delle foibe, da un esperto designato dall’Istituto regionale per la
cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste, da un esperto designato dalla Federazione delle associazioni degli esuli dell’Istria,
di Fiume e della Dalmazia, nonché da un funzionario del Ministero dell’interno. La partecipazione ai lavori della commissione
avviene a titolo gratuito. La commissione esclude dal riconoscimento i congiunti delle vittime perite ai sensi dell’articolo 3
per le quali sia accertato, con sentenza, il compimento di delitti
efferati contro la persona.
2. La commissione, nell’esame delle domande, può avvalersi
delle testimonianze, scritte e orali, dei superstiti e dell’opera e
del parere consultivo di esperti e studiosi, anche segnalati dalle
associazioni degli esuli istriani, giuliani e dalmati, o scelti anche
tra autori di pubblicazioni scientifiche sull’argomento.
Art. 6.
1. L’insegna metallica e il diploma a firma del Presidente della
Repubblica sono consegnati annualmente con cerimonia collettiva.
10
IL GIORNO DEL RICORDO
2. La commissione di cui all’articolo 5 è insediata entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e procede immediatamente alla determinazione delle caratteristiche dell’insegna metallica in acciaio brunito e smalto, con la
scritta «La Repubblica italiana ricorda», nonché del diploma.
3. Al personale di segreteria della commissione provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 7.
1. Per l’attuazione dell’articolo 3, comma 1, è autorizzata la
spesa di 172.508 euro per l’anno 2004. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Dall’attuazione degli articoli 4, 5 e 6 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004)
11
10 FEBBRAIO
IL DISCORSO DI DE GASPERI A PARIGI
I
l 10 agosto 1946, Alcide De Gasperi tenne un importante discorso al palazzo del Lussemburgo, a Parigi, sede della
Conferenza di pace che avrebbe deciso i nuovi confini dell’Italia dopo la guerra. Tutta la stampa – italiana ed estera – mise
in luce la straordinaria dignità del Presidente del Consiglio
italiano. Un giornale francese scrisse all’epoca che <<l’Italia
non poteva avere un avvocato migliore>> e che essa <<è
uscita più grande per questo discorso e per l’ingegno dell’oratore>>. I termini del trattato di pace, firmato il 10 febbraio
1947, furono comunque molto duri e pesanti, soprattutto sul
confine orientale.
Prendendo la parola in questo consesso mondiale sento che
tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro me: è soprattutto la mia qualifica di ex nemico, che mi fa considerare come
imputato, è l’essere arrivato qui dopo che i più influenti di voi
hanno già formulato le loro conclusioni in una lunga e faticosa elaborazione. Non corro io il rischio di apparire come uno
spirito angusto e perturbatore, che si fa portavoce di egoismi
nazionali e interessi unilaterali? Signori è vero: ho il dovere innanzi alla coscienza del mio Paese e per difendere la vitalità del
mio popolo di parlare come italiano, ma sento la responsabilità
e il diritto di parlare anche come democratico antifascista, come
rappresentante della nuova Repubblica che, armonizzando in
sé le aspirazioni umanitarie di Giuseppe Mazzini, le concezioni
universalistiche del cristianesimo e le speranze internazionalistiche dei lavoratori, è tutta rivolta verso quella pace duratura e
ricostruttiva che voi cercate e verso quella cooperazione fra i
popoli che avete il compito di stabilire.
12
IL GIORNO DEL RICORDO
Ebbene, permettete che vi dica colla franchezza che un alto
senso di responsabilità impone in quest’ora storica a ciascuno
di noi, questo Trattato è, nei confronti dell’Italia, estremamente
duro […]. Il carattere punitivo del Trattato risulta anche dalle
clausole territoriali. E qui non posso negare che la soluzione del
problema di Trieste implicava difficoltà oggettive che non era
facile superare. Tuttavia anche questo problema è stato inficiato
dall’inizio da una persistente psicologia di guerra, da un richiamo tenace ad un presunto diritto del primo occupante e dalla
mancata tregua fra le due parti più direttamente interessate. Mi
avete chiamato a Londra il 18 settembre 1945. Abbandonando
la frontiera naturale delle Alpi e per soddisfare alle aspirazioni
etniche jugoslave, proposi allora la linea che Wilson aveva fatto
propria, il 23 aprile 1919 nella Conferenza della Pace a Parigi […]. La soluzione internazionale, dicevo, come è progettata,
non accettabile. E specialmente l’esclusione dell’Istria occidentale fino a Pola causerà una ferita insopportabile alla coscienza
nazionale italiana. La mia preghiera non ebbe risposta e venne
messa agli atti. Oggi non posso che rinnovarla aggiungendo
degli argomenti che non interessano solo la nostra nazione ma
voi tutti che siete ansioni della pace del mondo. […]
Voi avete dovuto aggiudicare l’81 per cento di territorio della
Venezia Giulia agli jugoslavi (e anche se ne lagnano come di un
tradimento degli alleati e cercano di accaparrare il resto a mezzo di formule giuridiche costituzionali del nuovo stato). Voi avete
dovuto far torto all’Italia, rinnegando la linea etnica, avete abbandonato alla Jugoslavia la zona di Parenzo-Pola, senza ricordare la Carta Atlantica che riconosce alle popolazioni il diritto
di consultazioni sui cambiamenti territoriali, anzi ne aggravate le
condizioni stabilendo che gli italiani della Venezia Giulia passati
sotto la sovranità slava, che opteranno per conservare la loro
13
10 FEBBRAIO
cittadinanza, potranno entro un anno essere espulsi e dovranno trasferirsi in Italia abbandonando la loro terra, la loro casa,
i loro averi. Che più? I loro beni potranno venire confiscati e
liquidati come appartenenti a cittadini italiani all’estero, mentre
gli italiani che accetteranno la cittadinanza slava saranno esenti
da tale confisca. L’effetto di codesta vostra soluzione è che, fatta
astrazione dal territorio libero, 180 mila italiani rimangono in
Jugoslavia e 10 mila slavi in Italia (secondo il censimento del
1921) e che il totale degli italiani esclusi dall’Italia, calcolando
quelli di Trieste, è di 446 mila; né per queste minoranze avete
minimamente provveduto; mentre noi in Alto Adige stiamo preparando una generosa revisione delle opzioni, ed è già stato
raggiunto un accordo su una ampia autonomia regionale da
sottoporsi alla Costituente. A qual prò dunque ostinarsi in una
soluzione che rischia di creare molti guai, a qual prò voi chiuderete i vostri orecchi alle grida di dolore degli italiani dell’Istria?
Ho presente un elenco degli italiani di Pola che sono pronti a
partire, ad abbandonare terra e focolare, pur di non sottoporsi
al nuovo regime. […] C’è sempre tempo per commettere un
errore irreparabile. Il Trattato sta in piedi, anche se rimangono
aperte alcune clausole territoriali.
(A. De Gasperi, Difendo l’Italia, Roma, Magi-Spinetti, 1946,
pp. 11-12. 18-19. 22. 25-27)
14
r,
Heinrich Himmle
o delle SS
em
comandate supr
Dimensione internazionale
La politica della pulizia
etnica nel ‘900
La 2a guerra mondiale in Jugoslavia
N
ell’Europa centrale e in quella sud-orientale (o balcanica), la disgregazione dell’impero austro-ungarico nel
1918 provocò un mutamento politico di importanza straordinaria. Là dove, per secoli, si era esteso un vasto organismo
territoriale, capace di bilanciare la potenza del Reich tedesco
e della Russia zarista (imperi che, a loro volta, furono travolti
dal conflitto mondiale), i trattati di pace redatti a Parigi nel
1919 crearono una molteplicità di Stati di piccola o media
grandezza. Il criterio fondamentale, ispiratore dei nuovi trattati, fu quello di nazionalità: a fronte di un impero come quello asburgico, in cui l’elemento tedesco (austriaco) e quello
ungherese dominavano su innumerevoli popoli (cosicché in
queste regioni, nel 1914, 60 milioni di persone vivevano sotto
una qualche dominazione straniera), si cercò di costruire degli
Stati nazionali, il più possibile omogenei sotto il profilo etnico
e linguistico-culturale. Indubbiamente, si fecero dei notevoli
progressi rispetto al passato; tuttavia, a causa della complessità della distribuzione delle popolazioni, all’interno di ogni
nuovo Stato si vennero a trovare consistenti minoranze. La situazione, naturalmente, era differente in ogni singolo paese:
resta che, anche con i nuovi confini disegnati nel 1919, circa
30 milioni di individui continuarono a vivere sotto dominazione straniera.
La Jugoslavia fu uno dei numerosi nuovi stati nazionali che
emersero dopo il grande terremoto del 1918. Essa nacque
dall’unione, intorno al regno di Serbia, del Montenegro (un
piccolo regno, indipendente prima del 1914), della Croazia
(sotto dominio ungherese, prima della guerra), della Slovenia e
17
10 FEBBRAIO
della Bosnia-Erzegovina (amministrate da Vienna, fino al 191418). Queste regioni erano tutt’altro che omogenee fra loro per
sviluppo economico e ospitavano popolazioni molto diverse;
croati e sloveni, ad esempio, erano cattolici ed utilizzavano l’alfabeto latino, mentre i serbi erano per lo più ortodossi e facevano uso dei caratteri cirillici (russi). In Bosnia e in Erzegovina,
inoltre, esisteva una consistente minoranza di musulmani, cioè
di abitanti che - pur parlando la stessa lingua dei serbi e dei
croati - al tempo della dominazione degli ottomani avevano
adottato la religione islamica.
L’idea di uno Stato che raggruppasse in un’unica entità territoriale tutti gli jugoslavi (= slavi del Sud) era stata lanciata dagli
intellettuali croati, all’inizio del Novecento, visto che gli ungheresi tendevano a cancellare l’identità linguistica e culturale delle
popolazioni slave residenti nella porzione di impero asburgico
amministrata da Budapest. Alla fine della guerra, tuttavia, quando lo Stato jugoslavo nacque realmente, i rapporti fra serbi e
croati si deteriorarono molto in fretta. I serbi si consideravano
vincitori della guerra (che croati e sloveni avevano combattuto
sotto le bandiere dell’esercito austro-ungarico), e quindi autorizzati ad occupare tutte le principali posizioni di potere all’interno del governo, dell’esercito e della burocrazia statale. Per
protesta, i croati rifiutarono di partecipare alla vita politica del
paese, mentre l’atmosfera si surriscaldò progressivamente, al
punto che l’assassinio politico, clamoroso e plateale, divenne
una prassi corrente: il 20 giugno 1928, in pieno parlamento,
un deputato montenegrino uccise il leader dell’opposizione croata Stjepan Radic; analogamente, il sovrano serbo Alessandro
I fu assassinato il 9 novembre 1934 da un gruppo di terroristi
croati, capeggiato da Ante Pavelic, che voleva la separazione
da Belgrado.
Il 28 ottobre 1940, l’Italia fascista dichiarò guerra alla Grecia.
L’obiettivo di Mussolini era di tipo politico, cioè voleva mostrare
18
IL GIORNO DEL RICORDO
che l’Italia non era una semplice pedina tedesca, bensì poteva
condurre - in piena autonomia e proprie risorse - una guerra parallela, con obiettivi rispondenti solo agli interessi italiani.
L’attacco fu condotto a partire dall’Albania, un piccolo regno
che l’Italia aveva occupato nell’aprile del 1939, dopo che la
Germania si era impadronita, in marzo, della Cecoslovacchia.
Mussolini immaginava una campagna rapida, capace di portare gloria e prestigio al regime. All’opposto, incontrò una tenacissima resistenza greca, mentre sulle montagne i soldati italiani
dovettero affrontare il freddo invernale con un equipaggiamento scadente e inadeguato. Insomma, l’insuccesso fu totale, e il
risultato fu del tutto opposto a quello sperato. L’esercito italiano
fu salvato dalla completa disfatta solo in virtù del tempestivo intervento tedesco nei Balcani, nell’aprile 1941. Per accedere alla
Grecia, i tedeschi dovettero attraversare i territori della Bulgaria
e della Jugoslavia. La prima accettò di collaborare, facilitò il
transito dei tedeschi sulle proprie strade e fu ricompensata con
l’annessione della Tracia e della Macedonia: due regioni che i
greci avevano conquistato nel 1913, e che i bulgari rivendicavano come parte integrante del proprio territorio nazionale. La
Jugoslavia, invece, tentò di opporsi alle richieste tedesche e fu
punita con la completa disintegrazione politica.
Quando il paese venne smembrato per volontà di Hitler, la parte settentrionale della Slovenia fu annessa al Reich, mentre Lubiana (in Slovenia) e la zona centrale della Dalmazia diventarono italiane; inoltre, nacque uno stato indipendente di Croazia,
guidato dal movimento ultranazionalista degli ustascia (ribelli)
di Pavelic. Il nuovo stato comprendeva, oltre la Croazia propriamente detta, anche la Bosnia-Erzegovina ed altre terre abitate
da serbi. I musulmani furono considerati cittadini a pieno titolo
del nuovo Stato; serbi, ebrei e zingari, invece, furono oggetto
di una feroce politica di repressione, di deportazione e di massacro. Le cifre di queste violenze compiute dagli ustascia sono
19
10 FEBBRAIO
enormi: la Croazia vide l’uccisione di 28 mila zingari e di un
numero di serbi che, a seconda delle stime degli storici, oscilla
fra le 300 mila e le 600 mila vittime.
Alle forze degli invasori e degli ustascia si opposero due movimenti di resistenza, che non operarono mai insieme, ed anzi
spesso si combatterono a vicenda. Il primo comprendeva i cosiddetti cetnici, partigiani nazionalisti serbi fedeli alla monarchia; il secondo invece, guidato dal croato Josip Broz (detto
Tito), era di orientamento comunista e raccoglieva uomini di
ogni gruppo etnico jugoslavo.
20
IL GIORNO DEL RICORDO
VIOLENZA ED ESTREMISMO IN JUGOSLAVIA,
NEGLI ANNI TRENTA E QUARANTA
I
l 20 giugno 1928, nell’aula del parlamento di Belgrado,
fu ucciso il leader dell’opposizione croata Stjepan Radic. Si
trattò dell’inizio di una rottura radicale fra serbi e croati, una
frattura etnica e politica che avrebbe dato vita ad una tremenda spirale di violenza, culminata negli anni dell’occupazione
tedesca e italiana.
I funerali di Radic si trasformarono nella grandiosa
manifestazione di un popolo intero [= i croati – n.d.r.]
contro la dominazione straniera [serba – n.d.r.], e in una
chiara dimostrazione della grave frattura ormai esistente tra
Zagabria e Belgrado. Meno appariscente, ma forse ancor
più significativa, fu la concorde decisione degli scrittori croati
di ritornare alla versione tradizionale della lingua letteraria,
marcando così la propria differenza con i serbi. Alessandro
Karadjordjeic [sovrano del regno di Serbia e dell’intero Stato
jugoslavo – n.d.r.] non seppe captare questi segnali di un
progressivo distacco del popolo croato dalla realtà politica e
statale da lui capeggiata; al contrario, pensò di risolvere ogni
problema con la dittatura personale e la proclamazione ex
cathedra di un patriottismo jugoslavo nuovo di zecca che non
convinse nessuno, essendo il potere in mano ai personaggi
più biechi dell’establishment serbo. In tale situazione
riemerse il nazionalismo croato nella sua espressione più
aggressiva e irrazionale: se ne fece portavoce […] Ante
Pavelic, il quale nel ’29 fuggì all’estero per organizzare,
sul modello dell’organizzazione terroristica macedone, un
proprio nucleo di ribelli: gli ustascia. Il movimento ottenne
21
10 FEBBRAIO
l’appoggio dell’emigrazione croata, di quella macedone,
ma soprattutto dell’Italia mussoliniana e dell’Ungheria di
Horthy [l’ammiraglio Miklos Horthy, a guida di un governo
autoritario in Ungheria dal 1920 al 1944 – n.d.r.], decise
a minare dall’interno la monarchia dei Karadjordjeic per
accelerarne il crollo. E appunto in Italia e in Ungheria Pavelic
poté organizzare campi di addestramento per i suoi fanatici
seguaci col proposito di inviarli in Jugoslavia – come ormai lo
stato si chiamava – per compiervi atti terroristici e attentare
alla vita del re. Un primo tentativo, organizzato nel dicembre
’33 durante una visita di Alessandro a Zagabria, fallì
miseramente; il secondo, attuato l’anno successivo all’inizio
di un viaggio ufficiale del re in Francia, sarebbe stato invece
coronato da successo. […]
L’invasione della Jugoslavia da parte delle forze dell’Asse
fu salutata da molti croati come una liberazione: quando le
truppe della Wehrmacht entrarono a Zagabria il 10 aprile
1941, furono accolte in modo fin troppo trionfale: si videro
ragazze lanciarsi a baciare le ruote dei camion tedeschi!
Lo stesso giorno un seguace di Pavelic, il quale si trovava
ancora in Italia, proclamò la nascita dello Stato indipendente
croato, che avrebbe dovuto finalmente includere nelle sue
frontiere, almeno ad est, tutto il territorio considerato proprio
dai croati. Essi ottennero infatti l’intera Bosnia-Erzegovina,
ma in cambio dovettero cedere all’Italia gran parte della
Dalmazia, subendo inoltre l’onta di un re straniero imposto
da Mussolini e scelto nella persona di un infelice e riluttante
principe di casa Savoia: Aimone d’Aosta. Se con questa
politica i fascisti s’illudevano di trasformare la Croazia in
uno stato vassallo si sbagliavano però grossolanamente:
la perdita della Dalmazia alienando agli ustascia molte
22
IL GIORNO DEL RICORDO
simpatie dell’opinione pubblica croata, li spinse tra le braccia
dei tedeschi, che a Pavelic e ai suoi sembrarono alleati più
affidabili e maestri a cui guardare nella creazione dell’Ordine
nuovo, non solo per la loro maggior efficienza militare, ma
anche per la loro capacità di risolvere, una volta per tutte, la
questione ebraica. La soluzione finale che avevano in mente
gli ustascia, in verità, non riguardava tanto gli ebrei e gli
zingari (sebbene anch’essi non fossero risparmiati), quanto
piuttosto i serbi, il cui numero, con l’annessione della BosniaErzegovina allo stato indipendente croato, si accrebbe
ulteriormente. Gli ustascia, animati dalla convinzione che,
a parte i cattolici, non ci fosse posto nel loro stato se non
per i musulmani (considerati […] di <<purissimo sangue
croato>>), decisero di sbarazzarsi dei serbi, costringendo
un terzo di essi all’esilio, massacrandone un altro terzo e
ribattezzando gli altri secondo il rito cattolico per trasformarli
in veri croati. Tali aberranti propositi furono messi in pratica
con feroce determinazione e attraverso la creazione di
lager di sterminio come quello terribile di Jasenovac, che
si iscrissero nella mappa della moderna barbarie europea
con lettere d’indelebile vergogna. Le masse popolari croate,
quasi cloroformizzate da un imbelle partito contadino e da
una Chiesa cattolica oscillante tra la collaborazione con gli
ustascia e una resistenza fin troppo passiva ai loro crimini,
rimasero a lungo assenti nella grande bufera che sconvolgeva
il continente, lasciando ai serbi e ai pochi comunisti croati il
compito di animare la resistenza. […]
Nella primavera del ’45 Ante Pavelic e tutti coloro che negli anni
della guerra s’erano compromessi con il suo regime cercarono
scampo, quando furono in grado, in territori vicini occupati
dagli anglo-americani. A centinaia di migliaia si riversarono
23
10 FEBBRAIO
verso il Friuli e la Carinzia sperando di trovare, nel nome
del comune anticomunismo, favorevole accoglienza presso
gli occidentali. Questo calcolo non era del tutto sbagliato,
poiché molti riuscirono a salvarsi e a riparare in Argentina, in
Australia, negli Stati Uniti o in Canada grazie all’aiuto delle
autorità inglesi, americane o vaticane; qualcosa si inceppò
invece in Carinzia, dove, nel maggio del ’45, gli inglesi
decisero, per ragioni che sono tuttora oggetto di discussione
tra gli storici, di riconsegnare a Tito i collaborazionisti che si
trovavano in quella regione di frontiera. Fingendo di volerli
inviare in Italia, li caricarono su treni merci e li spedirono
al di là delle Caravanche [catena montuosa al confine tra
Slovenia e Austria – n.d.r.], dove li aspettavano truppe scelte
incaricate della loro liquidazione; coloro che non furono
ammazzati subito in Slovenia conobbero una via crucis che
li portò tra inenarrabili sofferenze e umiliazioni in patria,
dove la maggioranza perse la vita senza potersi difendere
né subire regolare processo. Alle violenze commesse dagli
ustascia (e dai loro alleati musulmani) contro i serbi e i
partigiani, e da questi nei confronti dei collaborazionisti in
genere, si aggiunsero così anche gli orrori perpetrati dai
comunisti, dopo la vittoria, sui nemici interni. Il popolo croato
ne uscì mutilato, traumatizzato da un’esperienza terribile,
diviso come non era mai stato nella sua storia. Ai croati
rimasti in patria si affiancò infatti una diaspora rabbiosa e
bellicosa, niente affatto disposta a riconoscere i propri errori
e a trarne qualche insegnamento ma decisa, al contrario, ad
attendere il momento della rivincita.
(J. Pirjevec, Serbi, croati, sloveni. Storia di tre nazioni, Bologna,
Il Mulino, 1995, pp. 107-112)
24
IL GIORNO DEL RICORDO
IL REGIME DEGLI USTASCIA CROATI
I
n Jugoslavia, la seconda guerra mondiale innescò un devastante meccanismo di violenza etnica, allorché il movimento
fascista degli ustascia fu posto a guida della Croazia, che Hitler decise di creare, dopo aver disgregato il Paese. C’è solo
un altro caso di cancellazione totale di un’entità statale da
parte del Führer, quello della Polonia. In entrambi i casi, si
trattava di Stati sorti a seguito dell’odiato trattato di Versailles;
per Hitler, distruggerne l’esistenza significava annullare le conseguenze della disfatta tedesca nel 1918.
Lo stato croato è fondato sul principio dell’autorità assoluta
del capo: il Poglavnik Pavelic concentra infatti tutti i poteri.
Viene instaurato un regime a partito unico a vantaggio
del movimento degli ustascia, affiancato dalla sua milizia
armata. I contadini sono proclamati fondamento della vita
nazionale e del potere dello stato, ma il partito contadino
viene sciolto come gli altri partiti e il suo leader Macek è
messo agli arresti domiciliari e poi internato nel campo di
concentramento di Jasenovac dal 15 ottobre 1941 al 16
marzo 1942. Due decreti datati 30 aprile 1941 fissano le
misure per la <<protezione del sangue ariano e dell’onore
del popolo croato>> contro ebrei, serbi e altri. Un
decreto del 17 aprile rende passibile di morte chiunque
attenti all’autorità dello stato o ne abbia – anche senza
conseguenze – l’intenzione e istituisce 34 tribunali speciali.
La pena di morte è esecutiva nelle tre ore che seguono la
sentenza.
Lo stato ustascia è infatti in mano a un potere essenzialmente
terroristico. Vengono aperti ventiquattro campi di
25
10 FEBBRAIO
concentramento e il governo croato provoca diverse stragi
tra la popolazione serba per croatizzarla e costringerla
a convertirsi al cattolicesimo romano. Il 22 luglio 1941 il
ministro dei Culti Mile Budak dichiara a Gospic [cittadina
della Croazia centrale – n.d.r.]: <<Noi uccideremo una
parte dei serbi, ne deporteremo un’altra e quella restante,
che sarà costretta ad abbracciare la religione cattolica,
si vedrà assorbita nell’elemento cattolico>>. Vengono
impartite direttive perché non siano accettate le conversioni
dei quadri sociali serbi (industriali, commercianti, intellettuali,
contadini agiati); anche agli ebrei è vietato convertirsi. In
compenso gli ustascia procedono a conversioni collettive
nei confronti degli strati più bassi della popolazione serba
degne delle persecuzioni dei dragoni di Luigi XIV contro i
calvinisti francesi. Secondo diverse fonti tedesche sarebbero
stati massacrati da 400.000 a 750. 000 serbi, tra cui 300
sacerdoti e 5 vescovi ortodossi. Tuttavia nella parte del paese
occupata dalle loro truppe gli italiani svolgevano piuttosto
il ruolo di protettori dei serbi e degli ebrei, che comunque
furono quasi tutti sterminati. Gli stessi occupanti tedeschi
finirono per trovare eccessivo questo regime di terrore
(vi si opposero a partire dalla seconda metà del 1942),
forse semplicemente perché esasperava la popolazione
e allargava l’influenza della resistenza jugoslava, a capo
della quale si trovava il croato Josip Broz detto Tito.
Tra i responsabili dei campi di concentramento troviamo,
non senza rimanerne sbigottiti, un discepolo del più <<non
violento>> tra gli eletti della Chiesa cattolica, il francescano
Miroslav Filipovic-Majstorovic, che aveva rinunciato al
bigello [= saio – n.d.r.] monastico per l’uniforme ustascia.
Il clero cattolico (con il vescovo di Zagabria monsignor
26
IL GIORNO DEL RICORDO
Stepinac in testa) aveva dichiarato di <<salutare con gioia
la proclamazione dello stato indipendente di Croazia>>.
Tuttavia il presule di Zagabria aveva protestato con
discrezione contro le conversioni forzate e ricordato nelle sue
lettere pastorali il principio della libertà della conversione. Il
numero di Natale 1941 del Giornale di Zagabria pubblicava
tuttavia una poesia in onore del Poglavnik, frutto della penna
dell’arcivescovo di Sarajevo Ivan Saric: <<Di una guida
come te il popolo / croato ha bisogno come del pane…
/ La Croazia possiede in lui / la felicità del cielo / o tu,
nostra guida adorata>>. Tutto ciò va un po’ oltre i ditirambi
dei prelati francesi che tessevano le lodi della persona del
maresciallo [Henri Philippe Petain – n.d.r.], il quale peraltro
non conduceva una politica tanto determinata a favore
della conversione al cattolicesimo. Sembra invece che il
Vaticano abbia dato il suo appoggio al regime ustascia e
al suo operato. Pio XII aveva ricevuto il Poglavnik in udienza
privata nel maggio 1941, nonché una delegazione della
milizia ustascia, guidata dal suo capo Dido Kvaternik; tutto
questo mentre, come ha scritto Ernst Nolte, <<la Croazia si
trasformava effettivamente durante la guerra in un grande
battistero e allo stesso tempo in un gigantesco macello>>
per mezzo degli ustascia, fascisti e collaborazionisti.
(Y. Durand, Il nuovo ordine europeo. La collaborazione nell’Europa tedesca (1938-1945), Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 135137. Traduzione di A. Romanello)
27
10 FEBBRAIO
I progetti razziali nazisti
N
el settembre-ottobre 1939, l’esercito tedesco conquistò
con notevole facilità la Polonia occidentale, mentre i sovietici invadevano le regioni orientali della Polonia stessa. I
russi, inoltre, conquistarono anche le tre repubbliche baltiche:
Lituania, Lettonia ed Estonia. In tali territori, caduti sotto controllo comunista, si trovavano numerosi Volksdeutsche, cioè
tedeschi etnici, ovvero elementi di lingua e cultura germanica,
che vivevano tuttavia fuori dall’area geografica a maggioranza tedesca (ovvero, nel 1939-1940, fuori dal Terzo Reich).
Questa comunità era il lascito di una vasta infiltrazione, che si
era spinta fino all’estremità orientale del Baltico nel corso del
Medioevo, quando l’Europa visse una straordinaria stagione
di incremento demografico e fu necessario trovare in Prussia,
in Polonia e in Lituania (regioni scarsamente popolate, nel XIII
secolo) terre e risorse per la popolazione tedesca in esubero.
Spesso, i coloni si mossero sotto la protezione armata dei Cavalieri teutonici, un ordine monastico militare affine a quello
dei Templari, che riuscì a costruire un piccolo stato territoriale nell’Europa del Nord, sul Baltico; la loro azione trovava
giustificazione nel fatto che gran parte delle popolazioni di
queste regioni di frontiera erano ancora pagane, cosicché le
loro terre potevano essere conquistate senza troppi scrupoli,
con il pretesto dell’evangelizzazione. Hitler si ripropose di rilanciare questa spinta verso est del popolo tedesco e il suo
obiettivo supremo era la creazione di un vasto spazio vitale
che garantisse alla razza ariana le risorse indispensabili alla
sopravvivenza e allo sviluppo. L’invasione dell’URSS (iniziata il
22 giugno 1941) fu l’esito coerente di tali progetti imperiali
a lunga scadenza: nell’immediato, però, Hitler e Himmler (il
capo delle SS) si proposero di permettere ai tedeschi etnici
delle regioni del Baltico di sfuggire alla dominazione comuni-
28
IL GIORNO DEL RICORDO
sta sovietica. A questa motivazione politica immediata se ne
aggiungeva un’altra, di tipo ideologico: i Volksdeutsche spesso erano idealizzati da Himmler, che li considerava portatori
delle più pure doti razziali tipiche dei veri ariani; infatti, per
non essere travolti dalla marea etnica circostante, nella quale
erano inseriti e dalla quale volevano restare distinti, essi - così
si diceva - si erano sempre sposati solo tra loro, rimanendo
integri da qualsiasi contaminazione, mentre il contatto diretto
con la terra e l’attività agricola li avevano preservati dal materialismo e dagli altri vizi connessi all’urbanesimo moderno e
al processo di industrializzazione.
L’operazione di emigrazione dei tedeschi etnici fu denominata
Heim ins Reich (cioè A casa, nel Reich) e fu accolta con entusiasmo dagli interessati: in media, aderì l’80-90% di coloro
che furono giudicati in possesso dei requisiti necessari per la
partenza. Nel giro di pochi mesi, rientrarono in Germania circa
500.000 Volksdeutsche: 84.000 dalla Lettonia e dall’Estonia;
circa 30.000 dalla Lituania; circa 180.000 dalle regioni polacche conquistate dall’Armata rossa; 400.000 dalla Romania e
60-70.000 dall’area di Bolzano, in Italia. Una volta completata
l’operazione di ritorno, il problema vero fu quello di garantire a questi immigrati una dignitosa sistemazione all’interno del
Reich; la prima decisione che venne presa fu quella di insediarli
all’interno delle regioni più occidentali della Polonia: terre appena conquistate e annesse a tutti gli effetti al Reich (coi nomi di
Gau Wartheland e Gau Danzica-Prussia Occidentale), mentre
nel resto del territorio polacco dominato dai nazisti veniva creata una specie di colonia denominata Governatorato generale.
L’idea che animava Hitler e Himmler era a un tempo radicale
e feroce: l’intera popolazione polacca ed ebraica (8-9 milioni
di persone) che viveva nei due distretti (Gau) del Wartheland e
della Prussia Occidentale sarebbe stata spostata a forza, per
lasciare posto ai nuovi arrivati. Anche per una simile soluzio-
29
10 FEBBRAIO
ne, però, i problemi non mancavano, in quanto era giudicato
comunque opportuno conservare un certo numero di polacchi,
da sfruttare come braccianti nei campi e manodopera non qualificata nelle industrie; sul versante opposto, Hans Frank, a capo
del Governatorato, dichiarò invece che il territorio da lui diretto
era già sovrappopolato: soprattutto nelle città, immettere altre
grandi masse avrebbe comportato gravi conseguenze di ordine
alimentare e di tipo igienico (col rischio di epidemie).
All’inizio del 1940, tutti gli ebrei polacchi furono rinchiusi in
ghetti, all’interno delle città più importanti. Nel medesimo tempo, mentre a Berlino si pensava di svuotare il Wartheland e
di rovesciare il suo contenuto etnico più <<scadente>> nel
Governatorato, vennero valutate numerose ipotesi, finalizzate a
liberare anche quest’ultimo, per far posto a chi sarebbe venuto
dalle terre situate più ad occidente. È in questo contesto che
nacque il progetto di costruire una riserva ebraica nella regione
di Lublino e soprattutto che si lavorò al grande piano Madagascar, finalizzato a deportare tutti gli ebrei della Polonia in quella
remota isola dell’Africa. Entrambi i progetti si rivelarono assolutamente impraticabili, ma l’idea di trovare nuovi spazi a oriente,
che consentissero di riorganizzare l’intero assetto etnico e demografico (razziale, dicevano ovviamente i nazisti) dell’Europa
tornò improvvisamente praticabile dopo le prime clamorose
vittorie in URSS, nell’estate-autunno del 1941. Mentre pareva
realistico deportare tutti gli ebrei nell’estremo est della Russia
o in Siberia, si giunse allora ad elaborare il Piano generale
orientale (Generalplan Ost), per la creazione del quale Himmler poté contare sul contributo di numerosi geografi, economisti
ed agronomi. La versione più ampia e radicale del Piano risale
al maggio 1942, in una fase in cui per gli ebrei si era già deciso
di risolvere il problema della loro presenza mediante lo sterminio totale; il Generalplan Ost, pertanto, di fatto parla solo degli
slavi, che a milioni avrebbero dovuto abbandonare l’Ucraina
30
IL GIORNO DEL RICORDO
e le altre regioni occidentali dell’URSS, per lasciare posto ad
una massiccia emigrazione di coloni tedeschi, che a quel punto
avrebbero avuto lo spazio vitale sognato da Hitler. Di lì a pochi
mesi, però, la disfatta di Stalingrado avrebbe rimesso in discussione le sorti della guerra e con essa, ovviamente, anche tutti i
progetti di spostamenti di grandi masse di popolazione previsti
da Himmler e dai suoi collaboratori.
31
10 FEBBRAIO
I PROBLEMI LEGATI AL RIMPATRIO DEI
VOLKSDEUTSCHE
I
nizialmente, numerose delle decisioni più gravi del Terzo Reich
furono legate alla scelta di richiamare in patria il maggior
numero possibile di Volksdeutsche, i tedeschi che, in gran numero, vivevano fuori dai confini della Germania e soprattutto
nei territori controllati dall’URSS. Si creò così una situazione
paradossale in cui mancava sempre spazio per qualcuno e
qualcun altro doveva essere – nei progetti nazisti – spostato
e reinsediato <<più ad Est>>. Infine, si decise che, per gli
ebrei, la soluzione più rapida era quella dello sterminio.
All’inizio del mese di ottobre del 1939 Heinrich Himmler
venne posto alla guida del RKFV (Reichskommissar für
die Festigung deutschen Volkstums – Commissariato del
Reich per il rafforzamento della nazionalità tedesca), e
senza perdere tempo avviò una politica di insediamenti e
reinsediamenti di vasta portata, che da un lato mirava a
espellere la popolazione autoctona di etnia polacca e gli
ebrei dai territori annessi, dall’altro aveva come obiettivo il
reinsediamento all’interno dei confini del Reich dei tedeschi
del Baltico <<rientrati in patria>> e il trasferimento nei
territori incorporati degli altri gruppi di tedeschi provenienti
dall’Europa centro-orientale e orientale. Una politica,
quella di Himmler, che era la conseguenza del ritorno,
sancito dal trattato d’amicizia e di demarcazione dei confini
tra Germania e l’Unione Sovietica siglato il 28 settembre
1939, delle minoranze tedesche che ricadevano nella sfera
d’influenza di Mosca. Nei mesi successivi, il fatto di dover
agire in fretta, che fu un’inevitabile conseguenza dell’intesa
32
IL GIORNO DEL RICORDO
con l’Unione Sovietica <<voluta>> in pratica dallo stesso
governo del Reich, avrebbe influenzato in modo determinante
la politica in tema di questione ebraica. L’assoluta necessità
di trovare nel giro di poco tempo abitazioni e posti di lavoro
per diverse centinaia di migliaia di immigrati – cosa che si
sarebbe dovuta ottenere mediante la confisca dei beni di
proprietà di polacchi ed ebrei e il reinsediamento forzato dei
contadini polacchi – fu un fattore che contribuì notevolmente
all’intensificazione della persecuzione antiebraica, anche se
le misure adottate furono dirette in primo luogo contro gli
agricoltori, gli artigiani, i commercianti e i piccoli industriali
polacchi. Il programma di reinsediamenti di Himmler funse
quindi da catalizzatore al fine di accelerare l’eliminazione
degli ebrei in primo luogo dai territori incorporati e in seguito
dallo stesso Reich e dal Protettorato di Boemia e Moravia.
Fino ad allora, i pianificatori dello SD [i servizi segreti
delle SS – n.d.r.] non avevano preso in considerazione la
possibilità di effettuare deportazioni su vasta scala, ma da
quel momento in poi il ricorso a tale metodo si generalizzò,
anche perché apparve il più ovvio per far uscire la soluzione
della questione ebraica dalle secche in cui si trovava.
L’effetto di radicalizzazione indotto dalla <<ricomposizione
fondiaria>> su base etnica voluta da Himmler si manifestò
anche nel fatto che gli uffici incaricati del reinsediamento
dei Volksdeutsche non ebbero timore, per mettere a
disposizione gli ospedali e gli ospizi necessari, di far ricorso
all’<<eutanasia>>, ciò che fecero chiedendo l’intervento
del personale impiegato nell’attuazione del programma
T4 (dall’indirizzo di Berlino – Tiergartenstrasse 4 – dove
avevano sede gli uffici preposti alle operazioni). Come
Götz Aly ha mostrato, nel quadro del <<programma
33
10 FEBBRAIO
di reinsediamento>> le SS eliminarono più di diecimila
malati di mente, prima nella vasta zona comprendente le
città portuali di Danzica, Swinemünde e Stettino e poi nel
Warthegau. La stretta relazione fra le misure di eutanasia e
il programma di reinsediamento è evidente, anche se i diretti
interessati non hanno lasciato dietro di sé praticamente nulla
di scritto, e inoltre manca, in merito alle misure adottate,
un ordine formale. Nel periodo in questione, all’interno dei
confini del Reich l’attuazione del programma di eutanasia
era solo all’inizio, e tutto lascia ritenere che anche a questo
riguardo la politica di reinsediamento abbia notevolmente
contribuito alla sua accelerazione.
Per preparare il previsto <<rientro in patria>> dei tedeschi
del Baltico, il 30 ottobre 1939 Himmler ordinò l’espulsione
di circa 500 mila ebrei e polacchi dal Warthegau, da
Danzica e dalla Prussia occidentale. In base al suo ordine,
gli ebrei avrebbero dovuto essere deportati in un non meglio
precisato territorio di reinsediamento compreso tra la
Vistola e il Bug, mentre tutte le misure finalizzate allo scopo
avrebbero dovuto essere eseguite entro il febbraio del 1940.
Entrambe le disposizioni si rivelarono del tutto inattuabili,
dal momento che non c’erano sufficienti mezzi di trasporto
disponibili e, soprattutto, spostamenti di popolazione di
quest’ordine di grandezza non potevano essere attuati in
tempi così rapidi. Heydrich [responsabile della polizia del
Terzo Reich e suprema autorità delle SS, subito dopo Himmler
– n.d.r.], quindi, si vide costretto a ridimensionare le direttive
emanate, e il 28 novembre intervenne da Berlino ordinando,
sotto forma di piano a breve termine, la deportazione nel
Governatorato generale di 80.000 persone dalle province
occidentali polacche già annesse. […]
34
IL GIORNO DEL RICORDO
Götz Aly ha mostrato che l’operazione di trasferimento
che ebbe luogo a Stettino tra il 12 e il 13 febbraio 1940
– operazione che coinvolse quasi tutta la locale comunità
ebraica e più di 1.100 persone – venne concepita e portata
a termine soprattutto con uno scopo: fare in modo che i
Volksdeutsche potessero trovare una qualche occupazione
legata al mare. Gli stessi treni già utilizzati per trasportare a
Stettino i coloni furono impiegati anche per la deportazione
degli ebrei, che ebbe luogo in condizioni a dir poco
terribili e provocò un gran numero di vittime. Non molto
diversamente andarono le cose un mese più tardi, quando si
procedette alla deportazione di 160 ebrei da Schneidemühl.
La crescente opposizione di Hans Frank alle deportazioni
nel Governatorato generale impedì in pratica a Heydrich,
che pure inizialmente aveva potuto contare sull’appoggio
di Himmler, di attuare il secondo piano a breve termine,
che prevedeva la deportazione di 220 mila ebrei e polacchi
dai territori incorporati. I programmi ancora più ambiziosi
che prevedevano nel lungo periodo la deportazione e
il reinsediamento di circa tre milioni e quattrocentomila
polacchi si rivelarono nient’altro che chimere. Se si
eccettuano le deportazioni da Stettino e da Scheidemühl,
il trasferimento nel Governatorato generale venne prima
bloccato e alla fine anche vietato con un decreto di Göring
del 23 marzo 1940 con cui la rinuncia al piano veniva messa
in relazione con la concentrazione degli ebrei nella regione
di Lublino.
(H. Mommsen, La soluzione finale. Come si è giunti allo sterminio degli ebrei, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 104-107.
Traduzione di E. Morandi)
35
10 FEBBRAIO
I PIANI DI HIMMLER SUL NUOVO ORDINE A
ORIENTE
N
el periodo compreso tra l’estate 1941 e l’autunno 1942,
l’avanzata tedesca in URSS sembrò destinata alla vittoria
(malgrado la battuta d’arresto subita dalla Wehrmacht nel dicembre 1941, davanti a Mosca). Himmler, pertanto, affidò ad
una vera schiera di esperti il compito di ridisegnare l’assetto
razziale del nuovo spazio vitale che sarebbe stato a disposizione del popolo tedesco per i mille anni a venire.
Come durante l’occupazione della Polonia, un piccolo
esercito di esperti accademici fu chiamato ad esprimersi
sul destino dell’Unione Sovietica. Senza rivali nel darsi
importanza, andavano e venivano nei corridoi del potere,
esempio ridicolo e insieme spaventoso dell’adagio che
poche cose sono più pericolose di <<un po’ di cultura>>,
specialmente quando si accompagni al gusto egocentrico
del protagonismo a buon mercato. Fu questo, senza dubbio,
il caso dell’SS-Oberführer professor Konrad Meyer, un
giovane agronomo particolarmente abile nel trasformare
le stravaganti ruminazioni di Himmler in freddi schemi
tecnocratici di pulizia etnica, anche se non va sottovalutato
lo strato di autentica follia probabilmente nascosto, nell’uno
e nell’altro, dietro una normalità di facciata. Si direbbe che
per Himmler fosse rilassante chiacchierare con persone
siffatte di spessore dei muri delle fattorie e di struttura dei
villaggi contadini, dopo giorni e giorni di gestione di un
tetro impero di polizia su scala continentale. Essendosi fatto
un nome con l’espulsione di polacchi e ebrei dai territori
annessi al Reich, Meyer fu incaricato di redigere un piano
36
IL GIORNO DEL RICORDO
comprendente l’area assai più ampia conquistata nella fase
iniziale dell’Operazione Barbarossa. Perfino tra le SS, la
pianificazione era un settore sovraffollato. In un discorso
inaugurale dell’ottobre 1941, a Praga, di fronte ad alti
esponenti del regime, il nuovo Reichsprotektor Reinhard
Heydrich illustrò la sua concezione degli insediamenti
nell’est. Ci sarebbero stati due universi etnici: i popoli affini
ai tedeschi, da trattare in modo relativamente decente; e
più a oriente, una massa di iloti slavi che l’élite guerriera
germanica avrebbe governato col pugno di ferro. Un po’
come in Olanda si era rubata terra al mare, lo spazio vitale
germanico sarebbe stato strappato al mare della subumanità slava tramite una barriera esterna di agricoltorisoldati, e un anello successivo di insediamenti germanici in
graduale espansione.
Verso la fine del 1941, l’Ufficio centrale per la sicurezza
del Reich [diretto da Heydrich – n.d.r.], un’istituzione delle
SS, preparò anch’esso un piano generale per l’est, il cui
contenuto si può inferire dalle critiche a esso rivolte dal dottor
Erhard Wetzel, il funzionario preposto alla politica razziale
nell’OMi [Ostministerium o Ministero per l’Est: il fatto che
due o più soggetti si occupassero in modo concorrenziale
della stessa questione era un fenomeno tipico all’interno
dell’amministrazione nazista, attraversata da furiosi conflitti
di competenza e da lotte di potere, al punto che il regime
stesso è denominato <<policrazia>> da numerosi storici –
n.d.r] di Rosenberg. La sua realizzazione avrebbe richiesto,
a guerra vinta, una trentina d’anni. […] I pianificatori delle
SS pensavano a un trasferimento a est di una decina di
milioni di coloni tedeschi, e al concomitante trasferimento
in Siberia di un numero di indigeni compreso tra 31 e 45
37
10 FEBBRAIO
milioni. Qui Wetzel corresse puntigliosamente l’aritmetica
SS, il numero di 45 milioni apparendo sia troppo basso,
sia inquinato da cinque-sei milioni di ebrei dei quali ci si
sarebbe dovuti <<disfare>> prima della colonizzazione.
Secondo Wetzel, gli abitanti interessati erano 60-65 milioni,
dei quali da 46 a 51 milioni erano da trasferire. Inoltre, le
deportazioni sarebbero avvenute in base a una percentuale
dipendente dalla nazionalità. Così i polacchi, da 20 a 24
milioni di persone, erano da trasferire nella misura dell’80
per cento. Quanto alla destinazione, Wetzel scartò la
Siberia (che ne avrebbe sofferto nella funzione di baluardo
rispetto alla Russia interna), concedendo che <<non ci si
può sbarazzare dei polacchi come degli ebrei>>. Optò
quindi per l’invio dell’intellighenzia polacca in Brasile, in
cambio del rimpatrio di polacchi di etnia tedesca, mentre il
resto dei polacchi sarebbe finito in Siberia dove, insieme ad
altri gruppi lì trasferiti, avrebbe formato un miscuglio etnico
<<americanizzato>> e separato dalla popolazione di
origine russa. Rimproverando le SS per la scarsità di proposte
sull’etnia russa, Wetzel si profuse in consigli su come limitarne
la fecondità. A una massiccia distribuzione di preservativi
sarebbe dovuta seguire la <<riqualificazione>> delle
ostetriche come abortiste e la dequalificazione programmata
dei pediatri, la sterilizzazione volontaria e l’abbandono
delle misure igieniche e profilattiche per la diminuzione
della mortalità infantile. Gli evidenti errori statistici e le
illogicità del piano dell’RSHA [= l’Ufficio centrale per la
sicurezza del Reich – n.d.r.] indussero Himmler a rivolgersi
al più pragmatico Meyer. In maggio questi consegnò
il memorandum <<Generalplan-Ost: basi giuridiche,
economiche e territoriali dello sviluppo all’est>>. Il piano,
38
IL GIORNO DEL RICORDO
che ci è giunto solo sunteggiato, prevedeva la creazione di
tre vaste marche di insediamento (Ingermanland, MemelNarew e Gotengau) con popolazione al 50 per cento
tedesca, collegate col Reich a intervalli di 100 chilometri da
36 roccaforti d’insediamento con popolazione tedesca al 25
per cento. La realizzazione di questo piano avrebbe richiesto
25 anni, avrebbe coinvolto cinque milioni di coloni tedeschi
e sarebbe costata 66 miliardi di Reichsmark. Himmler
gradì la deliberata esclusione dell’OMi dalle decisioni sulle
marche, ma voleva un calendario accorciato di cinque
anni, l’inserimento di Alsazia-Lorena e Boemia-Moravia nel
piano, e la germanizzazione accelerata del Governatorato
Generale e di parte del Baltico. Meyer fu incaricato di stilare
un nuovo progetto che recepisse tali modifiche.
(M. Burleigh, Il Terzo Reich, Milano, Rizzoli, 2003, pp. 607609. Traduzione di C. Capararo, S. Galli, M. Mendolicchio)
39
10 FEBBRAIO
Turchi, Russi, Polacchi e Tedeschi
È
opinione ampiamente condivisa fra gli storici che le travagliate vicende dell’impero ottomano negli anni 1912-1920
siano state d’esempio e di modello per la politica successiva
di numerosi altri stati, primi fra tutti i regimi totalitari nazista e
comunista. Per quanto riguarda la pulizia etnica, va ricordato
che, nell’ottobre del 1912, la Serbia decise di approfittare della difficile situazione in cui si trovava l’impero turco, impegnato contro l’Italia, determinata a conquistare la Libia. La Serbia
si alleò con il Montenegro, la Grecia e la Bulgaria; uniti nella
Lega balcanica, questi paesi attaccarono a loro volta l’impero
ottomano, che fu pesantemente sconfitto.
La Serbia vittoriosa conquistò il Kosovo, un territorio che ospitava
numerosi monasteri ortodossi e migliaia di serbi, ma era abitato
anche da moltissimi contadini albanesi, di religione musulmana. I kosovari albanesi furono eliminati a centinaia, in modo da
ridurre drasticamente il loro numero, a vantaggio della popolazione serba. Secondo alcuni storici, la brutale operazione di
pulizia etnica compiuta dai serbi in Kosovo nel 1912 è un chiaro
segnale della violenza assoluta che, di lì a poco, avrebbe travolto
l’intero continente. Ma – presagio ancora più fosco - quelle violenze furono un primo tentativo di soluzione violenta di problemi
demografici, di lì a poco ampiamente imitato da numerosi altri
soggetti, desiderosi di semplificare situazioni complesse, in cui
molteplici etnie si intrecciavano. Per molti versi, pare lecito individuare nell’azione dei serbi il prototipo di quanto avrebbero fatto i
turchi nei confronti degli armeni in Asia Minore (1915), i polacchi
e i cechi nei confronti dei tedeschi (1945) e i comunisti jugoslavi
nei confronti degli italiani in Istria e nella Venezia Giulia (1945).
In Asia Minore, i turchi uccisero più di un milione di armeni; in
questa sede, è però opportuno precisare che l’obiettivo primario
del governo turco era quello di liberare da una potenziale quinta
40
IL GIORNO DEL RICORDO
colonna un’area decisiva sotto il profilo strategico, ai confini del
nemico russo. La morte di massa degli armeni avvenne dunque
in concomitanza con una vasta operazione di trasferimento forzato: anzi, in ultima analisi, fu l’esito e l’atto conclusivo di questa
azione, in larga parte condotta in modo affatto improvvisato, e
per questo destinata a risolversi in catastrofe, anche nel caso in
cui (e su questo punto la discussione storiografica è, a dir poco,
incandescente) il massacro non fosse stato programmato in anticipo. Per molti aspetti, la deportazione degli armeni (compreso
il suo tragico epilogo nei deserti della Siria) assomiglia all’operazione di liquidazione dei kulaki condotta da Stalin negli anni
1930-1931. Ovviamente, dobbiamo precisare che i contadini
sovietici (sprezzantemente chiamati kulaki, cioè sfruttatori) non
erano una nazione, un’etnia, bensì un gruppo sociale, una classe, nel linguaggio comunista del tempo. La procedura, però, fu
per molti versi analoga: arresto in massa di intere famiglie (nel
caso degli armeni, però, molti dei maschi adulti furono immediatamente fucilati), deportazione in zone periferiche e del tutto
prive di strutture idonee alla ricezione dei nuovi arrivati, morte di
massa per colpevole negligenza delle autorità, che si disinteressarono completamente di quanto accadeva ai deportati.
Alcuni dei gravi crimini compiuti in URSS in età staliniana ebbero una connotazione nazionale decisamente più marcata,
rispetto alla liquidazione dei kulaki, o per lo meno le motivazioni etniche si fusero e si intrecciarono con quelle politiche e/o
sociali, secondo modalità che in parte si ritrovano anche nelle
violenze compiute dai comunisti jugoslavi in Istria o a Trieste nel
1943 e nel 1945. Il caso più celebre è quello dell’uccisione di
migliaia di ufficiali polacchi nel 1940 (i corpi di 4.500 di questi
militari furono trovati nella foresta di Katyn, nel 1943), uccisi
perché considerati a un tempo patrioti polacchi ed esponenti
delle classi superiori: in una parola, nemici dell’URSS (in quanto polacchi) e avversari del comunismo (in quanto borghesi).
41
10 FEBBRAIO
Questo micidiale intreccio di fattori si creerà di nuovo nell’area
di confine tra Italia e Jugoslavia, provocando l’uccisione di quei
soggetti che erano ritenuti nemici irriducibili sia perché italiani,
sia perché ostili al nuovo sistema comunista. In entrambi i casi,
però, è del tutto fuorviante l’adozione della categoria concettuale del <<genocidio>>, in quanto l’obiettivo ultimo dell’azione criminale non era, in sé e per sé, l’eliminazione di tutti gli
italiani o di tutti i polacchi dell’area che si cercava di sottomettere (la Polonia orientale, nel caso sovietico: ma il discorso può
ampiamente valere anche per Lituania, Lettonia ed Estonia; l’Istria e la Venezia Giulia, nel caso del confine orientale italiano).
Un carattere decisamente nazionale ebbe invece l’espulsione
dei cittadini tedeschi, nell’immediato dopoguerra, dalla Cecoslovacchia e dalla Polonia occidentale; in quest’ultimo caso,
si trattava di territori sotto sovranità tedesca, fino al 1945, ma
assegnati dai vincitori alla Polonia, per compensarla della perdita della vasta area occupata ad oriente dall’Armata Rossa nel
1939. Pertanto, il confine est della Germania fu spostato fino
alla linea rappresentata dai fiumi Oder e Neisse, mentre gran
parte della Polonia storica, a est, passava sotto controllo sovietico (e infatti oggi è territorio sotto sovranità della Ucraina – si
pensi alla città di Leopoli – a sud, e della Bielorussia, a nord).
In tutte queste aree, furono effettuate operazioni di pulizia etnica
più o meno radicali: pertanto, mentre i polacchi erano espulsi
dalla regione della Galizia (entrata a far parte dell’Ucraina), i
tedeschi vennero cacciati con estrema durezza da tutta la Polonia e la Cecoslovacchia, in modo da cancellare ogni presenza
di minoranze germanofone. Anche in questo caso si può individuare un precedente nella storia turca: infatti, con il trattato
di Losanna del 1920, Turchia e Grecia decisero di procedere
ad un vero scambio di popolazione: tutti i greci che vivevano
in Anatolia furono obbligati a trasferirsi in Europa, e tutti i turchi
che risiedevano in territorio greco a spostarsi in Asia Minore
42
IL GIORNO DEL RICORDO
LE VIOLENZE CONTRO I KOSOVARI ALBANESI NEL
1912
Q
uando la Serbia, nell’autunno del 1912, riuscì ad impadronirsi del Kosovo, i kosovari albanesi furono considerati come degli intrusi e dei ladri, degli usurpatori che si
erano impadroniti della terra altrui, grazie al sostegno di una
potenza straniera non cristiana. Ne nacque una feroce pulizia
etnica, anticipatrice dei numerosi stermini che avrebbero segnato il Novecento.
Un giornalista che seguì la guerra, il corrispondente da
Vienna del giornale ucraino Kievskaia Mysl, Lev Bronshtein
(più noto nella storia con il nome di Lev Trotzkij), rimase
impressionato dalle prove di atrocità da parte delle forze
serbe e bulgare. Un ufficiale serbo gli disse che le peggiori
furono commesse non dall’esercito regolare ma dai cetnici
[= guerriglieri, partigiani - n.d.r.] paramilitari: <<Tra
di loro vi erano intellettuali, uomini di pensiero, fanatici
nazionalisti, ma si trattava di individui isolati. Per il resto
erano solo delinquenti, ladri, che si erano uniti all’esercito
per far bottino>>. Ma altre prove persuasero Trotzkij che
l’uccisione degli albanesi e la distruzione dei loro villaggi
fosse il risultato di qualcosa di più dell’iniziativa di qualcuno:
concluse che <<i serbi della Vecchia Serbia>>, nel loro
sforzo nazionale di correggere i dati delle statistiche
etnografiche a loro non molto favorevoli, sono impegnati
molto semplicemente nello sterminio sistematico della
popolazione musulmana [= i kosovari albanesi - n.d.r. ]. [...]
A gran parte dei giornalisti stranieri fu proibito di entrare in
Kosovo, ma alcune notizie filtrarono: un giornalista danese
43
10 FEBBRAIO
a Skopje riferì che 5.000 albanesi erano stati uccisi a Pristina
dopo la cattura della città, e scrisse che la campagna serba
aveva <<assunto il carattere di un orrendo massacro della
popolazione albanese>>. Alcune informazioni raggiunsero
il mondo esterno attraverso la Chiesa cattolica: fu da un
prete cattolico locale che il Daily Telegraph apprese di un
massacro a Ferizaj, dove il comandante serbo aveva invitato
gli albanesi a ritornare alle loro case in pace: quelli che
lo fecero (300-400) furono poi portati fuori e fucilati. Il
resoconto più complesso e agghiacciante fu quello di Lazer
Mjeda, arcivescovo cattolico di Skopie, in una relazione a
Roma del 24 gennaio 1913. Scrisse che a Ferizaj solo tre
albanesi musulmani di età superiore ai 15 anni erano stati
lasciati in vita; la popolazione albanese di Gjilan era stata
anch’essa massacrata, nonostante la città si fosse arresa
senza combattere e Giacova era stata completamente
saccheggiata. Ma il caso peggiore fu Prizren, che, come
Gjilan, si era arresa pacificamente:
<<La città sembra il regno della morte. Picchiano alle porte
delle case albanesi, portano via gli uomini e sparano loro
immediatamente. In pochi giorni il numero degli uomini uccisi
ha raggiunto 400. Per quanto riguarda le devastazioni, i
saccheggi e gli stupri, non occorre parlarne: d’ora innanzi
l’ordine del giorno è: qualunque cosa è permessa contro
gli albanesi - non solo permessa, ma voluta e ordinata. E
nonostante tutti questi orrori, il comandante militare, Bozo
Jankovic, ha obbligato i notabili della città, con la pistola
in pugno, a spedire un telegramma di ringraziamento al re
Pietro!>>.
Nel complesso, l’arcivescovo calcolò che il numero totale
di albanesi uccisi in Kosovo a questo punto fosse già
44
IL GIORNO DEL RICORDO
di 25.000. Questo dato concordava con altri rapporti
apparsi sulla stampa europea, che avevano fornito una
stima di 20.000 ai primi di dicembre. Nel 1914, una
commissione internazionale d’inchiesta istituita
dal
Carnegie Endownment pubblicò i propri risultati. Non
azzardò una valutazione per quanto riguardava il numero
totale di albanesi uccisi, ma concluse che era stato attuato
qualcosa di simile a una politica sistematica: <<Case
e interi villaggi ridotti in cenere, popolazioni disarmate e
innocenti massacrate... questi furono i mezzi che vennero
e sono tuttora utilizzati dai soldati serbo-montenegrini, con
l’intenzione di trasformare del tutto il carattere etnico delle
regioni abitate esclusivamente da albanesi>>.
Una speciale caratteristica della politica serba e
montenegrina fu la conversione forzata dei musulmani e
cattolici all’ortodossia. Essa fu applicata con particolare
vigore dai montenegrini, che controllavano la regione di
Pec; nel maggio 1913, il console austriaco a Prizren riferì
che 2.000 famiglie musulmane nella città di Pec erano state
convertite e che quelli che rifiutavano venivano torturati o
uccisi. [...] Il motivo immediato di tutte queste misure era,
come lo si riconobbe chiaramente in alcuni resoconti citati
prima, quello di cambiare le statistiche della popolazione
e quindi di rafforzare la posizione diplomatica dei governi
serbo e montenegrino per vedersi riconosciuto il diritto di
incorporare queste terre conquistate.
(N. Malcom, Storia del Kosovo. Dalle origini ai giorni nostri,
Milano, Bompiani, 1999, pp. 290-292. Traduzione di M. Pagliano, O. Putignano e M. W. Croce)
45
10 FEBBRAIO
DINAMICA E MODALITÀ DELLA DEPORTAZIONE
DEI KULAKI
I
l termine kulaki (sfruttatori) era un appellativo ingiurioso con
cui furono designati i contadini più agiati ed intraprendenti,
che negli anni Venti avevano saputo sfruttare le possibilità offerte loro dalla Nuova Politica Economica. Nel 1930, Stalin
li deportò in gran numero, temendo che potessero costituire
un pericoloso nucleo di opposizione politica alla sua linea
economica, caratterizzata da un massiccio sfruttamento delle campagne e dallo sforzo di creare a tutti i costi in URSS
un’industria pesante. In questo caso, la repressione staliniana
non colpì un gruppo etnico particolare (anche se l’Ucraina
patì, negli anni Trenta, più di altre regioni dell’URSS); si trattò comunque di un gigantesco spostamento forzato di grandi
masse di persone, tipico della violenza totalitaria.
Le idee guida [della politica di Stalin nei confronti delle
campagne - n.d.r. ] erano quella di neutralizzare i contadini
attraverso l’annientamento della loro élite (dekulakizzazione)
e quella di costringere il maggior numero possibile di
famiglie in relativamente poche, grandi unità collettive
(collettivizzazione).
La prima era da molti punti di vista una generalizzazione
della formula applicata contro i cosacchi all’inizio del 1919,
quando nei documenti del partito si era parlato della necessità
di <<neutralizzare>> i cosacchi attraverso la spietata
eliminazione della loro élite, una politica come sappiamo
raffinata negli anni successivi in Kuban e nel governatorato
di Tambov. Per quel che riguarda la seconda, si riteneva
e non senza ragione che grazie ad essa sarebbe stato più
46
IL GIORNO DEL RICORDO
facile estrarre le quantità di grano ritenute necessarie, fino
ad allora oggetto di feroci dispute con milioni di piccoli e
caparbi nuclei famigliari. [...]
I documenti in nostro possesso provano che almeno la prima
fase dell’attacco, e cioè la dekulakizzazione, ebbe successo
e non solo per la brutalità e la decisione con cui fu condotta.
Il fatto innegabile, per quanto sgradevole, è che [...] almeno
in un primo momento essa riuscì a dividere le campagne,
facendo leva sulle invidie e le disparità sociali esistenti
nei villaggi. Implicitamente fu lasciato capire - o almeno
questo capirono tutti - che i beni dei <<kulak>> erano a
disposizione di chi si fosse fatto avanti a prenderli. Non a
caso, come gli stessi rapporti OGPU oggi ci confermano,
accanto ai pochi giovani entusiasti si mobilitò allora la
feccia, il mondo criminale delle campagne: le brigate dei
<<dekulakizzatori>>, formate in tutta fretta, furono così
infestate da <<elementi sociali alieni e spesso criminali>>
che <<cacciavano i dekulakizzati nudi nella strada
(nell’inverno russo, AG), li malmenavano, organizzavano
orge nelle loro case, gli sparavano appena al di sopra
della testa, li obbligavano a scavarsi la fossa, denudavano
le donne e le sottoponevano a perquisizioni personali, si
tenevano per sé i valori e il denaro sequestrati, ecc.>>.
A conferma di quanto Moshe Lewin aveva già dimostrato
30 anni fa, la dekulakizzazione fu quindi un saccheggio
generalizzato e il suo già menzionato successo fu dunque
politico, non certo economico. È possibile sostenere che la
<<tradizione>> cui essa si riallacciava fosse quella dei
pogrom, e in particolare dei pogrom istigati dallo stato. Ma
profonda, e da più punti di vista, era anche la continuità
col 1918-21 [gli anni del comunismo di guerra e delle
47
10 FEBBRAIO
requisizioni granarie nelle campagne, al tempo della guerra
civile - n.d.r. ]. [...]
Il bilancio quantitativo ufficiale della dekulakizzazione
parla di migliaia di repressi, e spesso fucilati, nelle prime
settimane e di 381.000 famiglie con 1,8 milioni di membri
deportate in regioni lontane tra il 1930 e il 1931. 64.000 di
queste famiglie venivano dall’Ucraina, 52.000 dalla Siberia
Occidentale, 30.000 dal Basso Volga e 28.000 dagli
Urali. Esse finivano in genere in villaggi speciali (spec o
trudposelenie ) la cui amministrazione fu affidata nel 1931
all’OGPU.
Negli anni successivi venne deportato qualche altro
centinaio di migliaia di contadini. [...] In tutto i deportati
in regioni lontane furono perciò circa 2.250 milioni, cui va
aggiunto un numero grosso modo equivalente di persone
esiliate all’interno dei confini della loro regione d’origine
(alcune di esse vennero poi rideportate in regioni lontane).
Al totale vanno infine aggiunti i contadini rinchiusi nei lager
veri e propri (ITL) del Gulag, circa 120.000 nel luglio 1932.
Dai loro nuovi luoghi di residenza, i deportati spedirono a
famigliari e autorità migliaia di strazianti lettere di protesta.
Particolarmente terribile è leggervi della sorte dei bambini
che, secondo un documento dell’Ufficio politico del gennaio
1931, morivano a un tasso che in certe regioni raggiungeva
il 10% mensile . Un buon numero di queste lettere sono state
di recente pubblicate insieme a quelle dei molti membri del
partito che trovarono allora il coraggio di protestare contro
uno stato che continuava a definirsi <<socialista>> mentre
perpetrava simili orrori.
Sappiamo inoltre che nel solo 1932-33 i morti tra i deportati
furono circa 250.000. E sappiamo che nel 1930-31 le
48
IL GIORNO DEL RICORDO
cose erano probabilmente andate ancora peggio, come
suggerisce il triste fato dei bambini. [...] Diverse centinaia di
migliaia di contadini e di nomadi morirono dunque prima che
la grande carestia colpisse il paese nell’autunno 1932. La
dekulakizzazione fu seguita a ruota dalla collettivizzazione,
che raggiunse il suo primo picco nel febbraio 1930, quando
vennero collettivizzate circa 8 milioni di famiglie. Ancora
una volta violenze e terrore furono i metodi cui si fece
generalmente ricorso.
(A. Graziosi, La grande guerra contadina in Urss. Bolscevichi
e contadini (1918-1933), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane,
1998, pp. 71-75)
LE DEPORTAZIONI ETNICHE NELL’URSS STALINIANA
M
entre i kulaki furono considerati dei nemici di classe, a
prescindere dalla loro nazionalità, in vari altri casi il regime staliniano tenne in maggior conto il fattore etnico. In certi
casi (polacchi e baltici, ad esempio) esso fu considerato un
elemento aggravante, che rendeva i potenziali nemici particolarmente inaffidabili: ciò provocò consistenti deportazioni, ma
non misure generalizzate contro un intero popolo. In alcune
regioni, invece, un’intera nazionalità fu considerata pericolosa
per la sicurezza dello Stato sovietico e deportata in blocco.
Gli <<specposelency>> – cioè le persone deportate in
quanto componenti di un gruppo – hanno continuato ad
49
10 FEBBRAIO
esistere anche dopo la dekulakizzazione e il trasferimento di
1,8 milioni di contadini ricchi. Negli anni Trenta e Quaranta
gli <<specposelency>> erano i membri dei popoli puniti
– usando un’espressione di Aleksandr Nekrich – che furono
sradicati dai luoghi in cui vivevano e deportati in tutto, o in
parte, in regioni lontane. Questi 3 milioni di persone circa
erano colpevoli – e pertanto condannati alla deportazione
– di appartenere a una nazione che il potere staliniano
sospettava o accusava di antisocialismo. Il numero dei nuovi
<<specposelency>> appare nelle liste stilate alla partenza
e/o all’arrivo dal Commissariato del popolo per gli affari
interni (NKVD), in cui sono indicati il luogo di provenienza e
la destinazione di ognuno di essi. Perciò a volte è possibile
calcolare solo le vittime morte durante gli spostamenti
o nei primi tempi dell’insediamento. Questa politica di
deportazione, che ha colpito dodici piccole nazionalità
del territorio dell’URSS, oltre ad alcuni cittadini originari di
nazioni occupate dai sovietici (paesi baltici, confini orientali
della Polonia), è parte integrante del retaggio totalitario
dello stalinismo. È stata denunciata come tale dal rapporto
Chruscev al XX Congresso del PCUS del 1956, in cui veniva
ricordata la <<deportazione di massa di intere nazioni>>
e si precisava che la <<deportazione non era dettata da
alcuna considerazione militare>>. […] Sebbene i 10.000
finnici della Carelia, trasferiti tra 1932 e 1934, siano stati
le prime cavie di questa politica, essa viene avviata in modo
sistematico con la deportazione in toto (171.000 persone)
dei coreani dell’Estremo Oriente verso le steppe kazache
nel corso del 1937. A partire dallo stesso anno, anche le
popolazioni tedesche dell’Ucraina, del Don e del Volga
iniziano a subire lo stesso destino; ma è soprattutto nell’estate
50
IL GIORNO DEL RICORDO
del 1941, in piena offensiva dell’esercito nazista, che
950.000 tedeschi di quelle regioni vengono rinchiusi in 364
convogli ferroviari e trasferiti in pochi giorni, e in condizioni
spaventose, verso il Kazakistan. In alcuni convogli la metà dei
deportati non arriva nemmeno a destinazione, mentre quelli
che vi giungono sono quasi sempre alloggiati in stalle o in
capanni improvvisati. La grande guerra patriottica diventa
così l’occasione per la maggior parte di queste punizioni e
deportazioni: quella dei balti e dei polacchi innanzi tutto […];
poi quella dei popoli del Caucaso settentrionale, a partire
dal marzo del 1943, quando il generale Ivan Serov, che
aveva già diretto l’operazione contro i tedeschi, fa trasferire
brutalmente 37.000 balcari in Kazakistan e in Kirghizistan;
tra l’ottobre e il dicembre dello stesso anno tocca a 70.000
karaciai e a 90.000 calmucchi, spostati in Siberia, nell’Altaj,
nella provincia di Omsk e in quella di Novosibirsk, dove alla
fine vengono distribuiti in vari kolchoz [= le grandi aziende
agricole create dopo la collettivizzazione delle campagne –
n.d.r.], in cui non possono però trovare un lavoro adatto a
loro, che sono pastori e allevatori per tradizione; rimangono
quindi senza approvvigionamenti, con tutte le conseguenze
che ciò comporta in pieno inverno. Nel febbraio del 1944,
120.000 uomini dell’NKVD dirigono una gigantesca
operazione di deportazione: mezzo milione di ceceni e di
ingusci sono caricati su 180 convogli diretti verso i kolchoz
poverissimi del Kazakistan. Al dramma vissuto dai popoli del
Caucaso, si aggiunge nel maggio del 1944 quello dei tatari
di Crimea: ne vengono deportati 180.000 nella provincia di
Samarcanda, e si calcola che il 46% di essi non sopravvisse.
Infine, in luglio le regioni limitrofe alla Georgia sono ripulite
dei loro 86.000 turchi messeti, curdi e kemsini, che si
51
10 FEBBRAIO
ritrovano anch’essi in Asia centrale. Il caso della Polonia
(occupata dai sovietici nel settembre del 1939) e quello dei
paesi baltici (nel giugno del 1940) sono un po’ diversi dai
precedenti, dato che le loro popolazioni sono state deportate
parzialmente e non totalmente, come invece è accaduto alle
altre appena elencate. Vengono deportate in primo luogo le
classi dirigenti (membri dei partiti nazionalisti reazionari con
le rispettive famiglie, ufficiali, poliziotti, funzionari, preti), ma
anche, per estensione di classe, contadini agiati, proprietari
terrieri, commercianti e imprenditori, in poche parole
tutti coloro che una direttiva segreta del PCUS definisce
<<elementi estranei alla società>>. Lituani, lettoni ed
estoni sono deportati in tre riprese: nel giugno del 1941, tra
1944 e 1945 e infine nel 1949. Complessivamente, 158.000
persone – tra cui 58.000 donne e 35.000 minori di quindici
anni – si ritrovano nella remota Siberia, assegnate per la
maggior parte alle aziende di sfruttamento forestale. […]
Ma su quali criteri si fondavano veramente le intenzioni dei
sovietici nelle loro politiche che attentavano alla vita di tutti
questi popoli? Alcuni autori (J. Otto Pohl, Francine Hirsch)
hanno sottolineato che tutte le deportazioni erano parte
integrante di una politica di sicurezza globale e rivestivano
anche un ruolo piuttosto importante nella politica estera
dell’URSS. Di fatto, chi colpiscono? Innanzi tutto i popoli
situati in prossimità di frontiere sensibili (finnici, coreani) o
in regioni strategiche difficili da difendere (Caucaso, Baltico,
confini polacchi). In quest’ultimo caso, la deportazione
di determinati popoli caucasici indebolisce ancor di più
un’area già fragile, mentre l’eliminazione di elementi
<<socialmente pericolosi>> ripulisce e rende più sicuro per
l’esercito sovietico il futuro campo di battaglia dell’Europa
52
IL GIORNO DEL RICORDO
orientale, da Leopoli a Riga. Le deportazioni colpiscono
anche le diaspore nazionali (tedeschi, polacchi dell’Ucraina
occidentale, turchi), che i sovietici credono essere legate ad
un paese straniero ostile (la Germania nazista a partire dal
1936, la Polonia di Pilsudski, la Turchia del 1945). Infine
alcuni popoli sono perseguitati perché in passato hanno
opposto resistenza alla penetrazione dei russi prima (ceceni)
e dei sovietici poi (calmucchi e ingusci hanno opposto
resistenza alla collettivizzazione, balkari e calmucchi sono
considerati traditori per aver collaborato con l’aggressore
nazista). Bisogna sottolineare a questo proposito che, sia
nella Russia zarista sia nell’Unione Sovietica, le ragioni
di sicurezza restano prioritarie: 200.000 tedeschi erano
già stati deportati tra 1915 e 1916 dalle regioni europee
dell’impero, e solo la rivoluzione del 1917 aveva impedito
che anche agli altri fosse riservata la stessa sorte.
(B. Bruneteau, Il secolo dei genocidi, Bologna, Il Mulino, 2005,
pp. 120-124. Traduzione di A. Flores d’Arcais)
GLI SPOSTAMENTI DI POPOLAZIONE NEL
SECONDO DOPOGUERRA
N
ell’immediato dopoguerra, l’Europa intera è stata caratterizzata da imponenti spostamenti di popolazione, che
hanno posto fine a presenze storiche secolari. Molte città e
stati, che fino al 1939 ospitavano molteplici popoli, furono
artificialmente trasformate in entità omogenee, sotto il profilo
etnico: le minoranze (che a volte erano già state liquidate durante la guerra) furono espulse o costrette a scegliere volon-
53
10 FEBBRAIO
tariamente (per modo di dire) tra l’oppressione discriminante
e la partenza verso uno Stato nazionale (la Germania, per i
tedeschi espulsi dalla Polonia; l’Italia, per gli istriani e i giuliani; Israele per gli ebrei…).
Il continente era un tempo un intricato arazzo di linguaggi,
religioni, comunità e nazioni. Molte città – soprattutto
quelle più piccole, all’intersezione dei vecchi e nuovi confini
imperiali, come Trieste, Sarajevo, Salonicco, Czernowitz,
Odessa o Vilnius – erano autentiche società multiculturali
avant le mot [= possono essere definite così, anche se il
termine è più recente – n.d.r.], dove cattolici, ortodossi,
musulmani, ebrei e altri ancora vivevano armoniosamente gli
uni accanto agli altri. Non si deve però idealizzare. Quello che
lo scrittore polacco Tadeus Borowski definì <<l’incredibile
e quasi comico crogiuolo di popoli e nazionalità
pericolosamente brulicanti nel cuore stesso dell’Europa>>
era periodicamente lacerato da rivolte, massacri e pogrom:
ma era reale ed è sopravvissuto nella memoria. Tra il 1914 e
il 1945, tuttavia, quel mondo era stato frantumato e ridotto
in polvere. La più compatta Europa formatasi, procedendo
a balzi irregolari, nella seconda metà del ventesimo secolo
aveva un minor numero di enclave labili. Grazie al conflitto,
all’occupazione, al riaggiustarsi dei confini, alle espulsioni
di massa e al genocidio, ora quasi tutti vivevano nel proprio
paese, in mezzo alla propria gente. […]
Ciò che stava accadendo nel 1945, e che era in corso già
da almeno un anno, era dunque un’immensa operazione
di pulizia etnica e trasferimento di popolazioni. Si trattava,
in parte, dell’effetto di una separazione volontaria [=
di una fuga di fatto inevitabile, e non di una espulsione
54
IL GIORNO DEL RICORDO
vera e propria – n.d.r.]: gli ebrei che si sentivano insicuri
e indesiderati, per esempio; o gli italiani che preferivano
lasciare l’Istria piuttosto che finire sotto la Iugoslavia. Molte
minoranze etniche che avevano collaborato con le forze di
occupazione (italiani in Iugoslavia, ungheresi in Transilvania,
già occupata e ora restituita alla Romania, ucraini nell’URSS
occidentale, e altri ancora) fuggirono insieme alle armate
della Wehrmacht in ritirata per evitare la vendetta delle
maggioranze locali o l’avanzata dell’Armata Rossa, e non
tornarono più nel loro paese. Anche se le autorità locali non
avevano ordinato e imposto per legge la partenza, a queste
minoranze non era rimasta praticamente altra scelta.
Altrove, comunque, la politica si era già messa al lavoro
ben prima che la guerra terminasse. Erano stati i nazisti,
naturalmente, a dare l’esempio, con la deportazione e il
genocidio degli ebrei e le espulsioni di massa di polacchi e
altre popolazioni slave. Tra il 1939 e il 1943, sotto l’egida
[= protezione – n.d.r.] tedesca, ungheresi e rumeni si
scontrarono per il confine della disputata Transilvania. Le
autorità sovietiche, a propria volta, organizzarono una serie
di trasferimenti forzati tra Ucraina e Polonia: tra l’ottobre
1944 e il giugno 1946, un milione di polacchi fuggì o fu
cacciato dalle proprie case in quella che divenne l’Ucraina
occidentale, mentre 500.000 ucraini lasciarono la Polonia,
trasferendosi in URSS. Nel giro di pochi mesi, quella che
era stata una regione composita, nella quale avevano
convissuto fedi, lingue e comunità estremamente diverse,
venne trasformata in due territori separati e monoetnici. […]
Analoghi trasferimenti si ebbero tra Polonia e Lituania e tra
Cecoslovacchia e URSS; 400.000 abitanti della Iugoslavia
meridionale furono fatti trasferire a nord per prendere
55
10 FEBBRAIO
il posto dei 600.000 tedeschi e italiani che avevano
abbandonato il territorio. Qui, come altrove, le popolazioni
interessate non furono consultate; furono però i tedeschi a
subire i maggiori contraccolpi. Quelli dell’Europa orientale
sarebbero probabilmente fuggiti a occidente in ogni caso:
nel 1945 non erano più bene accetti nei paesi in cui le
famiglie avevano abitato per secoli. Schiacciate tra un
autentico desiderio popolare di vendetta per le devastazioni
della guerra e dell’occupazione e lo sfruttamento di questo
sentimento da parte dei governi postbellici, le comunità
germaniche di Iugoslavia, Ungheria, Cecoslovacchia,
Polonia, della regione baltica e dell’URSS avevano il destino
segnato e lo sapevano perfettamente.
All’atto pratico, non fu lasciata loro alcuna possibilità
di scelta. Già nel 1942 gli inglesi avevano privatamente
accolto le richieste cecoslovacche per la loro rimozione dalla
regione dei Sudeti, e un anno dopo anche americani e russi si
erano dichiarati d’accordo. Il 19 maggio 1945, il presidente
della Cecoslovacchia Edvard Benes proclamò: <<Abbiamo
deciso di risolvere una volta per tutte il problema tedesco
della nostra Repubblica>>. Le loro proprietà (esattamente
come quelle degli ungheresi e di altri traditori) sarebbero
state poste sotto il controllo dello Stato. Nel giugno 1945
vennero loro tolte le terre e, il 2 agosto dello stesso anno,
anche la cittadinanza cecoslovacca. Nel corso dei successivi
diciotto mesi furono rispediti in Germania quasi 3 milioni
di profughi la maggior parte provenienti dalla regione dei
Sudeti. Nel trasferimento morirono circa 267.000 persone
[stima molto elevata, non accettata da tutti gli storici; molti
studiosi avanzano cifre molto inferiori – n.d.r.]. Mentre negli
anni Trenta i tedeschi avevano costituito il 29 per cento
56
IL GIORNO DEL RICORDO
della popolazione della Boemia e della Moravia, nel 1950
si erano ridotti ad appena l’1,8 per cento.
Dall’Ungheria ne furono espulsi 623.000, dalla Romania
786.000, dalla Iugoslavia circa 500.000 e dalla Polonia
1,3 milioni. Ma il numero maggiore arrivava dagli ex
possedimenti orientali della stessa Germania: Slesia, Prussia,
Pomerania e Brandeburgo orientali. […] L’Europa era stata
ripulita della sua popolazione tedesca: come promesso
nel settembre 1941, Stalin aveva riportato la <<Prussia
orientale nella terra degli slavi, alla quale appartiene>>.
(T. Judt, Dopoguerra. Com’è cambiata l’Europa dal 1945 a
oggi, Milano, Mondadori, 2007, pp. 13 e 34-36 Traduzione
di A. Piccato)
L’ESPULSIONE DEI TEDESCHI DEI SUDETI
I
n Cecoslovacchia, la sconfitta delle armate naziste fu immediatamente seguita dall’espulsione forzata di circa tre milioni
di tedeschi residenti nella regione dei Sudeti.
In un incontro con Stalin del 16 dicembre 1943, Benes
[presidente della Cecoslovacchia, prima dell’invasione
tedesca – n.d.r.] affermò che intendeva risolvere il problema
tedesco [ = il problema della presenza di tre milioni di
tedeschi all’interno dei confini della Cecoslovacchia,
concentrati soprattutto nella regione dei Sudeti – n.d.r.] una
volta per tutte e creare uno Stato cecoslovacco libero da
tedeschi e ungheresi: << La sconfitta della Germania ci
57
10 FEBBRAIO
offre l’irripetibile occasione storica di espungere in modo
radicale l’elemento tedesco dal nostro Stato. La futura
repubblica dovrà essere uno Stato di cechi, slovacchi e
carpazi ucraini. Dovrà essere uno Stato di nazioni slave.
Dalla Cecoslovacchia dovrebbero essere cacciati a forza tutti
gli insegnanti e i docenti tedeschi, i tipi alla SS, gli uomini
della Gestapo, gli esponenti della gioventù hitleriana, tutti
i membri attivi del movimento di Henlein [il capo del Partito
tedesco dei Sudeti , sostenuto da Hitler - n.d.r. ] e l’intera
borghesia tedesca, tutti i tedeschi ricchi.
In questa e altre occasioni durante la guerra, Benes e i suoi
consiglieri menzionarono la possibilità per alcuni tedeschi
buoni di restare in Cecoslovacchia. Al termine del conflitto,
tuttavia, nessun uomo o partito politico cecoslovacco
poté resistere all’ondata montante del nazionalismo ceco
antitedesco che gridava vendetta per gli insulti di Monaco,
la perdita di sovranità e i terribili eventi della guerra stessa.
[...]
La propaganda del governo ceco alimentò deliberatamente
i sentimenti antitedeschi nel paese. Il massacro di Lidice
[località boema, vittima di una brutale rappresaglia, dopo
l’uccisione a Praga di R. Heydrich, alto ufficiale delle SS
e capo della Gestapo – n.d.r.] trovò vastissima eco sulla
stampa. L’intero popolo tedesco è responsabile di Lidice,
titolò un giornale. Certo, alcuni degli attacchi ai tedeschi
erano fortemente interessati, dal momento che predatori
cechi piombarono da altre regioni del paese per fare man
bassa; ma la gran parte dei saccheggi fu perpetrata in nome
dello Stato e del suo programma nazionalista. Un proclama
del Partito comunista del 13 maggio 1945 incitava i suoi
membri a <<ripulire la madrepatria dei responsabili di un
58
IL GIORNO DEL RICORDO
tradimento senza uguali nella storia del nostro popolo!>>.
Nel medesimo spirito di istigazione dei cechi alla violenza
contro i tedeschi, il 18 agosto 1945 il Novo Slovo scrisse:
<<Il tedesco è senz’anima, e le parole che capisce meglio
sono – secondo Jan Masarik – le raffiche di un mitra>>.
Prokop Drtina, leader del liberale Partito nazionalsocialista,
[ ovviamente non ha nulla a che fare col partito di Hitler –
n.d.r. ] dichiarò il 17 maggio 1945 che compito principale
dei cechi era <<ripulire l’intera repubblica e in modo
radicale dai tedeschi [...]. Ciascuno di noi deve contribuire
a ripulire la madrepatria>>. Finanche la Chiesa cattolica
ceca fece sentire la propria voce. Monsignor Bohumil
Stasek, canonico di Vysehrad, dichiarò: <<Dopo mille
anni è giunto il momento di regolare i conti con i tedeschi,
che sono malvagi e per i quali il comandamento “Ama il
prossimo tuo” non si applica>>.
Imbevuti di un tal genere di propaganda, via via che l’esercito
tedesco batteva in ritirata incalzato dall’avanzata sovietica,
la milizia ceca (molti dei cui membri reclutati a Praga dopo
l’insurrezione), gruppi d’azione comunisti e il cosiddetto
esercito Svoboda invasero le aree tedesche e si scagliarono
contro i civili, in strada o irrompendo nelle case, facendo
ben poca distinzione tra tedeschi antifascisti, comuni
contadini o simpatizzanti henleinisti. In un parossismo di
violenza che lasciò sconvolti finanche esperti comandanti
e funzionari politici sovietici, i cechi pestarono a sangue
i tedeschi, li fucilarono, li obbligarono a svolgere lavori
umilianti e pericolosi senza mai mostrare un briciolo di pietà
nei loro confronti. I villaggi vennero messi a ferro e fuoco,
la gente uccisa a casaccio; molti vennero appesi agli alberi
a testa in giù, cosparsi di petrolio e bruciati vivi. Nel corso
59
10 FEBBRAIO
di veri e propri pogrom, la milizia rastrellò città e villaggi
sparando e uccidendo tedeschi all’impazzata. Migliaia di
rifugiati tedeschi dei Sudeti documentarono in seguito molto
accuratamente questi atti di brutalità gratuita, sebbene solo
in pochissimi casi mostrassero di comprendere i motivi dei
comportamenti dei cechi. [...]
Il 30 maggio 1945, nel corso della famosa marcia della
morte di Bruenn (Brno), l’intera popolazione tedesca,
circa 300.000 persone, venne cacciata da casa propria e
picchiata selvaggiamente durante la marcia verso i campi
al confine con l’Austria. Circa 1.700 tedeschi morirono
durante il tragitto.
Secondo fonti dei tedeschi dei Sudeti, circa 272.000
tedeschi (circa l’8 per cento dell’intera popolazione tedesca
in Cecoslovacchia) morirono durante le operazioni di sfratto
coatto dalle loro case, ivi incluso l’altissimo numero di
persone rientranti nella categoria degli scomparsi. Questa
cifra è stata contestata dagli storici cechi e tedeschi, i quali
la considerano fortemente esagerata e sostengono che
solo un decimo di tale numero morì in conseguenza del
trasferimento in Germania. La commissione storica cecotedesca di recente istituita, ad esempio, sostiene che il
numero di vittime va dalle 19.000 alle 30.000 unità. [...]
Le cifre dipendono spesso dal criterio di calcolo [...] e
da come vengono considerati gli scomparsi. Il fattore più
micidiale in assoluto fu la malattia: molti tedeschi perirono
durante il viaggio o una volta giunti nella Germania
occupata, stroncati da una varietà di malattie. Suicidi,
inedia ed esposizione alle intemperie imposero anch’essi un
prezzo altissimo. In altre parole, le cifre più basse indicano
forse il numero dei tedeschi dei Sudeti assassinati e uccisi
60
IL GIORNO DEL RICORDO
durante la deportazione, mentre quelle più alte includono
quanti morirono per altre cause durante il processo di
sfratto, detenzione, trasferimento e reinsediamento.
(N. M. Naimark, La politica dell’odio. La pulizia etnica nell’Europa contemporanea, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 135-137 e
141-142. Traduzione di S. Minucci)
61
i
e guerre mondial
du
le
tra
ia
av
sl
e Jugo
l 1924).
Il confine tra Italia
20 e di Roma de
9
1
l
de
llo
pa
Ra
(Trattati di
carta,
a di Zara, fuori
at
lm
da
ttà
ci
la
Anche
l’Italia.
viene annessa al
Dimensione nazionale
Il confine orientale
italiano
Italia e Jugoslavia nel primo dopo guerra
N
el momento in cui il governo italiano stipulò il Patto di
Londra (26 aprile 1915), impegnandosi ad entrare in
guerra con Francia e Gran Bretagna contro l’Austria-Ungheria, nessuno degli statisti europei credeva che una sconfitta
austriaca avrebbe provocato la totale disgregazione dell’impero asburgico. Nel 1915, la prospettiva non era quella di
una dissoluzione dell’entità multinazionale austro-ungarica e
della sua sostituzione con una pluralità di Stati organizzati
su base etnica. L’Italia, semplicemente, sperava in un arretramento dell’Austria-Ungheria verso est, in modo che regioni dominate fino ad allora dall’impero di Vienna passassero
sotto amministrazione e controllo italiani. Per questo motivo
l’Italia, nel Patto di Londra, non si limitò a rivendicare Trento
e Trieste (regioni di cultura e tradizione italiane), bensì chiese
per sé, in caso di vittoria, anche la Dalmazia (cioè la costa
orientale dell’Adriatico), sebbene essa fosse abitata prevalentemente da slavi. Viceversa, il Patto di Londra non menzionava
esplicitamente il porto di Fiume, sul cui destino dunque, prima
della guerra, non si era deciso assolutamente nulla.
Le prime difficoltà per il governo italiano nel dopoguerra sopraggiunsero nell’ottobre 1918: la città di Fiume, infatti, dichiarò la sua volontà di essere annessa al Regno d’Italia. Tale
dichiarazione pose un grave problema di strategia diplomatica alla delegazione italiana alla Conferenza di pace di Parigi, spingendola ben presto in un vicolo cieco. Poiché l’impero
austro-ungarico si era dissolto, e al suo posto erano sorti vari
Stati nazionali (Jugoslavia, Polonia, Cecoslovacchia, Austria,
63
10 FEBBRAIO
Ungheria), le rivendicazioni italiane sulla costa adriatica (slava)
perdevano ogni significato. La logica avrebbe voluto che l’Italia
rinunciasse alla Dalmazia (in nome del principio di nazionalità)
e, sulla base del medesimo criterio, si accontentasse di Trento,
Trieste e Fiume. Invece, la delegazione italiana tenne un atteggiamento a un tempo rigido e ambiguo, chiedendo sia Fiume
(in nome del principio di nazionalità), sia la Dalmazia (in nome
del Patto di Londra). Di fronte alla netta opposizione degli Alleati (e, soprattutto, del presidente americano Wilson) il 24
aprile 1919 la delegazione italiana abbandonò Parigi in segno
di protesta.
Nella primavera del 1919, Gabriele D’Annunzio lanciò una
formula destinata a colpire profondamente l’immaginazione
degli italiani e, ancor più, quella degli ex-combattenti. Secondo
il poeta abruzzese, quella ottenuta dall’Italia sarebbe stata una
<<vittoria mutilata>>, cioè un grande trionfo che, a causa
dell’egoismo e dello strapotere delle altre nazioni vincitrici, non
avrebbe comunque portato alcun profitto reale in termini di allargamento territoriale e di rafforzamento di prestigio. D’Annunzio, però, non si limitò a coniare quel fortunato slogan. Il 13
settembre 1919, anzi, passò all’azione effettiva, ponendosi a
guida di alcuni reparti dell’esercito che, dopo aver disobbedito
agli ordini del governo italiano, si impadronirono militarmente
di Fiume. Il 12 novembre 1920, il governo presieduto da Giovanni Giolitti trovò un accordo con la Jugoslavia (Trattato di
Rapallo): l’Italia poté almeno annettersi l’Istria, mentre Fiume
(che D’Annunzio fu obbligato ad abbandonare) fu dichiarata
città libera.
Anche se la situazione internazionale si era finalmente chiarita,
il clima politico rimase teso. Nelle regioni che si affacciano
sull’Adriatico settentrionale, infatti, la popolazione era tutt’altro
che omogenea, con una percentuale di italiani e di slavi (sloveni o croati, a seconda delle zone) molto variabile nelle differenti
64
IL GIORNO DEL RICORDO
aree. In molti casi (ma non sempre), le campagne erano abitate
da contadini slavi, mentre i centri urbani presentavano una forte
presenza italiana, che dava vita ad un vivace ceto borghese
di imprenditori e commercianti; all’interno delle città, tuttavia,
spesso esistevano sia importanti concentrazioni di operai italiani, sia nuclei molto attivi di borghesia slovena o croata. In Istria,
infine, oltre al gruppo dei grandi proprietari terrieri, era ben radicato sul territorio anche un significativo gruppo di agricoltori
italiani, che coltivavano piccoli fondi di loro proprietà.
Dopo la guerra, tutta l’area di recente annessione sperimentò gravi problemi economici, provocati in primo luogo dalla
perdita di prestigio e importanza strategica del porto di Trieste.
Fino al 1914, esso era stato il principale sbocco sul mare di un
vasto stato unificato, e quindi era stato un vivacissimo centro di
importazioni ed esportazioni. Nel sistema economico italiano,
al contrario, Trieste era periferica e del tutto ininfluente; mai
come nel caso triestino, aspirazioni politiche ed interessi economici erano entrati in collisione in modo più clamoroso: da
un lato, l’annessione allo stato unitario italiano era percepito
da molti italiani come il coronamento del sogno risorgimentale;
dall’altro, il collasso dell’impero asburgico e l’inserimento nello
stato nazionale di riferimento danneggiarono in modo gravissimo i traffici commerciali e l’economia cittadina. Il nazionalismo italiano assunse presto, nelle nuove regioni annesse, tinte
e sfumature estreme, al punto che Trieste vide il rapido sviluppo
di un movimento fascista radicale, ferocemente antislavo (e denominato da alcuni storici fascismo di confine).
Una delle prime azioni dello squadrismo organizzato, il 13 luglio 1920, portò alla distruzione del centro di ritrovo Casa della
Nazione (Narodni Dom) - simbolo della presenza slava a Trieste – e dell’Hotel Balkan, situato nello stesso edificio. Dopo il
1924, quando il regime fascista si fu pienamente insediato, il
governo fece proprio un orientamento già assunto dallo squa-
65
10 FEBBRAIO
drismo locale e tentò di cancellare ogni traccia della presenza
culturale slava. Tutte le associazioni slovene e croate furono
sciolte, i giornali in lingua diversa dall’italiana vennero proibiti,
mentre l’istruzione scolastica fu impartita solo nella lingua ufficiale. Infine, mentre i nomi delle località furono italianizzati fin
dal 1923, dal 1927 scattò l’offensiva contro i cognomi stranieri
(sostituiti d’ufficio con altri dal suono più italico), accompagnata dal divieto di porre ai propri figli nomi di battesimo slavi
66
IL GIORNO DEL RICORDO
NAZIONALISMO E SQUADRISMO A TRIESTE NEL
PRIMO DOPOGUERRA
S
e in Emilia Romagna e in altre zone dell’Italia la violenza
fascista si indirizzò in prevalenza contro i socialisti, a Trieste
e in altri centri vicini al confine con la Jugoslavia furono gli
slavi il nemico anti-nazionale da abbattere e da schiacciare.
Il fascismo nascente, però, fu considerato da molti soggetti
istituzionali (primi fra tutti i militari) non come un movimento
criminale, pericoloso per lo Stato liberale e per le sue istituzioni, bensì come un utile strumento capace di contrastare i
sovversivi e i nemici della nazione.
L’azione più clamorosa attribuibile al primo fascismo fu
l’incendio a Trieste del Balkan, il 13 luglio del 1920, seguito
agli incidenti di Spalato. Il centro dalmata [Spalato, appunto
– n.d.r.] non era incluso nei compensi italiani previsti nel
Patto di Londra. In ogni caso, l’ammiraglio Millo, appoggiato
in ciò dal capo di stato maggiore della marina, l’ammiraglio
Thaon de Revel, aveva fatto stazionare l’incrociatore Puglia
nel porto spalatino, ritenendo, in questo modo, di rafforzare
la posizione negoziale dell’Italia a Parigi. La presenza
del Puglia venne registrata con notevole nervosismo dalla
maggioranza croata di Spalato e venne a determinarsi
una situazione di tensione tra l’equipaggio italiano e la
componente nazionalista croata della popolazione. La
tensione crebbe in seguito al manifesto appoggio di Millo
e degli alti comandi della marina all’impresa fiumana,
sfociata nell’illegale occupazione di Traù, sotto controllo
delle truppe americane.
In questa particolare atmosfera, la sera dell’11 luglio 1920,
67
10 FEBBRAIO
alla vigilia del genetliaco di re Pietro di Jugoslavia, il capitano
serbo Lovric teneva a Spalato un acceso comizio in chiave
antitaliana. Gli incidenti ebbero origine dal gesto di due
ragazzi che, secondo il rapporto del comandante statunitense
Philipp Andrew, innalzarono nei pressi del Puglia una
bandiera jugoslava. Due sottufficiali italiani sequestrarono la
bandiera e la portarono sul Puglia. In seguito a ciò ci fu un
assalto contro il locale frequentato dalla borghesia spalatine
italiana con distruzione delle insegne. Due ufficiali del Puglia
vennero aggrediti dalla folla e feriti. Un altro ufficiale, inviato
con una lancia [= imbarcazione di piccole dimensioni –
n.d.r.] a recuperare i commilitoni, venne coinvolto in scontri
con armi da fuoco. Ci fu quindi un ulteriore spedizione dal
Puglia sulla terraferma, nel tentativo di riportare a bordo
gli ufficiali coinvolti negli scontri. Mentre erano in corso le
trattative tra il capo della polizia di Spalato e il capitano
Tommaso Gulli, una bomba esplose nel porto vicino alla
sede della Jadranska Banka. La violenza dilagò: il capitano
Gulli venne ucciso, due altri membri dell’equipaggio feriti
gravemente, uno dei quali morì poco dopo. La bomba aveva
fatto sulla riva diversi feriti e un morto. Si trattava di uno di
quegli incidenti dalla dinamica oscura, frequenti nelle zone
contese del primo dopoguerra, mai definitivamente chiariti e
in cui assai verosimilmente giocava un ruolo non marginale
la provocazione politica da parte di forze di intelligence più o
meno ufficiali. È interessante rilevare che il governo italiano
aveva perduto allora ogni controllo sulla situazione dalmata.
Secondo il comandante Andrews, l’ammiraglio Resio, con cui
ebbe un incontro dopo gli incidenti, era privo di istruzioni,
sia da parte del governo che da parte di Millo, allora
manifestamente dalla parte degli ammutinati di Fiume.
68
IL GIORNO DEL RICORDO
Gli incidenti di Spalato venivano resi noti a Trieste il 13
luglio. Le forze nazionaliste convocavano un’assemblea
pubblica in piazza Unità a cui partecipavano circa 2.000
persone. L’avvocato fascista Francesco Giunta arringava
la folla con toni da grand-guignol [= macabri, cruenti –
n.d.r.], incitando a far scorrere il sangue per vendicare
Gulli. Nel corso del comizio venivano pugnalati due giovani
in circostanze oscure. Uno di questi moriva sul colpo. Si
gridava quindi all’ulteriore provocazione slava, in quanto il
morto era ritenuto fascista. I più esagitati tra i dimostranti
si dirigevano verso la sede della rappresentanza serba: la
bandiera jugoslava era tolta dal balcone e calpestata dalla
folla. Una cinquantina di persone si dirigeva poi verso il
Balkan. Il Narodni Dom degli slavi di Trieste, inaugurato nel
1905, era un imponente edificio in stile Sezession, progettato
dall’architetto Max Fabiani. Era dislocato nel centro
cittadino, a simboleggiare e testimoniare la presenza slava
fin nel cuore della città. Vi avevano sede le più importanti
associazioni politiche e culturali, non solo slovene, ma
anche ceche, croate e serbe. L’edificio prendeva il nome
dall’albergo che ospitava (Balkan). Vi erano locati anche
diversi studi di professionisti slavi e abitazioni private.
Da un balcone dell’edificio una bomba veniva gettata
sulla folla, ferendo in modo grave un tenente. Testimoni
affermavano che la bomba era stata seguita da una fitta
sparatoria sui manifestanti. Asseritamente [= secondo
quanto asserisce, cioè sostiene, questa versione dei
fatti – n.d.r.], i manifestanti e la forza pubblica (polizia e
carabinieri, ma anche militari) davano alle fiamme l’edificio
in seguito a tali atti. In realtà le testimonianze sull’accaduto
sono reticenti e contraddittorie, non si trovarono prove
69
10 FEBBRAIO
certe né della sparatoria, né dell’esistenza di un arsenale
esplosivo che avrebbe dovuto trovarsi dentro l’edificio. A
causa dell’assalto un padre e una figlia, ospiti dell’albergo,
si gettarono dalla finestra per sfuggire alle fiamme. Il
padre morì e la figlia rimase gravemente invalida. Tutta
la vicenda continua a presentare diversi lati oscuri e la
maggior parte degli storici propende per l’ipotesi della
provocazione premeditata. Certo è che le devastazioni
videro all’opera inedite forme di cooperazione tra militari
e fascisti e segnarono una cesura nell’ascesa del fascismo
al confine orientale: non solo i fasci erano ora l’elemento
propulsivo della reazione violenta antislava e antisocialista,
cui si accodavano militari, carabinieri e le stesse autorità
civili. Essi erano riusciti anche ad acquisire una posizione di
preminenza e a definire meglio la loro fisionomia rispetto
alla nebulosa nazionalista delle origini. La giornata del 13
luglio 1920 vide altre devastazioni di proprietà slave, tutte
avvenute alla presenza della forza pubblica che non ritenne
di intervenire in alcun modo. […] Nei mesi successivi le
azioni intimidatorie, compiute con l’appoggio dell’elemento
militare, si moltiplicarono e si accrebbero di intensità. I
fascisti arrivarono addirittura a sparare in una chiesa nel
centro di Trieste contro un sacerdote colpevole di recitare
alcune preghiere in sloveno.
(M. Cattaruzza, L’Italia e il confine orientale: 1866-2006, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 141-145)
70
IL GIORNO DEL RICORDO
LA LOTTA DEL FASCISMO DI CONFINE CONTRO
L’USO DELLE LINGUE SLAVE
I
l proclama seguente fu emesso dagli squadristi di Dignano,
vicino a Pola, in Istria, nel 1921, per intimidire i croati. L’obiettivo della politica fascista era di cancellare la presenza
culturale slava. In un’ottica nazionalista, quella italiana era
l’unica vera forma di civiltà: giudicate barbare e inferiori, le
altre culture dovevano riconoscere la superiorità di Roma, cederle il passo e, di fatto, scomparire.
P.N.F. – Comando Squadristi – Dignano
Attenzione!
Si proibisce nel modo più assoluto che nei ritrovi pubblici e
per le strade di Dignano si canti o si parli in lingua slava.
Anche nei negozi di qualsiasi genere deve essere una buona
volta adoperata
SOLO LA LINGUA ITALIANA
Noi Squadristi, con metodi persuasivi, faremo rispettare il
presente ordine.
Gli Squadristi
(R. Pupo, Il lungo Esodo. Istria: le persecuzioni, le foibe, l’esilio,
Milano, Rizzoli, 2005, p. 160)
71
10 FEBBRAIO
Repressione italiana e occupazione
tedesca
D
opo l’occupazione italiana, in Slovenia si creò in breve
tempo una forte guerriglia comunista, parallela a quella
guidata da Tito in altre zone del paese. Nel 1941, alla fine di
novembre, i partigiani erano già riusciti a compiere numerose
azioni di sabotaggio contro treni, strutture ferroviarie, linee
del telegrafo. Inoltre, a Lubiana, la popolazione spesso dava
eloquenti segni di disapprovazione della presenza italiana,
mediante l’abbandono concordato, ad una data ora, di tutte
le strade e i locali. Riunitosi a Trieste, il Tribunale speciale italiano decretò nove condanne a morte e 666 anni di carcere a
esponenti politici e a intellettuali sloveni: quattro di essi furono
infine graziati da Mussolini, ma cinque sentenze capitali furono eseguite a Opicina, nei pressi di Trieste, il 15 dicembre.
Dal gennaio 1942, man mano che la guerriglia si faceva più
efficace e più pericolosa, l’esercito italiano fece ricorso a strumenti sempre più brutali, che vari storici definiscono coloniali. In pratica, ciò significava fucilazione di ostaggi, distruzione
di villaggi e deportazione di tutti i sospetti in campi situati in
Italia (il più importante divenne Gonars, in provincia di Udine) o nell’isola di Arbe (o Rab, nella Dalmazia settentrionale),
tristemente famosa per le sue pessime strutture logistiche. Ad
Arbe furono deportate diverse migliaia di persone: a causa del
freddo e delle infezioni intestinali, solo nel settembre-ottobre
1942 ne morirono 209; in totale, secondo la stima dello storico
Tone Ferenc, i decessi furono 1.400 (molti di più, secondo la
valutazione di altri studiosi). In vari casi, le direttive e le pratiche antiguerriglia adottate assomigliano molto a quelle che i
tedeschi applicarono sistematicamente in URSS, in Serbia e poi
dal settembre 1943, perfino in Italia; l’impressione complessiva, però, è che le truppe italiane agissero spesso di malavoglia,
72
IL GIORNO DEL RICORDO
senza condividere un preciso disegno imperialista o razzista.
Giorgio Rochat – specialista di storia militare – dopo aver notato che il contingente italiano impegnato nei Balcani era un’imponente forza di 600-650.000 uomini, osserva acutamente
che, pur essendo attivo un numero così alto di soldati, i diari e
le opere di memoralistica pubblicati sono pochissimi; è un altro
segno che questa guerra balcanica, fatta di rappresaglie e di
fucilazioni, più che di azioni militari vere e proprie, fu vissuta
con scarsa partecipazione dai soldati, che infine preferirono far
dimenticare la loro esperienza, invece di renderla di pubblico
dominio.
Nel settembre 1943, il completo collasso dell’esercito italiano
permise alle truppe di Tito non solo di impadronirsi di grossi
quantitativi di materiale, armi e munizioni, ma addirittura di assumere il controllo dell’Istria. L’occupazione militare jugoslava
fu accompagnata da una lunga serie di rappresaglie e di violenze, dirette nei confronti di tutti coloro che, in Istria, rappresentavano lo Stato italiano: carabinieri, insegnanti, messi comunali, impiegati postali… Alcune centinaia di queste persone
(tra le 500 e le 700, a seconda delle stime) furono arrestate
e uccise nei pressi di particolari cavità naturali carsiche, dette
foibe, nelle quali infine furono gettati i loro cadaveri. Questa
prima esplosione di violenza fu un’esperienza traumatica, per
gli italiani residenti in Istria, una regione che fino ad allora non
era stata toccata dalla guerriglia partigiana e dalle rappresaglie; pertanto, gli italiani si erano abituati a considerare innocui
i contadini slavi e non si aspettavano un attacco così duro e così
sistematico.
L’intervento delle forze tedesche obbligò i partigiani di Tito a
ritirarsi. I nazisti insediarono il loro comando a Trieste, all’interno della cosiddetta Risiera di San Sabba, un tetro edificio che
in precedenza era servito per l’essiccazione del riso. In breve
73
10 FEBBRAIO
tempo la risiera divenne un centro di transito per prigionieri destinati alla deportazione in Austria, in Germania o in Polonia e
un luogo di esecuzione dei partigiani catturati. A guida dell’apparato repressivo tedesco furono posti Odilo Globocnik e i suoi
più stretti collaboratori (ricordiamo ad esempio Christian Wirth
e Franz Stangl), che fino a quel momento avevano diretto la cosiddetta Aktion Reinhard, cioè lo sterminio degli ebrei polacchi
nei centri di Belzec, Sobibor e Treblinka. Nella Risiera di San
Sabba transitarono circa 20.000 prigionieri: la maggioranza di
essi fu deportata in campi di concentramento situati all’interno
del Reich; tuttavia, è possibile che 3-4.000 persone siano state
uccise all’interno del campo, che si era dotato di un proprio forno crematorio. Anche se si verificò il decesso di numerosi ebrei
rastrellati (e in verità destinati alla deportazione), per la grande
maggioranza i morti della Risiera furono partigiani e ostaggi
croati e sloveni, che venivano per lo più impiccati, di notte.
Sul confine orientale italiano (da loro ribattezzato Zona di operazioni del Litorale Adriatico), i tedeschi non dovettero confrontarsi mai, neppure a livello formale, con le autorità della
Repubblica Sociale Italiana, in quanto le province di Udine,
Trieste, Gorizia, Fiume, Pola e Lubiana furono sottratte alla sovranità italiana e di fatto incorporate nel Terzo Reich. In pratica,
ignorando completamente le proteste di Mussolini, Hitler, come
aveva già fatto in Polonia, anche in Italia si sforzò di cancellare
completamente le conseguenze della disfatta degli Imperi centrali nel 1918.
Libero di agire nel modo che riteneva più efficace, al fine di
schiacciare l’azione delle forze partigiane Globocnik introdusse
procedure di repressione violenta e indiscriminata, in tutto e per
tutto simili a quelle adottate fin dal 1941 sul fronte orientale.
Tuttavia, grazie alle risorse abbandonate dall’esercito italiano
(e ai cospicui rifornimenti inglesi), i guerriglieri jugoslavi riuscirono a tener testa ai tedeschi fino all’arrivo dell’Armata Rossa,
74
IL GIORNO DEL RICORDO
insieme alla quale entrarono a Belgrado il 20 ottobre 1944.
Pochi giorni prima di questa vittoria, il leader comunista italiano
Palmiro Togliatti si incontrò con alcuni delegati di Tito e decise
di sostenerne pienamente la politica. Alla fine di dicembre, in
nome del comune ideale comunista, i partigiani della brigata
Garibaldi Natisone (forte di ben 2.000 uomini) passarono sotto
il comando del IX corpus sloveno, che prendeva ordini dall’Esercito popolare di liberazione jugoslavo guidato da Tito
75
10 FEBBRAIO
LA REPRESSIONE DELLA GUERRIGLIA IN SLOVENIA
P
resentiamo alcuni passi di un bando emanato dal generale
Mario Robotti, comandante dell’XI corpo d’armata, e datato 18 luglio 1942. Il bando offre concreta esemplificazione di
una precedente ordinanza emanata dal Comando. I termini
usati dai generali italiani sono spesso molto duri: le truppe,
frequentemente, sono esortate ad essere spietate e a non lasciarsi prendere dai sentimenti.
a) Le misure di cui al n. II e III dell’ordinanza debbono essere
applicate con la massima energia e senza pietà.
b) chi compia comunque atti di ostilità alle autorità o truppe
italiane; chi venga trovato in possesso di armi, munizioni
ed esplosivi; chi favorisce comunque i rivoltosi; chi venga
trovato in possesso di passaporti, carta di identità e
lasciapassare falsificati, deve essere passato per le armi.
Non ammetto che gente colpevole di quanto sopra venga
deferita ai tribunali od internata; deve essere soppressa.
c) gli edifici da cui partano offese alle autorità e truppe
italiane; gli edifici in cui vengano trovate armi, munizioni
ed esplosivi o materiali bellici; le abitazioni i cui proprietari
abbiano volontariamente dato ospitalità ai rivoltosi (e per
logica conseguenza – ancora di più le abitazioni appartenenti
a ribelli) debbono essere inesorabilmente distrutte.
d) le misure di cui sopra non si applicano solo nella zona
in cui operano le truppe mobili, ma nell’intera provincia di
Lubiana.
e) la misura ultima del n. II dell’ordinanza (<<...saranno
passati per le armi... i maschi validi che si troveranno in
qualsiasi atteggiamento – senza giustificato motivo – nella
76
IL GIORNO DEL RICORDO
zona di combattimento>>) deve essere intesa nel modo
seguente:
1) I maschi validi trovati, in qualsiasi atteggiamento,
durante le azioni di combattimento, in aperta campagna,
dall’avanti sino alla linea di schieramento delle artiglierie,
non possono essere considerati (per ovvi motivi) che come
ribelli o favoreggiatori dei ribelli. E pertanto saranno passati
per le armi.
2) I maschi trovati in abitazioni isolate, gruppi di case e
centri abitati, sempre quando non siano rei degli atti
contemplati nei precedenti articoli del n. II della ordinanza,
saranno tutti arrestati. Quelli fra essi che non siano del
luogo saranno passati per le armi come quelli incontrati in
aperta campagna.
3) Saranno pure arrestati i maschi validi che affluiscono
in abitazioni isolate, gruppi di case e centri abitati, dopo
la nostra occupazione. Quelli tra essi che non risulteranno
del posto, o che non rientrino con le proprie famiglie
(circostanza questa che giustificherebbe la loro assenza al
momento della nostra occupazione) saranno passati per le
armi.
4) La procedura di cui ai nn. 1-2 e 3 sarà eseguita anche
nel caso che gli abitanti nel loro complesso accolgano
favorevolmente le truppe.
(E. Collotti, La seconda guerra mondiale, Torino, Loescher,
1985, pp. 110-111)
77
10 FEBBRAIO
IL COMPORTAMENTO DELLE TRUPPE ITALIANE NEI
BALCANI
L
’occupazione italiana di alcune regioni della Jugoslavia e
della Grecia fu brutale e spietata. Come nel caso delle colonie, gli italiani non furono affatto <<brava gente>>. Le
procedure applicate per reprimere le azioni dei partigiani non
sono molto diverse da quelle adottate dai tedeschi.
Nella pratica della repressione, la fenomenologia e la
tipologia delle azioni concrete previste e realizzate dalle
forze italiane non furono diverse da quelle riscontrabili
nella Wehrmacht, nelle forze delle SS e della polizia tedesca
coinvolte in operazioni analoghe. Negli ordini emanati da
autorità italiane per la lotta contro le bande partigiane e
per spezzare l’appoggio della popolazione ai partigiani
fu presente una vasta gamma di misure, comprendenti
la presa di ostaggi, la distruzione e l’incendio di intere
località, le rappresaglie sulle famiglie di semplici sospetti,
lo sgombero di larghe zone abitate in determinate aree,
il disboscamento di quelle considerate particolarmente
ricettive per le formazioni partigiane, la deportazione
di larghi nuclei della popolazione locale, la distruzione
e il saccheggio del bestiame, l’impunità per gli eccessi
compiuti. [...] Il tipo di repressione degli italiani nei Balcani
(ma non in Francia) s’ispirò decisamente all’esperienza
coloniale in Africa. Fu proprio nelle colonie che gli italiani
sperimentarono repressioni, deportazioni e internamenti
di massa. Ricordiamo che, in Etiopia, Mussolini impartì un
<<salutare monito>> alle popolazioni autoctone, inviando
un fonogramma nel quale impose che <<ogni civile o
78
IL GIORNO DEL RICORDO
religioso, uomo o donna, sospetto di aver favorito l’attentato
[contro le truppe italiane] doveva essere immediatamente
fucilato senza processo e senza indugio>>. Il 5 giugno
1936 telegrafò in Etiopia che <<tutti i ribelli fatti prigionieri
devono essere passati per le armi>> e, un mese dopo, l’8
luglio, autorizzò <<a condurre sistematicamente la politica
del terrore e dello sterminio contro i ribelli e le popolazioni
complici>>, poiché <<senza la legge del taglione al
decuplo non si sana la piaga in tempo utile>>. [...]
Per quanto riguarda la repressione nei territori jugoslavi
è indispensabile fare riferimento alla ben nota circolare
<< 3C >> del 1° marzo 1942, concepita dal generale
Mario Roatta, comandante della II Armata. Nelle pagine
che seguono essa sarà esaminata come paradigma della
normativa repressiva nei confronti delle popolazioni civili
e punto di partenza della radicalizzazione della lotta
antipartigiana. È fondamentale rilevare che fu redatta prima
che il sistema d’occupazione fosse in uno stato di precarietà
permanente a causa delle azioni dei partigiani. Il generale
Roatta scrisse esplicitamente che la lotta in corso era di tipo
coloniale e che bisognava impiegare, in forza massiccia,
mezzi potenti anche contro obiettivi sproporzionati. Questo
perché [...] la circolare non si limitò a descrivere i metodi
necessari a mantenere l’ordine e a reprimere i primi e,
tutto sommato, contenibili atti di ribellione organizzata,
ma avrebbe dovuto servire anche determinati scopi politici.
I metodi da applicare nella repressione oltrepassarono
chiaramente le esigenze militari, le necessità di lotta,
entrando nel campo della politica. L’internamento di massa
e la politica della terra bruciata furono dettati dall’esigenza
di <<sbalcanizzazione>> e di <<bonifica etnica>> e,
79
10 FEBBRAIO
almeno per quanto riguarda i territori annessi, obbedirono
allo scopo di un’imminente colonizzazione italiana. [...]
Le località occupate furono distinte tra zone in situazione
normale zone in situazione anormale (centri abitati e
campagne dove erano in atto operazioni belliche contro
formazioni armate ribelli). Nelle località in situazione
anormale, l’autore della circolare ordinò l’internamento
di tutte le famiglie da cui fossero mancati, senza chiaro e
giustificato motivo, maschi validi d’età compresa fra i 16 e i
60 anni, avviandole ad altra sede. L’internamento di massa
era una misura che il generale giustificò con la natura
delle azioni dei ribelli. In ogni zona in situazione anormale
si sarebbe designata la parte sospetta della popolazione
e fra questa sarebbero stati tratti e mantenuti in arresto
ostaggi che avrebbero risposto colla loro vita di aggressioni
proditorie a militari, nel caso che non fossero stati identificati
entro 48 ore gli aggressori. Gli abitanti di case prossime
al punto in cui fossero stati attuati sabotaggi a linee
ferroviarie, opere d’arte stradali, linee telefoniche e depositi
di materiali militari, furono considerati corresponsabili dei
sabotaggi stessi e, se trascorse 48 ore non fossero emersi i
responsabili, essi sarebbero stati internati, il loro bestiame
confiscato e le loro case distrutte. [...]
Nel Rapporto di Gorizia del 31 luglio 1942, Mussolini
<<benedisse>> la politica attuata in Slovenia e in
Dalmazia: <<Io penso che sia meglio passare dalla maniera
dolce a quella forte piuttosto che essere obbligati all’inverso.
Si ha in questo secondo caso la frattura del prestigio. Non
temo le parole. Sono convinto che al terrore dei partigiani
si deve rispondere con il ferro e con il fuoco. Deve cessare
il luogo comune che dipinge gli italiani come sentimentali
80
IL GIORNO DEL RICORDO
incapaci di essere duri quando occorre. Questa tradizione
di leggiadria e tenerezza soverchia va interrotta. Come
avete detto [è riferito al generale Roatta], è incominciato un
nuovo ciclo che fa vedere gli italiani come gente disposta a
tutto, per il bene del paese e il prestigio delle forze armate.
[...] Non vi preoccupate del disagio economico della
popolazione. Lo ha voluto! Ne sconti le conseguenze. [...]
Non sarei alieno dal trasferimento di masse di popolazioni.
[...] Considerate senza discriminazione i comunisti: sloveni o
croati, se comunisti vanno trattati allo stesso modo>>.
(D. Rodogno, Il nuovo ordine mediterraneo. Le politiche di occupazione dell’Italia fascista in Europa (1940-1943), Torino,
Bollati-Boringhieri, 2003, pp. 398-405)
IL CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI ARBE
A
lcuni degli episodi più gravi della violenza compiuta dagli
italiani in Jugoslavia si svolsero in Slovenia. Allorché Mussolini decise di trasformare Lubiana in una provincia a tutti gli
effetti italiana, migliaia di sloveni furono condotti nell’isola di
Arbe e internati in un campo di concentramento.
All’inizio dell’estate 1942, tra gli alti comandi militari italiani
era ormai diffusa l’idea che fosse necessario compiere
il “salto qualitativo” che avrebbe dovuto trasformare
le deportazioni parziali in “sgombero totalitario” della
popolazione della “Provincia di Lubiana”. Anche per questo
sull’isola di Rab (per gli italiani Arbe), da poco tempo
81
10 FEBBRAIO
annessa all’Italia, si stava predisponendo un enorme lager
che avrebbe dovuto accogliere 16.000 internati. L’occasione
per la presentazione al duce dell’imponente programma di
deportazione fu data dal summit politico-militare tenutosi
il 31 luglio 1942 a Gorizia. In quella occasione, parlando
alla folla dal palazzo del Comando militare, Mussolini
dichiarò apertamente guerra alla popolazione slovena,
minacciandola di deportazione e di sterminio. Poco dopo il
generale Robotti riferiva agli ufficiali che il progetto era stato
superiormente approvato e che, quindi, si sarebbe dovuto
“allargare il più possibile la macchia d’olio del dominio
italiano”, avviando “tutti gli uomini validi” nel campo di
concentramento di Arbe. [...]
La realizzazione del campo di Arbe era stata intrapresa alla
fine di giugno del 1942 con l’allestimento, su un terreno
paludoso in località Kampor, di una tendopoli capace di
“alloggiare” 6.000 internati. Altri settori (complessivamente
ne erano previsti quattro, oltre al cimitero), costituiti da
baracche e capaci di accogliere altre 10.000 persone,
dovevano essere realizzati prima del sopraggiungere della
stagione invernale. I civili deportati ad Arbe non furono
sottoposti al lavoro obbligatorio; tuttavia la fame, le pessime
condizioni igienico-sanitarie, il dormire sotto piccole tende
a contatto col nudo terreno e la mancanza di qualsiasi
tutela internazionale, resero la loro prigionia estremamente
penosa. Secondo i dati forniti dal Supersloda, dall’apertura
del campo sino alla metà di dicembre del 1942, erano già
morti 502 deportati.
Il nunzio papale presso il governo italiano, Monsignor
Francesco Borgognini Duca, che pure visitò quasi tutti i
campi di internamento della penisola, per i rischi connessi
82
IL GIORNO DEL RICORDO
ad un eventuale lungo viaggio da Roma al golfo del
Quarnero, non si recò dagli internati di Arbe. Lo fece, invece,
monsignor Giuseppe Srebrnic, vescovo della vicina isola di
Veglia (Krk), che rimase estremamente impressionato da
quanto visto. <<Ad Arbe, nel territorio della mia diocesi,
ove all’inizio del mese di luglio 1942 si aprì un campo
di concentramento nelle condizioni più miserabili che si
possono immaginare – scriveva il prelato il 5 agosto 1943 -,
morirono fino al mese di aprile dell’anno corrente, in base
agli esistenti verbali, più di 1.200 internati; però testimoni
vivi ed oculari, che cooperavano alle sepolture dei morti,
affermano decisamente che il numero dei morti per il detto
periodo ammonta almeno a 3.500, più verosimilmente a
4.500 e più...>>.
La storiografia jugoslava ha definito <<di sterminio>> il
campo fascista di Arbe; quella italiana, invece, avendolo
quasi completamente ignorato, non si è posta alcun problema
di definizione. Di fatto, i deportati vi cominciarono a morire
numerosi già nell’ottobre 1942, e il tasso di mortalità andò
aumentando sino al gennaio dell’anno successivo. Il fatto
che, sin dall’inizio, vi fosse stato predisposto un ampio
terreno per le sepolture (gli internati del campo lo definirono
<<quinto settore>>), dimostra, ad ogni modo, che
un’alta mortalità tra i prigionieri rientrava tra le previsioni
dell’Esercito italiano.
Da regolamento, il vitto avrebbe dovuto garantire ad ogni
deportato 1.000 calorie al giorno; di fatto, però, esso
ne offriva meno della metà. Particolarmente grave fu la
condizione delle partorienti, che molto frequentemente
diedero alla luce bambini già morti. All’inizio di novembre
130 internati avevano un’età inferiore ai dieci anni, e nel
83
10 FEBBRAIO
volgere di un mese il numero dei minorenni aumentò ad
alcune centinaia. La notte del 29 ottobre 1942, nel corso
di un violento nubifragio, un vicino torrente inondò il campo
e spazzò via moltissime tende. Negli ultimi mesi dell’anno,
tra i deportati di Arbe la mancanza di cibo era così grave e
diffusa che anche i giovani in pieno vigore fisico subivano
in poco tempo il dimezzamento del proprio peso corporeo:
centinaia di figure scheletriche, sfinite dalla fame si
trascinavano quotidianamente per il campo nell’improbabile
ricerca di qualcosa da poter mangiare.
(C. S. Capogreco, <<Internamento e deportazione dei civili
jugoslavi (1941-’43)>>, in C. Di Sante (a cura di), I campi
di concentramento in Italia. Dall’internamento alla deportazione
(1940-1945), Milano, Franco Angeli, 2001, pp. 149-151)
TOGLIATTI, TRIESTE E I COMUNISTI JUGOSLAVI
A
lla metà di ottobre del 1944, il leader comunista italiano
Palmiro Togliatti incontrò Edvard Kardeli e altri due dirigenti comunisti jugoslavi. Qualche giorno più tardi, il 19 ottobre, Togliatti comunicò a Vincenzo Bianco, un altro dirigente del partito, le decisioni prese durante quella riunione. Nel
testo, Togliatti esprime giudizi molto pesanti sulle prospettive
politiche che gli inglesi – a suo giudizio – avrebbero imposto
all’Italia dopo la fine della guerra. A suo giudizio, pertanto,
per Trieste e la Venezia Giulia, sarebbe stato meglio passare sotto sovranità jugoslava. In questa circostanza, nella valutazione politica del leader comunista, l’idea di nazione (e,
quindi, il principio della italianità di Trieste) fu completamente
84
IL GIORNO DEL RICORDO
subordinato al principio marxista dell’internazionalismo proletario.
1) Noi consideriamo come un fatto positivo, di cui dobbiamo
rallegrarci e che in tutti i modi dobbiamo favorire, la
occupazione della regione giuliana da parte delle truppe
del maresciallo Tito. Questo infatti significa che in questa
regione non vi sarà né un’occupazione inglese, né una
restaurazione dell’amministrazione reazionaria italiana,
cioè si creerà una situazione profondamente diversa da
quella che esiste nella parte libera dell’Italia, si creerà una
situazione democratica, in cui sarà possibile distruggere
a fondo il fascismo e organizzare il popolo tanto per la
continuazione della guerra contro gli invasori tedeschi,
quanto per la soluzione di tutti i suoi problemi vitali.
2) Il nostro Partito deve partecipare attivamente,
collaborando con i compagni jugoslavi nel modo più
stretto, alla organizzazione di un potere popolare in tutte
le regioni liberate dalle truppe di Tito (e anche prima di
questa liberazione) e in cui esista una popolazione italiana,
attraverso i suoi rappresentanti democraticamente scelti,
agli organi di potere popolare che si creeranno in queste
regioni. Esso lavorerà e lotterà per evitare che sorgano
conflitti tra la popolazione italiana e le popolazioni slave,
e per ottenere che italiani e slavi collaborino nel modo
più stretto alla soluzione dei compiti comuni immediati
dei due popoli, che sono: la sconfitta tedesca definitiva,
la distruzione del fascismo e la creazione di un regime
democratico e progressivo.
3) Questa direttiva vale anche e soprattutto per la città di
Trieste. Noi non possiamo ora impegnare una discussione
85
10 FEBBRAIO
sul modo come sarà risolto domani il problema di questa
città, perché questa discussione può oggi soltanto servire a
creare discordia tra il popolo italiano e i popoli slavi. Quello
che dobbiamo fare è, d’accordo con i compagni slavi e
nella particolare situazione che si sta creando in quella
regione, portare il popolo di Trieste a prendere nelle sue
mani la direzione della vita cittadina, garantendo che alla
testa della città vi siano le forze democratiche e antifasciste
più decise e disposte alla collaborazione più stretta con il
movimento slavo e con l’esercito e l’amministrazione di Tito.
I nostri compagni devono comprendere e fare comprendere
a tutti i veri democratici triestini che una linea diversa si
risolverebbe, di fatto, in un appello alla occupazione di
Trieste da parte delle truppe inglesi con tutte le conseguenze
che ciò avrebbe (cioè: disarmo dei partigiani, nessuna misura
seria contro il fascismo, instaurazione di un’amministrazione
reazionaria, nessuna democratizzazione, ecc.)…
4) Dovete reclutare nel modo più largo operai, contadini,
intellettuali italiani nelle unità partigiane le quali,
mantenendo il loro carattere nazionale, faranno parte
integrante dell’esercito di Tito. Questo, tra l’altro, è il solo
mezzo che permetta il disarmo di queste unità dopo la
cacciata dei tedeschi.
5) Il Partito è tenuto, in tutta l’Italia settentrionale e in tutte
le regioni già libere, a sviluppare un’ampia campagna di
solidarietà e per la collaborazione più stretta coi popoli
della Jugoslavia e col loro governo ed esercito nazionale,
popolarizzando [= divulgando tra le masse popolari – n.d.r.]
le conquiste democratiche di questi popoli, il carattere nuovo
del potere che essi hanno creato e soprattutto insistendo
sulla necessità della permanente amicizia tra il popolo
86
IL GIORNO DEL RICORDO
italiano e i popoli slavi…
6) Per quanto riguarda il futuro, dimostrare che la nostra
politica di collaborazione più stretta coi popoli della
Jugoslavia nel momento presente crea le condizioni in cui
tutte le questioni che possano esistere e sorgere tra l’Italia
e la Jugoslavia potranno essere risolte in conformità con
gli interessi dei due Paesi e con la volontà popolare, su
una base democratica e di stretta collaborazione, anche
per l’avvenire, nell’interesse comune di due Paesi che
non vogliono più essere la vittima e la preda di nessun
imperialismo.
(P. Spriano, Storia del Partito comunista italiano. 8. La Resistenza.
Togliatti e il partito nuovo, Torino, Einaudi, 1975, pp. 437-438)
87
10 FEBBRAIO
Trieste, Tito e le foibe
I
l 7 febbraio 1945, a Porzus, un gruppo di comunisti uccise
una ventina di partigiani democratico-cristiani della brigata
Osoppo, dopo averli accusati di tradimento. Questo scontro tra cattolici e comunisti in Venezia Giulia è il sintomo, a
livello locale, della situazione che di lì a poco si sarebbe creata a livello internazionale: venuto meno il comune nemico,
l’alleanza antinazista si sarebbe immediatamente sgretolata e
avrebbe lasciato il posto a relazioni sempre più fredde e ostili
tra americani e sovietici. Inoltre, l’eccidio di Porzus può essere
considerato come il preludio di una serie ancora più grave
di violenze, che furono compiute nei confronti degli italiani
nell’area di Trieste, allorché i partigiani comunisti jugoslavi
riuscirono a riconquistare l’intera Istria e ad entrare nel capoluogo giuliano, prima degli Alleati (1° maggio). Tito era un
comunista convinto, ma era animato anche da un marcato
nazionalismo slavo, e pertanto riteneva necessario allargare i
confini della nuova Jugoslavia che stava costruendo; al confine italiano, non nascose mai il proprio obiettivo di annettere
l’intera Venezia Giulia, spostando la frontiera con l’Italia al
fiume Tagliamento. Nelle aree occupate, le violenze del 1943
si ripeterono su scala ancora maggiore, in modo da eliminare
tutti coloro che potessero ostacolare o contrastare il controllo
slavo della Venezia Giulia. Per la seconda volta, i cadaveri
della maggioranza degli italiani uccisi furono gettati nelle foibe: e poiché esse erano spesso usate, dalla gente del luogo
come discariche, questo comportamento assunse anche un
potente significato simbolico. È difficile fornire un bilancio preciso di questi massacri, finalizzati ad imporre con la violenza,
in regioni tradizionalmente italiane, il nuovo ordine politicosociale, a un tempo slavo e comunista. Allo stato attuale degli
studi, pare corretto parlare di 4-5.000 vittime per il periodo
88
IL GIORNO DEL RICORDO
compreso tra l’occupazione jugoslava (1° maggio) e l’ingresso a Trieste delle truppe inglesi (12 giugno 1945).
L’operazione di repressione travolse centinaia di militari della
RSI, ma anche, più in generale, chiunque apparisse una minaccia per il potere comunista jugoslavo. Pertanto, furono colpiti
anche numerosi antifascisti italiani, che avevano combattuto
contro i tedeschi, ma ora – a guerra finita – rifiutavano il progetto annessionista di Tito. Insieme agli esponenti della borghesia giuliana, anch’essi furono dichiarati reazionari e nemici
del popolo, e di conseguenza giustiziati in modo sommario.
L’obiettivo, comunque, non era di ripulire l’intera area contesa
da qualsiasi presenza italiana. Anzi, nel 1947, un gruppo di
2.000-2.500 operai provenienti da Monfalcone e da altri centri
della valle dell’Isonzo, furono accolti con grande entusiasmo,
allorché decisero di trasferirsi a Fiume. Ovviamente, il fatto che
essi fossero di nazionalità italiana passava in secondo piano
rispetto ad altri due elementi decisivi: non erano di estrazione
borghese e, soprattutto, erano comunisti convinti, affascinati
dall’idea di poter vivere in un paese che aveva lasciato alle proprie spalle il capitalismo. Come scrive R. Pupo, l’avventura di
questi operai italiani (che avevano <<abbandonato la patria
della nazione per quella del socialismo e finirono per ritrovarsi
senza l’una né l’altra>>) si concluse in un <<cimitero di illusioni>>. Nel 1948, infatti, Tito entrò in contrasto con Stalin,
dopo aver lanciato l’idea di dar vita ad una federazione balcanica che comprendesse anche la Bulgaria e l’Albania. Poiché il
dittatore russo vide in questa proposta una sfida alla completa
egemonia che, nella sua concezione, l’Unione Sovietica doveva
esercitare su tutti i partiti e gli Stati comunisti, il 28 giugno 1948,
il partito comunista jugoslavo venne espulso dal Cominform, la
nuova versione dell’Internazionale comunista sorta poco tempo
dopo la guerra.
Per circa trent’anni, la Jugoslavia si trovò in una posizione stra-
89
10 FEBBRAIO
na e difficile: in quanto repubblica comunista, era guardata
con sospetto dagli Stati Uniti; nel medesimo tempo, rifiutava
di allinearsi, cioè di sottomettersi, alla potenza sovietica. Questa situazione permise a Tito di cementare l’unità di un paese
diviso e poco omogeneo. L’insistenza sul marxismo (con il suo
motto <<Proletari di tutto il mondo unitevi!>>) permetteva
di dare scarsa rilevanza alle varie nazionalità che esistevano
sul territorio jugoslavo e che spesso erano in contrasto tra loro
da lungo tempo. In secondo luogo, il pericolo di uno scontro
armato (sia con le potenze capitalistiche sia con l’URSS) permetteva di insistere sull’unione, sulla concordia interna, per la
sopravvivenza comune. Tito comunque, che era croato, conosceva bene il nazionalismo dei serbi: anzi, poiché lo temeva,
prese una serie di misure finalizzate a contenerlo. Innanzi tutto,
la nuova Repubblica di Jugoslavia fu costruita su base federale e organizzata in sei repubbliche (Slovenia, Croazia, BosniaErzegovina, Macedonia, Serbia e Montenegro). La Serbia, poi,
fu notevolmente indebolita, quanto a estensione territoriale, in
quanto perse la Macedonia (costituita in repubblica separata)
e il Kosovo (dichiarato nel 1974 provincia autonoma). Le cariche pubbliche e di partito, invece, furono distribuite in modo
equo, senza privilegiare alcuna nazionalità. Le rivendicazioni
serbe emersero subito dopo la morte di Tito (1980) e si fecero sempre più acute nel corso degli anni seguenti. Man mano
che la situazione economica, in Jugoslavia come in tutti gli altri
paesi comunisti, si faceva sempre più critica, in Serbia ripresero
vigore le vecchie ambizioni egemoniche. Il 28 giugno 1989, il
leader nazionalista serbo Slobodan Milosevic annunciò la revoca dell’autonomia del Kosovo. Per reazione, in Slovenia e in
Croazia - regioni settentrionali, più sviluppate dal punto di vista
industriale - si fece strada l’idea di una secessione dalle più
arretrate repubbliche del Sud (Serbia, Montenegro, Bosnia, Macedonia). Il 25 giugno 1991, Slovenia e Croazia dichiararono
90
IL GIORNO DEL RICORDO
la propria indipendenza dalla federazione jugoslava. Le due regioni, però, erano molto diverse tra loro, in quanto la Slovenia
era più omogenea della Croazia sotto il profilo etnico: in pratica, entro i propri confini ospitava solo una piccola minoranza,
formata dai pochi italiani che non erano fuggiti nel 1947. In
Croazia, invece, si trovavano moltissimi serbi, che oltre tutto
furono quasi subito oggetto di discriminazione. Costoro quindi
(appoggiati e sostenuti dall’esercito della Repubblica di Serbia)
si organizzarono in formazioni armate, per ottenere a loro volta
l’indipendenza dalla Croazia, dando inizio ad una sanguinosa
guerra che durò fino al 1995
91
10 FEBBRAIO
LE FOIBE
R
iportiamo due testimonianze relative alla tragica vicenda
delle foibe, verificatasi in Istria e nella zona di Trieste. Il
primo testo consiste nella dichiarazione rilasciata agli angloamericani da un maresciallo dei vigili del fuoco, incaricato di
recuperare dalla foiba istriana di Vines i corpi delle persone
uccise nel settembre 1943. Il secondo passo riguarda invece
il pozzo minerario di Basovizza, vicino a Trieste: si tratta di un
rapporto steso dagli Alleati, sulla base di interviste e testimonianze raccolte nell’estate del 1945.
LA FOIBA DI VINES
16 ott. ’43 – Foiba di Vines
Esplorata in mattinata la foiba di Cregli i cui lavori devono
essere sospesi perché la corda disponibile non basta per
raggiungere il fondo, il personale designato dall’Autorità
provinciale di Pola si reca nei pressi di Vines, alla foiba
denominata <<dei colombi>> ove, secondo la denunzia
di tale Monti da Albona, vi sarebbero dei cadaveri.
Iniziano immediatamente i lavori, organizzati come segue:
PERSONALE:
Maresc. Harzarich caposquadra
Vigile Prinz Giuseppe
Vigile Biluccaglia Giordano
Vigile Dellore Giovanni
Vigile de Angelini Mario
Tutti del 41° Corpo VV.FF. di Pola.
92
IL GIORNO DEL RICORDO
SCORTA
Per tema [= timore – n.d.r.] di attacchi da parte dei
partigiani, ogni spedizione del genere ha una scorta armata
che nella presente è rappresentata da 25 uomini forniti
dalla PS [Pubblica Sicurezza – n.d.r.] di Pola. [...]
OPERAZIONE
Terminata l’impalcatura [...] il Mar. Harzarich scende. Alla
profondità di 66 metri, sopra un piano fortemente inclinato,
trova alcuni indumenti di vestiario maschili e femminili e due
salme che vengono immediatamente portate alla luce.
Il direttore delle Miniere Carbonifere dell’ARSA, presente,
riconosce i due per:
1.Stossi Bruno, di Giovanni, di anni 39, elettricista da Pola,
operaio nelle miniere dell’ARSA [...]
2.Chersi Mario, fu Andrea, capo Operaio nelle miniere
dell’ARSA, da Albona. [...]
Il giorno successivo, il riconoscimento delle salme viene
confermato dai famigliari accorsi.
L’interrogato [Harzarich stesso, che sta descrivendo agli
angloamericani l’operazione di recupero delle salme –
n.d.r.] non è in grado di fornire particolari sulle eventuali
colpe dei due che hanno indotto i partigiani slavi a prelevarli
nelle loro case nella prima quindicina del settembre 43, per
gettarli nell’abisso.
I polsi dei disgraziati sono legati con filo di acciaio stretto da
pinze. I corpi fissati, spalla contro spalla, da un altro cavo
d’acciaio lungo circa 20 mt. e dello spessore di 5/6 mm. Il
lavoro viene sospeso a sera.
93
10 FEBBRAIO
17 ott. ’43
I lavori riprendono di buon mattino
Con materiale e personale messo a disposizione dalla
direzione delle miniere dell’ARSA, viene costruita
un’impalcatura più idonea [...], dopodiché l’Harzarich
scende a 146 metri per trovare un secondo piano. La visione
è delle più macabre: il piano è pieno di cadaveri.
(R. PUPO – R. SPAZZALI, Foibe, Milano, Bruno Mondadori,
2003, pp. 52-54)
LA FOIBA DI BASOVIZZA
N
ell’area di Basovizza una cavità, chiamata Pozzo della Miniera, fu usata dai partigiani jugoslavi, in particolare tra il
3 e il 7 maggio 1945, per l’eliminazione di numerosi italiani.
Tre testimoni oculari hanno dichiarato che gruppi da 100 a
200 persone sono stati precipitati o fatti saltare di sotto. Le
vittime dovevano saltare oltre l’apertura della foiba (larga
circa dodici piedi) e veniva detto loro che avrebbero avuto
salva la vita se ce l’avessero fatta. I testimoni riferiscono
che, sebbene qualcuno fosse riuscito nel salto, più tardi fu
ugualmente fucilato e scaraventato di sotto. Si dice che
un commissario [= funzionario del partito comunista, che
accompagnava le forze armate – n.d.r.] jugoslavo abbia
dichiarato che più di 500 persone sono state precipitate nel
pozzo ancora vive.
Successivamente sono stati gettati dentro i corpi di circa 150
tedeschi uccisi in combattimento nei dintorni, e così pure
94
IL GIORNO DEL RICORDO
circa 15 cavalli morti. Nella cavità furono poi gettati degli
esplosivi. La verità di queste affermazioni fu confermata
durante una chiacchierata con alcuni bambini del posto: una
di loro, dopo aver descritto quello che aveva visto, aggiunse
compiaciuta <<e in che modo i fascisti urlavano>>. Una
donna anziana, parlando delle esecuzioni, affermò che,
dal suo punto di vista, era stato un vero peccato sprecare
dei vestiti così buoni e che avrebbero dovuto far spogliare i
fascisti prima di precipitarli di sotto.
(R. PUPO – R. SPAZZALI, Foibe, Milano, Bruno Mondadori,
2003, p. 72)
LA VIOLENZA CONTRO GLI ITALIANI
NELL’IMMEDIATO DOPOGUERRA
È
difficile operare un confronto tra le violenze operate contro
gli italiani nel 1945 e altre azioni di pulizia etnica o di brutale riorganizzazione della fisionomia della popolazione che viveva in un territorio. In linea di principio, gli jugoslavi erano disposti a tollerare la presenza di nuclei di italiani: tuttavia, questi
avrebbero dovuto sottomettersi completamente ai progetti di
riorganizzazione sociale previsti dal regime e accettare passivamente l’annessione alla Jugoslavia di Trieste e dell’Istria.
Gli jugoslavi arrivarono nella Venezia Giulia con un
progetto ben preciso, a differenza degli anglo-americani,
che vi giunsero principalmente sull’onda di valutazioni di
ordine militare. Era un progetto che saldava in maniera
inestricabile motivazioni nazionali e ideologiche; era
95
10 FEBBRAIO
compiutamente totalitario, perché ambiva a controllare tutti
gli aspetti della realtà locale, ed era rivoluzionario. Fu questo
progetto a costituire la base dei comportamenti repressivi
tenuti dalle autorità jugoslave nella primavera-estate del
1945 nell’area giuliana, per designare i quali, come per
le stragi dell’autunno 1943, viene comunemente usata
l’espressione foibe. Una dizione questa, non va dimenticato,
da intendersi principalmente nel suo significato simbolico,
dal momento che buona parte delle vittime delle uccisioni di
massa (probabilmente alcune migliaia) non trovò la morte
nelle cavità carsiche, ma in circostanze diverse o durante
la prigionia. L’ondata di violenze coprì tutta la regione,
e in Istria apparve come una brutale ripresa della logica
di sangue interrotta nell’ottobre 1943. Tuttavia, arresti e
uccisioni si concentrarono questa volta [= nel 1945 - n.d.r.]
soprattutto nei centri urbani, che due anni prima ne erano
rimasti immuni in quanto prontamente occupati dai tedeschi,
e in particolare a Trieste e nel Goriziano. Quanto ai fatti,
basterà qui ricordare che appena cessarono i combattimenti
tra le truppe jugoslave e quelle nazifasciste, centinaia di
militari della RSI caduti prigionieri dei soldati di Tito furono
passati per le armi (lo stesso accadde anche ai tedeschi)
e migliaia di altri furono avviati verso i campi di prigionia,
dove fame, violenze e malattie mieterono un gran numero
di vittime. Contemporaneamente, le autorità jugoslave
diedero il via a un’ondata di arresti che seminò il panico
nella popolazione italiana. Parte degli arrestati venne subito
eliminata, molti di più vennero deportati in campi diversi da
quelli in venivano concentrati i militari, ma il cui trattamento
non era certo migliore.
Obiettivo delle violenze furono le persone più diverse,
96
IL GIORNO DEL RICORDO
accomunate dal fatto di costituire una minaccia per il
potere. Furono colpiti membri dell’apparato repressivo
nazifascista, quadri del fascismo e in particolare dello
squadrismo giuliano, elementi collaborazionisti (italiani e
slavi), ma anche partigiani italiani che non accettavano
l’egemonia del movimento di liberazione jugoslavo e alcuni
esponenti del CLN giuliano, insieme a sloveni anticomunisti
e a molti cittadini privi di particolari ruoli politici, ma
di chiaro orientamento filoitaliano e anticomunista. A
parte i casi evidenti di giustizia sommaria, sia gli arresti
che le eliminazioni non avvennero tanto sulla base delle
responsabilità personali quanto dell’appartenenza, mirando,
più che a punire colpevoli, a mettere in condizione di non
nuocere intere categorie di persone considerate pericolose.
La repressione quindi, più che giudiziaria, fu politica, una
sorta di epurazione preventiva diretta a eliminare tutti gli
oppositori, anche solo potenziali, al progetto del nuovo
potere: un progetto che era al tempo stesso nazionale e
politico, dal momento che consisteva nell’annessione della
Venezia Giulia alla Jugoslavia comunista.
Nel 1945 dunque, nei grandi entri urbani come Trieste,
Gorizia, Pola e Fiume non si ebbero in genere forme di
violenza spontanea da parte della popolazione slava contro
quella italiana, bensì una repressione dall’alto, anche se
essa si verificò in un clima di resa dei conti per le violenze
del fascismo e della lotta antipartigiana. Ancora una
volta, più confusa invece fu la situazione in Istria. In ogni
caso, protagonista dell’azione di sangue fu un movimento
rivoluzionario che si affermava con i modi propri delle
rivoluzioni e che, nel momento in cui conquistava il potere,
si trasformava in un regime di tipo stalinista, convertendo
97
10 FEBBRAIO
in violenza di Stato l’animosità nazionale e ideologica
diffusa nei quadri partigiani. […] Sia il disegno complessivo
di cui i comunisti jugoslavi erano portatori (e cioè la presa
del potere), che gli strumenti utilizzati per realizzarlo (la
violenza rivoluzionaria) non differivano sostanzialmente
da quelli messi in atto nel resto della Jugoslavia. Il
significato però che essi assunsero nella Venezia Giulia fu
ovviamente in parte diverso, perché si trattava di un’area a
nazionalità mista, appartenente ad altro Stato e oggetto di
rivendicazione. Nell’Istria come a Fiume, a Trieste come a
Gorizia, nella primavera del 1945 per le autorità jugoslave
il problema principale non era quello di eliminare sic et
simpliciter gli italiani, ma di ripulire il territorio da tutti i
soggetti che potevano mettere in discussione la saldezza del
nuovo dominio e incrinare l’immagine di compattezza della
partecipazione popolare agli obiettivi dei nuovi poteri. […]
Sloveni e croati non vennero trattati meglio degli italiani,
quando si trovarono sospettati di non aderire al nuovo
ordine; ma il punto è che gli italiani accusati di tale crimine, e
quindi perseguitati e, assai spesso, liquidati, furono nell’area
giuliana infinitamente di più. Ciò avvenne per molteplici
ragioni, ma soprattutto per una motivazione strutturale: fra gli
sloveni e i croati le parole d’ordine annessioniste fatte proprie
dal movimento di liberazione jugoslavo avevano consentito
di superare in larga misura la diffidenza nei confronti dei
comunisti […]. Al contrario, il rifiuto delle rivendicazioni
territoriali jugoslave, che riproponevano in toto le tradizionali
richieste del nazionalismo sloveno e croato, era patrimonio
comune della popolazione italiana, comprese le forze
antifasciste, a esclusione – non senza qualche perplessità –
della componente comunista. Dal punto di vista dei nuovi
98
IL GIORNO DEL RICORDO
poteri quindi, nei confronti della popolazione non slava la
pulizia doveva essere assai più larga, dal momento che,
se anche essere etnicamente italiani di per sé non veniva
considerato una colpa, essere politicamente filoitaliani lo era
senz’altro. […] Da parte della dirigenza jugoslava, il gruppo
nazionale italiano della Venezia Giulia era ritenuto nella
sua globalità, se non automaticamente nemico, perlomeno
altamente sospetto, a meno che i suoi membri non fossero
in grado di dimostrare il contrario con la militanza nel
movimento di liberazione jugoslavo.
(R. Pupo, Il lungo Esodo. Istria: le persecuzioni, le foibe, l’esilio,
Milano, Rizzoli, 2005, pp. 98-102)
LA VICENDA DELLE FOIBE: UN INQUIETANTE
NODO STORIOGRAFICO
P
er molti anni, i crimini compiuti dai partigiani jugoslavi in
Istria e in Venezia Giulia sono stati ignorati o minimizzati
dalle sinistre italiane. Altrettanto scorretta, tuttavia, fu la strumentalizzazione delle foibe effettuata a lungo dai neo-fascisti,
che si servirono delle atrocità comuniste per far dimenticare
tutte le violenze commesse, a Trieste, in Istria e in Slovenia,
prima dagli squadristi e poi dall’esercito italiano. Quella delle
foibe è una vicenda complessa: un microcosmo che riassume
tutte le tragiche contraddizioni del Novecento.
Nulla sarebbe più sbagliato del credere che delle foibe
si sia cominciato a parlare solo di recente. Al contrario,
l’argomento è stato frequentissimo, non solo nella
99
10 FEBBRAIO
pubblicistica [= sui giornali e, più in generale, sulla stampa
destinata ad un vasto pubblico – n.d.r.], che nel corso di
un cinquantennio ha dedicato al problema un vero diluvio
di interventi, ma anche nella storiografia, seppur in misura
nettamente minore. Piuttosto, c’è da chiedersi come mai i
contributi sul tema delle foibe abbiano trovato un’enorme
difficoltà a uscire da ambiti molto circoscritti: essenzialmente
quello locale giuliano e quello, del tutto speciale, degli esuli
giuliano-dalmati.
Per tentare una risposta, conviene partire dalla constatazione
che scarso interesse a livello nazionale non è stato suscitato
solo dal dramma delle foibe ma, più in generale, da quasi
tutte le vicende legate alla storia della frontiera orientale
italiana dopo la prima guerra mondiale. [...]
Dietro tali rimozioni incrociate sta probabilmente il fatto che
la storia del confine orientale per un verso ha potentemente
favorito la nascita di veri e propri miti politici e storiografici,
per l’altro, se rigorosamente investigata, offre pure tutti gli
elementi per mettere in crisi quei medesimi miti, oramai
consolidatisi nelle diverse culture politiche del nostro paese.
Ciò vale, per esempio, per il mito del buon italiano, che
può uscire alquanto ridimensionato dalla conoscenza
critica delle esperienze di occupazione italiane nei territori
ex jugoslavi, oppure per quello dell’innocenza della classe
dirigente italiana della Venezia Giulia e soprattutto di Trieste
nei confronti del potere germanico nel biennio 1943-1945,
se si tiene conto della rete di silenzi e complicità di cui i
nazisti poterono avvalersi per portare a compimento il loro
disegno di morte. Ma ombre tutt’altro che lievi non possono
che addensarsi anche sul mito del Movimento di liberazione
jugoslavo, a lungo considerato un esempio per tutti i
100
IL GIORNO DEL RICORDO
movimenti resistenziali europei, di fronte all’osservazione
delle violenze di massa – come, appunto, quella delle foibe
– attraverso le quali esso raggiunse i suoi obiettivi, e cioè
l’indipendenza del paese, l’annessione di territori rivendicati
ai confini e la costruzione del comunismo: passaggi tutti
di un progetto rivoluzionario che avrebbe condotto alla
formazione di un regime stalinista, anche se destinato
a scontrarsi con Stalin, al quale fra l’altro va addebitata
l’espulsione degli italiani dall’Istria. [...]
Nella primavera del 1945, a venire presi di mira non furono
tanto gli elementi di etnia italiana – che potevano venire
considerati buoni e onesti italiani se aderivano all’annessione
alla Jugoslavia – quanto tutti coloro che, a prescindere dalle
loro origini etniche, si sentivano politicamente italiani, vale
a dire desideravano il mantenimento della sovranità italiana
sulla regione. Secondo la medesima logica vennero perseguiti
pure gli sloveni e i croati contrari al comunismo. Anche la
formula rituale pertanto, secondo la quale molte delle vittime
delle foibe furono uccise soltanto perché italiane, risulta
sostanzialmente ambigua: poco fondata, specie per quanto
riguarda il 1945, se riferita all’origine etnica, appare invece
molto più significativa se declinata sul piano politico, con
l’avvertenza aggiuntiva che per <<italiani>> vanno intesi
non solo e non tanto quanti riconoscevano come italiana la
loro identità nazionale (lo facevano anche i comunisti che
si battevano per la Jugoslavia socialista) quanto piuttosto
coloro che volevano l’Italia, con una scelta politica in cui
preminente era la dimensione statuale.
(R. Pupo – R. Spazzali, Foibe, Milano, Bruno Mondadori, 2003,
pp. 108-113)
101
10 FEBBRAIO
TITO, IL COMINFORM E I LAVORATORI
COMUNISTI ITALIANI
L
’andamento delle relazioni tra Jugoslavia e Unione Sovietica ebbe drammatici risvolti per un gruppo di operai italiani
che, nel dopoguerra, scelsero di trasferirsi a Fiume per costruire il socialismo. Dopo la rottura fra Tito e Stalin, molti di loro
restarono legati al Cominform, assunsero posizioni critiche
nei confronti del Partito jugoslavo e quindi furono discriminati o incarcerati. Dopo anni di isolamento o dura reclusione,
furono rimandati in Italia, ma non poterono pubblicamente
descrivere le loro sofferenze perché Mosca, nel frattempo, si
era riconciliata con Belgrado: quindi, anche il PCI non aveva
più interesse a offrire un’immagine negativa della situazione
jugoslava.
[Nel 1947] a Fiume si trasferirono fra i 2.000 e i 2.500
operai isontini [= provenienti da Monfalcone e da altri centri
della valle dell’Isonzo – n.d.r.], che occuparono i posti di
maggior responsabilità nelle officine del siluruficio, della
Torpedo e della raffineria abbandonati dai lavoratori locali
[= italiani fuggiti dall’Istria – n.d.r.], ma non furono i soli
italiani a giungere in città: nel medesimo periodo fece infatti
il suo arrivo anche un buon numero di intellettuali regnicoli
[= originari del Regno (o meglio ex-Regno, nel 1947)
d’Italia – n.d.r.], provenienti cioè da varie parti d’Italia,
con una forte percentuale di meridionali. Erano insegnanti,
giornalisti, attori e artisti d’ogni genere, tanto che nel 1948
a Fiume l’intera orchestra dell’Opera, buona parte dei
cantanti, attori e registi del Teatro del Popolo, quasi tutti i
giornalisti del quotidiano la Voce del Popolo e delle altre
102
IL GIORNO DEL RICORDO
pubblicazioni in lingua italiana, molti maestri e insegnanti
di scuola media erano immigrati non giuliani. Per qualche
momento insomma, a Fiume si costituì una nuova, singolare
comunità italiana, non autoctona, giustapposta a quel che
restava di una società locale in via di rapida sparizione, le
cui logiche e passioni risultavano incomprensibili per i nuovi
arrivati, al di là del disagio dovuto alle sempre più serrate
partenze che, dall’oggi al domani, troncavano rapporti
appena allacciati e mutavano il volto della città. Quasi
accampata in una Fiume ormai largamente jugoslavizzata e
terribilmente immiserita, questa nuova comunità italiana era
assai variegata per composizione, ma unita nell’entusiasmo
di chi voleva costruirsi una vita nuova in un mondo che
avrebbe dovuto consentire la realizzazione degli ideali
socialisti e internazionalisti. In questo senso, anche se solo
per pochi mesi, Fiume rappresentò per quel grappolo di
italiani respinti dalla storia del loro Paese, una sorta di luogo
dell’utopia, o meglio dell’illusione. La durezza della politica
del dopoguerra, l’intollerante rigidità dei rapporti gerarchici
nel mondo comunista dominato dall’Unione Sovietica e
l’altrettanto intollerante fermezza del regime stalinista
jugoslavo stroncarono rapidamente quella breve stagione.
Quando la risoluzione del Cominform del 28 giugno
1948 scomunicò il partito comunista jugoslavo invitando
gli <<elementi sani>> a destituire i propri dirigenti, i
monfalconesi vennero a trovarsi in una situazione impossibile.
I comunisti italiani si riconobbero immediatamente nelle
critiche che la risoluzione rivolgeva al partito jugoslavo:
prevalenza degli elementi nazionalisti, scarsa democrazia
interna, metodi militari di direzione, incapacità di rifornire
di generi alimentari la popolazione urbana eccetera. Erano
103
10 FEBBRAIO
rilievi che esprimevano al meglio le perplessità che gli operai
isontini avevano già maturato nei mesi trascorsi a contatto
con la dirigenza croata […]. Ma se anche così non fosse
stato, la fedeltà dei comunisti giuliani a Stalin era indiscussa
ed essi, con incredibile ingenuità, la manifestarono in
maniera esplicita e clamorosa. A centinaia, i monfalconesi
parteciparono a riunioni e comizi pro Cominform e, quando
la dirigenza comunista jugoslava convocò un’assemblea in
un teatro cittadino, per spiegare le ragioni di Tito, accadde
l’irreparabile: i relatori ufficiali furono sommersi dai fischi,
mentre i monfalconesi prendevano la parola attaccando
la politica del partito a Fiume. Alla fine, il loro leader,
Ferdinando Marea, intonò l’Internazionale e tutti i presenti
si unirono al canto, abbandonarono la riunione e formarono
un corteo che sfilò per le vie della città.
A dire il vero la repressione non fu immediata. La dirigenza
jugoslava organizzò con gli esponenti monfalconesi una serie
di riunioni che misero però maggiormente in luce l’abisso
politico che si stava aprendo: alle accuse di deviazionismo
rivolte al partito jugoslavo, i monfalconesi si sentirono
rispondere che <<la patria si ama anche quando non è
socialista>>. Ma quella patria non era la loro, non era
riuscita a diventarlo, e l’Italia del resto non lo era più perché
era stata rifiutata. La portata del dramma perciò fu ben più
ampia di quanto non lasci intendere il numero di quanti
furono colpiti dai più gravi provvedimenti di polizia: solo una
quarantina di monfalconesi subirono la deportazione nel
campo di rieducazione di Goli Otok – l’inferno attraverso
il quale il regime cercava di piegare i cominformisti –, cui
vanno aggiunti i membri di una cellula clandestina di
militanti italiani, costituitasi a Fiume indipendentemente dalle
104
IL GIORNO DEL RICORDO
vicende dei monfalconesi al fine specifico di contribuire al
rovesciamento di Tito, ma ben presto individuata dall’UDBA,
la polizia politica. Al di là però della sorte terribile di una
cinquantina di elementi più esposti, l’intera esperienza delle
migliaia di lavoratori italiani emigrati in Jugoslavia perse di
colpo ogni senso. Il clima era cambiato, l’esistenza stessa del
socialismo nel Paese di elezione era messa radicalmente in
dubbio, i comunisti italiani erano divenuti complessivamente
sospetti e sottoposti a licenziamenti, angherie, isolamento.
Alla spicciolata quindi, piegati dalla delusione, cominciarono
a tornare in un’Italia che li accolse tutt’altro che volentieri,
ritrovandosi senza lavoro e spesso senza casa. <<Quel
marchio della Jugoslavia ce lo portiamo ancora sulle spalle,
perché siamo tornati con la coda fra le gambe, ce la siamo
cavata solo grazie alla tenacia>>, ha raccontato un
testimone, ma la tenacia non bastò per tutti, e molti, senza
patria e senza risorse, dovettero emigrare nuovamente, in
Francia, in Svizzera, in Svezia. Ancor peggio, se possibile,
andò agli oppositori più convinti del regime di Tito: liberati
alla metà degli anni Cinquanta dopo una durissima
detenzione, tornarono in Italia quando ormai si era avviato
il processo di destalinizzazione e i rapporti fra Tito e il PCUS
stavano migliorando. Il ricordo perciò della loro lotta e della
loro sofferenza divenne scomodo e fu cacciato anch’esso nel
grande armadio delle memorie dimenticate del Novecento,
colmo di spezzoni di vite bruciate, di drammi ignorati, di terre
perdute e di ideali infranti, che solo negli anni Novanta ha
cominciato a schiudere le sue ante.
(R. Pupo, Il lungo Esodo. Istria: le persecuzioni, le foibe, l’esilio,
Milano, Rizzoli, 2005, pp. 132-134)
105
a annette alcuni
goslavia del 1941, l’Itali
Ju
a
all
ne
sio
res
gg
e croati,
l’a
Dopo
la provincia di Lubiana,
re
tui
sti
co
a
o
nn
va
e
ch
territori sloveni,
ri carta).
lmazia (questi ultimi fuo
Da
in
e
me
Fiu
di
ni
tor
nei din
orienano a cavallo delle Alpi
cre
i
ch
es
ted
i
,
43
19
re
le province
Dopo l’8 settemb
adriatico, comprendente
ale
or
Lit
ni
zio
era
op
di
na
tali la zo
Lubiana,
a, Trieste, Pola, Fiume e
italiane di Udine, Gorizi
RSI è di fatto sospesa
in cui la sovranità della
la Venezia
jugoslavi occupano tutta
gli
45
19
io
gg
ma
di
i
Ai prim
e la parte
se devono abbandonar
Giulia, ma dopo un me
iso in due
ritorio viene pertanto div
ter
Il
e.
ion
reg
lla
de
e
oriental
n: la zona A
parate dalla linea Morga
verno
zone di occupazione, se
e di Pola) retta da un go
lav
nc
l’e
e
ch
an
nte
de
o
(compren
governo militare jugoslav
un
tto
so
B,
na
zo
la
e
militare alleato,
odena
ssoli – Carpi - M
L’ex Campo di Fo
Dimensione regionale
L’esodo dei profughi verso
l’Italia
Sospetti e diffidenze nei confronti dei
profughi
G
li italiani che, dopo il trattato di pace del 10 febbraio
1947 (e poi, più tardi, dopo l’intesa siglata a Londra
il 5 ottobre 1954) abbandonarono l’Istria e gli altri territori
passati sotto sovranità jugoslava non furono espulsi con la
violenza. Da questo punto di vista, la situazione fu molto diversa da quella dei tedeschi cacciati a forza dalla Polonia e
dalla Cecoslovacchia, prelevati casa per casa e obbligati con
la minaccia delle armi ad abbandonare il Paese. Tuttavia, è
del tutto fuorviante definire <<spontanea>> la partenza di
questi 250-300 mila italiani, in quanto le violenze si erano già
verificate nel 1945 e il nuovo sistema politico era percepito
da essi come una minaccia permanente, che incombeva sulla
loro identità culturale e nazionale, oltre che sulla loro sicurezza personale. Paura, angoscia per il futuro e consapevolezza
di un cambiamento irrimediabile, che aveva mutato in peggio
la loro condizione di vita, furono moventi che si intrecciarono,
si rafforzarono e infine spinsero migliaia di persone ad andarsene.
L’Italia della fine degli anni Quaranta, però, era un paese ancora molto provato dall’esperienza della guerra: macerie e rovine
erano ancora parte integrante del paesaggio cittadino, mentre
le risorse e il lavoro scarseggiavano sia per gli abitanti della
penisola sia per i numerosi altri profughi (dalle ex colonie africane o dalle isole del Dodecanneso) e rifugiati (ex prigionieri di
guerra ed ex deportati, ad esempio) che a ondate arrivavano in
Italia. L’arrivo dei profughi istriani e dalmati provocò numerosi
problemi particolari e delicati, in primo luogo di natura politica.
109
10 FEBBRAIO
Spesso, la stampa comunista li presentò in blocco come fascisti
o nazionalisti: comunque, agli occhi dei giornali legati al PCI,
si trattava di elementi infidi e pericolosi, che erano fuggiti da un
paese socialista, di cui si erano rifiutati a priori di condividere
il progetto di una società più giusta, perché esso avrebbe limitato i loro privilegi. Secondo un articolo pubblicato sul L’Unità
il 30 novembre 1946, era vero che nelle città italiane arrivavano anche migliaia e migliaia di <<italiani onesti, veri fratelli
nostri>>, definiti <<vittime della infame politica fascista, pagliuzze sbalestrate nel vortice dei rancori che questa ha scatenato… indotti a fuggire, incalzati dal fantasma di un terrorismo
che non esiste e che viene agitato per speculazione di parte>>.
Tuttavia, il resto dell’articolo insisteva sul fatto che, insieme ad
essi, erano partiti anche moltissimi gerarchi fascisti, <<briganti
neri>> e profittatori, oppure individui reazionari <<impauriti
dall’alito di libertà che precedeva o coincideva con l’avanzata degli eserciti liberatori>>. Costoro, concludeva l’articolo,
<<non meritano davvero la nostra solidarietà né hanno diritto
a rubarci pane e spazio che già sono così scarsi>>.
Articoli di questo tipo lanciavano di fatto un duplice messaggio:
da una parte cercavano di minimizzare o negare le violenze
che avevano trovato nelle foibe il proprio simbolo e il proprio
principale strumento di realizzazione concreto; dall’altro, lasciavano intendere che non era per nulla facile distinguere i
profughi <<buoni>> (vittime da compatire) da quelli <<neri
e reazionari>>, che non meritavano alcun tipo di assistenza e
aiuto, perché semplicemente cercavano di sfuggire al <<giusto castigo della giustizia popolare jugoslava>>. Alla luce
di questo orientamento di massima, si spiega come mai, alla
stazione di Bologna, il 18 febbraio 1947 un treno di profughi
(provenienti da Pola e diretti a La Spezia) sia stato accolto con
durezza e ostilità sia dalla gente che dai ferrovieri, che bloccarono la distribuzione dei pasti caldi preparati dalla Croce Rossa
110
IL GIORNO DEL RICORDO
e dalla Pontificia Opera di Assistenza; ai viaggiatori fu persino
impedito di scendere per bere e fare provvista di acqua per il
resto del tragitto: <<C’era gente che faceva il pugno chiuso
così – ricorda Giovanna B., che all’epoca era bambina – e ci
diceva fascisti e non si poteva neanche scendere dal treno, ma
noi avevamo bisogno di bere un po’ d’acqua e non ci lasciavano scendere. Allora mia madre mi ha detto: “Ma vai tu che
forse, visto che sei bambina ti fanno andare”, e infatti mi ha
accompagnato anche un ragazzino e ci han lasciato venire con
l’acqua sul treno. Ci hanno fermato una notte intera, avevamo
fame e sete e gli uomini non li lasciavano scendere, è stata
una cosa tremenda>>. Nello stesso febbraio 1947, una circolare inviata dalla direzione centrale a tutte le federazioni del
Partito cercò di cambiare la linea iniziale, esortò a <<non gettare fra le braccia della reazione>> i profughi e dichiarò che
<<il nostro partito e le organizzazioni democratiche di massa
non possono disinteressarsi di questi nostri connazionali>>, la
maggior parte dei quali non era per nulla fascista, ma semmai
cattolica e, quindi, democristiana.
De Gasperi si rese conto della complessità e della delicatezza della situazione; quindi cercò di far gestire a uomini di sua
assoluta fiducia le più urgenti questioni di assistenza e sistemazione. Sospetti e diffidenze, in realtà, non circolavano solo tra i
comunisti: basti pensare che, nel 1949, il ministro dell’Interno
Mario Scelba (democristiano noto per la sua intransigenza contro gli scioperanti) ordinò che a tutti i profughi che chiedevano il
rinnovo dei documenti di identità fossero obbligati a depositare
presso le autorità di polizia le proprie impronte digitali. In pratica, anche il governo – malgrado gli sforzi personali di De Gasperi e dei suoi diretti collaboratori (il provvedimento sulle impronte, infatti, fu rapidamente revocato) – considerava gli esuli
come soggetti potenzialmente pericolosi, da tenere sotto stretta
sorveglianza, piuttosto che sventurati connazionali bisognosi di
111
10 FEBBRAIO
solidarietà e di sostegno materiale e morale. Solo col passar
del tempo fu possibile procedere ad un vasto programma specifico di case popolari destinate ai giuliano-dalmati, che in 39
province complessive costruì 7.000 alloggi. Tuttavia, nell’estate
del 1963, 8.493 profughi giuliano-dalmati risultavano ancora
residenti in 15 dei 120 campi di accoglienza allestiti negli anni
Quaranta e Cinquanta
112
IL GIORNO DEL RICORDO
LE RAGIONI DELL’ESODO
N
el senso più stretto del termine, gli italiani non furono
espulsi con la violenza dall’Istria e dagli altri territori passati sotto sovranità jugoslava. Tuttavia, il mondo in cui erano
nati e cresciuti era completamente scomparso, al punto da
rendere impossibile la permanenza in quello che ormai era
per loro un paese straniero ed ostile.
La paura costituì senza dubbio una spinta importante e
spesso decisiva per l’Esodo, ma non fu la sola: in questa
direzione vi è stato piuttosto uno sbilanciamento della
memoria istriana e delle ricostruzioni che si sono limitate
a riprodurne i contenuti, mentre il problema presenta
dimensioni più ampie, in buona misura connesse ai
cambiamenti sostanziali, di natura cioè rivoluzionaria,
registrati dalla società istriana nel dopoguerra. Pur con le
molte varianti legate alla diversità dei contesti, i processi
cui le comunità italiane furono sottoposte presentano infatti
tratti marcatamente comuni: l’impoverimento generale,
la scrematura politica, il sovvertimento delle tradizionali
gerarchie – a un tempo nazionali e sociali – che avevano visto
gli italiani storicamente egemoni in Istria, e il ribaltamento
dei rapporti di potere fra città e campagna. Ma accanto
a tali elementi, riferibili alla sfera dell’economia e della
politica, ve ne erano altri, che coinvolgevano la quotidianità
dell’esistenza e davano la misura di una trasformazione che
finiva per venir percepita come un rivolgimento dell’ordine
naturale delle cose. I valori cardine della società venivano
messi radicalmente in discussione, le abitudini consolidate
da generazioni dovevano essere abbandonate, tutte le
113
10 FEBBRAIO
certezze scomparivano e le nuove regole (dalla necessità
di imparare la lingua di popoli da sempre considerati
senza cultura, al tentativo di forzare la terra ai ritmi di una
pianificazione irrispettosa dei tempi della natura e della
tradizione, all’impostazione di nuovi criteri di misura del
lavoro e del prestigio sociale) apparivano frutto di una
volontà insensata e malevola, alla fine insondabile. Ancor
più nere erano le prospettive per il futuro, e le sofferenze del
presente si sommavano all’angoscia per il destino dei figli.
In alcuni casi, fu proprio la preoccupazione per il modo in
cui le nuove generazioni sarebbero cresciute nelle maglie
del regime a far pendere la bilancia verso l’Esodo. […]
Per gli italiani il cambiamento era totale, e si trovarono a dover
vivere un passaggio così traumatico nelle peggiori condizioni
possibili: isolati, impotenti e progressivamente privati dei
loro usuali punti di riferimento, a seguito dell’eliminazione
della classe dirigente, della scomparsa dei soggetti sociali
più rappresentativi e dell’allontanamento delle figure chiave
della società locale. I religiosi e gli insegnanti vennero infatti
sostituiti dalle organizzazioni del regime e da un sistema
formativo che anche quando si svolgeva in lingua italiana
[…] era comunque orientato verso l’attenuazione dei legami
del gruppo nazionale italiano con la madrepatria e verso
la denigrazione dell’Italia, considerata irrimediabilmente
fascista e imperialista.
Ecco allora che per gli italiani dell’Istria i mutamenti,
generalmente in negativo, delle loro condizioni di vita
costituivano soltanto uno degli aspetti di un profondo disagio,
che prese la forma di una vera e propria crisi collettiva di
identità. È su quest’ultimo aspetto che la storiografia più
recente ha insistito con particolare attenzione, allargando
114
IL GIORNO DEL RICORDO
significativamente il campo delle fonti attraverso il recupero
di quelle della memoria, dalla memorialistica tradizionale
alla scrittura popolare, dalle elaborazioni letterarie al
patrimonio di ricordi e riflessioni portato alla luce dalle
raccolte di storie di vita. Seguendo tale percorso si è arrivati
a leggere l’Esodo come il rifiuto collettivo, espresso con una
scelta estrema, di un processo di modernizzazione accelerata
e violenta condotto dal potere statale comunista. Si tratta
di un giudizio che certamente coglie una delle dimensioni
centrali del rapporto traumatico instauratosi fra il regime, e
la popolazione residente, soprattutto nelle aree rurali o nelle
cittadine istriane dove il tempo della storia scorreva lento,
ma che non pare assolutamente generalizzabile a tutta
l’Istria. Una regione, come si è visto, assai variegata, entro
la quale situazioni che per certi aspetti potremmo definire
premoderne, convivevano con la realtà di centri come Fiume
e Pola – la seconda, addirittura, creazione artificiale della
politica asburgica tardo-ottocentesca – che pure vennero
massicciamente coinvolti dal fenomeno dell’Esodo.
Più produttiva invece si sta rivelando la categoria dello
spaesamento, che è divenuta la chiave interpretativa
privilegiata cui far ricorso per comprendere l’atmosfera in
cui furono costretti a vivere gli istriani di lingua, cultura e
sentimenti italiani, i quali, anche quando resistettero più a
lungo alle ondate repressive e alle pressioni politiche del
regime, finirono per ritrovarsi in una terra diversa, dove altre
presenze, altri costumi, altri meccanismi di integrazione
sociale, altri orizzonti di vita facevano sì che quella medesima
terra, in cui pure erano nati, non sembrasse più la loro.
Sentirsi <<stranieri in patria>> – secondo un’espressione
ricorrente nelle fonti – è una condizione lacerante, che getta
115
10 FEBBRAIO
le fondamenta psicologiche per la scelta dell’abbandono.
Una scelta che si rafforza perché accanto alla crescente
estraneità nei confronti del luogo d’origine – divenuto luogo
del dolore, dell’umiliazione e dell’incomprensione – prende
corpo l’immagine alternativa di una patria interiorizzata e
idealizzata, lontana dalla comunità reale, ormai stravolta
e irriconoscibile. Era l’immagine di un’Italia che forse non
esisteva, ma costituiva il possibile altrove, in cui era legittimo
sperare di realizzare quanto nella realtà dell’Istria jugoslava
era stato irreversibilmente negato.
La scelta dell’Esodo pertanto, che – a parte le fughe
individuali legate a situazioni di emergenza – fu in genere
scelta collettiva, capace di svuotare interi paesi o addirittura
intere città come Pola, si pose come punto di arrivo di un
lungo processo di destrutturazione e di atomizzazione delle
comunità italiane. Attraverso una molteplicità di itinerari e di
sofferenze esse furono condotte a riconoscere l’impossibilità
di mantenere la loro identità nazionale – intesa nel suo
senso forte, come complesso di modi di vivere e di sentire
secolarmente sedimentati, ben al di là della sola dimensione
politico-ideologica – nelle condizioni proposte dallo Stato
jugoslavo. È solo muovendo da tale conclusione che ha
senso porsi in maniera non astratta il problema dell’effettiva
libertà di scelta di cui poterono disporre gli italiani di Fiume
e dell’Istria, al di là del riconoscimento formale del diritto di
opzione. Il punto infatti è costituito dalla valutazione delle
alternative concrete a disposizione di chi, in una situazione
specifica, era restio a prendere la via dell’esilio, e in questo
senso con grande chiarezza si è espresso nel 1967 Theodor
Veiter: <<La fuga degli italiani secondo il moderno diritto
dei profughi è da considerare un’espulsione di massa. È vero
116
IL GIORNO DEL RICORDO
che tale fuga si configura come un atto apparentemente
volontario, ma […] colui che, rifiutandosi di optare o non
fuggendo dalla propria terra, si troverebbe esposto a
persecuzioni di natura personale, politica, etnica, religiosa
o economica, o verrebbe costretto a vivere in un regime che
lo rende senza patria nella propria patria di origine, non
compie volontariamente la scelta dell’emigrazione, ma è da
considerarsi espulso dal proprio paese>>.
(R. Pupo, Il lungo Esodo. Istria: le persecuzioni, le foibe, l’esilio,
Milano, Rizzoli, 2005, pp. 200-204)
117
10 FEBBRAIO
Il villaggio San Marco a Fossoli
G
li impianti che vennero attivati sul territorio nazionale,
per far fronte all’emergenza dell’esodo dei profughi giuliano-dalmati, in larga misura furono strutture di risulta (ex caserme, ex conventi, ex manicomi…). In provincia di Modena,
si decise di utilizzare ancora una volta l’area dell’ex campo
di concentramento di Fossoli, vicino a Carpi. La decisione di
usare strutture già impiegate, in tempo di guerra, come campi
di prigionia non riguardò solo Fossoli: a Laterina, in provincia
di Arezzo, l’area che ospitò i profughi aveva già visto rinchiusi
al suo interno dapprima soldati inglesi e americani, e poi militi
della RSI e soldati tedeschi.
Complessivamente, la regione Emilia Romagna ospitò 5.159
profughi, una cifra pari alla 0,142% dell’intera popolazione
della regione stessa. Bologna ne accolse il numero maggiore
(1.937), seguita da Modena (810), Forlì (714), Ravenna (534),
Ferrara (395), Parma (384), Reggio Emilia (251) e Piacenza
(134). Lo scarso numero di soggetti accolti si spiega soprattutto
con il prevalente orientamento rosso della regione, e quindi con
la diffidenza nutrita da gran parte della popolazione e delle amministrazioni nei confronti di individui spesso bollati in blocco e
in modo acritico come fascisti, in fuga da una meritata punizione o comunque incapaci di comprendere i mutamenti in atto
nella nuova Jugoslvia comunista. La maggior parte degli esuli
che furono indirizzati a Carpi proveniva da Pola e arrivò nel
periodo febbraio-maggio 1947. Alcuni di essi, in verità, erano
polesani solo in senso lato: si trattava, piuttosto, emigrati di
ritorno, che si erano recati a Pola per lavorare nel 1939-1940,
dopo che la Cooperativa muratori e braccianti di Carpi aveva
vinto un importante appalto per la costruzione delle infrastrutture finalizzate a potenziare il porto della città istriana.
In questo primo periodo immediatamente seguente la stipula-
118
IL GIORNO DEL RICORDO
zione del trattato di pace, che mette in moto l’esodo nella sua
forma più acuta e numericamente importante, Fossoli era utilizzato come campo di raccolta per profughi stranieri (provenienti
dalla Germania, dall’Austria o dall’Europa centro-orientale)
sospettati di essere colpevoli di crimini o reati, e come tali tenuti sotto stretta sorveglianza. Nel frattempo (dal maggio 1947
all’agosto 1952) diverse strutture di Fossoli diedero ospitalità a
don Zeno Saltini, che aveva fondato la comunità di Nomadelfia, finalizzata al sostegno dei bambini orfani, bisognosi e senza
famiglia, presenti in gran numero sul territorio carpigiano, a seguito della guerra e dei problemi della lenta ricostruzione postbellica. Trovatasi in gravi difficoltà economiche, la comunità fu
obbligata dapprima a sgomberare il campo, e poi costretta a
trasferirsi in provincia di Grosseto; a quel punto, Fossoli divenne
disponibile per altri usi, e quindi iniziò ad ospitare un nucleo di
profughi istriani, che diedero vita al cosiddetto Villaggio San
Marco e sarebbero rimasti in quell’area dal 1954 al 1970.
I profughi che si insediarono a Fossoli appartenevano, per così
dire, alla seconda ondata, quella che si mise in moto dopo il
Memorandum d’intesa siglato a Londra da Italia e Jugoslavia
il 5 ottobre 1954, che assegnò in via definitiva la Zona A del
Territorio Libero di Trieste (comprendente la città stessa) all’Italia, ma rese di fatto irrevocabile anche la sovranità jugoslava su
Capodistria, Pirano e altri centri (Umago e Buie, ad esempio)
situati sulla costa e nell’immediato entroterra istriani (Zona B).
Diversi di questi esuli abbandonarono le loro case ancor prima
della firma ufficiale dell’accordo, trovando un primo alloggio
nel campo di smistamento di Udine. Il progetto del Villaggio
San Marco viene elaborato dal prefetto di Modena d’intesa con
il Ministero dell’Interno (che si farà carico dell’acquisto dell’area
dell’ex campo di concentramento); sul piano finanziario (ma il
discorso, in verità, investe anche lo status e la dignità stessa dei
rifugiati) il progetto prevede che gli ospiti non vengano sempli-
119
10 FEBBRAIO
cemente assistiti, bensì aiutati soprattutto a trovare un lavoro
sul territorio e quindi nel più breve tempo possibile diventino
famiglie autonome e autosufficienti.
Il progetto incontrò l’opposizione di un nutrito gruppo di abitanti della frazione di Fossoli, ma tale protesta fu di fatto ignorata,
cosicché il prefetto di Modena annunciò la formale istituzione
del villaggio il 12 maggio 1954. Le prime sette famiglie di profughi arrivarono alla stazione di Carpi il giorno 7 giugno; alla
cerimonia di accoglienza erano presenti il parroco di Fossoli, il
vescovo di Carpi e un deputato democristiano, ma non il sindaco (comunista) della città di Carpi: con le sue presenze e le sue
assenze, di forte impatto e significato simbolico, questo episodio è una sorta di microcosmo di una situazione più generale,
che da solo mette in luce l’opposto atteggiamento assunto dalla
DC e dal PCI di fronte all’intera vicenda dell’esodo.
Nei 16 anni in cui funzionò, i rapporti tra il villaggio e il territorio
in cui era inserito, ovvero tra profughi e abitanti del comune
di Carpi, non registrarono mai violenze o episodi drammatici;
tuttavia, l’incomprensione dei carpigiani nei confronti dei nuovi
venuti fu tenace e difficile da scalfire, complice una serie di differenti e complementari fattori: la già più volte citata equazione tra esuli e fascismo; l’assoluta disinformazione sulle ragioni
della fuga e sulle terre da cui i fuggiaschi provenivano; il timore
che i nuovi arrivati fossero dei privilegiati, capaci di togliere
case e lavoro agli abitanti del luogo.
Nel 1956, il villaggio ospitava circa 400 persone, che diminuirono col passar del tempo, fino a che gli ultimi 100-150 abitanti, nel 1970, non trovarono sistemazione in alloggi popolari
appositamente allestiti per loro
120
IL GIORNO DEL RICORDO
IL RAPPORTO TRA IL VILLAGGIO SAN MARCO E
IL TERRITORIO CIRCOSTANTE
L
a maggioranza delle testimonianze ricorda la vita nel Villaggio San Marco come accettabile e dignitosa, sotto il profilo
materiale. Per quanto gli alloggi fossero stati recuperati dalle
strutture di un ex campo di concentramento, due donne di
Fossoli, dopo essersi sposate con due esuli, scelsero di vivere
all’interno del villaggio. Nel complesso, comunque, l’integrazione tra esuli e abitanti del luogo fu difficile e problematica:
i nuovi venuti furono a lungo guardati con sospetto e trattati
con diffidenza.
Se il giudizio complessivo sull’assistenza e sull’abitazione
è positivo, lo stesso non si può dire per l’integrazione
dei profughi giuliani nella cittadina di Carpi e a Fossoli:
l’inserimento infatti, soprattutto all’inizio, non è stato
indolore, ma anzi piuttosto difficoltoso. Innanzitutto perché
la popolazione inconsciamente continua a collegare
il Campo con le idee di fascismo, nazismo, minaccia,
repressione, violenza: una realtà ostile e pericolosa. Tutte le
successive destinazioni nel tempo, infatti, hanno in qualche
modo rappresentato un pericolo per Fossoli: anche quando
la fornitura di cibo e di servizi a internati e custodi era
un’importante fonte di reddito, gravava su di loro [= sugli
abitanti di Fossoli – n.d.r.] la minaccia di esservi internati
per la minima mancanza, per un sospetto o una delazione
malevola. Gli stessi internati, poi, hanno rappresentato un
pericolo per la popolazione locale, suscitandone l’ostilità,
in particolare nel periodo 1945-47, quando era attivo il
Centro di raccolta profughi stranieri: la stampa dell’epoca
121
10 FEBBRAIO
dedica ampio spazio ad articoli scandalistici di fughe, furti,
disordini all’interno e all’esterno del campo, e di dichiarazioni
allarmate dei residenti nelle zone limitrofe. Nemmeno il
periodo di Nomadelfia è stato scevro da problemi per la
popolazione locale, per i contrasti sorti tra i nomadelfi e
alcuni esponenti della Democrazia cristiana di Carpi, e per
la disinvoltura della gestione economica, che ha suscitato
amarezza in molti creditori. Se a questa realtà, già di per sé
critica, si aggiunge, da un lato, il contesto del dopoguerra
con le sue esasperate tensioni politiche, dall’altro il fatto che
i profughi giuliani vengono indiscriminatamente etichettati
come fascisti, non risulterà difficile comprendere quanto
negativamente abbia influito il connubio tra i sentimenti
antifascisti generati dai fatti avvenuti nel Campo e l’erronea
equazione “profughi = fascisti” riferita ai suoi nuovi abitanti.
Probabilmente il sentire comune degli abitanti di Fossoli
s’informa a una sensazione d’accerchiamento e di rinnovato
pericolo: si arriva a pensare che i nuovi gestori del campo,
equiparati senza vie di mezzo alle vecchie autorità fasciste,
si comporteranno esattamente come i loro predecessori,
<<…la faranno da padroni>>, insomma, per usare le
parole di Bruno, ex profugo istriano.
Non contribuisce a rassicurare gli animi dei carpigiani il
fatto che i profughi godano della protezione dello Stato, in
particolare di Scelba, di cui è noto l’impegno anticomunista
e che tutti associano alla repressione antioperaia tra la fine
degli anni Quaranta e i primi Cinquanta, in particolare
alla strage delle Fonderie riunite di Modena del 9 gennaio
1950: ancora un sillogismo mentale ingiustificato, che
porta a considerare con ostilità i profughi giuliani, genera
nei loro confronti sentimenti d’astio e di risentimento. […]
122
IL GIORNO DEL RICORDO
Ma l’elemento fondamentale che ostacola lo stabilirsi di
rapporti equilibrati tra le due parti e, di riflesso, anche
l’integrazione dei profughi, è sicuramente l’assoluta
mancanza d’informazione ufficiale della popolazione del
luogo sulla questione giuliana. Questa totale disinformazione
è confermata da tutti gli ex profughi intervistati: <<Guardi
tutti cadevano un po’ giù dalle nuvole, perché adesso poi…
cadono giù dalle nuvole ancor di più; ma secondo loro…
non riuscivano a capire il perché, forse bisognava esserci per
capirlo>>; o ancora: <<No, allora, allora, a spiegarglielo
in tutte le lingue… non sono mai riusciti a capire niente, mai,
mai, mai>>.
Si tratta di ignoranza, in primo luogo, geografica. L’Istria
è un non-luogo, per molti: forse a nord, forse a nord-est,
abitata non si sa bene da chi, e governata da autorità non
identificate. Solo dopo gli anni Settanta del Novecento le
vacanze di massa hanno insegnato a parecchi le strade per
raggiungere le sue spiagge, ma non hanno contribuito a far
conoscere l’orizzonte storico e umano di chi ha vissuto in
quei luoghi e li ha poi abbandonati. […]
Oltre alla disinformazione, un altro fattore che ha frenato
considerevolmente l’integrazione con la popolazione locale
è stato il fatto che quest’ultima vedeva i profughi come
concorrenti nei diritti al lavoro e alla casa. In un ambiente
povero, caratterizzato da difficoltà economiche e sociali e
da tensioni proprie di un’epoca di transizione, in cui il Paese
– conclusa la prima fase di ricostruzione dei disastri della
guerra – si sta avviando sulla strada di un nuovo benessere,
accade che i giuliani vengano visti negativamente perché
considerati coloro che sono venuti a “portare via” il lavoro
e la casa agli abitanti del luogo; una situazione, questa,
123
10 FEBBRAIO
che si verifica non solo a Fossoli, ma anche a Trieste e
in diverse parti d’Italia. Ricordiamo, nel caso locale, la
petizione del gennaio 1954, in cui una parte degli abitanti
fossolesi rivendica a sé l’utilizzo del compendio immobiliare
dell’ex città di Nomadelfia per destinarlo ad abitazioni
per gli indigenti e i disoccupati della frazione. Sono gli
stessi profughi ad avvertire questa situazione, soprattutto
in riferimento al lavoro: <<La popolazione che avevamo
intorno ci ha preso molto male, perché noi gli portavamo via
posti di lavoro>>. Maria ricorda che nell’ambiente di lavoro
le era stato provocatoriamente chiesto come mai, lei che
non era comunista, lavorasse per il Comune, sottintendendo
che stesse sottraendo il posto di lavoro a un carpigiano in
linea con la tradizione amministrativa della città.
(M. L. Molinari, Villaggio San Marco. Via Remesina 32, Fossoli
di Carpi. Storia di un villaggio per profughi giuliani, Torino, EGA
Editore, 2006, pp. 96-102)
124
IL GIORNO DEL RICORDO
125
10 FEBBRAIO
INDICE ICONOGRAFICO
Immagine: 10 agosto1946, Parigi Palazzo Luscembraury, De Gasperi parla alla Conferenza della Pace
Fonte: Fondazione Alcide De Gasperi - Roma
www.fondazionedegasperi.it
Per concessione: Fondazione Alcide de Gasperi, Via Pavia, n. 1- Roma
Immagine: 10 agosto 1946, Parigi Palazzo Luscembraury, la Conferenza
della Pace
Fonte: Fondazione Alcide De Gasperi - Roma
www.fondazionedegasperi.it
Per concessione: Fondazione Alcide de Gasperi, Via Pavia, n. 1- Roma
Immagine: Heinrich Himmler, comandante supremo delle SS.
Fonte: La seconda guerra mondiale : immagini dal fronte / testi di David
Boyle. - Vercelli : White Star, 1999. - 598 p. : in gran parte ill. ; 31 cm.
(Traduzione e ampliamento del testo a cura di Fabio Bourbon)
Per concessione: Istituto Storico Parri Emilia-Romagna, Via Sant’Isaia, n.
18, 40100 - Bologna
Immagine: Cartina: Il confine tra Italia e Jugoslavia tra le due guerre mondiali (Trattati di Rapallo del 1920 e di Roma del 1924). Anche la città
dalmata di Zara, fuori carta, viene annessa all’Italia.
Fonte: Il confine scomparso : saggi sulla storia dell’Adriatico orientale
nel Novecento / Raoul Pupo. - Trieste : IRSML, 2007. - 229 p. : ill. ; 21
cm. (In testa al front.: Istituto regionale per la storia del movimento di
liberazione nel Friuli Venezia Giulia)
Per concessione: Istituto Storico Parri Emilia-Romagna, Via Sant’Isaia, n.
18, 40100 - Bologna
Immagine: Cartina: Dopo l’aggressione alla Jugoslavia del 1941, l’Italia
annette alcuni territori sloveni, che vanno a costituire la provincia di
Lubiana, e croati, nei dintorni di Fiume e in Dalmazia (questi ultimi fuori
carta).
Fonte: Il confine scomparso : saggi sulla storia dell’Adriatico orientale
nel Novecento / Raoul Pupo. - Trieste : IRSML, 2007. - 229 p. : ill. ; 21
cm. (In testa al front.: Istituto regionale per la storia del movimento di
liberazione nel Friuli Venezia Giulia)
Per concessione: Istituto Storico Parri Emilia-Romagna, Via Sant’Isaia, n.
18, 40100 - Bologna
126
IL GIORNO DEL RICORDO
Immagine: Cartina: Dopo l’8 settembre 1943, i tedeschi creano a cavallo
delle Alpi orientali la zona di operazioni Litorale adriatico, comprendente le province italiane di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e Lubiana, in
cui la sovranità della RSI è di fatto sospesa
Fonte: Il confine scomparso: saggi sulla storia dell’Adriatico orientale
nel Novecento / Raoul Pupo. - Trieste : IRSML, 2007. - 229 p. : ill. ; 21
cm. (In testa al front.: Istituto regionale per la storia del movimento di
liberazione nel Friuli Venezia Giulia)
Per concessione: Istituto Storico Parri Emilia-Romagna, Via Sant’Isaia, n.
18, 40100 - Bologna
Immagine: Cartina: Ai primi di maggio 1945 gli jugoslavi occupano tutta
la Venezia Giulia, ma dopo un mese devono abbandonare la parte
orientale della regione. Il territorio viene pertanto diviso in due zone di
occupazione, separate dalla linea Morgan: la zona A (comprendente
anche l’enclave di Pola) retta da un governo militare alleato, e la zona B,
sotto un governo militare jugoslavo.
Fonte: Il confine scomparso : saggi sulla storia dell’Adriatico orientale
nel Novecento / Raoul Pupo. - Trieste : IRSML, 2007. - 229 p. : ill. ; 21
cm. (In testa al front.: Istituto regionale per la storia del movimento di
liberazione nel Friuli Venezia Giulia)
Per concessione: Istituto Storico Parri Emilia-Romagna, Via Sant’Isaia, n.
18, 40100 - Bologna
Immagine: L’ex Campo di Fossoli – Carpi - Modena
Fonte: IBC - Istituto per i beni culturali - Regione Emilia-Romagna
Per concessione: Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, Via Galliera, 21,cap. 40121-Bologna
Immagine: L’ex Campo di Fossoli – Carpi - Modena
Fonte: IBC - Istituto per i beni culturali - Regione Emilia-Romagna
Per concessione: Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, Via Galliera, 21,cap. 40121-Bologna
127
10 FEBBRAIO
128
IL GIORNO DEL RICORDO
129
© Regione Emila-Romagna - Assemblea Legislativa
Progetto grafico: lucignolo progetti grafici (Bo)
I° edizione - finito di stampare il xx Xxxxxx 2011
stampa a cura di XXXXXXX
Francesco Maria Feltri
insegna Italiano e Storia
presso l'ITAS "Francesco Selmi" di Modena.
E' autore di numerosi manuali
di Storia per la Scuola Superiore,
tra cui ricordiamo "I giorni e le idee" (SEI, Torino, 2001)
e "Chiaroscuro" (SEI, Torino, 2011).
In qualità di studioso della Shoah,
ha collaborato con la Fondazione Anne Frank
di Amsterdam e con il Museo Yad Vashem di Gerusalemme.
Per l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, ha
curato il sussidio didattico on line
"Viaggio visivo nel Novecento totalitario".
CONSAPEVOLEZZA
MEMORIA
LucignoloProgettiGrafici
Cittadinanza