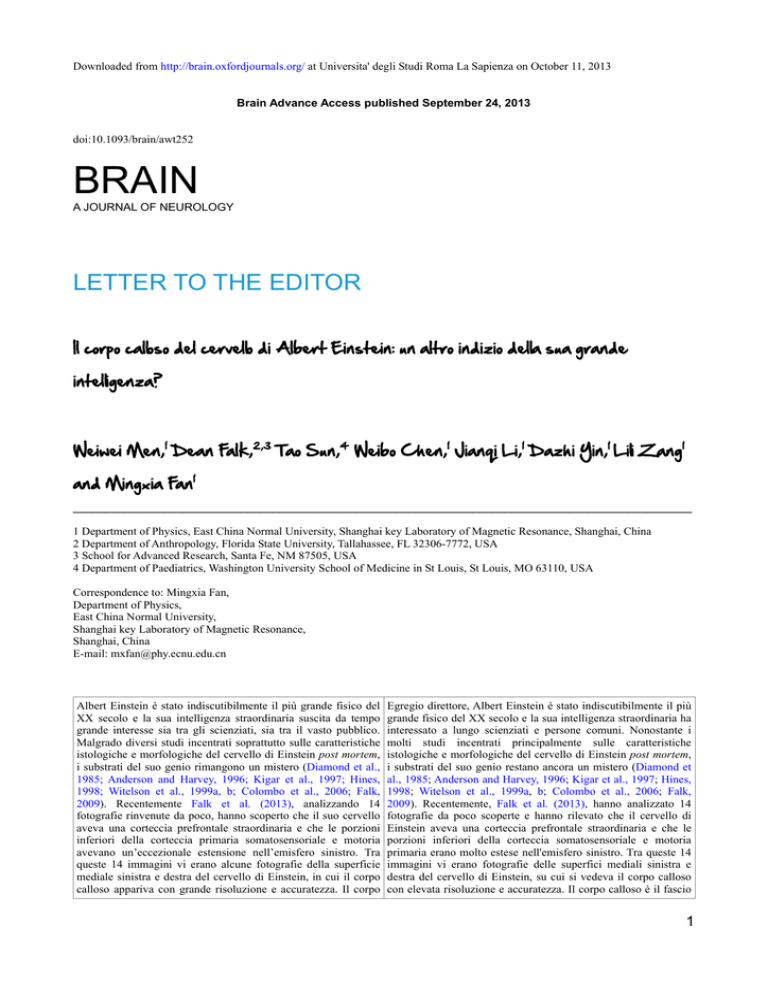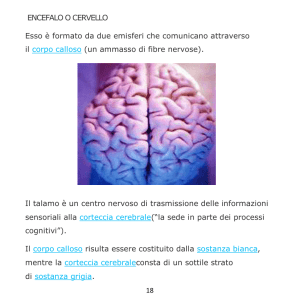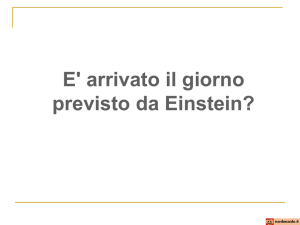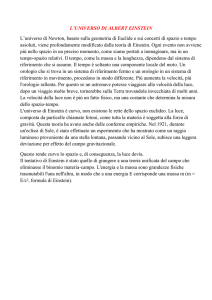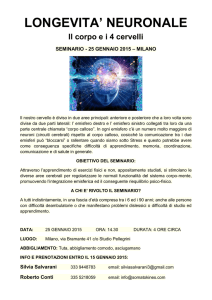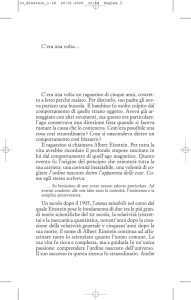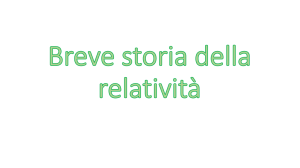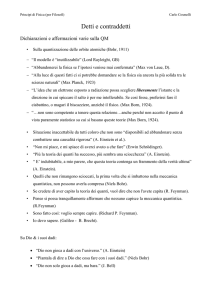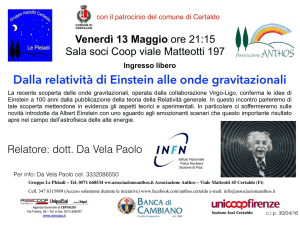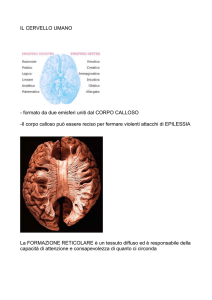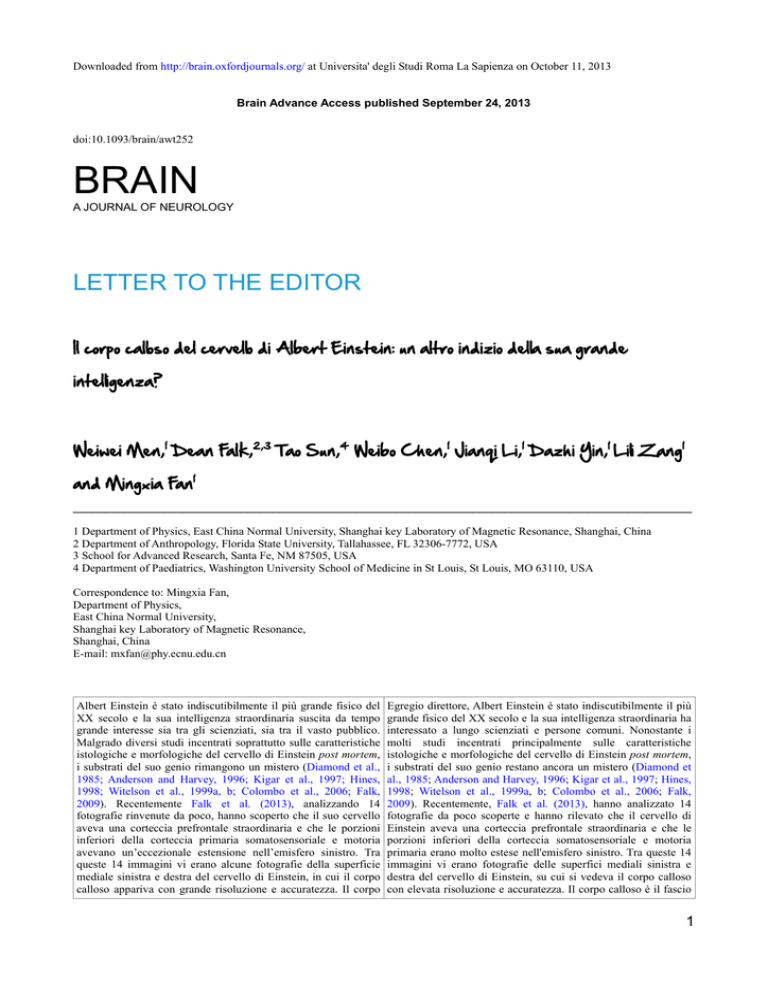
Downloaded from http://brain.oxfordjournals.org/ at Universita' degli Studi Roma La Sapienza on October 11, 2013
Brain Advance Access published September 24, 2013
doi:10.1093/brain/awt252
BRAIN
A JOURNAL OF NEUROLOGY
LETTER TO THE EDITOR
e
d
n
a
r
g
a
u
s
a
l
l
e
d
o
i
z
i
d
n
i
o
r
t
l
a
n
u
:
n
i
e
t
s
n
i
E
t
r
e
b
l
A
i
d
o
l
l
e
v
r
e
c
l
e
d
o
s
o
l
l
a
c
o
p
r
o
c
l
I
?
a
z
n
e
g
i
l
l
e
t
n
i
1
g
n
a
Z
i
l
i
L
1
,
n
i
Y
i
h
z
a
D
1
,
i
L
i
q
n
a
i
J
1
,
n
e
h
C
o
b
i
e
W
4
,
n
u
S
o
a
T
3
,
1
2
,
k
l
a
F
n
a
e
D
,
n
e
M
i
e
w
i
e
W
1
n
a
F
a
i
x
g
n
i
M
d
n
a
________________________________________________________________________________________________
1 Department of Physics, East China Normal University, Shanghai key Laboratory of Magnetic Resonance, Shanghai, China
2 Department of Anthropology, Florida State University, Tallahassee, FL 32306-7772, USA
3 School for Advanced Research, Santa Fe, NM 87505, USA
4 Department of Paediatrics, Washington University School of Medicine in St Louis, St Louis, MO 63110, USA
Correspondence to: Mingxia Fan,
Department of Physics,
East China Normal University,
Shanghai key Laboratory of Magnetic Resonance,
Shanghai, China
E-mail: [email protected]
Albert Einstein è stato indiscutibilmente il più grande fisico del
XX secolo e la sua intelligenza straordinaria suscita da tempo
grande interesse sia tra gli scienziati, sia tra il vasto pubblico.
Malgrado diversi studi incentrati soprattutto sulle caratteristiche
istologiche e morfologiche del cervello di Einstein post mortem,
i substrati del suo genio rimangono un mistero (Diamond et al.,
1985; Anderson and Harvey, 1996; Kigar et al., 1997; Hines,
1998; Witelson et al., 1999a, b; Colombo et al., 2006; Falk,
2009). Recentemente Falk et al. (2013), analizzando 14
fotografie rinvenute da poco, hanno scoperto che il suo cervello
aveva una corteccia prefrontale straordinaria e che le porzioni
inferiori della corteccia primaria somatosensoriale e motoria
avevano un’eccezionale estensione nell’emisfero sinistro. Tra
queste 14 immagini vi erano alcune fotografie della superficie
mediale sinistra e destra del cervello di Einstein, in cui il corpo
calloso appariva con grande risoluzione e accuratezza. Il corpo
Egregio direttore, Albert Einstein è stato indiscutibilmente il più
grande fisico del XX secolo e la sua intelligenza straordinaria ha
interessato a lungo scienziati e persone comuni. Nonostante i
molti studi incentrati principalmente sulle caratteristiche
istologiche e morfologiche del cervello di Einstein post mortem,
i substrati del suo genio restano ancora un mistero (Diamond et
al., 1985; Anderson and Harvey, 1996; Kigar et al., 1997; Hines,
1998; Witelson et al., 1999a, b; Colombo et al., 2006; Falk,
2009). Recentemente, Falk et al. (2013), hanno analizzato 14
fotografie da poco scoperte e hanno rilevato che il cervello di
Einstein aveva una corteccia prefrontale straordinaria e che le
porzioni inferiori della corteccia somatosensoriale e motoria
primaria erano molto estese nell'emisfero sinistro. Tra queste 14
immagini vi erano fotografie delle superfici mediali sinistra e
destra del cervello di Einstein, su cui si vedeva il corpo calloso
con elevata risoluzione e accuratezza. Il corpo calloso è il fascio
1
calloso è il più grande fascio di fibre nervose che connette le
regioni corticali degli emisferi cerebrali nel cervello umano e
gioca
un
ruolo
fondamentale
nell’integrazione
dell’informazione, trasmessa da un emisfero all’altro attraverso
migliaia di assoni (Aboitiz et al., 1992). Le due fotografie delle
superfici mediali degli emisferi cerebrali di Einstein sono alla
base del presente studio.
di fibre nervose più grande che connette le regioni corticali degli
emisferi cerebrali nei cervelli umani e svolge un ruolo essenziale
nell'integrazione delle informazioni trasmesse da un emisfero
all'altro tramite migliaia di assoni (Aboitiz et al., 1992). Le due
fotografie delle superfici mediali degli emisferi cerebrali di
Einstein costituiscono la base del presente studio.
2
Figura 1 Fotografie delle sezioni sagittali mediane destra e sinistra del cervello di Einstein, con le etichette originali (Falk et al.,
2013), qui riprodotte con il permesso del National Museum of Health and Medicine, Silver Spring, MD. I cerchi rossi indicano due
rotture su ogni emisfero del corpo calloso di Einstein, di forma differente tra di loro, che possono essere state provocate al momento
della separazione dei due emisferi, nel 1955.
Per esaminare se esistono differenze regionali del corpo
calloso tra il cervello di Einstein e quello delle persone comuni e
per ridurre al minimo le potenziali differenze della morfologia
del corpo calloso causate da morte, atrofia cerebrale, età e sesso,
sono stati usati insiemi di dati MRI in vivo di due gruppi
differenti di età. Le fotografie ad alta risoluzione degli emisferi
sinistro e destro di Einstein sono state fornite da Dean Falk con il
permesso del National Museum of Health and Medicine (Fig.1).
Poiché Einstein era destrimano ed è morto all’età di settantasei
anni, il nostro primo gruppo di controllo era composto di 15
maschi anziani, destrimani, sani, di età compresa tra i 70 e gli 80
anni (media: 74,20 ± 2,60 anni). Tutti i partecipanti erano
laureati o in possesso di un titolo di studio superiore alla laurea e
non dementi (Clinical Dementia Rating = 0, il Mini-Mental State
Examination andava da 28 a 30, media ± SD: 29,53 ± 0,64)
(Marcus et al., 2007, 2010). Le informazioni riguardanti il
background razziale/etnico dei soggetti non sono disponibili. I
dati MRI T1-weighted di questi 15 maschi più anziani sono stati
ottenuti dall’Open Access Series of Imaging Studies (OASIS,
http://www.oasis-brains.org/). Tutte le immagini sono state
acquisite con uno scanner 1.5 T Vision (Siemens) e una sequenza
T1-weighted MPRAGE, con i seguenti parametri: tempo di
ripetizione/tempo di eco/tempo d’inversione = 18ms/10
ms/20ms, 128 sezioni sagittali contigue di spessore 1,25 mm e
dimensione voxel = 1 x 1 x 1,25 mm3. Il secondo gruppo di
controllo era composto di 52 maschi caucasici più giovani, sani e
destrimani, di età compresa tra i 24 e i 30 anni (media 26,60 ±
2,19 anni). Le ragioni della selezione sono descritte nel materiale
supplementare. I dati MRI T1-weighted ad alta risoluzione di
questi 52 maschi caucasici sono stati ottenuti dal database
dell’International Consortium for Brain Mapping (ICBM)
(www.loni.ucla.edu/ICBM). Trentacinque insiemi di dati MRI
sono stati acquisiti con uno scanner Philips 1.5 T ACSIII (Philips
Intera, Philips Medical System) e una sequenza 3D T1-weighted
(T1-FFE) con i seguenti parametri: tempo di ripetizione/tempo di
eco = 18 ms/10 ms, ~160–190 sezioni sagittali contigue di
spessore 1mm e dimensione voxel = 1 x 1 x 1 mm3. I rimanenti
17 insiemi di dati MRI sono stati acquisiti con uno scanner GE
1.5 T Signa (General Electric) e una sequenza 3D T1-weighted
con i seguenti parametri: tempo di ripetizione/tempo di eco = 24
ms/4 ms, 124 sezioni sagittali contigue di spessore 1,2 mm, e
dimensione voxel = 0,9766 x 0,9766 x 1,2 mm3.
Per esaminare la presenza di differenze regionali nel corpo
calloso tra il cervello di Einstein e quello di persone comuni, e
per ridurre al minimo le differenze potenziali della morfologia
del corpo calloso dovute alla causa del decesso, ad atrofia del
cervello, età e sesso, sono stati usati set di dati MRI in vivo di
due gruppi di età diversa. Le fotografie ad alta risoluzione degli
emisferi sinistro e destro di Einstein sono state fornite da Dean
Falk con il permesso del National Museum of Health and
Medicine (Fig. 1). Poiché Einstein era destrimano ed è morto
all'età di 76 anni, il primo gruppo di controllo era composto da
15 soggetti maschi sani destrimani anziani, di età compresa tra i
70 e gli 80 anni (media: 74,20 ± 2,60 anni). Tutti i partecipanti
erano in possesso di laurea o titolo superiore e non affetti da
demenza (Clinical Demential Rating = 0, Mini-Mental State
Examination, compreso tra 28 e 30, media ± DS: 29,53 ± 0,64
(Marcus et al., 2007, 2010). Le informazioni relative
all'appartenenza razziale/etnica dei soggetti non sono disponibili.
I dati MRI T1-pesati dei 15 soggetti maschi più anziani sono stati
ottenuti dall'Open Access Series of Imaging Studies (OASIS,
http://www.oasis-brains.org/). Tutte le immagini sono state
acquisite con uno scanner 1.5 T Vision (Siemens) e una sequenza
MPRAGE T1-pesata, con i seguenti parametri: tempo di
ripetizione/tempo di eco/tempo di inversione = 18ms/10
ms/20ms, 128 fette contigue sul piano sagittale da 1,25 mm e
dimensioni voxel = 1 x 1 x 1,25 mm3. Il secondo gruppo di
controllo era composto da 52 maschi sani più giovani caucasici e
destrimani, con età compresa tra 24 e 30 anni (media: 26,60 ±
2,19 anni). I motivi alla base della selezione sono descritti nel
materiale supplementare. I dati MRI T1-pesati ad alta risoluzione
dei 52 maschi caucasici sono stati ricavati dal database ICBM
(International
Consortium
for
Brain
Mapping)
(www.loni.ucla.edu/ICBM). Trentacinque dei set di dati MRI
sono stati acquisiti con uno scanner Philips 1.5 T ACSIII (Philips
Intera, Philips Medical System) e una sequenza 3D T1-pesata
(T1-FFE) con i seguenti parametri: tempo di ripetizione/tempo di
eco = 18 ms/10 ms, ~160–190 fette contigue sul piano sagittale
da 1 mm e dimensioni voxel = 1 x 1 x 1 mm3. I 17 set di dati
MRI rimanenti sono stati acquisiti con uno scanner GE 1.5 T
Signa (General Electric) e una sequenza 3D T1-pesata con i
seguenti parametri: tempo di ripetizione/tempo di eco = 24 ms/4
ms, 124 fette contigue sul piano sagittale da 1,2 mm e
dimensioni voxel = 0,9766 x 0,9766 x 1,2 mm3.
3
Figura 2 Misure della morfologia del corpo calloso (CC) e del cervello di Einstein e dei due gruppi di controllo diversi per età. Le
barre rosse, blu e verdi rappresentano, rispettivamente, le misure di Einstein, del gruppo di controllo anziano e del gruppo di
controllo giovane. Le misure devono essere moltiplicate come riportato nelle loro etichette. Gli asterischi in cima alle barre indicano
differenze significative tra Einstein e il gruppo di controllo, *P<0,05, **P<0,001.
Poiché per il cervello di Einstein non sono disponibili dati
MRI, abbiamo usato le misure ottenute da due fotografie del suo
cervello conservato come termini di comparazione con i dati
MRI dei cervelli di controllo. Questa procedura è giustificata da
uno studio precedente in cui 44 cervelli conservati di cadaveri e
30 insiemi di dati di MRI cerebrali in vivo, in due gruppi
comparabili per età e sesso, sono stati messi a confronto,
riscontrando una notevole somiglianza tra le misure del corpo
calloso dei due gruppi (Gupta et al., 2008). Abbiamo sviluppato
un nuovo metodo per determinare lo spessore del corpo calloso e
lo abbiamo usato per verificare se il corpo calloso di Einstein
differisse in modo significativo da quelli dei gruppi di controllo.
La connettività delle regioni cerebrali simmetriche bilaterali di
varie suddivisioni del corpo calloso di Einstein è stata valutata e
comparata con le corrispondenti misure nei controlli, partendo
dal principio che a un’area maggiore di una subregione del corpo
calloso di Einstein o di quelli dei controlli, corrisponda una
connettività interemisferica relativamente maggiore (Aboitiz et
al., 1992).
Poiché non sono disponibili dati MRI per il cervello di
Einstein, abbiamo usato le misure basate sulle due fotografie del
suo cervello conservato per confrontarle con i dati MRI dei
cervelli di controllo. Questo metodo è giustificato da uno studio
precedente in cui sono stati confrontati 44 cervelli di cadaveri
conservati con 30 set di dati MRI di cervelli in vivo di due gruppi
di analogo sesso ed età e in cui è stata riscontrata una analogia
significativa tra le misure del corpo calloso dei due gruppi
(Gupta et al., 2008). Abbiamo sviluppato un nuovo metodo per
determinare lo spessore del corpo calloso e lo abbiamo utilizzato
per verificare se il corpo calloso di Einstein differisse
significativamente da quello dei gruppi di controllo. La
connettività delle regioni cerebrali simmetriche bilaterali delle
varie suddivisioni del corpo calloso di Einstein è stata valutata e
confrontata con le misure corrispondenti nei controlli, con
un'area più grande di una sottoregione in Einstein o nei controlli
che indicava una connettività interemisferica relativamente
maggiore (Aboitiz et al., 1992).
In breve, la scala/calibro delle due fotografie del cervello di
Einstein è stata determinata usando le lunghezze dei suoi
emisferi (17,2 cm sinistro/16,4 cm destro) riportate in letteratura
(Anderson and Harvey, 1996). I contorni di entrambi i corpi
callosi sono stati tracciati da un solo valutatore (M.W.), e i bordi
superiori e inferiori sono stati definiti in relazione ai punti
terminali anteriori e posteriori. La linea mediana del corpo
calloso di Einstein (ossia quella che corre rostrocaudalmente
attraverso il centro del corpo calloso in modo
approssimativamente parallelo ai bordi superiore e inferiore) è
stata definita in base al Symmetry-Curvature Duality Theorem
(Leyton, 1987) e poi sezionata in 400 punti equidistanti, con 400
punti corrispondenti sul bordo superiore e altrettanti sul bordo
inferiore. La distanza tra i punti corrispondenti dei bordi
superiore e inferiore è stata definita come spessore del corpo
calloso a quel livello. Il valore dei 400 spessori è stato codificato
a colori e mappato sul contorno del corpo calloso dell’emisfero
sinistro di Einstein. È stata calcolata la media dei 400 valori,
definita come spessore medio del corpo calloso, mentre la
In breve, la scala/calibro delle due fotografie del cervello di
Einstein è stata determinata usando le lunghezze degli emisferi di
Einstein (17,2 cm sinistro/16,4 cm destro) riportate in letteratura
(Anderson and Harvey, 1996). I contorni di entrambi i corpi
callosi sono stati tracciati da un valutatore (M.W.), i margini
superiore e inferiore sono stati definiti in rapporto ai punti finali
anteriore e posteriore. La linea mediana del corpo calloso di
Einstein, che attraversa rostrocaudalmente il centro del corpo
calloso, all'incirca parallela ai margini superiore e inferiore, è
stata definita in base al Symmetry-Curvature Duality Theorem
(Leyton, 1987) e quindi sezionata in 400 punti equidistanti, con
400 punti corrispondenti sui margini superiore e inferiore. La
distanza tra i punti corrispondenti sui margini superiore e
inferiore è stata definita come lo spessore del corpo calloso a
quel livello. I valori dei 400 spessori sono stati codificati
cromaticamente e mappati sullo spazio calloso sinistro di
Einstein. Dai 400 valori è stata ricavata una media, definita come
spessore medio del corpo calloso, mentre la somma delle
distanze tra i 400 punti adiacenti è stata definita come lunghezza
4
somma delle distanze tra i 400 punti adiacenti è stata definita
come lunghezza della linea mediana del corpo calloso. L'area
callosa, il perimetro e la lunghezza massima del corpo calloso
sono state misurati dal contorno del corpo calloso; la circolarità
del corpo calloso accordata con la definizione di Ardekani et al.
(2013). Abbiamo identificato le suddivisioni del corpo calloso
dividendolo a intervalli specificati sulla lunghezza
anteroposteriore, come descritto e illustrato nel materiale
supplementare. Sono stati determinati lo spessore massimo e le
posizioni lungo il corpo calloso del genu, del tronco e dello
splenio e lo spessore minimo e la posizione dell’istmo. L’analisi
computazionale è stata eseguita con un programma Matlab inhouse (MATLAB 7, Mathworks). Per determinare in modo
affidabile il contorno del corpo calloso, lo stesso valutatore
(W.M.) ha tracciato i contorni del corpo calloso sinistro e destro
di Einstein cinque volte e l’errore di ripetibilità nel totale delle
aree callose è stato dello 0,40% per l’emisfero sinistro e dello
0,90% per l’emisfero destro. Dopo la rimozione, il cervello di
Einstein è stato diviso in due emisferi, cosa che ha causato
distorsioni leggermente diverse nei rispettivi corpi callosi. Per
ridurre le possibilità di errore, entrambi i corpi callosi di Einstein
sono stati misurati più volte ed è stata calcolata la media dei
risultati. Poiché i corpi callosi degli emisferi in vivo non
presentano tali distorsioni, abbiamo misurato il corpo calloso dei
cervelli di controllo in un solo emisfero (destro). Altri dettagli
dell’elaborazione delle fotografie di Einstein e dei dati MRI dei
gruppi di controllo sono descritti nel materiale supplementare,
mentre le misure del cervello di Einstein e di quelli dei due
gruppi di controllo sono indicate nella fig. 2. I grafici del corpo
calloso degli individui presi in esame nel nostro studio sono
riportati nella fig. 3, A e C. Per comparare la differenza tra lo
spessore del corpo calloso di Einstein e quelli dei cervelli di
controllo, la distribuzione dello spessore calloso è stata divisa in
tre sezioni lungo il corpo calloso con partizioni al massimo
spessore nel genu e al minimo spessore nell’istmo (fig.3B) e le
sezioni dei gruppi di controllo sono state registrate con le
corrispondenti sezioni del cervello di Einstein. I tracciati, così
registrati, dei gruppi di controllo sono riportati in fig. 3, B e D, le
mappe adattate dello spessore sono riportate nelle colonne a
destra delle fig. 4 e 5. I dettagli della misurazione dello spessore
del corpo calloso e dell’adattamento dei dati ottenuti sono forniti
nel materiale supplementare.
della linea mediana del corpo calloso. L'area, il perimetro e la
lunghezza massima del corpo calloso sono stati misurati a partire
dalla maschera callosale; la circolarità si basa sulla definizione di
Ardekani et al. (2013). Abbiamo identificato le suddivisioni del
corpo calloso dividendolo a intervalli specificati lungo la linea
anteroposteriore, come descritto e illustrato nel materiale
supplementare. Sono stati determinati lo spessore massimo e le
posizioni lungo il corpo calloso del ginocchio, del tronco e dello
splenio e lo spessore minimo e la posizione dell'istmo. L'analisi
computazionale è stata condotta con un programma Matlab inhouse (MATLAB 7, Mathworks). Per l'affidabilità del contorno
del corpo calloso, lo stesso valutatore (W.M.) ha tracciato il
contorno del corpo calloso sinistro e destro di Einstein cinque
volte; l'errore di ripetibilità sul totale delle aree del corpo calloso
è stato dello 0,40% per l'emisfero sinistro e dello 0,90% per
l'emisfero destro. Il cervello di Einstein è stato separato in due
emisferi dopo essere stato prelevato, questa separazione ha
causato distorsioni leggermente diverse nei corpi callosi. Per
ridurre l'errore, entrambi i corpi callosi di Einstein sono stati
misurati più volte, quindi è stata calcolata la media. Poiché i
corpi callosi degli emisferi in vivo non presentano tali
distorsioni, abbiamo misurato il corpo calloso dei controlli solo
su un emisfero (il destro). Altri dettagli sull'elaborazione delle
fotografie di Einstein e dei dati MRI dei gruppi di controllo sono
descritti nel materiale supplementare, le misure del cervello di
Einstein e quelle dei due gruppi di controllo sono mostrate nella
figura 2. I tracciati dei corpi callosi degli individui del nostro
studio sono mostrati nella figura 3, A e C. Per confrontare le
differenze tra lo spessore del corpo calloso di Einstein e quello
dei cervelli di controllo, la distribuzione dello spessore è stata
suddivisa in tre sezioni lungo il corpo calloso, in corrispondenza
dello spessore massimo nel ginocchio e dello spessore minimo
nell'istmo (figura 3, B), e le sezioni dei gruppi di controllo sono
state registrate sulle sezioni corrispondenti del cervello di
Einstein. I tracciati registrati dei gruppi di controllo sono
mostrati nella figura 3, B e D, le mappe degli spessori registrati
sono mostrate nelle colonne di destra delle figure 4 e 5. I dettagli
sulle misure dello spessore del corpo calloso e sulle registrazioni
sono forniti nel materiale supplementare.
Un test non-parametrico, il test U di Mann-Whitney (Mann
and Whitney, 1947), già utilizzato in un precedente studio del
cervello di Einstein (Anderson and Harvey, 1996), è stato usato
in questo studio come test per rilevare differenze significative.
Lo stesso test è stato usato per valutare la differenza dello
spessore calloso di Einstein e dei gruppi di controllo, per
confronti multipli, usando il False Discovery Rate (FDR) con
una soglia limite di 0,05 (Benjamini and Hochberg, 1995), i Pvalue corretti sono stati rappresentati con un codice di colore e
mappati sul contorno del corpo calloso di Einstein. Queste
statistiche sono state realizzate con uno script Matlab.
Un test non parametrico, il test U di Mann–Whitney (Mann
and Whitney, 1947), è stato usato in questo studio per esaminare
le differenze significative ed è stato utilizzato in uno studio
precedente del cervello di Einstein (Anderson and Harvey,
1996). Lo stesso test è stato utilizzato per confrontare la
differenza tra lo spessore del corpo calloso di Einstein e quello
dei gruppi di controllo, per confronti multipli utilizzando il False
Discovery Rate (FDR) con valore di soglia dello 0,05 (Benjamini
and Hochberg, 1995); i valori P corretti sono stati codificati
cromaticamente e mappati sullo spazio del corpo calloso di
Einstein. Queste statistiche sono state implementate tramite uno
script Matlab.
5
Figura 3 Tracciati dello spessore del corpo calloso (CC) che rappresentano in sequenza, da sinistra a destra, dal genu allo splenio
(come indicato in F).
(A) Tracciati della misura dello spessore di Einstein (linea spessa rossa) e del gruppo di controllo anziano (linee colorate sottili). (B)
Ogni tracciato degli spessori del gruppo di controllo suddiviso in tre segmenti (spessore massimo nel genu e spessore minimo
nell’istmo) e registrati sul tracciato dello spessore calloso di Einstein. (C) Tracciati della misura dello spessore di Einstein (linea
spessa rossa) e del gruppo di controllo giovane (linee colorate sottili). (D) I tracciati dello spessore calloso del gruppo giovane sono
stati suddivisi in sezioni e registrati sul tracciato dello spessore del corpo calloso di Einstein. (E) Tracciati della misura dello spessore
medio del corpo calloso di Einstein (in rosso), del gruppo di controllo anziano (in blu) e del gruppo di controllo giovane (in verde),
gli intervalli viola (gruppo anziano) e azzurro (gruppo giovane) indicano che queste regioni differiscono significativamente (P<0,05,
con la correzione FDR) tra Einstein e i due gruppi di controllo per età. (F) I tracciati, suddivisi in sezione e adattati, dello spessore
medio del corpo calloso di Einstein (in rosso), del gruppo di controllo anziano (in blu) e del gruppo di controllo giovane (in verde);
secondo Witelson (1989). Il significato degli intervalli viola e azzurri è uguale a quello in (E). Le frecce rosse indicano che lo
spessore calloso di Einstein è del 10% più spesso della media del gruppo giovane, specialmente nello splenio, mentre la larghezza del
corpo calloso di Einstein è notevolmente più grande nel genu.
6
Figura 4 Mappe di distribuzione dello spessore del corpo calloso tra Einstein e i controlli anziani. Mappa dello spessore del corpo
calloso di Einstein (riga in alto); mappe del gruppo di controllo anziano (seconda riga), con lo spessore effettivo misurato del corpo
calloso a sinistra e lo spessore adattato a destra. Gli spessori del corpo calloso di Einstein sono maggiori dei rispettivi spessori nei
controlli anziani (terza riga), come indicato dalle mappe di significatività dei valori effettivi (a sinistra) registrati (a destra) tra
Einstein e il gruppo di controllo anziano (quarta riga, P < 0,05 corretto con FDR).
Le dimensioni del corpo calloso e il peso del cervello di
Einstein e dei due gruppi di controllo sono riportati nella Tabella
1 e nella Figura 2. Le misure del corpo calloso del cervello di
Einstein sono maggiori di quelle dei due gruppi di controllo,
eccetto la lunghezza della linea mediana e il perimetro del corpo
calloso, che sono entrambi più lunghi nel gruppo anziano, e la
circolarità del corpo calloso che nel gruppo giovane è
leggermente maggiore di quella di Einstein. Vi sono differenze
significative in tutte le misure del corpo calloso tranne che nella
lunghezza del corpo calloso di Einstein rispetto a quella del
gruppo anziano (P<0,001). Il corpo calloso di Einstein differisce
statisticamente anche da quelli del gruppo più giovane nello
spessore medio, nella lunghezza e nell’area del corpo calloso,
nello spessore massimo della zona intermedia, nello spessore
minimo dell’istmo (tutti i P-value<0,05) e nello spessore
massimo nello splenio (P<0,001). Il peso del cervello di Einstein
è 1230 g (Anderson e Harvey, 1996), molto simile al peso medio
dei cervelli del gruppo di controllo dei soggetti anziani (1219 ±
102,93 g), ma inferiore a quello del gruppo di controllo dei
soggetti giovani (1374,13 ±111,56 g). Falk et al. (2013) hanno
suggerito che il peso del cervello di Einstein è consistente con la
sua età. Tuttavia, all’età di 22 anni, Einstein era alto 171,5 cm
(http://www.relativity.li/en/epstein2/read/d0_en/d7_en/), meno
della media in quella fascia d’età (176 cm, tra i 22 e i 30 anni)
(Dekaban, 1978). Schreider (1966) scoprì che vi è una
correlazione positiva tra il peso cerebrale e l’altezza corporea,
che indica che Einstein avesse un cervello/testa relativamente
piccoli. Tuttavia, il peso del suo cervello è leggermente superiore
al peso del cervello del gruppo di controllo più anziano di questo
studio, il che potrebbe inferire che il suo cervello era sano e solo
lievemente atrofico, quando morì. Questa conclusione è in linea
Le dimensioni del corpo calloso e il peso del cervello di
Einstein e dei due gruppi di controllo sono mostrati nella tabella
1 e nella figura 2. Le misure del corpo calloso del cervello di
Einstein superano quelle dei due gruppi di controllo eccetto per
la lunghezza della linea mediana e per il perimetro del corpo
calloso, che sono entrambi più lunghi nel gruppo di controllo di
anziani, e della circolarità del corpo calloso, che è
trascurabilmente più lunga nel gruppo di controllo di giovani.
Sono presenti differenze significative in tutte le misure del corpo
calloso tra Einstein e il gruppo di anziani, eccetto la lunghezza (P
< 0,001). Il corpo calloso di Einstein, inoltre, differisce
statisticamente da quelli del gruppo di giovani nello spessore
medio, nella lunghezza e nell'area del corpo calloso, nello
spessore massimo del tronco, nello spessore minimo dell'istmo
(tutti i valori P < 0,05) e nello spessore massimo dello splenio (P
< 0,001). Il cervello di Einstein pesa 1230 gr (Anderson and
Harvey, 1996), un valore molto simile al peso medio dei cervelli
del gruppo di controllo di anziani (1219 ±102,93 gr), ma
inferiore a quello del gruppo di controllo di giovani (1374,13
±111,56 gr). Falk et al. (2013) hanno suggerito che il peso del
cervello di Einstein è consistente con la sua età. Tuttavia Einstein
era
alto
171,5
cm
quando
aveva
22
anni
(http://www.relativity.li/en/epstein2/read/d0_en/d7_ en/), ossia
era più basso della media per la sua età (176 cm, 22–30 anni)
(Dekaban, 1978). Schreider (1966) ha scoperto che esiste una
correlazione positiva tra il peso del cervello e l'altezza del corpo,
a indicare che Einstein doveva avere un cervello/testa
relativamente piccolo. Tuttavia, il peso del suo cervello è
leggermente superiore al peso medio dei cervelli dei controlli
anziani di questo studio, dal che si poteva dedurre che al
momento del decesso il suo cervello era sano e presentava una
7
con le scoperte precedenti descritte dal Dott. Harry Zimmerman,
“Einstein’s brain was normal for his age” (Lepore, 2001). La
forma del corpo calloso, caratterizzata dalla sua circolarità,
risente dell’atrofia cerebrale (Ardekani et al., 2013). La
circolarità del corpo calloso di Einstein è significativamente
maggiore di quella del gruppo di controllo anziano (P<0,001) e
leggermente inferiore a quella del gruppo più giovane (P =
0,4160), un’altra conferma che il cervello di Einstein era sano e
solo lievemente atrofico, quando egli morì.
bassa atrofia; questa deduzione è in linea con i risultati già
conseguiti dal Dr. Harry Zimmerman e descritti in 'Einstein’s
brain was normal for his age' (Lepore, 2001). La forma del corpo
calloso, caratterizzata da circolarità, è sensibile ad atrofia
cerebrale (Ardekani et al., 2013). La circolarità del corpo calloso
di Einstein è significativamente più grande di quella del gruppo
di controllo di anziani (P < 0,001) e leggermente inferiore a
quella del gruppo di giovani (P = 0,4160), a ulteriore conferma
che il cervello di Einstein era sano e presentava una bassa atrofia
al decesso.
Sebbene il peso del cervello di Einstein sia inferiore del 10%
al peso medio del cervello del gruppo di controllo giovane, sei
misure del corpo calloso di Einstein sono significativamente
maggiori di quelle del gruppo di controllo giovane (Fig. 2). Al
fine di esaminare più approfonditamente le differenze regionali
del corpo calloso di Einstein e dei gruppi di controllo (Aboitiz et
al, 1992), è stato messo a punto un nuovo metodo per esplorare i
corrispondenti gradi di connettività, in certe suddivisioni del
corpo calloso. La distribuzione dello spessore del corpo calloso
di Einstein a confronto con quella dei due gruppi di controllo è
indicata nelle figure 3, 4 e 5. La Figura 3 mostra i tracciati dello
spessore del corpo calloso del cervello di Einstein, a confronto
con quelli dei due gruppi di controllo, dopo essere stati suddivisi
in sezioni e registrati sul grafico dello spessore calloso del
cervello di Einstein. Lo spessore calloso totale di Einstein (in
rosso) è maggiore dello spessore medio del corpo calloso del
gruppo di controllo più anziano (in blu), eccetto che all’estremità
del rostro e dello splenio posteriore (Fig.3F). Gli intervalli viola
in basso nei grafici indicano le aree con differenze significative
tra il corpo calloso di Einstein e quelli del gruppo di controllo
più anziano (P<0,05, con la correzione FDR). Nella maggior
parte del genu, del tronco, dell’istmo e in parte dello splenio, il
corpo calloso di Einstein è più spesso dello spessore calloso
medio del gruppo di controllo giovane (in verde), ma più sottile
nella maggior parte del corpo rostrale (Fig. 3F). La fascia azzurra
indica le aree con differenze significative tra il corpo calloso di
Einstein e quelli del gruppo di controllo giovane (P<0,05, con la
correzione FDR). Risultati simili sono presentati nella colonna di
destra, nelle figure 4 e 5, rispettivamente. Nel genu, il corpo
calloso di Einstein è più largo di quelli di entrambi i gruppi di
controllo (Fig. 3F).
Sebbene il cervello di Einstein pesi il 10% in meno rispetto
al peso medio dei cervelli dei controlli giovani, sei misure del
corpo calloso di Einstein risultano significativamente più grandi
di quelle dei controlli giovani (figura 2). Per esaminare
ulteriormente le differenze regionali del corpo calloso tra
Einstein e i controlli (Aboitiz et al., 1992), è stato sviluppato un
nuovo metodo che consente di esplorare i gradi di connettività
relativi in alcune suddivisioni del corpo calloso. La distribuzione
dello spessore del corpo calloso di Einstein e quella dei due
gruppi di controllo sono mostrate nelle figure 3, 4 e 5. La figura
3 mostra i tracciati dello spessore del corpo calloso del cervello
di Einstein e di quelli dei due gruppi di controllo, dopo essere
stati sezionati e registrati sul tracciato dello spessore del corpo
calloso del cervello di Einstein. Lo spessore totale del corpo
calloso di Einstein (rosso) è più grande dello spessore medio del
corpo calloso del gruppo di controllo di anziani (blu), tranne che
sulla punta del rostro e dello splenio posteriore (figura 3, F). Gli
intervalli viola nella parte inferiore dei grafici indicano le aree
con differenze significative tra il corpo calloso di Einstein e
quelli dei controlli anziani (P < 0,05, corretto da FDR). Nella
maggiore parte del ginocchio, del tronco, dell'istmo e in parte
dello splenio, il corpo calloso di Einstein è più spesso del valore
medio dei controlli giovani (verde), ma più sottile nella maggior
parte del rostro (figura 3, F). L’intervallo azzurro indica le aree
con differenze significative tra il corpo calloso di Einstein e
quelli dei controlli giovani (P < 0,05, corretto da FDR). Risultati
simili appaiono nella colonna di destra, rispettivamente nelle
figure 4 e 5. Il corpo calloso di Einstein nel ginocchio è più largo
di quello di entrambi i gruppi di controllo (figura 3, F).
Il corpo calloso è il più grande fascio di fibre nervose di
materia bianca cerebrale che connette le cortecce
interemisferiche e può essere coinvolto in tutti i substrati
neuroanatomici della specializzazione emisferica (Witelson,
1989). Le assunzioni alla base di questa ricerca sono che a
un’area callosa più sviluppata corrisponda un numero
complessivo maggiore di fibre che attraversano il corpo calloso e
che la contrazione post mortem del corpo calloso sia uniforme in
tutte le sue subregioni (Aboitiz et al., 1992, 2003). Pertanto ci
siamo concentrati sullo spessore del corpo calloso che è
indicativo delle fibre che attraversano l'area della sezione
trasversale della regione callosa, piuttosto che sul volume 3D del
corpo calloso, impossibile da misurare nel cervello di Einstein.
Il corpo calloso è il fascio di fibre neuronali più grande di
materia bianca cerebrale che connette le cortecce
interemisferiche, e può essere coinvolto in qualsiasi substrato
neuroanatomico della specializzazione emisferica (Witelson,
1989). Le assunzioni alla base di questa ricerca sono che una
maggiore area del corpo calloso indica un maggiore numero
complessivo di fibre che si incrociano nel corpo calloso e che la
riduzione del corpo calloso post mortem è uniforme in tutte le
sottoregioni (Aboitiz et al., 1992, 2003). Abbiamo quindi rivolto
la nostra attenzione allo spessore del corpo calloso che indica le
fibre che attraversano l'area trasversale della regione callosa,
anziché al volume tridimensionale del corpo calloso, che sarebbe
stato impossibile misurare nel cervello di Einstein.
Diversi studi in vivo basati sull’imaging con tensore di
diffusione hanno messo in luce la connettività delle regioni
corticali fra gli emisferi attraverso il corpo calloso (Hofer e
Frahm, 2006; Park et al., 2008; Chao et al., 2009). Le fibre che
passano attraverso il rostro e il genu del corpo calloso sembrano
collegare le regioni interemisferiche dei giri orbitali e delle
Diversi studi di imaging con tensore di diffusione in vivo
hanno mostrato la connettività delle regioni corticali tra gli
emisferi attraverso il corpo calloso (Hofer and Frahm, 2006;
Park et al., 2008; Chao et al., 2009). Le fibre che attraversano il
rostro e il ginocchio del corpo calloso sembrano connettere le
regioni interemisferiche dei giri orbitali e delle cortecce
8
cortecce prefrontali corrispondenti alle aree di Brodmann 11/10
di sinistra e di destra, che sono coinvolte nella pianificazione, nel
ragionamento, nell’attività decisionale, nel recupero dei ricordi e
nella funzione esecutiva. Secondo Aboitiz et al. (1992, 2003), le
fibre sottili sono più fitte nelle regioni del rostro e del genu del
corpo calloso che nel tronco e in alcune regioni caudali e
partecipano al trasferimento dell'informazione cognitiva. Nel
rostro e nel genu, il corpo calloso di Einstein è più spesso e più
grande di quelli dei soggetti di controllo giovani; ciò fa pensare
che i giri orbitali e le cortecce prefrontali nel suo cervello fossero
eccezionalmente ben connessi. Questa ipotesi è consistente con il
fatto che Einstein aveva cortecce prefrontali relativamente estese
(Falk et al., 2013). È possibile che la morfologia tanto del suo
corpo calloso quanto della sua corteccia prefrontale abbia fornito
le basi delle sue capacità cognitive eccezionali e dei suoi
esperimenti mentali straordinari (Einstein, 1979).
prefrontali corrispondenti alle aree 11/10 di Brodmann sui lati
sinistro e destro, che sono coinvolte nella pianificazione, nel
ragionamento, nella capacità decisionale, nel recupero dalla
memoria e nella funzione di esecuzione. Secondo Aboitiz et al.
(1992, 2003), le fibre sottili sono più dense in queste regioni del
rostro e del ginocchio del corpo calloso rispetto al tronco e ad
alcune regioni caudali, e sono coinvolte nella trasmissione delle
informazioni cognitive. Il corpo calloso di Einstein è più spesso e
più grande di quelli dei controlli giovani nel rostro e nel
ginocchio, il che suggerisce che i giri orbitali e le cortecce
prefrontali fossero insolitamente ben connessi nel suo cervello.
Questa ipotesi è consistente con la conclusione secondo cui
Einstein aveva cortecce prefrontali relativamente estese (Falk et
al., 2013). La morfologia sia del corpo calloso sia della corteccia
prefrontale può aver fornito solide basi alle sue abilità cognitive
eccezionali e ai suoi esperimenti concettuali non comuni
(Einstein, 1979).
Il fascio di fibre nervose che passa attraverso il tronco e
l’istmo del corpo calloso connette principalmente le aree
interemisferiche corrispondenti delle cortecce premotorie (area
di Brodmann 6), delle cortecce motorie primarie (area di
Brodmann 4), delle cortecce somatosensoriali primarie (aree di
Brodmann 1/2/3), delle cortecce somatosensoriali secondarie
(area di Brodmann 5) e parti della regione parietale (Park et al.,
2008; Chao et al., 2009). Queste fibre hanno gli assoni più
grandi e meglio mielinizzati, che trasferiscono con maggior
rapidità le informazioni (Aboitiz et al., 1992). Nella corteccia
motoria primaria destra, Einstein aveva una piega più estesa a
forma di omega (il cosiddetto ‘pomello'), che probabilmente
rappresentava la parte di corteccia motoria della sua mano
sinistra, caratteristica insolita forse associata al fatto che egli fu
sin dall’infanzia un violinista destrimano (Falk, 2009; Falk et.al.,
2013). Il corpo calloso di Einstein era più spesso della regione
paragonabile di quelli dei controlli giovani nella regione
verosimilmente in corrispondenza con il suo 'pomello'.
Il fascio di fibre neuronali che attraversa il tronco e l’istmo
del corpo calloso connette principalmente le cortecce premotorie interemisferiche corrispondenti (area 6 di Brodmann), le
cortecce motorie primarie (area 4 di Brodmann), le cortecce
somatosensoriali primarie (aree 1/2/3 di Brodmann), le cortecce
somatosensoriali secondarie (area 5 di Brodmann) e parti della
regione parietale (Park et al., 2008; Chao et al., 2009). Queste
fibre hanno gli assoni più grandi e maggiormente mielinizzati,
che trasmettono le informazioni più rapidamente (Aboitiz et al.,
1992). Il cervello di Einstein presentava una piega estesa a forma
di omega (nota come 'pomello') nella corteccia motoria primaria
destra, che era probabilmente la corteccia motoria della sua
mano sinistra, una caratteristica insolita forse associata al fatto
che fu un suonatore di violino destrimano sin dall’infanzia (Falk,
2009; Falk et al., 2013). Il corpo calloso di Einstein era più
spesso della regione confrontabile dei controlli giovani nell’area
presumibilmente corrispondente a questo 'pomello'.
9
Figura 5 Mappe di distribuzione dello spessore del corpo calloso tra Einstein e il gruppo di controllo giovane. La mappa dello
spessore del corpo calloso di Einstein (riga in alto) confrontata con quelle dei giovani (seconda riga). La terza riga illustra in che
misura il corpo calloso di Einstein è più spesso in alcune regioni rispetto a quelli dei controlli giovani; la quarta riga rappresenta
graficamente la significatività statistica di queste differenze. Nelle righe 2-4 lo spessore calloso effettivo misurato è a sinistra mentre
lo spessore calloso registrato è a destra.
)
i
n
a
v
o
i
g
(
o
l
l
o
r
t
n
o
C
)
i
n
a
i
z
n
a
(
o
l
l
o
r
t
n
o
C
n
i
e
t
s
n
i
E
e
r
u
s
i
m
Tabella 1 Misure della morfologia del corpo calloso di Einstein e di due gruppi di controllo di età diversa.
P
z
S
D
a
i
d
e
m
P
z
S
D
a
i
d
e
m
#
S
D
a
i
d
e
m
9
2
,
2
1
0
,
7
5
3
,
1
2
7
7
1
,
0
9
8
,
4
4
8
,
2
5
4
0
0
,
0
7
4
,
8
2
7
4
3
,
2
8
2
0
,
2
0
4
,
3
1
2
5
2
,
5
1
8
0
,
0
1
3
9
,
0
*
*
6
5
,
0
4
3
,
5
7
3
0
0
0
,
0
2
2
2
0
,
0
0
5
,
7
3
2
,
6
9
8
0
2
4
,
0
8
5
,
3
5
1
,
4
1
*
0
0
0
0
,
0
1
8
,
0
9
6
,
0
5
3
1
,
4
8
4
,
4
9
0
,
7
9
6
,
5
3
2
6
5
,
0
1
9
,
8
6
6
1
1
,
6
7
8
,
7
7
4
3
,
2
1
6
,
7
0
1
4
2
,
0
0
0
,
1
2
2
5
6
,
0
1
7
,
1
7
7
5
0
,
0
9
4
,
9
7
)
m
m
(
C
C
o
r
t
e
m
i
r
e
P
7
0
,
9
9
)
2
m
m
(
C
C
a
e
r
A
)
m
m
(
8
8
,
7
)
m
m
(
C
C
a
z
z
e
h
g
n
u
L
C
C
o
i
d
e
m
e
r
o
s
s
e
p
S
3
0
0
0
,
0
a
e
n
i
l
a
z
z
e
h
g
n
u
L
*
*
8
5
,
3
)
m
m
(
a
n
a
i
d
e
m
–
*
5
3
4
0
,
0
*
*
*
7
6
8
0
,
0
1
7
,
1
*
0
0
0
0
,
0
1
6
,
0
–
*
3
1
,
4
*
0
0
0
0
,
0
0
6
1
4
,
0
2
0
,
3
7
9
,
0
3
6
,
7
7
0
,
0
3
9
,
9
x
(
C
C
e
r
a
l
o
c
r
i
c
a
m
r
o
F
1
8
,
0
*
)
0
5
–
9
9
7
0
,
0
5
7
,
1
2
4
,
1
6
9
,
1
1
*
0
0
0
0
,
0
3
1
,
4
8
2
,
1
1
6
,
9
7
0
,
0
9
3
,
2
1
)
m
m
(
o
i
h
c
c
o
n
i
g
l
e
n
x
a
M
*
10
*
0
0
0
0
,
0
-
*
4
1
0
0
,
0
-
*
1
7
2
0
,
0
7
9
,
4
-
9
1
,
3
-
1
2
,
2
0
2
,
3
0
1
8
1
,
1
6
5
,
1
1
1
0
9
,
0
7
1
,
1
7
2
1
7
6
,
0
3
1
,
4
7
3
1
8
8
,
4
2
3
,
2
1
-
4
3
,
7
-
-
*
-
2
2
,
5
9
*
0
0
0
0
,
0
3
9
,
2
0
1
7
6
,
7
2
1
1
*
0
0
0
0
,
0
4
2
,
1
1
0
,
9
1
2
1
*
1
0
0
0
,
0
5
3
,
1
1
-
3
1
,
4
9
8
,
3
8
0
,
0
3
1
,
4
7
1
,
0
6
8
,
3
8
2
,
0
7
8
,
5
4
6
,
0
2
7
,
7
)
m
m
(
o
m
t
s
i
l
l
e
n
n
i
M
6
9
,
5
)
m
m
(
o
c
n
o
r
t
l
e
n
x
a
M
1
6
,
0
’
*
5
2
,
5
1
)
m
m
(
o
i
n
e
l
p
s
o
l
l
e
n
x
a
M
Δ
*
*
0
3
2
1
)
g
(
o
l
l
e
v
r
e
c
o
s
e
P
-
)
3
m
c
(
o
l
l
e
v
r
e
c
e
m
u
l
o
V
Il test U di Mann–Whitney è stato usato per confrontare le misure del corpo calloso di Einstein con i due gruppi di controllo di
diverse età, rispettivamente.
# Deviazione standard delle misure
Δ
Lo spessore calloso massimo di Einstein è significativamente più grande di quelli di entrambi i gruppi di controllo, giovani e
anziani.
Gli asterischi indicano le differenze statisticamente significative tra i gruppi di controllo ed Einstein, *P<0,05, **P<0,001.
CC = corpo calloso.
Si ritiene che le fibre dell’istmo posteriore e dello splenio
connettano parti corrispondenti dei lobuli parietali superiori (area
di Brodmann 7), dei lobuli parietali inferiori (aree di Brodmann
39/40) e delle cortecce temporali (aree di Brodmann 20/21/37),
mentre è stato evidenziato che altre fibre dello splenio
connettono regioni corticali estese inclusa la corteccia occipitale
(aree di Brodmann 17/18/19) (Luders et al., 2007; Park et al.,
2008; Chao et al., 2009). La maggior parte delle distribuzioni
dello spessore calloso dello splenio di Einstein (soprattutto nella
porzione centrale dello splenio) è significativamente più grande
delle regioni corrispondenti dei controlli giovani. Le fibre che
attraversano questa sottoarea sono solitamente assoni di diametro
piccolo, che trasferiscono l'informazione cognitiva tra gli
emisferi e facilitano l'elaborazione di livello superiore nei lobi
parietale, temporale e occipitale (Aboitiz et al., 1992). I lobuli
parietali superiori sono coinvolti nella coordinazione
visuomotoria, nell'attenzione spaziale e nella visualizzazione di
immagini nello spazio (Formisano et al., 2002). Studi recenti di
MRI funzionale indicano che il lobulo parietale superiore e il
solco intraparietale si attivano entrambi nel calcolo mentale e nel
digit span (Arsalidou and Taylor, 2011; Tanaka et al., 2012). I
lobuli parietali inferiori sono coinvolti nel linguaggio, nelle
operazioni matematiche (sopratutto il sinistro), nella percezione
dello spazio e nell'integrazione visomotoria (Hugdahl et al.,
2004). Le cortecce occipitali sono responsabili dell'elaborazione
visiva e possono attivarsi durante la visualizzazione di immagini
a occhi chiusi (O’Craven and Kanwisher, 2000). I giri temporali
inferiori (area di Brodmann 20) sono coinvolti nell'elaborazione
visiva di alto livello, nella memoria di riconoscimento, nel
riconoscimento del volto e del corpo e nell'elaborazione
dell'informazione cromatica (Buckner et al., 2000). Witelson et
al. (1999a) hanno dimostrato che i lobi parietali del cervello di
Einstein sono del 15% più grandi di quelli dei controlli. Falk et
al. (2013) hanno mostrato che il lobulo parietale superiore destro
di Einstein (area di Brodmann 7) è considerevolmente più grande
del sinistro, il suo solco intraparietale destro è molto insolito, il
suo lobulo parietale inferiore sinistro sembrava relativamente
grande rispetto al destro e le superfici corticali dei lobi occipitali
di Einstein sono molto convoluti. Il rapporto tra cellule gliali e
Si ritiene che le fibre dell'istmo e dello splenio posteriori
connettano le parti corrispondenti dei lobuli parietali superiori
(area 7 di Brodmann ), dei lobuli parietali inferiori (aree 39/40 di
Brodmann) e delle cortecce temporali (aree 20/21/37 di
Brodmann), mentre è stato mostrato come altre fibre dello
splenio connettano le regioni corticali estese che includono la
corteccia occipitale (aree 17/18/19 di Brodmann) (Luders et al.,
2007; Park et al., 2008; Chao et al., 2009). La maggior parte
delle distribuzioni dello spessore del corpo calloso di Einstein
nello splenio (in particolare nella parte centrale dello splenio) è
significativamente più grande delle regioni confrontabili dei
controlli giovani. Le fibre che attraversano questa sottoarea sono
in genere assoni di diametro piccolo, che trasmettono le
informazioni cognitive tra emisferi e favoriscono l'elaborazione
di alto livello nei lobi parietali, temporali e occipitali (Aboitiz et
al., 1992). I lobuli parietali superiori sono coinvolti nella
coordinazione visuo-motoria, nell'attenzione spaziale e
nell’immaginazione spaziale (Formisano et al., 2002). Studi
recenti di MRI funzionale indicano che il lobulo parietale
superiore e il solco intraparietale vengono entrambi attivati
durante attività di calcolo mentale e digit span (Arsalidou and
Taylor, 2011; Tanaka et al., 2012). I lobuli parietali inferiori sono
coinvolti nel linguaggio, nelle operazioni matematiche (in
particolare sul lato sinistro), nella percezione dello spazio e
nell'integrazione visuo-motoria (Hugdahl et al., 2004). Le
cortecce occipitali si occupano dell'elaborazione visiva e possono
attivarsi durante attività di immaginazione a occhi chiusi
(O’Craven and Kanwisher, 2000). I giri temporali inferiori (area
20 di Brodmann) sono coinvolti in elaborazioni visive di alto
livello, memoria di riconoscimento, riconoscimento di volto e
corpo ed elaborazione della informazione cromatica (Buckner et
al., 2000). Witelson et al. (1999a) hanno dimostrato che i lobi
parietali del cervello di Einstein sono più larghi del 15% rispetto
a quelli dei controlli. Falk et al. (2013) hanno mostrato che il
lobulo parietale superiore destro di Einstein (area 7 di
Brodmann) è considerevolmente più largo del sinistro, il suo
solco intraparietale destro era molto insolito, il suo lobulo
parietale inferiore sinistro sembra essere relativamente esteso
rispetto al destro e le superfici corticali dei lobi occipitali di
11
neuroni era significativamente più grande nell'area di Brodman
39 di sinistra di Einstein rispetto a quella di destra e
relativamente aumentato nelle neocortecce temporali bilaterali
rispetto alla media dei controlli (Diamond et al., 1985). La glia
influenza l'eccitabilità neuronale, la trasmissione sinaptica e
l'attività coordinata tra le reti di neuroni (Fields and StevensGraham, 2002). Luders et al. (2007) hanno osservato delle
correlazioni positive significative tra le misure dello spessore
calloso posteriore e le misure di intelligenza. Ciò nonostante il
corpo calloso di Einstein non è sempre più spesso di quelli dei
controlli giovani, specialmente nel corpo rostrale, in cui le fibre
collegano principalmente i giri frontali superiori medi destri e
sinistri (area di Brodman 8), che sono coinvolti nella gestione
dell'incertezza (Volz et al., 2005). Tuttavia, i nostri risultati
complessivi suggeriscono con forza che Einstein aveva
connessioni più ampie tra alcune aree dei suoi emisferi cerebrali
sia rispetto ai controlli della stessa fascia di età sia rispetto ai
controlli più giovani, ciò è consistente con gli studi discussi
sopra e aggiunge un altro livello alla crescente evidenza che la
capacità di visualizzazione spaziale straordinaria di Einstein e il
suo talento matematico erano fondati su substrati neurologici
definibili. Sebbene l’intelligenza degli esseri umani non possa
essere completamente spiegata dal volume delle aree corticali
(Gazzaniga, 2000), i nostri risultati suggeriscono che le capacità
cognitive straordinarie di Einstein fossero legate non solo
all'unicità della sua struttura corticale e citoarchitettura ma anche
a vie di comunicazione più efficaci, almeno tra alcune aree dei
suoi emisferi cerebrali.
Einstein presentavano molte circonvoluzioni. Il rapporto tra
cellule gliali e neuroni è significativamente maggiore nella parte
sinistra dell'area 39 di Brodmann di Einstein rispetto alla parte
destra e relativamente accresciuto nelle neocortecce temporali
bilaterali rispetto alla media dei controlli (Diamond et al., 1985).
La glia influisce sull'eccitabilità dei neuroni, sulla trasmissione
sinaptica e sull'attività coordinata tra le reti neurali (Fields and
Stevens-Graham, 2002). Luders et al. (2007) hanno osservato
correlazioni positive significative tra lo spessore del corpo
calloso posteriore e le misure dell'intelligenza. Tuttavia, il corpo
calloso di Einstein non è sempre più spesso di quelli dei controlli
giovani, in particolare nel rostro, dove le fibre connettono
principalmente i giri frontali medio-superiori destro e sinistro
(area 8 di Brodmann), interessati nella gestione dell'incertezza
(Volz et al., 2005). Ciò nonostante, i nostri risultati complessivi
suggeriscono con forza che Einstein aveva connessioni più estese
tra alcune parti degli emisferi cerebrali rispetto sia ai controlli
più giovani che ai controlli di pari età, una conclusione
consistente con gli studi discussi sopra e che aggiunge un altro
livello all'evidenza crescente che le abilità straordinarie di
immaginazione spaziale e matematiche di Einstein fossero
radicate in sostrati neurologici definibili. Anche se l'intelligenza
degli esseri umani non può essere spiegata completamente con i
volumi corticali regionali (Gazzaniga, 2000), i nostri risultati
suggeriscono che le facoltà cognitive straordinarie di Einstein
fossero legate non solo alla sua struttura corticale e alla sua
citoarchitettura uniche, ma coinvolgessero anche percorsi di
comunicazione potenziati almeno tra alcune delle parti dei due
emisferi cerebrali.
Riassumendo, questo studio è il primo, a nostra conoscenza,
a indagare la connettività degli emisferi cerebrali di Einstein,
confrontando la morfologia del suo corpo calloso con quella di
15 maschi anziani sani e di 52 maschi giovani sani. Abbiamo
scoperto che il corpo calloso di Einstein aveva, nella stragrande
maggioranza delle sue sottoaree, uno spessore maggiore rispetto
a quello delle aree corrispondenti del corpo calloso dei controlli
anziani e che il corpo calloso di Einstein era più spesso di quelli
dei controlli più giovani, nel rostro, nel genu, nel tronco e
(soprattutto) nello splenio. Queste scoperte mostrano che, in
Einstein, la connettività tra i due emisferi era in generale
potenziata rispetto a quella dei controlli. I risultati del nostro
studio suggeriscono che il talento intellettuale di Einstein non
fosse
collegato
soltanto alle
specializzazioni
delle
circonvoluzioni cerebrali e della citoarchitettura in alcune
regioni del suo cervello ma coinvolgessero anche una
comunicazione coordinata tra gli emisferi cerebrali. E per
ultimo, ma non meno importante, la metodologia perfezionata
per la misura del corpo calloso, usata in questo studio, può avere
applicazioni più generali negli studi sul corpo calloso.
Riassumendo, al meglio delle nostre conoscenze, questo
studio è il primo a indagare la connettività degli emisferi
cerebrali di Einstein confrontando la morfologia del suo corpo
calloso con quello di 15 maschi anziani sani e 52 maschi giovani
sani. Abbiamo scoperto che il corpo calloso di Einstein era più
spesso nella maggior parte delle sottoregioni rispetto alle parti
corrispondenti nel corpo calloso dei controlli anziani, e che il
corpo calloso di Einstein era più spesso nel rostro, nel ginocchio,
nel tronco, nell'istmo e (in particolare) nello splenio rispetto ai
controlli giovani. Questi risultati mostrano che la connettività tra
i due emisferi è generalmente potenziata in Einstein che nei
controlli. I risultati del nostro studio suggeriscono che i doni
intellettivi di Einstein non erano solo legati alle specializzazioni
delle pieghe corticali e della citoarchitettura in determinate
regioni del cervello, ma coinvolgessero anche la comunicazione
coordinata tra emisferi cerebrali. Da ultimo, ma non certo per
importanza, il metodo migliorato per la misurazione del corpo
calloso utilizzato in questo studio può avere ulteriori applicazioni
generali negli studi sul corpo calloso.
i
t
n
e
m
a
i
z
a
r
g
n
i
R
i
t
n
e
m
a
i
z
a
r
g
n
i
R
Gli autori desiderano ringraziare il National Museum of Health
and Medicine degli Stati Uniti per aver avuto il permesso di
accedere alle fotografie ad alta risoluzione del cervello di
Einstein. Ringraziamo l'Open Access Series of Imaging Studies
(OASIS; Daniel S. Marcus, PhD) per averci permesso di
scaricare i dati MRI dei 15 soggetti anziani. Ringraziamo inoltre
l'International Consortium for Brain Mapping (ICBM; Principal
Investigator: John Mazziotta, MD, PhD) per averci concesso di
scaricare e pubblicare i dati MRI del cervello dei 52 maschi sani.
Gli autori desiderano ringraziare il National Museum of Health
and Medicine degli Stati Uniti per aver permesso di accedere alle
fotografie ad alta risoluzione del cervello di Einstein.
Ringraziamo la Open Access Series of Imaging Studies (OASIS;
Daniel S. Marcus, PhD) per averci permesso di scaricare i dati
MRI dei 15 soggetti di età avanzata. Ringraziamo inoltre
l'International Consortium for Brain Mapping (ICBM; Principal
Investigator: John Mazziotta, MD, PhD) per averci concesso di
scaricare e pubblicare i dati MRI sul cervello dei 52 maschi sani.
12
L'acquisizione di questi dati e il supporto per l'analisi sono stati
possibili grazie ai grant NIH P50 AG05681, P01 AG03991, R01
AG021910, P50 MH071616, U24 RR021382 e R01 MH56584.
Questo studio è stato finanziato in parte dal ‘XII piano
quinquennale a supporto del progetto del Ministero della scienza
e della tecnologia della Repubblica Popolare Cinese’ (codice
finanziamento 2013BAI10B03).
e
r
a
t
n
e
m
e
l
p
p
u
s
e
l
a
i
r
e
t
a
M
e
r
a
t
n
e
m
e
l
p
p
u
s
e
l
a
i
r
e
t
a
M
Il materiale supplementare è disponibile sul sito di Brain.
i
t
n
e
m
a
i
z
n
a
n
i
F
i
t
n
e
m
a
i
z
n
a
n
i
F
L'acquisizione di questi dati e il supporto per l'analisi dei dati è
stato fornito dai grant NIH P50 AG05681, P01 AG03991, R01
AG021910, P50 MH071616, U24 RR021382 e R01 MH56584.
Questo studio è stato finanziato in parte dal ‘XII piano
quinquennale a sostegno del progetto del Ministero della scienza
e della tecnologia della Repubblica Popolare Cinese’ (numero
grant 2013BAI10B03).
Il materiale supplementare è disponibile su Brain online.
13
s
e
c
n
e
r
e
f
e
R
Gazzaniga MS. Cerebral specialization and interhemispheric
communication: does the corpus callosum enable the human
condition? Brain 2000; 123 (Pt 7): 1293–326.
Aboitiz F, Lopez J, Montiel J. Long distance communication in
the human brain: timing constraints for inter-hemispheric
synchrony and the origin of brain lateralization. Biol Res 2003;
36: 89–99.
Gupta T, Singh B, Kapoor K, Gupta M, Kochar S. Corpus
callosum morphometry: comparison of fresh brain, preserved
brain and magnetic resonance imaging values. Anat Sci Int 2008;
83: 162–8.
Aboitiz F, Scheibel AB, Fisher RS, Zaidel E. Fiber composition
of the human corpus callosum. Brain Res 1992; 598: 143–53.
Hines T. Further on Einstein’s brain. Exp Neurol 1998; 150:
343–4.
Anderson B, Harvey T. Alterations in cortical thickness and
neuronal density in the frontal cortex of Albert Einstein.
Neurosci Lett 1996; 210: 161–4.
Hofer S, Frahm J. Topography of the human corpus callosum
revisited– comprehensive fiber tractography using diffusion
tensor magnetic resonance imaging. Neuroimage 2006; 32: 989–
94.
Ardekani B, Bachman A, Figarsky K, Sidtis J. Corpus callosum
shape changes in early Alzheimer’s disease: an MRI study using
the OASIS brain database. Brain Struct Funct 2013, Jan 16.
[Epub ahead of print].
Arsalidou M, Taylor MJ. Is 2 + 2=4? Meta-analyses of brain
areas needed for numbers and calculations. Neuroimage 2011;
54: 2382–93.
Hugdahl K, Rund BR, Lund A, Asbjornsen A, Egeland J, Ersland
L, et al. Brain activation measured with fMRI during a mental
arithmetic task in schizophrenia and major depression. Am J
Psychiatry 2004; 161: 286–93.
Kigar D, Witelson S, Glezer I, Harvey T. Estimates of cell
number in temporal neocortex in the brain of Albert Einstein.
Soc Neurosci Abst 1997; 23: 89–9.
Benjamini Y, Hochberg Y. Controlling the false discovery rate: a
Lepore FE. Dissecting genius: Einstein’s brain and the search for
pratical and powerful approach to multiple testing. J R Statist
the neural basis of intellect. New York: Dana Press; 2001. p. 11–
Soc 1995; 57: 289–300.
26.
Buckner RL, Koutstaal W, Schacter DL, Rosen BR. Functional
MRI evidence for a role of frontal and inferior temporal cortex in Leyton M. Symmetry-curvature duality. Comput Vision Graphics
amodal components of priming. Brain 2000; 123 (Pt 3): 620–40. Image Process 1987; 38: 327–41.
Chao YP, Cho KH, Yeh CH, Chou KH, Chen JH, Lin CP.
Probabilistic topography of human corpus callosum using
cytoarchitectural parcellation and high angular resolution
diffusion imaging tractography. Hum Brain Mapp 2009; 30:
3172–87.
Colombo JA, Reisin HD, Miguel-Hidalgo JJ, Rajkowska G.
Cerebral cortex astroglia and the brain of a genius: a propos of
A. Einstein’s. Brain Res Rev 2006; 52: 257–63.
Luders E, Narr KL, Bilder RM, Thompson PM, Szeszko PR,
Hamilton L, et al. Positive correlations between corpus callosum
thickness and intelligence. Neuroimage 2007; 37: 1457–64.
Mann HB, Whitney DR. On a test of whether one of two random
variables is stochastically larger than the other. Ann Math Stat
1947; 1: 50–60.
Marcus DS, Fotenos AF, Csernansky JG, Morris JC, Buckner RL.
Open access series of imaging studies: longitudinal MRI data in
Dekaban AS. Changes in brain weights during the span of human nondemented and demented older adults. J Cogn Neurosci 2010;
life: relation of brain weights to body heights and body weights. 22: 2677–84.
Ann Neurol 1978; 4: 345–56.
Marcus DS, Wang TH, Parker J, Csernansky JG, Morris JC,
Diamond MC, Scheibel AB, Murphy GJ, Harvey T. On the brain Buckner RL. Open Access Series of Imaging Studies (OASIS):
cross-sectional MRI data in young, middle aged, nondemented,
of a scientist: Albert Einstein. Exp Neurol 1985; 88: 198–204.
and demented older adults. J Cogn Neurosci 2007; 19: 1498–
507.
Einstein A. Autobiographical Notes. Paul Arthur Schilpp
(Centennial ed.). Chicago: Open Court Publishing Company;
O’Craven KM, Kanwisher N. Mental imagery of faces and
1979. p. 48–51.
places activates corresponding stiimulus-specific brain regions. J
Cogn Neurosci 2000; 12: 1013–23.
Falk D. New Information about Albert Einstein’s Brain. Front
Park HJ, Kim JJ, Lee SK, Seok JH, Chun J, Kim DI, et al.
Evol Neurosci 2009; 1: 3.
Corpus callosal connection mapping using cortical gray matter
parcellation and DT-MRI. Hum Brain Mapp 2008; 29: 503–16.
Falk D, Lepore FE, Noe A. The cerebral cortex of Albert
Einstein: a description and preliminary analysis of unpublished
Schreider E. Brain weight correlations calculated from original
photographs. Brain 2013; 136 (Pt 4): 1304–27.
results of Paul Broca. Am J Phys Anthropol 1966; 25: 153–8.
Fields RD, Stevens-Graham B. New insights into neuron-glia
Tanaka S, Seki K, Hanakawa T, Harada M, Sugawara SK, Sadato
communication. Science 2002; 298: 556–62.
N, et al. Abacus in the brain: a longitudinal functional MRI study
Formisano E, Linden DE, Di Salle F, Trojano L, Esposito F, Sack of a skilled abacus user with a right hemispheric lesion. Front
AT, et al. Tracking the mind’s image in the brain I: time-resolved Psychol 2012; 3: 315.
fMRI during visuospatial mental imagery. Neuron 2002; 35:
185–94.
14
Volz KG, Schubotz RI, von Cramon DY. Variants of uncertainty
in decision- making and their neural correlates. Brain Res Bull
2005; 67: 403–12.
Witelson SF. Hand and sex differences in the isthmus and genu
of the human corpus callosum. A postmortem morphological
study. Brain 1989; 112 (Pt 3): 799–835.
Witelson SF, Kigar DL, Harvey T. The exceptional brain of
Albert Einstein. Lancet 1999a; 353: 2149–53.
Witelson SF, Kigar DL, Harvey T. Authors’ reply. Lancet 1999b;
354: 1822.
15