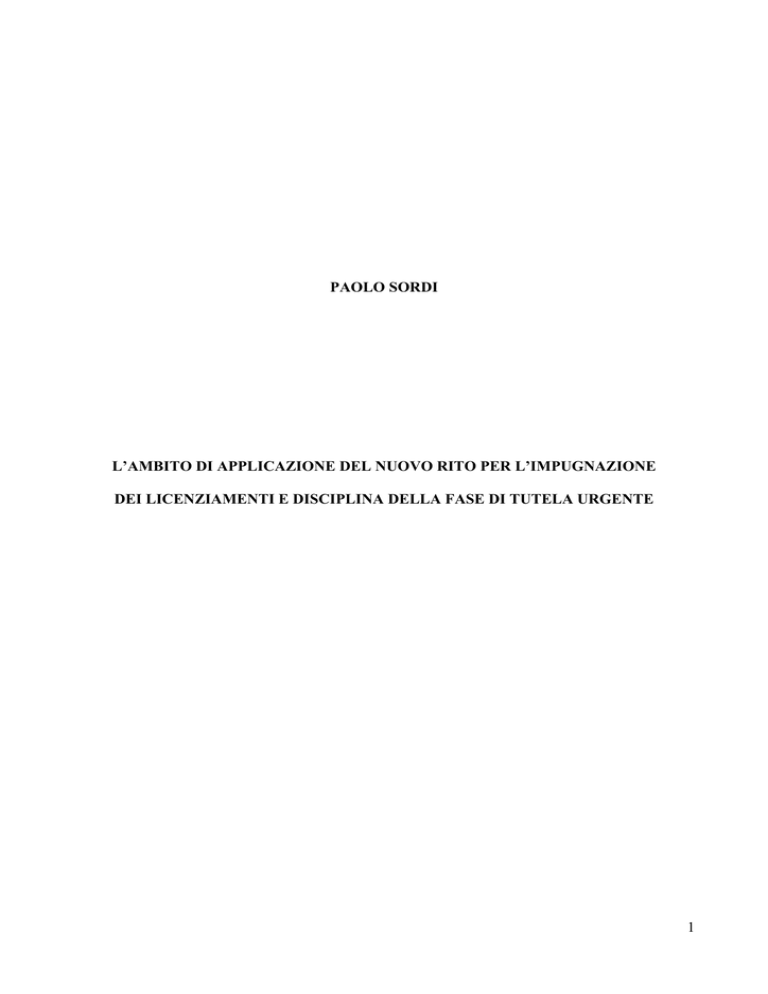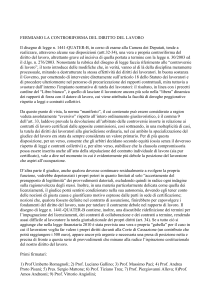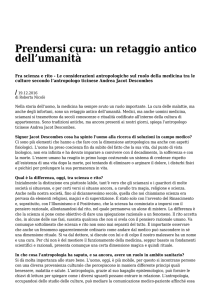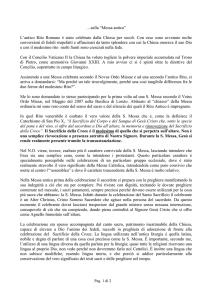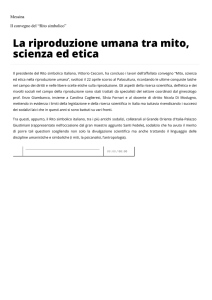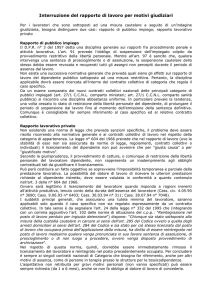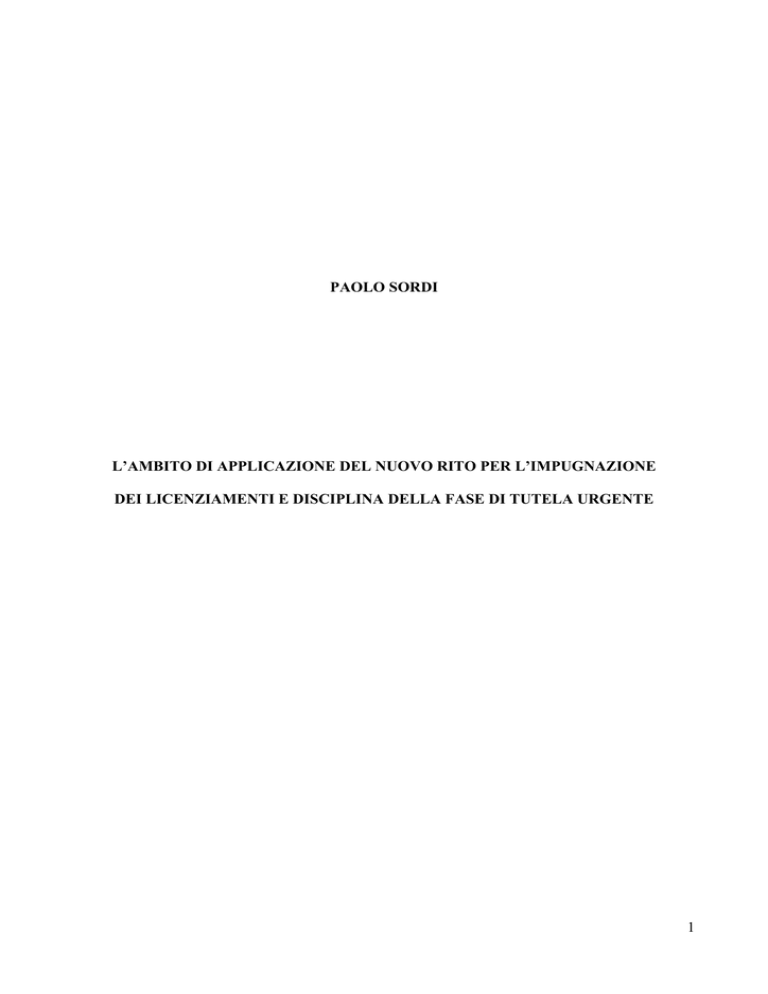
PAOLO SORDI
L’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO RITO PER L’IMPUGNAZIONE
DEI LICENZIAMENTI E DISCIPLINA DELLA FASE DI TUTELA URGENTE
1
SOMMARIO
1. Caratteri generali del nuovo rito e sua collocazione sistematica.
1.1. La finalità del nuovo modello processuale.
1.2. La specialità del nuovo rito.
1.3. Il carattere necessario del nuovo rito.
pag. 3
pag. 4
pag. 5
2. Ambito di applicabilità.
2.1. I licenziamenti la cui impugnazione è soggetta al nuovo rito.
pag. 7
2.2. Le azioni di accertamento promosse dal datore di lavoro.
pag. 10
2.3. Il fallimento del datore di lavoro.
pag. 10
2.4. Le questioni relative alla qualificazione del rapporto.
pag. 11
2.5. Le domande fondate sugli identici fatti costitutivi.
pag. 12
2.6. La contemporanea pendenza di cause aventi ad oggetto diritti del lavoratore diversi da
quelli derivanti dall’illegittimità del licenziamento.
pag. 15
3. La fase “urgente”: a) l’introduzione della causa.
3.1. La competenza per territorio.
3.2. Il ricorso.
3.3. Il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti.
3.4. La notificazione del ricorso.
3.5. La costituzione del convenuto.
3.6. Preclusioni e decadenze.
pag. 17
pag. 17
pag. 18
pag. 19
pag. 19
pag. 20
4. segue: b) la trattazione e l’istruzione della causa.
4.1. La concentrazione della trattazione.
4.2. Gli adempimenti preliminari del giudice.
4.3. L’interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione.
4.4. La superficialità dell’istruttoria.
4.5. I singoli mezzi istruttori.
4.6. Le istanze istruttorie delle parti.
4.7. I poteri istruttori officiosi.
4.8. Le formalità non essenziali al contraddittorio.
4.9. Alcuni incidenti processuali.
pag. 21
pag. 22
pag. 22
pag. 22
pag. 24
pag. 25
pag. 25
pag. 26
pag. 29
5. segue: c) la decisione.
pag. 30
6. Il problema del giudicato.
pag. 31
7. Questioni di rito.
7.1. L’applicabilità in via analogica dell’art. 4 d. lgs. n. 150 del 2011.
7.2. Il contenuto dell’ordinanza di mutamento di rito.
7.3. Il regime dell’ordinanza di mutamento del rito.
7.4. Il cumulo di domande.
7.5. Il regime degli effetti della domanda.
7.6. Il regime delle preclusioni e delle decadenze.
pag. 36
pag. 38
pag. 39
pag. 41
pag. 42
pag. 43
8. Rapporti con gli altri riti previsti dall’ordinamento.
pag. 44
9. Le misure organizzative.
pag. 47
2
1. Caratteri generali del nuovo rito e sua collocazione sistematica.
1.1. La finalità del nuovo modello processuale. – Il legislatore, contestualmente alla
modificazione dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 (e, cioè, del sistema delle tutele sostanziali
contro i licenziamenti illegittimi), ha introdotto una importante novità sul piano processuale. Ha
previsto, infatti (art. 1, commi 47-69, della legge n. 92 del 2012), una specifica disciplina per le
«controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’articolo
18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere
risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro».
La limitazione dell’àmbito di applicabilità del nuovo rito alle sole controversie nelle quali si
discuta dell’applicazione di una o più delle tutele previste dall’art. 18 del legge n. 300 del 1970
costituisce un primo indizio nel senso dell’esistenza di uno stretto nesso, sul piano sistematico, tra
le disposizioni processuali e quelle sostanziali in materia di recesso datoriale. E l’esattezza di tale
assunto è confermata anche da un semplice sommario esame della nuova disciplina delle
controversie in questione. In effetti, il legislatore ha delineato un procedimento che si articola in una
prima fase (che, per comodità, d’ora in avanti chiameremo anche fase “urgente”, senza però voler
attribuire all’aggettivo alcun significato tecnico) caratterizzata da termini più ristretti (anche se non
di molto) rispetto a quelli stabiliti per le controversie di lavoro dal capo I del titolo IV del libro
secondo del codice di rito, da una trattazione deformalizzata e da un’istruttoria superficiale che deve
condurre, nel più breve tempo possibile, ad un primo pronunciamento giudiziale, in ordine alla
legittimità o meno del licenziamento, reso nella forma dell’ordinanza e svincolato da qualsiasi
esigenza cautelare (non è infatti richiesto, per l’accoglimento del ricorso, che il diritto del lavoratore
sia minacciato dal rischio di un imminente ed irreparabile pregiudizio); possono seguire, poi, una
fase di opposizione (sempre in primo grado, davanti allo stesso Tribunale che ha emesso
l’ordinanza) a cognizione piena ed approfondita e i consueti altri due gradi di giudizio, rispetto ai
quali pure sono previsti dispositivi acceleratori; sono state introdotte, infine, misure dirette ad
assicurare l’effettivo rispetto, da parte dei giudici del lavoro, dei più ristretti termini processuali
stabiliti.
Sembra evidente che la previsione di una disciplina processuale diretta ad assicurare la
contrazione dei tempi necessari per la definizione di una controversia nella quale si verta in tema di
tutele previste dal nuovo art. 18 della legge n. 300 del 1970 costituisca, da un lato, il necessario
completamento dell’intervento del legislatore del 2012 diretto a ridurre il tasso di incertezza relativo
ai possibili esiti dell’impugnazione di un licenziamento (incertezza che dipende, oltre che dal tipo di
conseguenze collegate alla valutazione rimessa al giudice, anche dalla distanza di tempo che separa
la formulazione di tale valutazione dal momento del licenziamento1), e, dall’altro, un congruo
contrappeso all’introduzione degli insuperabili limiti massimi all’ammontare della somma che il
lavoratore può ottenere quale indennità risarcitoria del pregiudizio economico causato
dall’iniziativa datoriale, imposti dal nuovo art. 18 per la maggior parte delle ipotesi di illegittimità
del licenziamento.
Anticipando gli esiti dell’analisi che si svolgerà nel prosieguo, può dirsi che il nuovo
modello processuale va ricondotto nella categoria delle tutele sommarie non cautelari.
È però doveroso riconoscere anche che la finalità del nuovo rito non sembra essere
solamente quella – tipica delle tutele sommarie non cautelari – di consentire la formazione
anticipata di un titolo esecutivo, ma anche quella di pervenire, nel più breve tempo possibile, ad un
1
In questo contesto si spiega anche la riduzione, da 270 a 180 giorni (disposta dall’art. 1, comma 38, della legge n. 92
del 2012), del termine – stabilito dall’art. 6, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, a pena di inefficacia
dell’impugnazione del licenziamento – entro il quale deve essere depositato il ricorso giudiziario avverso il recesso
datoriale.
3
accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento idoneo, in mancanza di attivazione del
rimedio oppositorio, ad acquistare caratteri di stabilità e definitività. Il nuovo procedimento,
dunque, è diretto a realizzare, oltre che l’interesse del lavoratore, anche quello del datore di lavoro.
Non osta a tale conclusione la constatazione dell’ormai residuale àmbito di applicabilità della tutela
risarcitoria con tendenzialmente integrale corresponsione delle retribuzioni maturate tra il
licenziamento e l’effettiva reintegrazione (sanzione che, con il protrarsi dei tempi di definizione
della controversia, aumenta la sua gravosità per la parte datoriale); infatti, non può negarsi che, in
ogni caso in cui un licenziamento sia contestato dal lavoratore che lo abbia subito, sussista
l’interesse dell’imprenditore affinché, in presenza di un’impugnazione giudiziale del licenziamento,
si pervenga nel più breve tempo possibile ad un definitivo pronunciamento giudiziale circa la
legittimità del recesso e, soprattutto, circa la sussistenza o meno del diritto del lavoratore ad essere
reintegrato nel posto di lavoro (diritto previsto dal nuovo art. 18 non solamente per il caso del
licenziamento discriminatorio, ma anche per una altra nutrita serie di ipotesi), misura la cui
esecuzione è tale da determinare comunque rilevanti conseguenze sull’organizzazione aziendale.
In sostanza, la riduzione dei tempi del processo con riferimento alle controversie in tema di
licenziamento è stata considerata dal legislatore come un significativo tassello del più generale
intervento mirante a «realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire
alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla
riduzione permanente del tasso di disoccupazione» (art. 1, comma 1, della legge n. 92). Com’è stato
detto, si tratta di un esempio di impiego del processo civile in vista di obiettivi di politica pubblica,
ulteriori rispetto alla tutela giurisdizionale dei diritti individuali2.
1.2. La specialità del nuovo rito. – L’altra evidente caratteristica dell’intervento del
legislatore è la scelta di non ricorrere a qualcuno dei modelli processuali già rinvenibili
nell’ordinamento, ma di crearne uno nuovo, in chiara (ed immediata) smentita del lodevole
proposito di semplificazione dei riti che aveva condotto, meno di anno prima, all’emanazione del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Si aggiunga che quello creato dal legislatore del 2012
è un rito difficilmente assimilabile ad uno di quelli già presenti nell’ordinamento. Invero, come pure
è stato notato3, esso presenta alcune caratteristiche proprie del procedimento di repressione della
condotta antisindacale di cui all’art. 28 della legge n. 300 del 1970, altre tipiche del procedimento
sommario di cognizione disciplinato dagli artt. 702-bis ss. c.p.c. ed altre ancora comuni alla
disciplina del procedimento cautelare uniforme (artt. 669-bis ss. c.p.c.). È pertanto impossibile
qualificare il nuovo modello processuale come una species di qualcuno di quei genera e occorre
invece riconoscere che si tratta di un rito con proprie caratteristiche che si affianca a quelli già noti.
Una simile conclusione non è priva di conseguenze: una volta ammessa la piena specificità
del procedimento di cui all’art. 1 della legge n. 92 del 2012, al fine di risolvere questioni di natura
interpretativa poste dalla sua disciplina, non è possibile ricorrere sempre e comunque a soluzioni
elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza in riferimento ad uno dei tre modelli processuali
prima ricordati; quelle elaborazioni vanno sicuramente tenute presenti, ma limitatamente ai singoli
tratti di disciplina che siano sovrapponibili con quelli del nuovo rito; e comunque sempre previa
verifica della compatibilità della soluzione con le specifiche caratteristiche e la ratio del
procedimento introdotto dal legislatore del 2012.
Invece, al fine di colmare le lacune della disciplina della legge n. 92 del 2012 (nella quale
manca la regolazione di numerosi aspetti del procedimento, anche di indubbia rilevanza, come, ad
esempio, la competenza per territorio), occorre, in generale, far riferimento alle disposizioni
codicistiche in materia di controversie di lavoro4. Vale a dire che la disciplina dettata dagli artt. 409
2
R. CAPONI, La corsia preferenziale per alcune cause di lavoro rallenta le altre in assenza delle adeguate risorse, in
Guida dir., 2012, n. 18, 9.
3
G. BENASSI, La Riforma del mercato del lavoro: modifiche processuali, in Lav. giur., 2012, 752.
4
Conformi: L. DE ANGELIS, Art. 18 dello Statuto dei lavoratori e processo: prime considerazioni, in Working Papers
Massimo D’Antona, www.lex.unict.it, 10; C. CONSOLO-D. RIZZARDO, Vere o presunte novità, sostanziali e
4
ss. c.p.c. si applica alle controversie in questione per tutto quanto non previsto dall’art. 1, commi da
48 a 65 (ovviamente a condizione che sussista la compatibilità di cui si è detto in precedenza).
Seppure nella legge n. 92 del 2012 manchi un’espressa disposizione in tal senso, tale conclusione
può essere agevolmente argomentata sulla base dell’espressione utilizzata dal legislatore, il quale
non ha qualificato la disciplina da esso dettata come esaustiva; esso invece si è limitato a prevedere
che quella disciplina «si applica» alle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei
licenziamenti, presupponendo, quindi, che si tratti di una disciplina “aggiuntiva”, per così dire, a
quella che ordinariamente regola quella categoria di controversie. E tale è, appunto, quella del Capo
I del titolo IV del libro secondo del codice di rito che, a norma dell’art. 409, n. 1, c.p.c. si applica a
tutte le controversie relative a rapporti di lavoro subordinato privato.
A conforto di tale conclusione si aggiungano, da un lato, la già segnalata irriducibilità del
nuovo rito ad uno degli altri procedimenti “speciali” (con conseguente impossibilità di ricorrere alla
disciplina di questi ultimi per colmare le lacune di quella della legge n. 92 del 2012) e, dall’altro,
che, considerato l’oggetto delle controversie di cui qui si tratta, è sicuramente maggiormente
coerente con il generale ordinamento giuridico processualcivilistico ricondurre tali cause al rito
codici stico del lavoro, piuttosto che al rito ordinario.
1.3. Il carattere necessario del nuovo rito. – Un’altra caratteristica fondamentale del nuovo
procedimento risiede nel fatto che, come accennato, per le controversie alle quali esso è applicabile
(v., infra, n. 2), il rito di cui all’art. 1 della legge n. 92 del 2012 costituisce l’unica modalità di
esercizio dell’azione giudiziale. In altri termini, non è concessa alla parte interessata la facoltà di
scelta tra l’ordinario rito del lavoro di cui al codice di procedura civile e quello introdotto dal
legislatore del 2012, essendo il ricorrente tenuto a seguire questo secondo5. Ciò si desume in
maniera incontrovertibile dal tenore del comma 47 dell’art. 1 della legge n. 92 del 2012, a norma
del quale «le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle controversie aventi ad oggetto
l’impugnativa dei licenziamenti». Come si vede, la disposizione prevede come inevitabile
l’applicazione delle regole enunciate nei commi successivi alla categoria di controversie da essa
contemplata.
Questione diversa è, però, quella relativa alla possibilità per le parti di “saltare”, per così
dire, la prima fase del giudizio di primo grado. Qui, infatti, non si tratta di riconoscere alle parti di
scegliere un rito piuttosto che un altro. Si tratta invece di verificare se, ferma restando
l’applicazione della disciplina processuale dettata dall’art. 1 della legge n. 92 del 2012, le parti
possano iniziare la controversia a partire da quella che, nel disegno complessivo del nuovo modello
processuale, è la seconda fase del giudizio di primo grado, introdotta con un ricorso in opposizione
al provvedimento conclusivo della prima fase “urgente”. Ove si ritenga di fornire risposta
affermativa a tale interrogativo, resterebbe comunque ferma l’applicazione di tutta la parte della
disciplina del nuovo rito relativa al giudizio di opposizione, a quello di reclamo e a quello di
cassazione: non vi sarebbe, dunque, alcuna deroga al generale principio dell’indisponibilità del rito
per le parti.
Una seconda premessa che deve essere svolta è l’inutilizzabilità, al fine della risoluzione
della questione, di soluzioni elaborate per analoghe questioni poste rispetto a quei modelli
processuali, sui licenziamenti individuali, in Corr. giur., 2012, 736. Analogamente, D. BORGHESI, Conciliazione e
procedimento speciale dei licenziamenti per la riforma Fornero, in Lav. giur., 2012, 914, afferma che «il nuovo
processo speciale va inserito nella cornice del processo del lavoro».
5
Conformi: L. DE ANGELIS, op. cit., 11; A. BOLLANI, Il rito speciale in materia di licenziamento, in M.
MAGNANI-M. TIRABOSCHI (a cura di), La nuova riforma del lavoro, Giuffré, 2012, 315; L. CAVALLARO, La
riforma cd. Fornero: questioni processuali, Relazione all’incontro di studi “La tutela del lavoratore tra novità normative
e revirements giurisprudenziali”, Agrigento, 21 settembre 2012, pag. 3 del dattiloscritto; G. PACCHIANI
PARRAVICINI, Il nuovo art. 18 st. lav.: problemi processuali e sostanziali, in Mass. giur. lav., 2012, 755. Contra,
senza motivazione, C. CONSOLO-D. RIZZARDO, Vere o presunte novità, sostanziali e processuali, sui licenziamenti
individuali, in Corr. giur., 2012, 735.
5
processuali che, come già segnalato, presentano qualche tratto in comune con quello di cui qui ci
stiamo occupando.
Così, non rileva segnalare che, con riferimento al procedimento sommario di cognizione, la
giurisprudenza sembra propensa a riconoscere al ricorrente la facoltà – da esercitare prima della
pronuncia dell’ordinanza istruttoria – di chiedere ed ottenere la conversione del rito da sommario ad
ordinario6. È agevole, infatti, rilevare come l’ordinamento preveda la piena facoltatività – per la
parte attrice – della scelta per il rito sommario di cognizione, scelta che invece, come detto, non è
riconosciuta dalla legge n. 92 del 2012 al lavoratore che intenda impugnare il licenziamento, onde il
problema si pone in termini del tutto diversi nei due casi.
È inutile anche volgere lo sguardo al procedimento di repressione della condotta
antisindacale. Invero, anche in questo caso, l’associazione sindacale è del tutto libera di proporre
un’azione ordinaria a tutela del proprio diritto; conseguentemente, non ha alcun senso chiedersi se
essa possa introdurre un procedimento ex art. 28 legge n. 300 del 1970 iniziando dalla fase di
giudizio (quella di opposizione al decreto) che, come detto, coincide con quella che il sindacato può
comunque promuovere (con un ordinario ricorso) senza necessità di invocare la tutela sommaria ed
urgente assicurata dalla norma statutaria.
Volendo dunque concentrare l’attenzione sulle specificità della disciplina nel nuovo rito per
l’impugnazione dei licenziamenti, il ragionamento deve necessariamente prendere le mosse
dall’individuazione delle differenze tra la prima e la seconda fase nelle quali si articola il giudizio di
primo grado. Come si vedrà più ampiamente nel prosieguo dell’esposizione, la diversità risiede
essenzialmente nella qualità della cognizione del giudice, nel senso che, nella fase “urgente”, il
giudice deve pervenire ad un giudizio di mera verosimiglianza e probabilistico circa i fatti rilevanti
per la decisione della lite; invece, nel giudizio di opposizione, la cognizione è piena ed
approfondita. È del tutto evidente, poi, che una istruttoria superficiale se, da un lato, consente di
ridurre i tempi di durata del procedimento, dall’altro offre alle parti minori garanzie circa la
corrispondenza del giudizio espresso dal giudice alla verità materiale.
In questo contesto, il comune consenso delle due parti ad omettere la prima fase equivale, in
sostanza, alla preventiva manifestazione della loro indisponibilità ad accettare l’esito sfavorevole
della cognizione superficiale dei fatti di causa ovvero, per dirla diversamente, costituisce
l’espressione anticipata della loro volontà di sottoporre i fatti controversi al più completo ed
approfondito accertamento istruttorio consentito dall’ordinamento, accertamento che esse ritengono
imprescindibile per la piena attuazione del diritto ad agire in giudizio a tutela dei rispettivi interessi
assicurato a tutti dall’art. 24 della Costituzione.
Ora, se si considera che una simile volontà è sicuramente tutelata anche dalla disciplina
dettata dalla legge n. 92 del 2012 (la quale prevede, appunto, la facoltà di impugnare l’ordinanza a
cognizione sommaria), negare alle parti, che hanno espresso il loro comune intento sul punto, la
possibilità di anticipare il momento di svolgimento di un accertamento di questo tipo sembra
consentito solamente se tale anticipazione (e, cioè, l’omissione della prima fase “urgente”) comporti
la lesione di qualche interesse, superiore alle parti stesse, tutelato dall’ordinamento.
A ben guardare, non pare che nella vicenda in esame sia ravvisabile un pregiudizio del
genere. In effetti, l’omissione della prima fase del giudizio di primo grado, in primo luogo, non
produce alcuna conseguenza sul regolare andamento dell’attività degli uffici giudiziari. Invero, da
un lato, essa non altera la distribuzione degli affari tra gli uffici giudiziari, essendo comunque
rispettate le regole in tema di competenza per materia e per territorio; dall’altro non è suscettibile di
determinare alcun incremento di contenzioso, anzi, semmai, potrebbe avere effetti opposti,
considerato che la singola controversia darebbe luogo, in primo grado, ad un solo giudizio invece
che due (quello della fase “urgente” e quello della fase di opposizione). In secondo luogo, non si
determina alcun allungamento dei tempi, perché, posto che le parti hanno comunque mostrato
l’intenzione di addivenire al giudizio a cognizione piena, la scelta di saltare la fase a cognizione
6
Così Trib. Varese, 4 aprile 2011, in www.ilcaso.it.
6
superficiale può comportare solamente una riduzione del tempo necessario per l’emanazione della
sentenza che definisce il giudizio di primo grado.
Né è possibile sostenere che la scelta delle parti comprometterebbe la coerenza del modello
processuale articolato dal legislatore del 2012 e, in particolare, lo scopo da quest’ultimo perseguito.
Infatti, se è vero, come segnalato, che il legislatore ha individuato nella riduzione dei tempi
necessari perché la magistratura si pronunci sulla legittimità dei licenziamenti non accettati dai
lavoratori un obiettivo funzionale al successo del più ampio disegno riformatore mirante alla
crescita economica ed alla creazione di occupazione, è anche vero che tale obiettivo è comunque
condizionato – anche ove si rispettino tutte le articolazioni del meccanismo processuale ideato dal
legislatore – dalle iniziative adottate dalle parti protagoniste delle singole controversie; a queste
ultime, infatti, è conservata intatta la facoltà di prolungare la controversia fino al giudizio di
cassazione, non essendo stato limitato in alcuna maniera né il potere di ricorrere contro la pronuncia
di primo grado, né quello di ricorrere in cassazione; in sostanza, anche alle parti delle cause di
impugnazione dei licenziamenti, sono attribuite le medesime facoltà riconosciute alle parti di una
qualsiasi causa di lavoro e il cui esercizio incide in maniera drastica sulla durata complessiva della
controversia. Altri sono, come si vedrà, gli accorgimenti adottati dal legislatore per assicurare il
risultato finale della contrazione dei tempi processuali (essenzialmente: la deformalizzazione della
trattazione della causa, sia in primo, sia in secondo grado, e la previsione di una corsia preferenziale
per le cause di licenziamento) e sulla loro efficacia non incide in alcuna maniera la scelta di saltare
la prima fase del giudizio di primo grado.
In conclusione, non sembra che esistano serie ragioni per escludere che, consenzienti
entrambe le parti, la causa a partire da quello che, nel modello processuale previsto dal legislatore, è
il giudizio di opposizione all’ordinanza conclusiva della prima fase.
Quanto, poi, alle modalità attraverso le quali tale volontà si può manifestare nel processo, si
rinvia a quanto si dirà nel paragrafo 11.
2. Ambito di applicabilità.
2.1. I licenziamenti la cui impugnazione è soggetta al nuovo rito. – Come detto, la nuova
procedura riguarda le controversie aventi ad oggetto «l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi
regolate dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni».
Il chiaro tenore letterale della disposizione non consente dubbi sul fatto che il rito speciale si
applica quale che sia, tra le tutele contro i licenziamenti illegittimi disciplinate dall’art. 18 della
legge n. 300 del 1970, quella invocata dal lavoratore. Pertanto sono soggetti al nuovo procedimento
non solamente i ricorsi diretti ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, ma anche quelli con i
quali il lavoratore richieda solamente l’indennità risarcitoria prevista dai nuovi commi quinto e
sesto dell’art. 18. Analoga conclusione vale per il caso in cui, nel proprio ricorso, il lavoratore,
deducendo l’esistenza di uno dei vizi che, secondo la nuova versione della norma statutaria, dà
diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, eserciti la facoltà di opzione per l’indennità sostitutiva
pari a quindici mensilità e chieda esclusivamente la condanna del datore di lavoro al pagamento di
tale emolumento (non dovrebbero nutrirsi dubbi circa la possibilità per il lavoratore di esercitare la
predetta opzione già nel ricorso ex art. 1, comma 47, della legge n. 92 del 2012, il testo del nuovo
terzo comma dell’art. 18 non contenendo novità idonee a smentire le conclusioni raggiunte dalla
giurisprudenza, con riferimento alla precedente versione della disposizione, circa l’efficacia
dell’opzione per l’indennità sostitutiva esercitata dal lavoratore prima della pronuncia della
sentenza che dispone la reintegrazione nel posto di lavoro7).
7
V. Cass., 25 gennaio 2011, n. 1690 (in un caso in cui l’opzione era stata esercitata nel ricorso cautelare); Cass., 28
novembre 2006, n. 25210, in Notiz. giur. lav., 2007, 206.
7
Non altrettanto vale, invece, per i ricorsi diretti ad ottenere la concessione di altre forme di
tutela contro i licenziamenti viziati, come, ad esempio, quella prevista dall’art. 8 della legge n. 604
del 1966 oppure quella stabilita nei contratti collettivi per il licenziamento ingiustificato del
dirigente o, ancora, la concessione dell’indennità sostitutiva del preavviso in caso di licenziamento
in tronco intimato nell’area della recedibilità ad nutum rispetto al quale si accerti l’insussistenza
della giusta causa (diverso è il problema dell’ammissibilità di simili domande se proposte in via
subordinata alla domanda principale di tutela ex art. 18, sul quale si veda quanto detto infra).
Poiché ai licenziamenti collettivi illegittimi si applicano le tutele previste dall’art. 18 della
legge n. 300 del 1970 (anche a quelli intimati dopo l’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012,
che ha cura di individuare, tra gli apparati sanzionatori contemplati dalla nuova versione della
norma statutaria, quello applicabile ad ogni singolo tipo di vizio: v. art. 1, comma 46), anche le
impugnazioni di tali recessi datoriali rientrano nell’àmbito di applicabilità del nuovo procedimento8.
Del resto, le esigenze di certezza e concentrazione dei tempi processuali che ispirano la nuova
disciplina processuale sussistono nella medesima intensità tanto se si tratta dell’impugnazione di un
licenziamento individuale, quanto nell’ipotesi di impugnazione di un licenziamento collettivo.
In considerazione della disposizione transitoria espressa dall’art. 1, comma 67, e secondo la
quale «i commi da 47 a 66 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge», si deve ritenere che, a decorrere dal 18 luglio 2012, debbono
essere proposte secondo il nuovo rito tutte le impugnazioni giudiziali di licenziamenti, anche quelle
relative a licenziamenti intimati prima di quella data, e tuttavia a condizione che si applichi il
regime previsto dal testo dell’art. 18 precedente alla novella del 2012.
In effetti, questo è un punto che merita di essere rimarcato: condizione affinché
l’impugnazione di un qualsiasi licenziamento (indipendentemente dal fatto che sia stato intimato
prima o dopo il 18 luglio 2012) sia soggetta al nuovo rito è il fatto che il recesso illegittimamente
adottato dal datore di lavoro sia sanzionato con una delle misure previste dall’art. 18 nel testo di tale
norma applicabile ratione temporis. Con la conseguenza che, se un licenziamento illegittimo
risalente ad epoca antecedente all’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 non rientra tra quelli
ai quali, secondo l’art. 18 all’epoca vigente, si applicava la tutela reale, la sua impugnazione andrà
proposta seguendo le comuni regole del rito codicistico del lavoro, anche se quella stessa fattispecie
sia oggi compresa tra quelle sanzionate dal nuovo testo dell’art. 18. L’esempio più notevole, in
proposito, è costituito dal licenziamento orale intimato, prima del 18 luglio 2012, da un datore di
lavoro che occupava meno di 16 dipendenti: non rientrando tale fattispecie di licenziamento
illegittimo nella sfera di applicabilità dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 nel testo vigente
all’epoca del compimento dell’atto, la sua impugnazione, diretta ad ottenere la tutela di diritto
comune, deve essere proposta seguendo la disciplina dettata dagli artt. 409 ss. c.p.c., a nulla
rilevando il fatto che, a seguito della novella del 2012, quella fattispecie dia luogo, oggi,
all’applicazione di una delle tutele previste dall’art. 18 (v., infatti, il nuovo primo comma di tale
norma)9.
8
Conforme L. CAVALLARO, op. cit., 2.
Diversa è l’impostazione di L. CAVALLARO, op. cit., 1, secondo il quale il nuovo testo dell’art. 18 funziona «come
norma processuale, preordinata all’individuazione delle controversie che vi debbono essere assoggettate: le quali
saranno tutte (e solo) quelle per le quali la nuova versione dell’art. 18 St. lav. prevede l’applicazione di qualcuna delle
sanzioni ivi previste per il caso d’invalidità del licenziamento, indipendentemente dal fatto che poi, in concreto, tale
disciplina sia applicabile ratione temporis». La tesi non sembra persuasiva: in primo luogo, essa è poco coerente con il
tenore letterale del comma 47 che fa riferimento alle impugnative dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’art. 18
della legge n. 300 del 1970 «e successive modificazioni», con ciò mostrando chiaramente di volersi riferire alle
controversie concernenti la legittimità di recessi datoriali ai quali si applica la norma dello Statuto dei lavoratori in una
qualsiasi delle sue versioni succedutesi nel corso del tempo; in secondo luogo, essa introduce un elemento di disarmonia
nel disegno del legislatore (mirante chiaramente a riservare il nuovo procedimento processuale ai licenziamenti
ricadenti nell’àmbito di applicabilità di qualcuna delle tutele assicurate dall’art. 18), ricomprendendo senza alcuna
ragione sistematica tra le cause soggette al nuovo rito anche alcune categorie di quelle nelle quali non si deve discutere
affatto dell’applicazione della predetta norma statutaria.
9
8
Il regime processuale introdotto dal legislatore del 2012 non si applica, poi, alle cause già
instaurate alla data del 18 luglio 2012, neppure per i gradi di giudizio promossi successivamente a
tale data. Infatti, la citata norma transitoria del comma 67 fa esplicito riferimento alle
«controversie» instaurate dopo l’entrata in vigore della legge n. 92 ed è indubbio che una causa che,
a quella data, risultasse già pendente in primo o secondo grado sia una controversia «già
instaurata», onde l’impugnazione contro la relativa sentenza (pronunciata dopo il 18 luglio 2012) va
proposta secondo le ordinarie regole dell’appello ex artt. 433 ss. c.p.c. e del ricorso per cassazione
ex artt. 360 ss. c.p.c., senza possibilità di integrare queste discipline codicistiche con quella dettata,
per quei gradi di giudizio, dai commi 58-66 dell’art. 1 della legge n. 92 del 2012.
Meno agevole è la soluzione della questione dell’applicabilità del nuovo rito alle
impugnazioni dei licenziamenti irrogati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni il cui
rapporto di lavoro sia stato contrattualizzato.
In effetti, a norma del comma 7 dell’art. 1 della legge n. 92, «le disposizioni della presente
legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono princìpi e criteri per la
regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in coerenza con quanto disposto
dall’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo». Ai sensi del successivo comma 8, poi,
«ai fini dell’applicazione del comma 7» il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione «individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità
e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche».
Il problema sta nello stabilire se le disposizioni della legge n. 92 la cui applicabilità ai rapporti di
lavoro dei dipendenti pubblici è condizionata all’adozione, da parte del Ministro per la pubblica
amministrazione, delle iniziative di cui al citato comma 8 siano tutte quelle contenute nella legge (e,
dunque, anche quelle relative al nuovo procedimento per l’impugnazione dei licenziamenti) ovvero
solamente quelle aventi ad oggetto la disciplina sostanziale del rapporto di lavoro.
Nel primo senso depone il riferimento, senza alcuna eccezione, alle «disposizioni della
presente legge» con il quale si apre il comma 7; nel secondo la qualificazione – espressa subito
dopo dallo stesso comma – di quelle disposizioni come princìpi e criteri «per la regolazione dei
rapporti di lavoro».
Pur nella consapevolezza del fatto che la formulazione dei commi 7 ed 8 è tale da rendere
opinabile qualsiasi proposta interpretativa, si ritiene preferibile la seconda delle opzioni enunciate.
Effettivamente, oltre al già segnalato dato testuale che sembra restringere l’area delle disposizioni
non immediatamente applicabili a quelle idonee a costituire principi regolativi dei rapporti di
lavoro, si deve aggiungere la considerazione, di natura sistematica, secondo la quale, rispetto alla
disciplina processuale dettata dai successivi commi 47-69, non sembra concepibile riconoscere uno
spazio di intervento al Ministro per la pubblica amministrazione per interventi di «armonizzazione».
In altri termini, l’estraneità delle norme processuali alla disciplina transitoria di cui ai commi 7 e 8
sembra confermata sia dal tenore letterale di quest’ultima, sia dalla sua incompatibilità “ontologica”
con una normativa di natura processualcivilistica, per sua natura tendenzialmente uniforme per tutte
le controversie aventi ad oggetto rapporti contrattuali della stessa natura (altrimenti detto: mentre è
comprensibile che il recesso della pubblica amministrazione sia regolato da norme diverse da quelle
che disciplinano l’analogo atto dei datori di lavoro privati10, non altrettanto può dirsi a proposito
della disciplina processuale delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti11.
Il fatto che, seguendo l’impostazione qui propugnata, finiscono con l’essere regolate dai
commi 47-69 dell’art. 1 della legge n. 92 anche impugnazioni di licenziamenti (come quelli intimati
ai dipendenti pubblici) ancora soggetti (fino all’adozione dei provvedimenti previsti dal comma 8)
10
E, infatti, così è sempre stato. Ci si permette, al riguardo, di rinviare a P. SORDI, Licenziamenti/IV) Impiego pubblico
privatizzato, in Enc. giur. Treccani, Roma, 2002.
11
E, infatti, nonostante le profonde differenze di disciplina sostanziale tra rapporto di lavoro subordinato nel settore
privato e impiego pubblico “contrattualizzato”, la disciplina processuale è sempre stata uniforme, salvo che per aspetti
del tutto marginali (v. artt. 413, quinto comma, e 417-bis, c.p.c.).
9
all’art. 18 nel testo precedente a quello riformato dal legislatore del 2012, non costituisce un
ostacolo all’accoglimento della tesi. Si è già visto, infatti, come il nuovo rito processuale si applichi
comunque a controversie aventi ad oggetto la legittimità di licenziamenti intimati prima del 18
luglio 2012 e, quindi, disciplinati dal precedente testo dell’art. 18 legge n. 300 del 1970.
L’applicazione della nuova procedura è condizionata, dunque, dall’oggetto della domanda
così come prospettata dal ricorrente. Può darsi che costui invochi una delle tutele ex art. 18
deducendo una fattispecie sostanziale alla quale quelle tutele sono sicuramente estranee. Può farsi,
al riguardo, il caso del lavoratore assunto a termine che, eccependo la nullità del termine, chieda la
conversione del rapporto e la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro ai
sensi dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970. Quest’ultima domanda – seppur chiaramente
infondata in diritto – è altrettanto sicuramente ammissibile anche se proposta seguendo il nuovo rito
speciale (ovviamente dovrà essere rigettata dal giudice senza necessità di alcuna attività istruttoria
circa la validità o meno del termine apposto al rapporto)12. Analoga conclusione vale nel caso in cui
il lavoratore assunto in prova invochi l’applicazione dell’art. 18 deducendo l’illegittimità del
recesso, per l’inadeguata durata della prova o l’esistenza di un motivo illecito, ipotesi nella quale la
giurisprudenza di legittimità esclude l’applicabilità della norma statutaria13. O, ancora, nell’ipotesi
in cui il lavoratore, deducendo un vizio delle dimissioni da lui rassegnate, chieda la condanna del
datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro, tutela appunto inapplicabile a tale
fattispecie.
2.2. Le azioni di accertamento promosse dal datore di lavoro. – Com’è noto, si ammette
che, tutte le volte in cui ricorra il necessario interesse ad agire, il datore di lavoro possa promuovere
un giudizio chiedendo l’accertamento della legittimità del proprio recesso14 (e addirittura anche che
il datore di lavoro, ancor prima di recedere dal rapporto, possa chiedere che determinati
comportamenti posti in essere dal lavoratore integrino gli estremi della giusta causa o del
giustificato motivo di licenziamento15). Tali domande, che, in generale, restano ammissibili anche
dopo l’introduzione, da parte del legislatore, di uno specifico rito per le controversie in materia di
licenziamenti, continueranno a dover essere proposte secondo le comuni regole dettate dagli artt.
409 ss. c.p.c. Infatti il nuovo rito è previsto espressamente per le sole cause aventi ad oggetto
«l’impugnativa» dei licenziamenti (art. 1, commi 47 e 48) e tali non possono essere definite le
menzionate azioni di accertamento promosse dallo stesso datore di lavoro16.
Ovviamente, non si può escludere che, in simili casi, il lavoratore convenuto in giudizio
proponga a sua volta domanda riconvenzionale diretta ad ottenere, previa declaratoria
dell’illegittimità del licenziamento, l’applicazione di qualcuna delle tutele previste dall’art. 18 della
legge n. 300 del 1970. Tuttavia questa eventualità non sembra che possa rappresentare un valido
motivo per discostarsi dall’inequivoco tenore letterale della norma che, come detto, riserva il nuovo
rito alle sole azioni di impugnazione dei licenziamenti.
2.3. Il fallimento del datore di lavoro. – Circa i rapporti con la competenza del Tribunale
fallimentare stabilita dall’art. 24 del r.d. 16 marzio 1942, n. 267, va ricordato come, prima
dell’introduzione del nuovo rito per l’impugnativa dei licenziamenti, la giurisprudenza di legittimità
12
Conforme A. VALLEBONA, La riforma del lavoro, Giappichelli, 2012, 73.
Cass., 17 novembre 2010, n. 23231; Cass., 18 novembre 1995, n. 11934.
14
Cass., 9 maggio 2012, n. 7096; Cass., 14 luglio 1998, n. 6891; Cass., 15 gennaio 1996, n. 279, in Giur. it., 1996, I, 1,
1054.
15
Cass., 26 maggio 1993, n. 5883, in Giust. civ., 1993, I, 2661.
16
Contra, L. DE ANGELIS, op. cit., 14, sulla base della considerazione che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
simili azioni sono proponibili dal datore di lavoro a condizione che il licenziamento sia stato impugnato; l’argomento
non sembra pertinente, poiché in questi casi si tratta dell’impugnazione (ritenuta dalla giurisprudenza necessaria perché
possa considerarsi sussistente l’interesse ad agire del datore di lavoro) stragiudizialmente proposta dal lavoratore e
l’unica azione giudiziale che si riscontra è quella del datore di lavoro che, come detto nel testo, non può essere in alcuna
maniera essere qualificata come «impugnativa di licenziamento».
13
10
affermava la persistente competenza del giudice del lavoro a decidere della domanda del lavoratore
diretta ad ottenere, previa dichiarazione dell’illegittimità o dell’inefficacia del licenziamento, la
reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, in quanto tale
domanda non è configurabile come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul
patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull’interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione
all’interno dell’impresa fallita, sia per l’eventualità della ripresa dell’attività lavorativa
(conseguente all’esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell’azienda, o a un concordato
fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei
all’esigenza della par condicio creditorum17.
È evidente che la nuova articolazione delle tutele contro il licenziamento illegittimo propria
dell’attuale versione dell’art. 18 impone qualche precisazione al riguardo.
In effetti, l’applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza ora richiamata dovrebbe
comportare il riconoscimento della persistente competenza del giudice del lavoro a conoscere della
domanda di reintegrazione nel posto di lavoro; spetterebbe invece al tribunale fallimentare la
competenza a decidere sulle domande aventi ad oggetto la concessione della semplice tutela
indennitaria o comunque il pagamento delle retribuzioni conseguenti al licenziamento illegittimo,
tutti casi in cui l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento costituisce solo la premessa
logico-giuridica della decisione relativa al pagamento delle somme spettanti al lavoratore. Il
problema scaturente dalla nuova articolazione del sistema di tutela contro il licenziamento
illegittimo sta, evidentemente, nel fatto che – contrariamente al regime previgente – il tipo di vizio
riconosciuto dal giudice non è indifferente rispetto al titolo di tutela da accordare al lavoratore, il
quale, pertanto, potrà essere costretto – anche al fine di evitare il maturare della decadenza di cui
all’art. 6 della legge n. 604 del 1966 – ad impugnare il medesimo recesso datoriale sia davanti al
giudice del lavoro (denunciando in quella sede qualcuno dei vizi previsti dai commi primo,
secondo, terzo, quarto e settimo, primo e secondo periodo, dell’art. 18, ovvero del comma 5, primo
e terzo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223), sia davanti al tribunale fallimentare (facendo
valere qualcuno degli altri vizi indicati nelle due predette norme).
2.4. Le questioni relative alla qualificazione del rapporto. – Il citato comma 47 precisa che
il nuovo rito deve essere esperito anche nei casi in cui, per decidere sulla domanda relativa
all’impugnativa del licenziamento, «devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del
rapporto di lavoro». La norma, evidentemente, intende riferirsi ai casi in cui, a fronte di una
qualificazione formale del rapporto come lavoro autonomo18, il prestatore ne deduca la natura
subordinata e su tale presupposto qualifichi il recesso della controparte come licenziamento
soggetto all’applicazione dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970.
Ci si può chiedere se rientri in tale ipotesi anche il caso in cui il lavoratore somministrato
denunci l’irregolarità della somministrazione ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Che in questa fattispecie non si ponga una questione di qualificazione del
rapporto (pacificamente di natura subordinata, indipendentemente dalla regolarità o meno della
somministrazione) è constatazione tanto esatta quanto ininfluente al fine di verificare l’applicabilità
o meno del nuovo rito, posto che ciò che è decisivo è il tipo di domanda formulata dal lavoratore: se
è chiesta l’applicazione di una delle tutele previste dall’art. 18, il ricorso ex legge n. 92 sarà
ritualmente proposto (anche se eventualmente infondato), in caso contrario, no. E tale conclusione
vale, più in generale, in tutti i casi in cui si faccia questione di imputazione del rapporto di lavoro
(come, ad esempio, quando il lavoratore deduca che il rapporto, formalmente imputato ad
un’azienda, in realtà deve essere ricondotto ad un gruppo di imprese).
17
Cass., 29 marzo 2011, n. 7129; Cass., sez. un., 10 gennaio 2006, n. 141, in Giust. civ., 2007, I, 12349; Cass., 27
febbraio 2004, n. 4051, in Riv. it. dir. lav., 2005, II, 242.
18
O altre simili fattispecie, come quella del fittizio contratto di associazione in partecipazione.
11
Al riguardo è importante sottolineare come la norma non parli di “domande” relative alla
qualificazione del rapporto, bensì di “questioni”. Ciò dovrebbe indurre a ritenere che, anche in
simili casi, la domanda sul merito della quale, nel giudizio regolato dal nuovo rito, il giudice può
pronunciare è pur sempre solamente quella relativa alla pretesa illegittimità del licenziamento e alle
conseguenze di tale illegittimità. Così come dovrebbe ritenersi che il lavoratore, nella controversia
soggetta al nuovo rito, possa formulare esclusivamente tali domande, onde se, nel ricorso proposto
ai sensi dell’art. 1, comma 48, della legge n. 92 del 2012, il prestatore proponga anche una domanda
diretta ad ottenere una pronuncia di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro
intercorso con l’impresa, il giudice dovrà dichiararla inammissibile19.
In sostanza, quella della natura giuridica del rapporto tra le parti è solamente una delle tante
questioni che il giudice dovrà risolvere per pervenire alla decisione su quella che resta l’unica
domanda sul merito della quale egli può statuire e, cioè, la domanda concernente la legittimità o
meno del licenziamento. Ed allora, nel caso in cui il Tribunale, pur convincendosi – nonostante la
diversa qualificazione sostenuta dall’azienda – della natura subordinata delle prestazioni di lavoro
eseguite dal ricorrente, concluda tuttavia per la legittimità del recesso datoriale, l’unica pronuncia
che potrà emettere sarà quella del rigetto del ricorso, senza possibilità di statuire alcunché circa la
natura del rapporto.
2.5. Le domande fondate sugli identici fatti costitutivi. – Il comma 48, peraltro, dispone che
con il ricorso possono essere proposte, oltre alle domande relative all’impugnativa del
licenziamento, anche quelle «che siano fondate sugli identici fatti costitutivi».
Occorre pertanto precisare cosa debba intendersi per «identici fatti costitutivi» e, in
particolare, se il citato comma 48 consenta di proporre solamente le domande che annoverino nella
loro fattispecie costitutiva tutti i fatti costitutivi della domanda diretta ad ottenere la concessione
della tutela di cui all’art. 18 della legge n. 300 del 1970 azionata dal lavoratore nel proprio ricorso
oppure se siano ammissibili anche le domande nella cui fattispecie costitutiva rientrino (non tutti,
ma) solamente alcuni dei fatti costitutivi della domanda di impugnativa del licenziamento.
Ad esempio, il lavoratore che deduca che il rapporto intercorso con l’azienda, formalmente
qualificato come autonomo, avesse invece natura di lavoro subordinato e che il recesso della
controparte (da qualificare conseguentemente come licenziamento) fosse privo di giusta causa e di
giustificato motivo, può proporre, contestualmente alla domanda diretta ad ottenere una delle tutele
previste dall’art. 18, anche una domanda di condanna dell’azienda al pagamento della tredicesima
mensilità e del t.f.r., domande fondate appunto sulla natura subordinata delle prestazioni lavorative
da lui eseguite? Tra i fatti costitutivi di queste altre domande rientrano non tutti quelli sui quali si
fonda l’impugnativa di licenziamento (rappresentati da: pregresso rapporto di lavoro subordinato,
recesso dal rapporto da parte dell’imprenditore, vizio di tale recesso), ma solamente uno di essi (il
pregresso rapporto di lavoro subordinato). È evidente, dunque, che la risposta all’interrogativo circa
l’ammissibilità o meno di simili domande sarà diversa a seconda che si ritenga che l’art. 1, comma
48, della legge n. 92 del 2012, nel pretendere l’identità dei fatti costitutivi, richieda che la domanda
diversa da quella di impugnativa del licenziamento comprenda, tra i suoi fatti costitutivi, tutti quelli
sui quali si fonda l’impugnativa del recesso datoriale, ovvero che sia sufficiente che ne ricorra
almeno uno.
Orbene, si deve riconoscere che probabilmente la formulazione letterale della disposizione
(«identici» fatti costitutivi) potrebbe giustificare la soluzione maggiormente rigorosa, quella, cioè,
che ammette solamente le domande che annoverino tra i propri fatti costitutivi tutti e solamente
19
Nel senso che, invece, il lavoratore possa proporre una vera e propria domanda di accertamento della natura
subordinata del rapporto, tutte le volte in cui essa sia strumentale alla richiesta di applicazione dell’art. 18 della legge n.
300 del 1970, D. BORGHESI, op. cit., 912.
12
quelli sui quali si fonda la domanda con la quale il lavoratore chiede l’applicazione dell’art. 18 della
legge n. 300 del 197020.
Però una simile impostazione finisce per sacrificare oltre ogni ragionevole limite le più
elementari esigenze di economia processuale. Si pensi al caso in cui il ricorrente chieda
l’applicazione di qualcuna delle tutele contemplate dai commi dal quarto al settimo dell’art. 18 e, in
via subordinata – ove non risultasse l’esistenza del requisito dimensionale previsto dall’ottavo
comma dello stesso art. 18 – la concessione della tutela di cui all’art. 8 della legge n. 604 del 1966;
in un simile caso, il giudice che, pur riconoscendo l’esistenza del vizio del licenziamento
denunciato dal lavoratore, ritenga che l’impresa occupi meno di sedici dipendenti, non potrebbe
emanare i provvedimenti previsti dall’art. 8 della legge n. 604 appunto perché – ove si dovesse
ritenere che, a seguito della riforma dell’art. 18, il requisito dimensionale sia divenuto fatto
costitutivo del diritto del lavoratore illegittimamente licenziato ad una delle tutele in oggetto – la
relativa domanda sarebbe inammissibile in quanto non fondata su tutti i fatti costitutivi di quella
svolta ex art. 18 legge n. 300 del 1970 (difettando, appunto, quello rappresentato dal requisito
dimensionale).
Maggiormente convincente è, pertanto, un’interpretazione dell’art. 1, comma 48, della legge
n. 92 del 2012, che contemperi adeguatamente le due esigenze in gioco: da un lato, come detto,
quella di evitare uno spreco di attività processuale, dall’altro, quella di tener ferma la ratio
fondamentale del nuovo rito, che è quella di fornire una risposta più tempestiva possibile alle
questioni connesse con la legittimità o illegittimità di un licenziamento non accettato dal
dipendente. In questa prospettiva non è sostenibile neppure un’impostazione che consenta la
proposizione, nel nuovo procedimento delineato dal legislatore del 2012, di qualsiasi domanda
(diversa da quella relativa alle tutele previste dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970) che
comprenda, tra i propri fatti costitutivi, anche uno soltanto dei fatti sui quali si fonda la domanda ex
art. 18. In questa maniera, infatti, l’oggetto del giudizio sarebbe suscettibile di ampliamenti tali da
coincidere, o quasi, con l’intera gamma delle controversie ipotizzabile a proposito di un rapporto di
lavoro cessato ad iniziativa del datore di lavoro. Con il rischio, facilmente pronosticabile,
dell’impossibilità – anche per gli uffici giudiziari maggiormente virtuosi – di rispettare i termini
processuali previsti dal legislatore e la compromissione dell’obiettivo principale perseguito
mediante l’introduzione del nuovo rito. Si aggiunga che contro l’interpretazione che si contesta
depone anche la disposizione dell’art. 1, comma 65, della legge n. 92 del 2012 (sulla quale v., infra,
n. 13) a norma della quale alla trattazione delle controversie in oggetto debbono essere riservati
particolari giorni nel calendario delle udienze. È evidente, infatti, che una simile previsione
presuppone che la categoria di cause destinatarie della “corsia preferenziale” sia composta da un
numero ristretto di controversie, pena la sua sostanziale inutilità.
Orbene, al fine di individuare la soluzione maggiormente soddisfacente, si potrebbe
prendere le mosse dalla constatazione che i fatti costitutivi delle domande che invocano
l’applicazione dell’art. 18 nella versione introdotta dalla legge n. 92 del 201221 possono essere
ricondotti a due categorie: da un lato, quelli che sono costitutivi di ognuna delle quattro forme di
tutela (cc.dd. “reintegrazione piena”, “reintegrazione attenuata”, “tutela indennitaria forte”, “tutela
indennitaria debole”) previste dall’art. 18, dall’altro quelli che sono costitutivi solamente di uno (o
alcuni) di quei quattro tipi di tutela. Il primo dei predetti due gruppi di fatti costitutivi è composto
da (1) la sussistenza di un pregresso rapporto di lavoro subordinato e (2) un recesso datoriale
20
Secondo L. DE ANGELIS, op. cit., 14, deve ritenersi insufficiente «una identità solo parziale dei fatti costitutivi».
È vero che, come detto in precedenza nel testo, il nuovo rito per l’impugnativa dei licenziamenti deve essere seguito
anche in caso di impugnazione di recessi datoriali precedenti al 18 luglio 2012 e ai quali, quindi, si applica (non
l’attuale, bensì) la vecchia versione dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970. Tuttavia il discorso verrà svolto con
riferimento al nuovo testo della norma statutaria, essendo l’applicazione della precedente testo destinata a divenire
sempre più residuale con l’andar del tempo, fino a scomparire del tutto tra non molto. Si vedrà, comunque (infra, nota
23), come la soluzione raggiunta rispetto al vigente testo dell’art. 18 sia applicabile anche alle controversie relative ai
licenziamenti risalenti ad epoca precedente all’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012.
21
13
viziato; invero, questi due fatti sono richiesti dall’ordinamento perché possa essere accordata una
qualunque tra le quattro tutele contemplate dall’art. 18; mancando uno di essi, nessuna di quelle
tutele può aver corso. Al secondo gruppo appartengono, invece, quei fatti che sono richiesti
esclusivamente per l’applicazione di una o più (e, comunque, non tutte) di quelle tutele. Ad
esempio: il motivo illecito determinante o gli altri motivi di nullità di cui al primo comma (richiesti
esclusivamente per la concessione della tutela reintegratoria piena); l’insussistenza del fatto
contestato o la previsione dello stesso fra le mancanze punibili con una sanzione conservativa
(previsto soltanto per la “reintegrazione attenuata”); il requisito dimensionale di cui all’ottavo
comma dell’art. 18 (necessario solamente per le tutele di cui ai commi dal quarto al settimo); e così
via22.
Ed allora potrebbe ritenersi che i fatti costitutivi che debbono essere «identici» siano
solamente quelli appartenenti alla prima delle due categorie sopra menzionate. Vale a dire che con il
ricorso ex art. 1, comma 48, legge n. 92 del 2012 con il quale il lavoratore impugna il
licenziamento, egli potrà proporre anche le domande che, al pari di quelle ex art. 18 legge n. 300 del
1970, riconoscano tra i propri fatti costitutivi sia il preesistente rapporto di lavoro subordinato, sia
l’illegittimità del licenziamento23; ciò pur se la fattispecie costitutiva di tali ulteriori domande, da un
lato, comprenda anche fatti ulteriori rispetto a quelli richiesti per la concessione delle tutele previste
dall’art. 18 e, dall’altro, non includa tutti gli altri fatti costitutivi della domanda svolta dal ricorrente
in riferimento all’art. 18 (cioè quelli ulteriori rispetto alla preesistenza di un rapporto di lavoro
subordinato e al licenziamento viziato).
Ad esempio, debbono essere considerate ammissibili ex art. 1, comma 48, legge n. 92 del
2012: la domanda, proposta in via subordinata, di concessione della tutela di cui all’art. 8 della
legge n. 604 del 1966 in caso di mancato accertamento del requisito dimensionale stabilito per
l’applicazione dell’art. 18 legge n. 300 del 197024; la domanda di risarcimento dei danni ulteriori
22
Deve pertanto essere rimeditata la massima giurisprudenziale secondo cui fatti costitutivi del diritto soggettivo del
lavoratore a riprendere l’attività e, sul piano processuale, dell’azione di impugnazione del licenziamento siano
esclusivamente l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l’illegittimità dell’atto espulsivo (Cass., sez. un., 10
gennaio 2006, n. 141, in Giust. civ., 2007, I, 1239, seguita dalla successiva giurisprudenza di legittimità). Tale
impostazione, infatti, era coerente con un sistema di tutela contro il licenziamento illegittimo (quello proprio
dell’originaria versione dell’art. 18) caratterizzato dal fatto che le conseguenze erano le stesse (il diritto soggettivo del
lavoratore a riprendere l’attività di cui parla la massima citata) quale che fosse il vizio che affliggesse il recesso
datoriale. Non altrettanto può dirsi a proposito del sistema di tutele attualmente vigente, in base al quale sono
individuabili quattro “diritti soggettivi” (tra loro alternativi) del lavoratore illegittimamente licenziato, ognuno dei quali
deve dunque avere una sua propria specifica fattispecie costitutiva idonea a distinguerlo dagli altri.
23
Una simile conclusione è utilizzabile anche nelle controversie concernenti i licenziamenti intimati prima del 18 luglio
2012, appunto perché rispetto ad essi, la giurisprudenza affermava che i fatti costitutivi della tutela offerta dal vecchio
art. 18 della legge n. 300 del 1970 sono appunto l’esistenza di un rapporto subordinato e un licenziamento viziato (v. la
precedente nota 21).
24
Conformi A. VALLEBONA, op. cit., 73; L. CAVALLARO, op. cit., 7. In proposito si può anzi ricordare come,
secondo la giurisprudenza formatasi nel previgente regime di tutela contro i licenziamenti illegittimi, proposta dal
lavoratore una domanda di reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, tale
petitum doveva ritenersi comprensivo di quello concernente il riconoscimento della minore tutela di cui all’art. 8 della
legge n. 604 del 1966, con la conseguenza che non violava il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato
la sentenza con la quale il giudice, ritenendo carenti le condizioni per l’operatività dell’invocata tutela reale,
condannava il datore di lavoro alla riassunzione del lavoratore o, in alternativa, a corrispondergli l’indennità di cui al
citato art. 8 (Cass., 9 settembre 1991, n. 9460). In un’analoga prospettiva, si è affermato, in tema di inefficacia del
licenziamento, che, se il dipendente illegittimamente licenziato aveva chiesto l’applicazione dell'art.18 della legge n.
300 del 1970, e quindi anche il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal giorno in cui il
licenziamento ha trovato attuazione, il giudice, accertato che non sussistono i requisiti dimensionali per l’applicazione
dell’art. 18, doveva accordare, sussistendo i relativi presupposti, la tutela in tal caso applicabile (dichiarazione di
inefficacia del licenziamento e risarcimento del danno), essendo tale tutela omogenea e di ampiezza minore rispetto a
quella prevista dall’art. 18 (Cass., 11 settembre 2003, n. 13375, in Foro it., 2003, I, 3321). Ovvero che non era
ravvisabile mutamento della causa petendi nell’ipotesi in cui il dipendente che aveva impugnato il licenziamento,
deducendone la illegittimità per mancanza di giustificato motivo, proponeva con ricorso introduttivo domanda di tutela
reale, mentre, in sede di precisazione delle conclusioni, richiedeva quella obbligatoria, in quanto, in detta ipotesi, il
14
(ad esempio, alla salute o all’onore) rispetto a quelli che debbono ritenersi coperti dalle indennità
risarcitorie contemplate dai commi dal quarto al settimo dell’art. 1825; la domanda del dirigente
volta ad ottenere l’indennità prevista dal contratto collettivo per ingiustificatezza del licenziamento
e proposta subordinatamente al mancato accoglimento della domanda di reintegrazione per la natura
discriminatoria del recesso datoriale; la domanda, formulata in via subordinata rispetto a quella
principale di illegittimità del licenziamento per difetto di giusta causa, diretta alla condanna al
pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, previa la riqualificazione del recesso datoriale
come licenziamento per giustificato motivo26.
Non è invece proponibile con il ricorso ex art. 1, comma 48, la domanda diretta ad ottenere
la condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive, neppure se scaturenti dalla
diversa qualificazione del rapporto (in termini di subordinazione invece che di autonomia, come
formalmente risultante)27; né quella di pagamento del t.f.r. (considerato che il fatto costitutivo di
tale credito è l’estinzione del rapporto di lavoro in sé e per sé considerata, indipendentemente dalla
parte che abbia assunto l’iniziativa di risolvere il rapporto e, nel caso in cui sia stato il datore di
lavoro, dalla legittimità o meno del licenziamento). Identica conclusione vale per un’altra ipotesi
prospettata in dottrina, quella del lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto che
impugni il licenziamento assumendo che la malattia sia stata determinata da un comportamento
colposo del datore di lavoro posto in violazione dell’art. 2087 c.c. e che contestualmente proponga
anche domanda di risarcimento dei danni biologico e morale; infatti, tra i fatti costitutivi di questa
seconda domanda non rientra l’illegittima risoluzione del rapporto ad iniziativa del datore di
lavoro28.
2.6. La contemporanea pendenza di cause aventi ad oggetto diritti del lavoratore diversi da
quelli derivanti dall’illegittimità del licenziamento. – Ovviamente, mentre per le domande dirette ad
ottenere la concessione delle tutele di cui all’art. 18 della legge n. 300 del 1970 debbono
necessariamente essere proposte secondo le regole del nuovo rito, l’introduzione, nella controversia
regolata dalle nuove disposizioni delle domande che si fondano sugli identici fatti costitutivi
rappresenta il frutto di una scelta meramente discrezionale del lavoratore, come reso evidente dal
predicato verbale («possono») utilizzato. Tornando agli esempi già prospettati, nulla impedisce al
lavoratore di proporre un ricorso ex legge n. 92 del 2012 deducendo che il datore di lavoro
occupava più di 15 dipendenti e chiedendo solamente l’applicazione di qualcuna delle tutele
previste dall’art. 18 e un altro ricorso, questa volta ai sensi dell’art. 414 c.p.c., diretto ad ottenere la
concessione della tutela offerta dall’art. 8 della legge n. 604 del 196629 oppure la condanna del
datore di lavoro al risarcimento del danno alla salute causato dal licenziamento illegittimo.
Più in generale, deve dirsi che l’introduzione nell’ordinamento processualcivilistico di un
rito riservato alle impugnazioni dei licenziamenti rende concreta un’eventualità che in precedenza
mutamento riguardava solo gli effetti ricollegabili alla tutela richiesta da ultimo, che sono compresi in quelli cui dà
luogo la tutela originariamente invocata (Cass., 27 agosto 2003, n. 12579; Cass., 19 novembre 2001, n. 14486); così
come doveva ritenersi ammissibile la domanda, proposta per la prima volta in appello dal lavoratore illegittimamente
licenziato, diretta ad ottenere la riassunzione ex art. 8 della legge n. 604 del 1966, ove in primo grado il lavoratore
medesimo avesse proposto la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18, atteso che la prima doveva
ritenersi compresa, come minus, in quest’ultima (Cass., 11 settembre 1997, n. 8906, in Foro pad., 1998, I, 10).
Insomma, dalla pregressa giurisprudenza emerge con nettezza l’impostazione secondo la quale la domanda di
concessione della tutela assicurata dall’art. 18 conteneva implicitamente anche quella di minore intensità prevista
dall’art. 8.
25
Conformi, D. BORGHESI, op. cit., 912, e L. CAVALLARO, op. cit., 5. Contra, A. VALLEBONA, op. cit., 74.
26
Conforme, L. CAVALLARO, op. cit., 5.
27
Conforme A.VALLEBONA, op. cit., 74. Invece, nel senso dell’ammissibilità di simili domande, v. D. BORGHESI,
op. cit., 912, e G. BENASSI,op. cit., 752.
28
Contra, G. BENASSI, op. cit., 753.
29
Ammesso che non si possa ancora ritenere valido il pregresso orientamento della giurisprudenza di legittimità di cui
si è dato conto nella nota 22 e secondo il quale la domanda di applicazione della tutela ex art. 18 legge n. 300 del 1970
era implicitamente comprensiva della richiesta della minore tutela di cui all’art. 8 della legge n. 604 del 1966.
15
(quando, cioè, il lavoratore poteva azionare con lo stesso ricorso sia diritti connessi all’illegittimità
del licenziamento, sia qualsiasi altro diritto derivante dal rapporto di lavoro) ben difficilmente si
verificava nella pratica: quella della contemporanea pendenza di due cause tra le parti di un
rapporto di lavoro aventi ad oggetto rivendicazioni relative a diritti diversi scaturenti tutti da quel
rapporto: una nella quale il lavoratore chiede l’applicazione di qualcuna delle tutele previste
dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970, l’altra nella quale il medesimo lavoratore chiede la
condanna dello stesso datore di lavoro all’adempimento di qualcuno dei debiti scaturenti dal
rapporto di lavoro (pagamento di differenze retributive, compensi per lavoro straordinario, ecc.).
Simili evenienze sono normalmente ricondotte dalla giurisprudenza nell’àmbito di
applicabilità dell’istituto della continenza di cui all’art. 39 c.p.c. Precisamente, secondo il
consolidato orientamento della Corte di cassazione, la continenza ricorre non solo quando due cause
siano caratterizzate da identità di soggetti e di titolo e da una differenza quantitativa dell’oggetto,
ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono
prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di
alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae petendi, nonché
quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario
presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la
definizione del giudizio successivo, come nell’ipotesi in cui le contrapposte domande concernano il
riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla
soluzione di una o più questioni comuni30.
Il rimedio previsto dall’art. 39, secondo comma, c.p.c., com’è noto, è quello secondo cui, se
(come nelle ipotesi che qui ci interessano) il giudice preventivamente adito sia competente anche
per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e
fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al primo giudice. L’ordinamento,
cioè, predispone un meccanismo perché le cause siano concentrate davanti al medesimo giudice e si
realizzi così il simultaneus processus.
Orbene, la norma del codice di rito appena richiamata non è applicabile alle fattispecie di cui
qui si tratta, essendo incompatibile con la disciplina specificamente dettata dalla legge n. 92 per il
caso in cui nel giudizio di opposizione all’ordinanza che ha definito la prima fase siano proposte
anche domande estranee al nuovo rito. In simili casi, infatti, il comma 56 (sul quale v., amplius,
infra, n. 6) impone la separazione delle cause. La disciplina specifica del nuovo rito, dunque,
prevede espressamente che domande ex art. 18 legge n. 300 del 1970 e domande a queste estranee
(seppur fondate sullo stesso rapporto contrattuale) non possano essere trattate e decise in un unico
contesto neppure quando siano state proposte dalle stesse parti nel medesimo giudizio. È evidente,
pertanto, che non può ritenersi compatibile con un simile procedimento un meccanismo (quello
definito dall’art. 39, secondo comma, c.p.c.) diretto, al contrario, a concentrare in un unico processo
cause originariamente proposte separatamente.
Per analoghe ragioni non è neppure ipotizzabile, nel caso in cui le due controversie pendano
davanti allo stesso giudice nello stesso stato e grado di giudizio, una loro riunione ai sensi dell’art.
151, primo comma, disp. att. c.p.c.
La conseguenza di quanto detto è, dunque, che le diverse cause (quella di impugnazione del
licenziamento e quella avente ad oggetto diritti fondati su fatti costitutivi non identici)
proseguiranno autonomamente.
Si deve peraltro segnalare come, con riferimento alla previsione dell’art. 702-ter c.p.c. che
prevede un’analoga deroga al principio generale del simultaneus processus nel caso in cui nel
procedimento sommario di cognizione sia proposta una domanda riconvenzionale che non possa
essere decisa con il rito sommario, la dottrina ha espresso l’avviso che, nei casi in cui la domanda
principale e quella riconvenzionale siano legate da connessione forte o per pregiudizialità, il sistema
deve comunque garantire, a chi al richiede, coerenza fra le decisioni e, pertanto, si è ipotizzato che,
30
Cass., sez. un., 1° ottobre 2007, n. 20596, in Riv. dir. proc., 2008, 1759, nonché le coeve ordinanze nn. 20598-20600.
16
in tali casi, la necessità dell’istruzione non sommaria di una delle cause comporta per tutte il
mutamento del rito da sommario a cognizione piena31.
Trattasi, all’evidenza, di un’interpretazione correttiva della norma codicistica, che peraltro
può trovare un appiglio nella previsione del terzo comma dello stesso art. 702-ter c.p.c., secondo la
quale il giudice, se le difese delle parti richiedono una istruzione non sommaria, converte il rito.
Invero, anche le domande riconvenzionali sono riconducibili nell’ampia categorie delle difese delle
parti e dunque potrebbe sostenersi che, effettivamente, se sulla base di una valutazione complessiva
di domanda principale e domanda riconvenzionale il giudice si dovesse convincere della necessità
di un’istruzione non sommaria (e nella formazione di tale convinzione egli deve tener conto anche
dell’eventuale nesso di pregiudizialità-dipendenza che lega le due domande), ecco che il mutamento
del rito per entrambe le cause si rivela una misura del tutto coerente anche con la disciplina positiva
del procedimento sommario di cognizione32.
Non altrettanto potrebbe dirsi a proposito della disciplina del nuovo rito per le impugnative
dei licenziamenti, la quale non offre alcuno spunto in tal senso, onde l’interprete dovrebbe
rassegnarsi all’idea che il legislatore abbia scientemente sacrificato sull’altare della rapidità
dell’accertamento giudiziale della legittimità dei licenziamenti anche esigenze fondamentali in un
ordinato svolgimento dei rapporti tra privati qual è quella di evitare decisioni giudiziali contrastanti
circa l’esistenza o meno di diritti e rapporti giuridici.
Su tale questione si rimanda a quanto esposto nel paragrafo 10.
3. La fase “urgente”: a) l’introduzione della causa.
3.1. La competenza per territorio. – Dispone l’art. 1, comma 48, della legge n. 92 del 2012
che la domanda si propone con ricorso «al tribunale in funzione di giudice del lavoro». Anche se
nulla è specificato in ordine alla competenza per territorio, è indubbio che questa è regolata dall’art.
413 c.p.c.33, norma sicuramente compatibile con il nuovo rito e, anzi, di necessaria applicazione,
non potendosi tollerare lacune circa l’individuazione, sotto tutti i profili, del giudice competente a
decidere la causa.
3.2. Il ricorso. – Il ricorso deve avere i requisiti (non dell’art. 414, bensì) dell’art. 125 c.p.c.
Quindi il lavoratore deve indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e
le conclusioni, non anche i mezzi istruttori dei quali intende avvalersi.
Non si può sostenere l’opinione opposta sulla scorta della constatazione secondo cui, nei
fatti, il ricorso del lavoratore non potrà discostarsi dalle modalità di redazione previste dall’art. 414
c.p.c., pena il rischio che la domanda risulti generica o sfornita di prova e sul rilievo che il richiamo
ai poteri del giudice di cui all’art. 421 c.p.c. operato dal comma 49 costituirebbe una spia
dell’impossibilità per il giudice di sanare le decadenze derivanti dagli artt. 414 e 416 c.p.c.34.
Invero, quanto al primo argomento, non si vede per quale motivo il fatto che il lavoratore
(così come la sua controparte processuale) sia esonerato dalla necessità della deduzione delle
istanze istruttorie già nel suo primo scritto difensivo esporrebbe il ricorrente al rischio di vedersi
rigettare la domanda per carenza di prova, considerato che la parte – come si è visto – è
31
F.P. LUISO, Diritto processuale civile, IV, Giuffré, 2011, 119; G. BALENA, Il procedimento sommario di
cognizione, in Foro it., 2009, V, 331; S. MENCHINI, L’ultima “idea” del legislatore per accelerare i tempi della tutela
dichiarativa dei diritti: il processo sommario di cognizione, in Corr. giur., 2009, 1030. Sulla base della medesima
preoccupazione, in giurisprudenza è stata dichiarata l’inammissibilità di entrambe le domande: Trib. Biella, 9 febbraio
2010, in www.lexform.it.
32
Per un’analoga impostazione, v. A. CARRATTA, Procedimento sommario di cognizione (dir. proc. civ.), in Enc.
giur. Treccani, Roma, 2009, 5
33
Conformi L. DE ANGELIS, op. cit., 17; L. CAVALLARO, op. cit., 8.
34
G. PACCHIANA PARRAVICINI, op. cit., 756.
17
perfettamente legittimata a formulare le proprie istanze istruttorie in udienza e, ciò facendo, non
corre alcun rischio di soccombere per mancata indicazione dei mezzi istruttori.
Quanto al riferimento all’art. 421 contenuto nel comma 49, trattasi di disposizione del tutto
irrilevante al fine di appurare se anche i primi scritti difensivi delle parti nella prima fase del nuovo
procedimento siano o meno soggetti alle prescrizioni degli artt. 414 e 416 c.p.c., una volta che si
ammetta (come è doveroso: v., infra, n. 4) che esiste comunque un momento ultimo oltre il quale le
parti non possono avanzare richieste di ammissione di nuove prove.
Tanto chiarito, resta comunque la possibilità che il ricorso proposto dal lavoratore sia redatto
in maniera difforme rispetto al modello rappresentato dall’art. 125 c.p.c. In proposito, va ricordato
che, secondo la giurisprudenza, la mancanza di uno o più dei requisiti di cui all’art. 125 c.p.c. non
causa la nullità dell’atto, non comminata da alcuna disposizione di legge, salvo che non determini il
mancato raggiungimento dello scopo dell’atto di cui volta per volta si tratta35. Applicando quindi il
generale principio enunciato dall’art. 156 c.p.c. al ricorso in oggetto, può concludersi nel senso che
tale atto deve essere dichiarato nullo se privo delle indicazioni necessarie a rendere chiari petitum e
causa petendi, poiché in tal caso esso non è idoneo al raggiungimento del suo scopo, non potendo
né il convenuto difendersi adeguatamente, né il giudice essere in condizione di esercitare
efficacemente il suo potere di conduzione della lite.
Nulla deve però essere dedotto dal ricorrente circa l’eventuale periculum in mora, perché,
come già detto, non si tratta di un procedimento cautelare e la concessione o meno della tutela
prevista dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970 prescinde completamente dall’esistenza del rischio
che il diritto del lavoratore sia soggetto ad un imminente pregiudizio irreparabile.
Al deposito del ricorso ex legge n. 92 deve essere attribuito effetto impeditivo della
decadenza prevista dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966, se non altro perché tale ricorso è ormai
l’unica modalità di esercizio dell’azione di impugnativa del licenziamento consentita
dall’ordinamento.
3.3. Il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti. – A seguito della
presentazione del ricorso, il giudice deve emettere un decreto con il quale fissa l’udienza di
comparizione delle parti e il termine per la notificazione dell’atto introduttivo. Nessun termine è
imposto al giudice per la pronuncia di tale decreto (a differenza di quanto previsto dall’art. 415
c.p.c.). Tuttavia, poiché è stabilito che l’udienza debba essere fissata non oltre quaranta giorni dal
deposito del ricorso e che il termine per la notificazione di ricorso e decreto non possa essere
stabilito oltre il venticinquesimo giorno antecedente quello dell’udienza, è ovvio che il giudice
debba procedere nel più breve tempo possibile all’emanazione del decreto medesimo.
Come già accennato, l’udienza deve essere stabilita entro quaranta giorni dal deposito del
ricorso; è certo che tale termine non sia perentorio36, tale non essendo espressamente qualificato dal
legislatore, né potendosi desumere da alcuna altra disposizione una deroga alla regola generale (art.
152 c.p.c.) del carattere ordinatorio dei termini processuali.
Si è già detto di come, a differenza di quanto previsto dall’art. 415 c.p.c., non è la legge che
fissa il termine per la notificazione di ricorso e decreto, bensì lo stesso giudice, volta per volta, nel
proprio decreto, la norma limitandosi a stabilire che tale termine debba essere «non inferiore a
venticinque giorni prima dell’udienza»; tale non felicissima espressione deve necessariamente
essere intesa nel senso che il venticinquesimo giorno antecedente a quello dell’udienza costituisce il
limite massimo oltre il quale il giudice non può andare nell’individuare il termine ultimo assegnato
al ricorrente per la notificazione.
Infine, nello stesso decreto, il giudice assegna al convenuto un termine per la propria
costituzione. Anche qui, la norma si limita a disporre che tale termine non possa essere «inferiore a
cinque giorni prima» dell’udienza di comparizione delle parti.
35
36
Cass., 15 maggio 2002, n. 7055; Cass., 14 marzo 2001, n. 3695.
Conformi: L. CAVALLARO, op. cit., 8; A. BOLLANI, op. cit., 315.
18
Non è chiarissimo cosa il legislatore abbia voluto intendere con una simile espressione: che
la costituzione del convenuto debba avvenire non oltre il quinto giorno antecedente quello
dell’udienza oppure che tra la costituzione del resistente e il giorno dell’udienza debbano
intercorrere al massimo cinque giorni? Probabilmente l’intento era quello di far sì che il convenuto
abbia a disposizione almeno venti giorni (tra la data della notificazione – al massimo venticinque
giorni prima dell’udienza – e quella ultima utile per la costituzione tempestiva – cinque giorni
prima dell’udienza stessa –) per predisporre le proprie difese, analogamente a quanto accade nel rito
codicistico del lavoro per effetto del combinato disposto degli artt. 415, quinto comma, e 416,
primo comma. Ma l’espressione utilizzata dal legislatore per enunciare tale necessità non è
certamente perspicua. Si può allora ritenere che, aldilà di qualsiasi indagine circa l’esatto significato
da attribuire al testo legislativo, una prassi che sicuramente risulta rispettosa del dettato normativo –
sia sul piano sostanziale, sia su quello letterale – è quella di stabilire comunque, quale termine
ultimo per la costituzione del resistente, quello del quinto giorno antecedente l’udienza di
comparizione delle parti.
Non è previsto che il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti sia
comunicato al ricorrente (analogamente a quanto si ritiene valga per il decreto ex art. 415 c.p.c.37).
3.4. La notificazione del ricorso. – La notificazione deve essere eseguita dal ricorrente,
eventualmente anche a mezzo di posta elettronica certificata. Valgono, per il resto, tutte le ordinarie
regole che presiedono alla notificazione degli atti introduttivi di una lite, ivi incluso l’art. 151 c.p.c.
che attribuisce al giudice il potere di prescrivere che la notificazione sia eseguita in modo diverso da
quello stabilito dalla legge nel caso, tra gli altri, in cui sussistano «esigenze di maggiore celerità»,
ipotesi sicuramente ravvisabile nel procedimento in questione. Si deve comunque trattare di
modalità di notificazione idonee ad assicurare la trasmissione dell’integrale contenuto dell’atto
introduttivo, in ossequio al fondamentale principio del contraddittorio e del diritto di difesa del
convenuto.
Nelle controversie promosse contro pubbliche amministrazioni si applica sicuramente
l’ultimo comma dell’art. 415 c.p.c.
3.5. La costituzione del convenuto. – Nulla è detto circa le modalità della costituzione del
convenuto. Ma è ovvio che essa debba avvenire mediante deposito in cancelleria di memoria scritta.
Ciò, se non altro, almeno in attuazione del principio espresso dall’art. 416, secondo comma, c.p.c.,
sembrando eccessivo far discendere dal fatto che tale norma sia espressamente richiamata dal
comma 53 dello stesso art. 1 della legge n. 92 del 2012 per la costituzione del convenuto nella fase
di opposizione e non anche per il medesimo incombente nella fase “urgente”, la conclusione
secondo cui, in questa prima fase, il resistente pootrebbe costituirsi anche solo col ministero del
difensore, senza necessità di depositare alcun atto38.
La difesa in giudizio delle pubbliche amministrazioni è regolata, anche nelle controversie in
oggetto, dall’art. 417-bis c.p.c., norma sicuramente compatibile con la specialità del rito in
questione.
Circa il contenuto della memoria di costituzione, poiché la norma (ai commi 53-56)
disciplina le ipotesi della chiamata in causa di terzi e delle domande riconvenzionali solamente
quando tratta del giudizio di opposizione, dovrebbe concludersi nel senso (coerente con la natura
“urgente” della prima fase) che in questa fase simili iniziative siano precluse alla parte convenuta39.
Quanto, poi, all’onere (espressamente imposto al resistente dall’art. 416, terzo comma, c.p.c.) di
prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione circa i fatti
37
Cass., 5 marzo 2003, n. 3251.
Come sostenuto, invece, da G. TREGLIA, Brevi note sul nuovo processo per licenziamento introdotto dalla riforma
del mercato del lavoro, in Lav. giur., 2012, 766. Nel senso del testo G. BENASSI, op. cit., 753.
39
Conformi: D. BORGHESI, op. cit., 913; G. BENASSI, op. cit., 753; L. CAVALLARO, op. cit., 9.
38
19
affermati dal ricorrente, sembra superfluo discutere circa l’applicabilità o meno di tale onere anche
nel procedimento di cui si tratta, per la semplice ragione che la sua inosservanza non produce
conseguenze in rito, ma direttamente sul convincimento del giudice circa il merito della
controversia, anche in virtù del disposto dell’art. 115, primo comma, c.p.c. (e ciò, a maggior
ragione, in un giudizio a cognizione sommaria come quello costituito dalla prima fase del nuovo
rito, a cognizione, come si vedrà, sommaria).
3.6. Preclusioni e decadenze. – Nessuna decadenza è prescritta a carico né del ricorrente, né
del resistente con riferimento alla proponibilità di eccezioni40 e di istanze istruttorie.
Con specifico riferimento alle domande, pur restando ferma la regola generale secondo la
quale l’oggetto della domanda deve essere specificato già nell’atto introduttivo e non può essere
modificato nel corso del giudizio, si deve ammettere un’eccezione nel caso in cui il licenziamento
sia stato comunicato per iscritto, ma senza indicare la sua motivazione. Per tale vizio, infatti, il
nuovo sesto comma dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 prevede la modesta sanzione della
condanna del datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria variabile tra sei e dodici
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (c.d. “tutela indennitaria debole”); se nel corso del
giudizio emerga il motivo per il quale il datore ha receduto dal rapporto, sembra inevitabile
consentire al lavoratore di modificare di conseguenza le proprie conclusioni e di integrare le proprie
deduzioni in fatto e in diritto (oltre che, ovviamente, le istanze istruttorie), al fine di poter chiedere
la tutela (più intensa di quella indennitaria debole) corrispondente al motivo addotto dall’azienda a
giustificazione del licenziamento e indicato solamente in corso di causa.
Tale assunto discende dal disposto del citato sesto comma dell’art. 18, il quale, pur
prevedendo la ricordata tutela indennitaria in caso di licenziamento non motivato, aggiunge però
che si applicano le più intense tutele di cui ai commi quarto, quinto e settimo quando il giudice
«sulla base della domanda del lavoratore» accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del
licenziamento. Dunque il legislatore richiede che vi sia un’esplicita domanda del lavoratore in tal
senso (come, del resto, è inevitabile, sulla base dei generali principi che informano il nostro
processo civile). E tuttavia, considerata la pluralità e varietà dei vizi del recesso datoriale che danno
luogo all’una piuttosto che all’altra forma di tutela, sembra eccessivo pretendere, a pena di
inammissibilità, che il lavoratore formuli già nel ricorso la relativa domanda (con il collegato onere
di deduzione dei relativi fatti costitutivi in relazione ai quali, stante l’omissione della motivazione, il
lavoratore può avanzare solamente mere ipotesi).
L’unica prescrizione dettata dal legislatore del 2012 attiene alla produzione documentale,
l’ultimo periodo del comma 48 imponendo alle parti di depositare i documenti in duplice copia; è
tuttavia evidente che (anche per la mancata previsione di una qualsiasi sanzione) l’inosservanza di
tale prescrizione non produce alcuna decadenza in capo alle parti, sempre abilitate ad integrare la
loro produzione mediante il deposito della copia mancante del documento. Si aggiunga che, in ogni
caso, non sembra consentito desumere da tale disposizione l’onere per le parti, a pena di decadenza,
di produrre i documenti dei quali intendano avvalersi contestualmente al deposito del loro primo
scritto difensivo; la norma stabilisce semplicemente che, se le parti intendano produrre documenti,
debbono depositare due copie di ciascun documento, non anche che esse debbano necessariamente
depositare tutti i documenti unitamente al ricorso e alla memoria di costituzione.
4. segue: b) la trattazione e l’istruzione della causa.
40
Conforme L. CAVALLARO, op. cit., 9, il quale esclude giustamente la possibilità di applicare in via analogica l’art.
702-bis, quarto comma, ultimo periodo, c.p.c. Circa l’impossibilità di itnegrare la disciplina del nuovo rito ex legge n.
92 del 2012 con quella propria del rito sommario di cognizione, si rinvia a quanto detto in generale nel paragrafo 1.
20
4.1. La concentrazione della trattazione. – Il comma 49 dell’art. 1 della legge n. 92 del
2012 stabilisce che «il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili
richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, ai sensi dell’articolo 421 del codice di procedura civile».
Da questa scarna disposizione (ispirata, evidentemente, all’art. 669-sexies, primo comma,
c.p.c. in materia di procedimenti cautelari) sembra doversi desumere anzitutto che, pur mancando
un’esplicita precisazione al riguardo41, il legislatore abbia inteso delineare un procedimento nel
quale, ove possibile, la trattazione e l’istruzione della causa siano concentrate in un’unica udienza.
Ciò non significa che siano incompatibili con il nuovo rito adempimenti istruttori che richiedano
necessariamente un rinvio ad altra udienza o che simili rinvii siano comunque vietati; si vuole dire
semplicemente che, ove possibile, la trattazione deve essere concentrata nella stessa udienza di
comparizione delle parti.
Si potrebbe pertanto riproporre la questione relativa alla sussistenza o meno dell’onere per le
parti di citare i testimoni da essi indicati già alla prima udienza di comparizione che, con
riferimento alle controversie individuali di lavoro disciplinate dal rito codicistico, ha dato luogo a
contrastanti soluzioni da parte della giurisprudenza di legittimità42. Si deve tuttavia riconoscere che
l’opinione che postula l’esistenza dell’onere per le pari di intimare i testimoni a comparire già alla
prima udienza non sembra comunque compatibile con le specificità della disciplina del rito
introdotto dal legislatore del 2012 il quale, come visto, si caratterizza anche per il fatto che alle parti
non è imposto di dedurre, a pena di decadenza, tutte le loro istanze istruttorie già nei rispettivi primi
scritti difensivi; ed in un simile contesto non si vede davvero come possa addirittura ipotizzarsi che
le parti abbiano l’onere di citare per la prima udienza come testimoni persone che potrebbero
benissimo non aver indicato nel loro atto di costituzione oppure per rispondere a domande su
circostanze che, in quell’atto, non erano comprese tra quelle oggetto di richiesta di ammissione di
prova testimoniale. Si vuole dire che, alle obiezioni che, del tutto condivisibilmente, la dottrina ha
costantemente opposto al richiamato e più risalente orientamento della Suprema Corte43, si deve
aggiungere che, in ogni caso, esso non appare compatibile con un meccanismo processuale che
consente alle parti di indicare per la prima volta all’udienza di comparizione i mezzi istruttori dei
quali intendono avvalersi.
41
Invece espressamente prevista nella disciplina del procedimento sommario di cognizione: v. art. 702-ter, quinto
comma, c.p.c.
42
Il tradizionale orientamento secondo cui rientra tra i poteri del giudice del lavoro quello, previsto dall’art. 420, quinto
comma, c.p.c., di disporre, nell’udienza di discussione, l’ammissione e l’immediata escussione dei testi con la
conseguenza che grava su ciascuna delle parti l’onere di citare per tale udienza i testi di cui chiede l’ammissione e che
l’inosservanza di tale prescrizione è a causa di decadenza a carico della parte istante (Cass., 7 giugno 1995, n. 6368, in
Arch. loc., 1995, 814; Cass., 29 aprile 1994, n. 4161; Cass., 13 aprile 1987, n. 3681; Cass., 14 febbraio 1984, n. 1133)
appariva superato, dopo che Cass., 16 aprile 1997, n. 3275, in Giust. civ., 1997, I, 1795, si era espressa nel senso che nel
rito del lavoro vige il principio che il giudice provvederà nella stessa udienza di ammissione della prova testimoniale
alla audizione dei testi, comunque presenti, ma non potrà dichiarare decaduta la parte della prova per la mancata
presentazione di essi, essendogli consentito di poterli citare solo in forza del provvedimento di ammissione, con la
conseguenza che il giudice dovrà fissare altra udienza per la prosecuzione della prova. Tuttavia, più recentemente,
Cass., 8 aprile 2008, n. 9136, ha ribadito la validità dell’impostazione maggiormente risalente.
43
F.P. LUISO, Un opportuno ripensamento della Suprema Corte, in Giust. civ., 1997, I, 1795; G. IANNIRUBERTO, Il
processo del lavoro rinnovato, Cedam, 1999, 153; P. SANDULLI-A.M. SOCCI, Il processo del lavoro, Giuffré, 2000,
216; L. NEGRINI, Una soluzione ragionevole per il procedimento di assunzione della prova testimoniale nel rito del
lavoro, in Nuova giur. civ. comm., 1998, 241; F. CENTOFANTI, Intimazione dei testimoni nel rito del lavoro e
correlata decadenza dalla prova in prima udienza: la Cassazione innova nella continuità, in Mass. giur. lav., 1997,
658. Con riferimento al rito introdotto dalla legge n. 92 del 2012, L. CAVALLARO, op. cit., 10, ha utilizzato
l’argomento fondamentale di tale orientamento dottrinale (e, cioè, che prima dell’ordinanza di ammissione della prova
testimoniale non ci sono testimoni e, pertanto, neppure possono ipotizzarsi decadenze connesse con la loro mancata
citazione a comparire) per pervenire alla stessa conclusione sostenuta nel testo.
21
4.2. Gli adempimenti preliminari del giudice. – In tale udienza il giudice deve procedere,
secondo i principi generali, agli accertamenti preliminari relativi alla regolare costituzione del
contraddittorio: verifica della regolarità della notificazione (e, al riguardo, il rispetto dei termine a
difesa di venti giorni costituisce senz’altro formalità «essenziale al contraddittorio»: v., in
proposito, infra) e della costituzione delle parti ai sensi dell’art. 182 c.p.c.; verifica della integrità
del contraddittorio nel caso in cui ricorra un’ipotesi di litisconsorzio necessario.
In tutti questi casi, il carattere concentrato della trattazione della causa nella prima fase non
impedisce che il giudice possa e debba somministrare i provvedimenti previsti in generale
dall’ordinamento processualcivilistico in simili evenienze.
Così, sicuramente il giudice dovrà concedere al ricorrente un nuovo termine per eseguire la
notificazione nel caso in cui questa sia nulla o inesistente ovvero sia avvenuta in violazione del
termine minimo previsto a favore del convenuto44.
Così come dovrà assegnare un termine perentorio nelle ipotesi previste dall’art. 182 c.p.c. e
per integrare il contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c.
4.3. L’interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione. – Compiute queste verifiche
preliminari, il giudice deve procedere a «sentire le parti». Si potrebbe ritenere che il fatto che il
comma 49 dell’art. 1 della legge n. 92 contenga questa semplice indicazione, in luogo della più
articolata attività richiesta al giudice dai primi tre commi dell’art. 420, escluda la necessità per le
parti di comparire personalmente all’udienza e per il giudice di procedere al loro interrogatorio
libero ed al tentativo di conciliazione.
Una simile conclusione non sembra però condivisibile.
In effetti, se si ammette che al procedimento di cui si tratta si applicano tutte le norme
regolatrici delle controversie individuali di lavoro che non siano incompatibili con la specialità del
nuovo rito, si dovrebbe ritenere l’applicabilità anche della disciplina dettata dai primi tra commi
dell’art. 420 c.p.c., sicuramente coerente con il procedimento in oggetto. Conseguentemente le parti
hanno l’onere delle parti di comparire personalmente all’udienza e di essere informate sui fatti di
causa. Dal canto suo, il giudice, anche in tali controversie, sarà tenuto ad interrogarle e a tentare la
conciliazione, formulando alle parti una proposta transattiva, il cui rifiuto senza giustificato motivo
costituirà comportamento valutabile ai fini della decisione. Così come dovrà ritenersi che la
conciliazione eventualmente raggiunta durante la fase “urgente” del nuovo rito sia assistita dal
regime di stabilità di cui all’art. 2113, ultimo comma, c.c. Invero, anche la sede conciliativa
costituita dall’udienza fissata nel nuovo procedimento relativo alle impugnazioni dei licenziamenti
può essere ricondotta (al pari dell’udienza ex art. 420 c.p.c., neppure essa menzionata
espressamente dalla predetta norma del codice civile), a quella dell’art. 185 c.p.c.
4.4. La superficialità dell’istruttoria. – Quanto all’istruttoria, la formula utilizzata dal
comma 49 è davvero infelice. Nell’evidente intento di stabilire che essa, in questa prima fase del
procedimento, debba essere sommaria, il legislatore si è ispirato, anche sotto questo profilo, all’art.
669-sexies c.p.c., ma ripetendo solamente la prima parte del corrispondente precetto contenuto in
tale disposizione (vale a dire quella che prevede la necessità di assumere solamente gli «atti di
istruzione indispensabili»), non anche la seconda (quella, cioè, che collega il requisito
dell’indispensabilità «ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto») che è proprio ciò che
vale a caratterizzare nel senso della sommarietà l’istruttoria che si compie nei procedimenti
cautelari45.
44
Conforme L. CAVALLARO, op. cit., 9.
Analogamente, l’art. 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (ormai superato dalla riforma operata sul punto
dall’art. 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150) in materia di azioni contro le discriminazioni faceva
riferimento agli «atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto».
45
22
Ed infatti, per quanti sforzi si vogliano compiere, sul piano logico non v’è alcuna differenza
tra atti istruttori «indispensabili», atti istruttori «ammissibili e rilevanti» (tale è la formula utilizzata
dal successivo comma 57 al fine di definire l’istruttoria propria della fase di opposizione), mezzi di
prova «rilevanti» (art. 420, quinto comma, c.p.c.)46. Né sembra che si possa ricorrere alle
acquisizioni giurisprudenziali in ordine all’interpretazione dell’analoga espressione utilizzata
dall’art. 437, secondo comma, c.p.c. Infatti in quest’ultimo caso la nozione di indispensabilità dei
mezzi istruttori è stata elaborata essenzialmente in rapporto alle preclusioni previste a carico delle
parti dal rito codicistico del lavoro relativamente al giudizio di primo grado, aspetto del tutto
estraneo alla fase del giudizio di impugnazione dei licenziamenti di cui qui si sta trattando.
Ed allora, al fine di riempire di contenuto il precetto del comma 49, occorre necessariamente
tener conto delle indicazioni circa i caratteri della prima fase del nuovo procedimento che si
traggono da altri precetti dell’art. 1 della legge n. 92 del 2012. E tali indicazioni sono tutte nel senso
dell’intenzione del legislatore di definire un procedimento idoneo a consentire la formazione, nel
tempo più rapido possibile, di un primo pronunciamento giudiziale circa la legittimità di un
licenziamento intimato nell’area di applicabilità dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970.
In tale direzione depone, anzitutto, già lo sdoppiamento del primo grado di giudizio in due
fasi, sdoppiamento che non avrebbe senso se l’attività che il giudice deve compiere per pervenire
alla decisione (e, in particolare, quella istruttoria che, com’è noto, comprende gli adempimenti che
richiedono il maggior tempo) fosse la stessa; conseguentemente, poiché l’istruttoria che deve essere
compiuta nella fase di opposizione è sicuramente quella piena (consistendo nell’assunzione di tutti i
mezzi istruttori «ammissibili e rilevanti») è giocoforza concludere nel senso che l’istruttoria propria
della prima fase debba da quella distinguersi sotto qualche profilo, in particolare al fine di renderla
più snella.
In secondo luogo, la già segnalata impossibilità per le parti di chiamare in causa terzi e di
proporre domande riconvenzionali nella prima fase del giudizio di primo grado (facoltà che invece
esse conservano integre nella fase di opposizione) conferma che quella prima fase è concepita come
caratterizzata dalla massima concentrazione.
Infine, occorre considerare che opinare diversamente (ritenendo, cioè, che anche la prima
fase del giudizio di primo grado sia a cognizione piena) condurrebbe alla conclusione secondo la
quale il legislatore del 2012 avrebbe introdotto per le impugnazioni dei licenziamenti un
procedimento articolato addirittura su quattro gradi a cognizione ordinaria (vale a dire uno in più
rispetto a quelli che caratterizzano il comune rito del lavoro), il cui unico temperamento sarebbe la
previsione di una trattazione deformalizzata (misura di invero modesta portata acceleratoria, come
si vedrà) e che comunque non costituisce un elemento che vale a distinguere la prima fase da quella
di opposizione, posto che anche in questa seconda il giudice deve procedere omettendo le formalità
non essenziali al contraddittorio. Ciò (oltre ad essere in clamorosa antitesi con le intenzioni
dichiarate dal legislatore, anche negli atti parlamentari) renderebbe incomprensibile la ragione per
la quale il legislatore avrebbe, contestualmente, introdotto tutta una serie di misure dirette alla
semplificazione dell’attività processuale e alla riduzione dei termini.
46
Per analogo rilievo, v. L. CAVALLARO, op. cit., 5. Nel senso della sostanziale equivalenza tra indispensabilità degli
atti istruttori ex art. 669-sexies c.p.c. e rilevanza degli stessi ex art. 702-ter, A. CARRATTA, Nuovo procedimento
sommario di cognizione e presupposto dell’ “istruzione sommaria”: prime applicazioni, in Giur. it., 2010, 904; Id.,
Procedimento sommario di cognizione, cit., 7. Invece D. BORGHESI, op. cit., 915, trae proprio dal fatto che la legge n.
92 parla di atti istruttori indispensabili – che è la formula utilizzata per l’istruttoria, appunto sommaria, propria dei
procedimenti cautelari – per la fase “urgente” e di atti istruttori rilevanti – che è la formula utilizzata per l’istruttoria del
procedimento sommario di cognizione, vale a dire di un rito semplificato ma a cognizione piena – per il giudizio di
opposizione, la dimostrazione del fatto che la prima fase in cui si articola il nuovo rito è appunto a cognizione
somamria, mentre la seconda fase è a cognizione piena.
23
Tutte le considerazioni di natura sistematica appena esposte impongono pertanto di ritenere
che l’istruttoria propria della fase “urgente” sia ridotta rispetto a quella propria di un giudizio a
cognizione piena47. Si tratta ovviamente di precisare in cosa consista tale riduzione.
Si può escludere che essa comporti una selezione dei fatti sui quali svolgere l’istruttoria, non
essendovi alcun elemento testuale o sistematico che consenta di affermare che il giudice possa
omettere di procedere ad accertamenti su qualcuno dei fatti richiesti dall’art. 18 della legge n. 300
del 1970 per l’applicazione di una delle tutele da esso previste ovvero su qualcuno dei fatti dedotti
dal datore di lavoro a sostegno della legittimità del proprio operato.
Si deve pertanto concludere che l’indispensabilità richiesta dal comma 49 vada intesa come
posta in relazione all’urgenza del provvedimento richiesto, in conformità con la modifica suggerita
dalla dottrina quando il disegno di legge era ancora all’esame del Parlamento e il segmento della
disciplina relativo alla prima fase del nuovo procedimento era contenuta in un articolo
significativamente intitolato «Tutela urgente»48. Ecco allora che la prima fase in cui si articola il
giudizio di primo grado del nuovo procedimento è sommaria, non solamente nel senso che la
trattazione è deformalizzata, ma anche nel senso che l’istruttoria consiste nell’assunzione dei soli
mezzi istruttori necessari a consentire al giudice la formazione di un giudizio di mera
verosimiglianza circa l’esistenza o meno del vizio (o dei vizi) del licenziamento denunciati dal
ricorrente49.
4.5. I singoli mezzi istruttori. – Ciò non significa affatto, però, che vi siano, tra le prove
tipiche, alcune incompatibili con tale fase. Infatti, la sommarietà del procedimento, così come sopra
precisata, non impone al giudice di limitare l’attività istruttoria ai mezzi di prova di più semplice e
rapida assunzione; gli impone, invece, di assumere solamente quelli necessari per pervenire ad una
ricostruzione meramente probabilistica dei fatti oggetto di causa50. Così, non v’è ragione per
dubitare dell’ammissibilità della consulenza tecnica d’ufficio (che, del resto, è uno strumento
praticamente indispensabile per il giudice, una volta che si ammetta la proponibilità, in simili
procedimenti, anche delle domande dirette ad ottenere il risarcimento del danno alla salute
eventualmente causato dal licenziamento illegittimo). Qui, infatti, non v’è la necessità (propria
invece dei giudizi cautelari) di rispettare i limiti di tempo imposti dall’esigenza di scongiurare il
verificarsi dell’irreparabile pregiudizio al diritto del ricorrente51.
L’estraneità del rito in oggetto alla tutela cautelare (i cui esiti sono provvisori e sempre
suscettibili di essere modificati da un successivo giudizio di merito) rileva, in materia di prove
tipiche, sotto altro profilo, sempre in materia di prove tipiche. Precisamente, non sembra corretto
escludere la possibilità per le parti di ricorrere al giuramento decisorio o a quello suppletorio; il
fatto che tali mezzi siano finalizzati alla decisione della causa, se costituisce un elemento che
depone in senso contrario alla loro esperibilità nei giudizi cautelari, è invece del tutto coerente con
47
Contra A. BOLLANI, op. cit., 320, secondo il quale l’ordinanza pronunciata dal giudice nei procedimenti in
questione si fonda su un accertamento istruttorio pieno e conclude nel senso che la riforma ha, di fatto, introdotto un
grado aggiuntivo di giudizio (ivi, 321). In senso analogo, L. CAVALLARO, op. cit., 3, secondo il quale la sommarietà
del procedimento non sta nella qualità dell’accertamento giudiziale, tendenzialmente analogo a quello della normale
cognizione, quanto dal modo in cui esso è condotto, che si vorrebbe scevro da formalismi superflui; anche questo
Autore però, sottolineando che tali formalismi sono del tutto assenti nel rito del lavoro, finisce con il riconoscere che la
diversità con tale rito sarebbe impalpabile.
48
R. CAPONI, op. cit., 10.
49
Nel senso che nella prima fase del giudizio di primo grado «il convincimento in fatto è per definizione superficiale,
riguardando il “fumus” di fondatezza della domanda», A. VALLEBONA, op. cit., 74.
50
In un primo provvedimento giudiziale è stato affermato che nella fase “urgente” possono essere ammessi mezzi di
prova diversi da quelli documentali «solo se assolutamente necessari alla decisione, anche in considerazione del
carattere di articolare rapidità che il legislatore ha voluto attribuire al procedimento»: Trib. Rovigo 11 ottobre 2012, Est.
Ferrari, N.F. c. S.M. s.r.l.
51
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità appare orientata a ritenere la c.t.u. compatibile anche con procedimenti
prettamente cautelari: Cass., 22 ottobre 1997, n. 10388.
24
la natura del nuovo procedimento per l’impugnazione dei licenziamenti, il provvedimento
definitorio della cui prima fase è sicuramente idoneo (v., infra, n. 5) ad acquisire la stabilità propria
della cosa giudicata.
4.6. Le istanze istruttorie delle parti. – Aspetto diverso da quello della compatibilità delle
prove tipiche con il nuovo rito è quello che attiene alla definizione del perimetro entro il quale il
giudice deve scegliere i mezzi istruttori da assumere. Al riguardo, il comma 49 dispone che il
giudice compie gli atti istruttori «richiesti dalle parti» e quelli «disposti d’ufficio, ai sensi
dell’articolo 421 del codice di procedura civile».
Quanto ai primi, si è già detto che il richiamo all’art. 125 c.p.c. quale modello per l’atto
introduttivo della presente procedura impone di escludere che le parti abbiano l’onere di indicare, a
pena di decadenza, già nel loro primo scritto difensivo, i mezzi istruttori dei quali intendano
avvalersi. E tuttavia, se si concorda sul fatto che il legislatore abbia delineato un procedimento
tendenzialmente concentrato in una sola udienza, si deve anche convenire nella necessità che le
parti formulino definitivamente le loro istanze istruttorie subito dopo l’interrogatorio libero e
l’esperimento del tentativo di conciliazione (nonché la decisione sulle eventuali questioni
pregiudiziali). Ciò, direi, prendendo spunto dalla previsione dell’art. 420, quinto comma, c.p.c., la
quale colloca appunto in quella fase dell’udienza la decisione del giudice sui mezzi di prova già
proposti dalle parti e su quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima. Sembrerebbe ovvio,
pertanto, che, anche nel procedimento di cui stiamo trattando, quello debba essere il momento in cui
il giudice adotta la propria decisione circa l’istruttoria da compiere e, conseguentemente, anche il
limite temporale ultimo perché le parti formulino le loro istanze al riguardo52.
4.7. I poteri istruttori officiosi. – Per quanto concerne, poi, i poteri istruttori officiosi, la loro
latitudine non sembra che possa essere apprezzata prescindendo dal richiamo al disposto dell’art.
421 c.p.c. operato dal legislatore. Vale a dire che il legislatore del 2012 non ha attribuito al
Tribunale un’illimitata e generica facoltà di ammettere d’ufficio mezzi istruttori, ma solamente il
medesimo potere riconosciuto in generale al giudice del lavoro dall’art. 421 c.p.c. Questo è un
aspetto meritevole di essere sottolineato: non sembra possibile affermare che tra le «formalità non
essenziali al contraddittorio» sia compresa anche quella della necessità dell’istanza di parte per
procedere all’ammissione dei mezzi istruttori. In altri termini, il fatto che il comma 49 abbia cura di
precisare che gli atti istruttori che il giudice deve compiere sono o quelli richiesti dalle parti o quelli
ammessi d’ufficio (non illimitatamente, ma solamente) ai sensi dell’art. 421 c.p.c.53 impone di
escludere che, nella fase “urgente” del nuovo rito, il giudice disponga di un potere probatorio
ufficioso più ampio di quello ordinariamente riconosciutogli dalla disciplina propria delle
controversie individuali di lavoro.
Ed allora, in primo luogo, va confermato il limite costituito dalle allegazioni delle parti, non
potendo il giudice, neppure quello del nuovo rito per l’impugnazione dei licenziamenti, disporre
indagini su fatti ulteriori rispetto a quelli dedotti dalle due parti in causa54.
52
Diversa l’opinione di L. CAVALLARO, op. cit., 5, e G. TREGLIA, op. cit., 767, secondo i quali le parti sarebbero
libere di promuovere istanze istruttorie lungo tutto l’arco del procedimento. Anche con riferimento al procedimento
sommario di cognizione, la dottrina afferma in prevalenza che le parti sarebbero abilitate ad avanzare istanze istruttorie
per tutto il corso del processo: C. CONSOLO, Spiegazioni, cit., 189; MENCHINI, op. cit., 1031; invece, nel senso che,
per ragioni sistematiche derivanti dalla necessità di assicurare la ragionevole durata del processo e la coerenza con il
modello processuale delineato dal legislatore, G. ARIETA, Il rito “semplificato” di cognizione, in judicium.it, 19; G.
OLIVIERI, Il procedimento di primo grado, in Giur. it., 2010, 732, e, in giurisprudenza, Trib. Varese, 18 novembre
2009, in Guida dir., 2009, n. 50, 47.
53
Precisazione che rappresenta un’ulteriore sensibile differenza rispetto alla disciplina del procedimento cautelare
uniforme, laddove l’art. 669-sexies c.p.c., nel prevedere che il giudice proceda agli atti di istruzione indispensabili, non
vincola tale attività alle istanze delle parti, né ai limiti imposti dall’art. 421 c.p.c.
54
V., tra le tante, la recente Cass., 4 maggio 2012, n. 6753.
25
In secondo luogo, si ripropone nel presente procedimento il dilemma circa la possibilità per
il giudice di ricercare autonomamente fonti materiali di prova o se invece anche al riguardo egli sia
limitato dalle indicazioni contenute negli atti delle parti, onde potrebbe procedere d’ufficio
all’assunzione delle sole prove le cui fonti siano già acquisite al processo in virtù dell’attività
difensiva delle parti55.
Ma, soprattutto, ciò che forse merita di essere sottoposto a verifica è l’applicabilità della
ricorrente massima giurisprudenziale secondo la quale il giudice deve far ricorso ai poteri officiosi
attribuitigli dall’art. 421 c.p.c. solamente quando dalle allegazioni delle parti e dal materiale
probatorio acquisito al processo già emergano significativi dati di indagine56. In effetti non è
agevole coniugare un simile principio con la natura superficiale dell’istruttoria che si deve compiere
in un giudizio, come quello della fase “urgente” del nuovo rito, caratterizzato dal fatto che il
convincimento che il giudice deve maturare è di mera verosimiglianza dell’esistenza del diritto
azionato dal lavoratore. Ci si può chiedere, in particolare, se, a fronte di risultanze istruttorie che
depongano in senso favorevole ad una delle parti, senza però assurgere al livello di piena prova, il
giudice possa disporre d’ufficio altri mezzi istruttori o si debba arrestare e formulare il proprio
giudizio che, appunto, è di ricostruzione meramente probabilistica dei fatti (mentre l’attribuzione al
giudice del potere-dovere di assumere d’ufficio mezzi istruttori è finalizzata proprio ad attuare
pienamente il principio della ricerca della verità materiale).
Non vi possono essere dubbi, poi, sull’ammissibilità delle prove atipiche, almeno negli stessi
limiti in cui esse sono ammesse nel giudizio ordinario dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la
quale, nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del
giudice, è possibile che questi ponga a fondamento della decisione prove non espressamente
previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto
non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo57 e purché sia fornita adeguata
motivazione della relativa utilizzazione, rimanendo, in ogni caso, escluso che tali prove atipiche
possano valere ad aggirare preclusioni o divieti dettati da disposizioni sostanziali o processuali, così
introducendo surrettiziamente elementi di prova che non sarebbero altrimenti ammessi o la cui
ammissione richieda il necessario ricorso ad adeguate garanzie formali58.
4.8. Le formalità non essenziali al contraddittorio. – Come accennato, l’altro profilo nel
quale si manifesta il carattere sommario del giudizio è il suo carattere deformalizzato, il legislatore
avendo previsto che il giudice proceda nel modo che ritenga maggiormente opportuno e omettendo
ogni formalità non essenziale al contraddittorio.
Non è agevole individuare tali «formalità non essenziali al contraddittorio» che, pur essendo
previste dalla disciplina ordinaria del processo, il giudice deve trascurare. Ciò essenzialmente per il
fatto, già segnalato (supra, n. 1) secondo cui al rito in oggetto si applica, per tutto quanto non
previsto dalla legge n. 92 del 2012, la disciplina codicistica delle controversie individuali di lavoro,
la quale è già di per se stessa caratterizzata da un notevole tasso di “semplificazione” rispetto a
quella del rito civile ordinario. Ne discende che la “trasposizione” nel procedimento di cui stiamo
trattando, della formula relativa all’omissione delle formalità non essenziali al contraddittorio
propria della disciplina del rito cautelare uniforme e del rito sommario di cognizione produce effetti
molto più modesti che in questi due casi.
55
Per le varie posizioni espresse al riguardo dalla dottrina, si vedano L. MONTESANO-R. VACCARELLA, Manuale
di diritto processuale del lavoro, Jovene, 1996, 189; F.P. LUISO, Il processo del lavoro, Utet, 1992, 192; G. TARZIA,
Manuale del processo del lavoro, Giuffré, 1999, 153.
56
Cass., 24 ottobre 2007, n. 22305; Cass., 5 febbraio 2007, n. 2379; Cass., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353, in Foro
it., 2005, I, 1135; Cass., 6 luglio 2000, n. 9034, in Riv. giur. lav., 2001, II, 637.
57
Cass., 25 marzo 2004, n. 5965; Cass., 27 marzo 2003, n. 4666, in Giur. it., 2003, 2013; Cass., 26 settembre 2000, n.
12763, in Giur. it., 2001, 1378.
58
Cass., 5 marzo 2010, n. 5440, in Giur. it., 2010, 2589.
26
Ed infatti, premesso che non potrà comunque determinarsi il vantaggio costituito
dall’affrancazione dalla necessità della concessione dei termini per la trattazione scritta ex art. 183
c.p.c. o del duplice termine per lo scambio degli scritti difensivi finali ovvero della fissazione
dell’udienza di precisazione delle conclusioni (adempimenti la cui esclusione discende, non già
dalla previsione di un procedimento de formalizzato contenuta nel comma 49 dell’art. 1 della legge
n. 92 del 2012, bensì dalla segnalata applicabilità al nuovo rito della disciplina generale del rito
codicistico del lavoro), si deve convenire anche che non si potrà mai omettere il rispetto delle
formalità previste per la costituzione stessa del contraddittorio. Quelle, cioè, dirette ad assicurare il
pieno esercizio del diritto di difesa delle parti.
Così, come già detto, sicuramente non si potrà derogare al termine minimo di venti giorni
concesso al convenuto per approntare la sua difesa. Infatti, posto che è assolutamente pacifico che
la concessione al convenuto di un termine per esaminare il ricorso avversario e predisporre le
proprie difese costituisca una formalità essenziale al contraddittorio59, deve anche ritenersi, in
aggiunta, che, contrariamente al modello processuale costituito dal procedimento cautelare
uniforme (nel quale il legislatore ha lasciato al giudice ampia discrezionalità nel determinare la
durata del termine a difesa60), nel caso del nuovo rito per le impugnazioni dei licenziamenti, le
indicazioni contenute nel sesto periodo del comma 48 circa il termine per l’esecuzione della
notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e per la
costituzione del convenuto sono chiaramente rivelatrici dell’intenzione del legislatore del 2012 di
prefigurare un termine minimo che comunque deve essere concesso al resistente al fine di
predisporre la propria difesa.
Analogamente, in caso di eccezioni tempestivamente sollevate da una delle parti, si dovrà
assicurare alla controparte la possibilità di adeguatamente replicare e dedurre circa la necessità di
nuovi mezzi istruttori; e la stessa facoltà deve essere assicurata ad entrambe le parti in caso di
ammissione d’ufficio di mezzi di prova ai sensi dell’art. 421 c.p.c. ovvero nel caso in cui il giudice
ritenga di porre a fondamento della decisione una questione rilevabile d’ufficio (in ossequio al
principio consacrato nell’art. 101, secondo comma, c.p.c.).
Sembra al pari indubbio che natura di formalità essenziale al contraddittorio debba essere
riconosciuta anche al diritto delle parti di esprimere, una volta esaurita la fase istruttoria, le loro
valutazioni finali, mentre rientra sicuramente nella discrezionalità che la norma attribuisce al
giudice la scelta delle relative modalità (discussione orale immediata, rinvio ad altra udienza per la
discussione, concessione di termine per il deposito di note scritte).
Va egualmente escluso agevolmente che la deformalizzazione pretesa dalla norma attenga
alla distribuzione dell’onere della prova tra le parti, aspetto che nulla ha a che vedere con le
modalità di svolgimento del processo61
Ed allora si può convenire sul fatto che le formalità non essenziali al contraddittorio che
possono essere omesse siano essenzialmente quelle attinenti all’assunzione delle prove costituende.
Premesso che, anche al riguardo, deve essere mantenuto fermo il rispetto della garanzia
minima rappresentata dal diritto di entrambe le parti di essere presenti agli esperimenti istruttori su
59
In giurisprudenza, con riferimento all’analoga espressione contenuta nell’art. 669-sexies, primo comma, c.p.c., v.
Trib. Lecce, 26 aprile 1994, in Foro it., 1994, I, 2249, nel senso che deve considerarsi essenziale affinché il ricorso
cautelare possa raggiungere il suo scopo, che è anche quello di consentire alla controparte di difendersi adeguatamente.
In dottrina, in generale, sulla necessità, di rilevanza costituzionale, della concessione al convenuto di un termine
dilatorio inderogabile per la predisposizione delle difese, nei procedimenti sommari nei quali la legge riconosce al
giudice un’elevata discrezionalità nella guida dello svolgimento del processo, A. GRAZIOSI, La cognizione sommaria
del giudice civile nella prospettiva delle garanzie costituzionali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2009, 168.
60
E ciò anche nel caso di concessione della misura cautelare con decreto emesso inaudita altera parte, poiché il
secondo periodo del secondo comma dell’art. 669-sexies c.p.c. si limita a stabilire il termine entro il quale deve essere
fissata l’udienza di comparizione delle parti e il termine massimo entro il quale deve essere eseguita la notificazione del
ricorso e del decreto, non anche il termine minimo che deve intercorrere tra la notificazione e l’udienza.
61
Conforme, in una fattispecie relativa al processo sommario di cognizione, Trib. Piacenza, 27 maggio 2011, in
www.ilcaso.it.
27
un piano di parità, va segnalato che, con riferimento all’identica espressione utilizzata dall’art. 702ter, quinto comma, c.p.c., in giurisprudenza è stata dichiarata l’inammissibilità della prova
testimoniale richiesta senza idonea capitolazione delle circostanze di fatto sulle quali i testimoni
avrebbero dovuto essere interrogati e senza l’indicazione nominativa di questi ultimi62; con
riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio, è stato disposto che, considerata la celerità che deve
contraddistinguere il procedimento, le nomine dei consulenti di parte sono ammesse solamente fino
all’udienza di giuramento del c.t.u. e non sono osservate le procedure previste dall’art. 195, con
conseguente onere dei consulenti di parte di partecipare alle operazioni peritali e di evidenziare in
quella sede le loro osservazioni63.
In dottrina, si è detto che testimoni e c.t.u. debbono giurare, ma capitoli e quesiti possono
essere deformalizzati e financo elisi64; che il giudice potrebbe porre ai testi domande anche fuori dal
capitolato di prova dedotto dalla parte65, pur se nell’àmbito delle relative allegazione di fatto66; che
il giudice possa disporre anche al di fuori dell’accordo delle parti l’assunzione della prova
testimoniale secondo la modalità di cui all’art. 257-bis c.p.c.67.
Al riguardo, al fine di evitare che tutto sia lasciato alla personale sensibilità di ciascun
giudice, sembra opportuno individuare almeno un criterio generalissimo che valga a costituire un
attendibile strumento di orientamento per l’interprete. A questo fine, sembra inevitabile prendere le
mosse dalla ratio della deformalizzazione prevista dal legislatore; essa, all’evidenza, è funzionale
alla concentrazione dei tempi di definizione della controversia. Ed allora, non si vede davvero
perché dovrebbero essere omesse formalità la cui soppressione non comporta alcun apprezzabile
risparmio di tempo.
E così, iniziando dalla prova testimoniale, sembra ovvio che non può essere omesso quanto
richiesto dall’art. 251 c.p.c., in difetto del quale, anzi, neppure potrebbe parlarsi di prova
testimoniale. Circa la previa indicazione delle persone da interrogare, non si vede davvero quale
aggravio sui tempi di definizione della causa possa derivare da tale adempimento che, del resto,
sembra davvero «essenziale al contraddittorio», poiché non dovrebbero esservi dubbi sul fatto che
per la controparte sia essenziale conoscere, oltre che i fatti sui quali il testimone verrà interrogato,
anche il nominativo di chi sia chiamato a rispondere a quelle domande. Venendo alla deduzione
della prova testimoniale per capitoli separati e specifici, abbiamo già visto come sia stato lo stesso
legislatore, nel non prevedere l’onere per le parti di indicare già nei rispettivi primi atti difensivi i
mezzi istruttori dei quali intendano avvalersi, ad introdurre nel nuovo modello processuale un
elemento di fortissima contraddizione con la proclamata intenzione di costruire un procedimento
idoneo a consentire al giudice di pervenire nel più breve tempo possibile ad una decisione. Ciò
comporta, come detto, la possibilità che le parti possano liberamente integrare le loro richieste
istruttorie nel corso della prima udienza ed è evidente che, in quel contesto, è molto più agevole
chiedere genericamente la prova testimoniale su tutte le circostanze di fatto dedotte nel ricorso o
nella memoria di costituzione, piuttosto che formulare articoli specifici e separati, come preteso
dall’art. 244 c.p.c. Ma è altrettanto evidente che richiedere che i difensori delle parti procedano a
tale capitolazione nel corso dell’udienza comporterebbe inevitabilmente una dilatazione dei tempi
62
Trib. Mondovì, 12 novembre 2009, in Giur. it., 2010, 899.
Trib. Mondovì, 12 novembre 2009, cit.
64
C. CONSOLO, La legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69: altri profili significativi a prima lettura, in Corr. giur.,
2009, 885. Nel senso sia della necessità della prestazione dell’impegno di cui all’art. 251 c.p.c. (così come manipolato
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 149 del 1995), sia della superfluità della capitolazione, a condizione che le
circostanza su cui la parte chieda di sentire il testimone siano sufficientemente specificate, anche M.A. LUPOI,
Sommario (ma non troppo), in Riv. trim. dir. proc. civ., 2010, 1256.
65
G.F. RICCI, La riforma del processo civile, Giappichelli, 2009, 110.
66
L. DITTRICH, Il nuovo procedimento sommario di cognizione, in Riv. dir. proc., 2009, 1595, il quale precisa che non
altrettanto potrebbe ritenersi per l’interrogatorio formale (su quest’ultimo punto, concorde C. CONSOLO, Spiegazioni
di diritto processuale civile, vol. III, Giappichelli, 2010, 189; invece diversa l’opinione di G.F. RICCI, op. loc. cit.).
67
C. BESSO, Il nuovo rito ex art. 702 bis c.p.c.: tra sommarietà del procedimento e pienezza della cognizione, in Giur.
it., 2010, 725, nt. 35.
63
28
della stessa. Ed è dunque per questo solo motivo (e non certo perché la previa capitolazione
costituisca di per sé un adempimento idoneo ad allungare i tempi di definizione della causa, essendo
semmai vero il contrario) che probabilmente deve ammettersi che le parti siano abilitate a richiedere
l’ammissione della prova per testi senza necessità di una analitica capitolazione, fermo restando
comunque la possibilità di formulare tale istanza solamente con riferimento ai fatti ritualmente
dedotti in giudizio. Deve, infine, ritenersi essenziale al contraddittorio il riconoscimento alle parti
della facoltà di fare osservazioni sull’attendibilità del testimone e di pretendere i chiarimenti
necessari (art. 252, seocndo comma, c.p.c,.) e di chiedere al giudice di rivolgere al testimone ogni
domanda utile a chiarire i fatti sui quali esso depone (art. 253 c.p.c.).
Passando alla consulenza tecnica d’ufficio, per quanti sforzi si vogliano fare, non sarà mai
possibile immaginare una modalità di svolgimento di tale accertamento maggiormente concentrata
rispetto al modello già offerto dal rito codicistico del lavoro all’art. 422. Com’è noto, è qui previsto
che il giudice, nominato «in qualsiasi momento» uno o più consulenti tecnici, possa assegnare alle
parti un termine perentorio non superiore a cinque giorni per note sui quesiti da formulare
all’ausiliare (nonché un termine non superiore a sei giorni per la nomina dei consulenti di parte: art.
145 disp. att. c.p.c.); il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente ovvero, in caso di
relazione scritta, gli può essere concesso all’uopo un termine non superiore a venti giorni. Non si
vede davvero come i tempi per il compimento delle operazioni peritale potrebbero essere
ulteriormente compressi. Se si aggiunge che la prestazione del giuramento assume anche al riguardo
formalità in difetto della quale neppure potrebbe parlarsi di consulenza tecnica d’ufficio, che la
formulazione del quesito deve necessariamente essere riportata nel verbale d’udienza (per le più
elementari esigenze di certezza e di rispetto dei poteri defensionali delle parti) e che la facoltà delle
parti di ricorrere alla nomina di consulenti di parte rientra in pieno nell’esercizio del diritto di
difesa, si può agevolmente concludere che, rispetto al mezzo in questione, la prescrizione secondo
la quale il giudice omette ogni formalità non essenziale al contraddittorio si riduce all’impossibilità
di applicare il complesso meccanismo previsto dall’art. 195, terzo comma, c.p.c. (ammesso e non
concesso che esso sia, in generale, compatibile con il rito lavoristico).
In conclusione, la previsione della de formalizzazione non sembra idonea a determinare
particolari vantaggi sul piano della contrazione dei tempi. Ma ciò non deve sorprendere, se si
considera che essa si colloca nell’àmbito di un procedimento che è assoggettato, in generale, alla
disciplina codicistica delle controversie di lavoro, vale a dire a un rito che è già di epr sé scevro da
formalismi. Una disposizione che consente al giudice di omettere le formalità non essenziali al
contraddittorio produce effetti molto significativi se applicato a cause regolate dal rito ordinario,
consentendo di evitare di seguire pedissequamente il complesso iter prefigurato dall’art. 183 c.p.c.
ovvero quello di cui agli artt. 190 e 281-quinquies, c.p.c. La medesima disposizione, invece, non ha
molto senso, occorre riconoscerlo, se si inserisce in una disciplina come quella del rito del lavoro.
4.9. Alcuni incidenti processuali. – Questione diversa rispetto a quelle affrontate sinora è
quella relativa alla compatibilità con il particolare carattere della prima fase del nuovo rito di
incidenti quali la verificazione della scrittura privata, la querela di falso, l’ordinanza di rimessione
alla Corte costituzionale di una questione di legittimità costituzionale, il rinvio alla Corte di
giustizia delle Comunità europee di una questione pregiudiziale di interpretazione del diritto
comunitario.
Iniziando dalla prima delle predette ipotesi, indubbia essendo la facoltà della parte di
disconoscere la scrittura privata anche nel procedimento in questione, si dovrebbe ammettere con
altrettanta sicurezza la facoltà della controparte di proporre istanza di verificazione. Le segnalate
caratteristiche dell’istruttoria nella fase “urgente”, infatti, non consentono di ritenere incompatibile
con tale fase un accertamento istruttorio per il solo fatto che esso sia caratterizzato da complessità.
Il limite, piuttosto, è costituito, anche con riferimento al procedimento di verificazione, dal suo
carattere di indispensabilità, nel senso che il giudice può evitare di dar corso a tale procedimento se
29
ritenga che la genuinità o meno della scrittura in questione sia elemento irrilevante alla formazione
del giudizio di verosimiglianza che caratterizza la prima fase del nuovo procedimento.
Analoghe considerazioni sembrerebbero valide rispetto alla querela di falso, con
l’avvertenza che la valutazione della rilevanza del documento che l’art. 222 c.p.c. impone al
giudice, andrà compiuta anche qui nella prospettiva del predetto giudizio di verosimiglianza.
Non vi sono ragioni, infine, per escludere l’ammissibilità degli incidenti di costituzionalità e
di pregiudizialità comunitaria, i quali attengono, non già all’attività istruttoria, bensì, per così dire,
alla rimozione di ostacoli giuridici all’effettivo dispiegarsi di diritti soggettivi già enucleabili
dall’ordinamento. Negare la praticabilità di tali incidenti significherebbe precludere la possibilità
stessa di tutela dei diritti soggettivi delle parti in un procedimento che, come già accennato e come
si vedrà meglio in seguito, è destinato a sfociare in un provvedimento giudiziale idoneo ad acquisire
la stabilità tipica del giudicato.
Si può invece escludere con sicurezza la compatibilità, con la prima fase del nuovo giudizio
di impugnazione dei licenziamenti, dell’istituto dell’accertamento pregiudiziale sull’efficacia,
validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi di cui all’art. 420-bis c.p.c., destinato ad
introdurre nella controversia un complesso procedimento dai tempi inconciliabili con quelle
richiesti dalla nuova procedura ex legge n. 92 del 2012 e non indispensabile al fine della tutela delle
posizioni soggettive delle due parti della controversia, tutela perfettamente ottenibile anche senza
mettere in moto quel procedimento.
Quanto alle vicende anomale del processo, non sembra che possano ipotizzarsi soluzioni
diverse da quelle in generale valide tanto per il rito civile ordinario, quanto per quello lavoristico
codicistico.
Così, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti, non v’è alcuna ragione per
derogare alla disciplina di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c. In particolare, non si vede per quale motivo
l’indubbia concentrazione della trattazione che caratterizza il nuovo procedimento debba far premio
sulle generali esigenze di garanzia delle parti che sono alla base della disciplina del codice di rito in
tema di diserzione bilaterale delle udienze.
Analogamente, la mancanza di un termine esterno, seppure non rigido (come per esempio
l’esigenza di evitare che si verifichi il pregiudizio irreparabile), esclude che possa dubitarsi
dell’applicabilità degli istituti della sospensione e dell’interruzione della causa di cui agli artt. 295
ss. c.p.c.
Ovviamente compatibile col nuovo rito è, infine, la disciplina dell’estinzione (artt. 306-310
c.p.c.).
5. segue: c) la decisione.
L’art. 1, comma 49, della legge n. 92 del 2012 prevede che, all’esito della prima fase, il
giudice decide circa l’accoglimento o il rigetto della domanda con ordinanza immediatamente
esecutiva. Trattandosi di ordinanza, si applica l’art. 134 c.p.c., onde il provvedimento può essere
pronunciato in udienza ovvero fuori udienza.
Deve considerarsi sicuramente legittima la prassi secondo la quale il giudice si riserva la
decisione concedendo un breve termine alle parti per depositare note scritte (facoltà della quale, a
causa della ristrettezza dei tempi imposti alle precedenti attività defensionali e della delicatezza
dell’oggetto delle controversie in questione, è pronosticabile che le parti si avvarranno con una certa
frequenza). Ciò pur se si deve negare che la concessione di tale termine costituisca una formalità
essenziale al contraddittorio, potendo le parti adeguatamente esercitare il loro diritto di difesa in
sede di discussione orale. Pertanto è inevitabile riconoscere al giudice un ampio potere
discrezionale circa l’accoglimento o meno dell’istanza delle parti in tal senso.
Nonostante che il comma 49 preveda, quali unici esiti del procedimento, l’accoglimento o il
rigetto della domanda (vale a dire, decisioni nel merito), è ovvio che la fase in questione può
30
concludersi anche con pronunce in rito, quali quelle dichiarative dell’incompetenza per territorio o
della nullità del ricorso.
Il regime dell’ordinanza è descritto nei commi 49 e 50 dell’art. 1. Il primo stabilisce che essa
è immediatamente esecutiva; il secondo che la sua efficacia esecutiva non può essere sospesa o
revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice «definisce» il giudizio di opposizione
(non è necessario – affinché venga meno l’efficacia esecutiva dell’ordinanza – che la sentenza che
conclude il giudizio di opposizione passi in giudicato, poiché sarebbe davvero contrario a qualsiasi
principio di ragionevolezza che l’accertamento sommario prevalesse su quello pieno, seppur non
ancora definitivo).
La dottrina ha già manifestato perplessità circa la legittimità costituzionale di quest’ultima
previsione (peraltro analoga a quella prevista dall’art. 28, secondo comma, della legge n. 300 del
1970 con riferimento al decreto con il quale il giudice dichiara l’antisindacalità della condotta
datoriale), sottolineando come l’esclusione della sospensione e della revoca leda il diritto di difesa
della controparte68. Ed in effetti si deve riconoscere che, se è sicuramente legittima l’attribuzione
dell’esecutività ad un provvedimento (quale l’ordinanza conclusiva della fase “urgente”) emanato a
seguito di un’istruttoria meramente sommaria, non altrettanto può dirsi circa la stabilità di tale
immediata esecutività, suscettibile di resistere anche alle diverse indicazioni derivanti dagli
elementi acquisiti nel corso del successivo giudizio a cognizione piena.
La legge tace completamente sul regime dell’ordinanza nel caso in cui essa non sia
tempestivamente opposta (ovvero delle parti della statuizione giudiziale non oggetto di tempestiva
opposizione).
Tuttavia, il fatto che il legislatore abbia previsto un termine perentorio («a pena di
decadenza», recita il comma 51 dell’art. 1 della legge n. 92) per la proposizione dell’opposizione
dovrebbe indurre senz’altro a ritenere che l’ordinanza (o la parte dell’ordinanza) non oggetto di
tempestiva opposizione acquisisca la stabilità propria della cosa giudicata69.
Il problema piuttosto sta nel definire i confini dell’accertamento contenuto nell’ordinanza
non opposta che diventa vincolante per le parti e per i giudici chiamati a decidere altre controversie
tra le stesse parti. Sull’argomento, si rinvia a quanto esposto nel paragrafo 10.
Proprio perché in mancanza di opposizione l’ordinanza è destinata a concludere
definitivamente il procedimento, è sicuro che il giudice debba statuire anche sul riparto delle spese
processuali.
6. Il problema del giudicato.
Si è accennato come un punto critico della disciplina del nuovo procedimento previsto dal
legislatore per l’impugnazione dei licenziamenti sia costituito dall’individuazione dei limiti
dell’accertamento compiuto nel provvedimento divenuto definitivo (ordinanza ex comma 49 non
opposta; sentenza ex comma 57 non reclamata; sentenza della Corte d’appello non impugnata o
confermata dalla Corte di cassazione) idoneo ad acquistare la stabilità propria del giudicato.
In particolare, occorre appurare se, oltre alla legittimità o illegittimità del licenziamento e
alla titolarità o meno, in capo al lavoratore, dei diritti configurati dall’art. 18 della legge n. 300 del
1970, la definitività dell’accertamento si estenda anche all’esistenza o meno del rapporto di lavoro
subordinato tra le due parti.
68
R. CAPONI, op. cit., 10.
Conformi: L. DE ANGELIS, op. cit., 11; A. VALLEBONA, op. cit., 75; D. BORGHESI, op. cit., 914. Nello stesso
senso, rispetto al decreto ex art. 28 legge n. 300 del 1970 non opposto, Cass., 23 novembre 1989, n. 5039, in Giust. civ.,
1990, I, 2123, e Cass., 5 maggio 1984, in Arch. civ., 1984, 1170. Contra, C. CONSOLO-D. RIZZARDO, op. cit., 735,
con l’unica motivazione secondo la quale «ritenere che l’ordinanza acquisti un’efficacia analoga a quella del giudicato
sembra eccessivo, in considerazione della forte informalità della fase sommaria e quanto meno per la parte debole del
rapporto». Dubbioso L. CAVALLARO, op. cit., 10.
69
31
Trattasi di una classica ipotesi di c.d. pregiudizialità in senso logico: chiedendo al Tribunale
la concessione di qualcuna delle tutele di cui al predetto art. 18, il lavoratore deduce in giudizio
anche la pregressa esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la controparte e fa valere,
appunto, uno dei tanti effetti di un simile rapporto giuridico. La fattispecie, pertanto, è diversa da
quella della c.d. pregiudizialità tecnica, categoria che comprende le ipotesi in cui un diritto (e non
un rapporto) rientra tra gli elementi costitutivi di un altro diritto.
È noto come la dottrina sia divisa circa l’applicabilità dell’art. 34 c.p.c. (e dei principi da
esso espressi al fine di individuare i limiti del giudicato) alle ipotesi di pregiudizialità in senso
logico. Ma è altrettanto noto come la giurisprudenza di legittimità esprima una posizione negativa al
riguardo, sostenendo che, indipendentemente dalla proposizione di una domanda in tal senso, il
giudicato sul diritto oggetto della domanda si estenda all’esistenza del rapporto giuridico dal quale
quello trae origine70.
Ove si ritenesse che tale consolidato orientamento sia applicabile alla fattispecie che qui
interessa, si deve concludere che la definitività del provvedimento giudiziale conclusivo della
controversia che riconosce a favore del lavoratore una delle tutele previste dall’art. 18 della legge n.
300 del 1970, fa acquisire carattere di stabilità anche all’accertamento positivo dell’esistenza di un
pregresso rapporto di lavoro subordinato tra le due parti, sussistenza che, pertanto, non potrà più
essere messa in discussione in eventuali futuri giudizi.
Per quanto concerne, invece, l’ordinanza di rigetto, occorre operare la necessaria
precisazione secondo la quale a quel provvedimento giudiziale va riconosciuto l’effetto di esprimere
un accertamento definitivo circa l’inesistenza o l’invalidità del rapporto fondamentale dedotto in
giudizio solamente se il rigetto delle domande del lavoratore si fondi proprio su quell’accertamento;
invece, se il rigetto derivi dalla decisione di questioni attinenti esclusivamente ai diritti derivanti
dall’illegittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di recesso, non è possibile ritenere
che l’ordinanza di rigetto faccia stato anche sull’inesistenza o l’invalidità del rapporto di lavoro
subordinato tra le parti71.
Volendo fare alcuni esempi: se il giudice respinga la domanda ex art. 18 legge n. 300 del
1970 perché ritenga insussistente la subordinazione e l’ordinanza non sia opposta tempestivamente,
dovrebbe ritenersi definitivamente accertato che le prestazioni lavorative siano state eseguite in
regime di autonomia; se invece il giudice rigetti la medesima domanda senza appurare alcunché
circa la natura del rapporto, ma solamente perché ritenga che il rapporto non sia cessato ad
iniziativa del convenuto ovvero perché escluda che questi occupi più di 15 dipendenti, all’ordinanza
non opposta non potrebbe essere riconosciuto alcun effetto di accertamento definitivo circa
l’insussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Potrebbe darsi il caso in cui il giudice, respinga la domanda di applicazione della tutela
prevista dall’art. 18 per uno dei motivi appartenenti alla categoria appena indicata per seconda e,
70
V., tra le più recenti, Cass., 9 aprile 2009, n. 8723, Cass. 18 dicembre 2008, n. 29531, e Cass. 24 marzo 2006, n.
6628, secondo cui in relazione ai rapporti di durata, se l’accertamento dell’esistenza, validità e natura giuridica di un
contratto, fonte di un rapporto obbligatorio, costituisce il presupposto logico-giuridico di un diritto derivatone, il
giudicato si estende al predetto accertamento e spiega effetto in ogni altro giudizio, tra le stesse parti, nel quale il
medesimo contratto è posto a fondamento di ulteriori diritti, inerenti al medesimo rapporto.
71
V. Cass., 16 maggio 2006, n. 11356, in Corr. giur., 2006, 1216 (secondo cui la pronunzia di rigetto non più soggetta
ad impugnazione non costituisce giudicato implicito – con efficacia vincolante nei futuri giudizi – laddove le questioni
concernenti l’esistenza, la validità e la qualificazione del rapporto che ne è il presupposto logico-giuridico non abbiano
costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice); Cass., 17 novembre 2003, n. 17375, Cass.,
14 gennaio 2002, n. 349, in Giust. civ., 2002, I, 637, e Cass., 11 febbraio 2000, n. 1532 (che hanno stabilito che
l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, anche nel caso di pronuncia di rigetto della domanda,
estende i suoi effetti non solo alla decisione relativa al bene della vita chiesto dall’attore, ma anche a tutte le statuizioni
inerenti all’esistenza e alla validità del rapporto dedotto in giudizio necessarie ed indispensabili per giungere a quella
pronuncia). Significativo, in tal senso, anche l’orientamento secondo il quale il provvedimento giurisdizionale di merito,
pur quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o
di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i princìpi di diritto che ne costituiscono il
fondamento: Cass., 25 novembre 2010, n. 23918.
32
tuttavia, nella motivazione dell’ordinanza, si esprima nel senso della sussistenza della
subordinazione. Ad esempio, in un caso in cui il ricorrente, deducendo la qualificazione in termini
di subordinazione delle prestazioni lavorative da lui eseguite, chieda la condanna della controparte
alla reintegrazione sostenendo di essere stato licenziato verbalmente, il giudice dia atto nella
motivazione dell’ordinanza di rigetto che dall’istruttoria espletata emerge la natura subordinata del
rapporto, ma, ritenendo provato che il datore di lavoro abbia comunicato per iscritto il proprio
recesso, rigetti comunque la domanda del lavoratore. Qui dovrebbe escludersi che l’accertamento
della sussistenza della subordinazione acquisti la stabilità propria della cosa giudicata. Infatti, le
affermazioni formulate al riguardo nel provvedimento giudiziale non sono affatto legate alla
statuizione sull’inesistenza del diritto alla reintegrazione da un nesso tale che questa seconda non
sia concepibile prescindendo dalle prime, onde non è possibile predicare l’estensione dell’effetto di
stabilità anche all’accertamento del rapporto di lavoro subordinato72.
A questo punto, appare evidente come quanto appena esposto se, da un lato, costituisce la
piana applicazione di consolidati principi giurisprudenziali, dall’altro è fonte di gravi inconvenienti
in un modello processuale nel quale, come s’è visto (supra, n. 2), è esclusa in radice la possibilità di
realizzazione del simultaneus processus in caso di contemporanea pendenza di controversie legate
dal vincolo della pregiudizialità logica73.
Ed infatti, nel caso in cui sia controversa tra le parti la sussistenza di un rapporto di lavoro
subordinato (il che può avvenire per i motivi più vari: contestazione della natura subordinata delle
prestazioni eseguite, contestazione dello stesso svolgimento di attività lavorativa, contestazione
dell’imputabilità del rapporto di lavoro proprio alla parte contro al quale il lavoratore ha proposto la
domanda, ecc.), se il lavoratore sostenga di vantare una pluralità di diritti scaturenti da quel
rapporto, egli, tutte le volte in cui qualcuno di quei diritti trovi fonte nell’art. 18 della legge n. 300
del 1970, sarà costretto a introdurre almeno due controversie: una relativa alle domande di cui al
predetto art. 18, l’altra per avanzare tutte le altre pretese. In base ai principi ricordati, il giudicato
formatosi in entrambi i giudizi copre anche l’esistenza/inesistenza del rapporto di lavoro
subordinato e, in ipotesi di decisioni segno diverso, ecco che si verificherà il contrasto tra giudicati.
Al fine di evitare che si determini una simile, inaccettabile eventualità, possono essere
ipotizzate due soluzioni.
La prima è quella di ritenere che all’accertamento contenuto nel provvedimento conclusivo
della controversia di impugnazione del licenziamento dispieghi effetti propri della cosa giudicata
solamente rispetto allo specifico diritto contemplato dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970 azionato
dal lavoratore nella controversia, non anche relativamente all’esistenza o meno del rapporto di
lavoro subordinato dal quale quel diritto dovrebbe scaturire.
72
Del resto, opinare diversamente comporterebbe la necessità di ammettere l’esistenza dell’interesse del datore di
lavoro, pur pienamente vittorioso, ad impugnare un’ordinanza come quella ipotizzata nel testo, e ciò in contrasto con
l’altro orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’interesse all’impugnazione va apprezzato in
relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’accoglimento del gravame, e si collega alla soccombenza, anche
parziale, nel precedente giudizio, mancando la quale l’impugnazione è inammissibile; conseguentemente deve
escludersi l’interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare la sentenza al solo fine di ottenere una
modificazione della motivazione: Cass., 10 novembre 2008, n. 26921. Ciò anche se la parte prospetti l’utilità che
l’auspicata diversa motivazione potrebbe avere con riguardo ad eventuali altre controversie di natura simile: Cass., 13
maggio 1997, n. 4168.
73
Eventualità del resto non del tutto sconosciuta nell’ordinamento processuale. Si consideri, in proposito, il consolidato
orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nell’opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del
creditore opposto, nei cui confronti sia stata proposta dall’opponente domanda riconvenzionale, non determina
l’improcedibilità dell’opposizione e la rimessione dell’intera controversia al giudice fallimentare, rimanendo il
Tribunale ordinario competente per l’opposizione mentre al Tribunale fallimentare, previa separazione dei giudizi, deve
essere rimessa esclusivamente la domanda riconvenzionale: Cass., 27 maggio 2011, n. 11749; Cass., 14 settembre 2007,
n. 19290. Con la conseguente affermazione secondo la quale non sussiste alcuna possibilità di simultaneus processus tra
l’opposizione a decreto ingiuntivo in sede ordinaria e la controversia di natura fallimentare, vuoi che quest’ultima sia
già pendente presso il giudice del fallimento, vuoi che insorga nell’ambito dello stesso processo di opposizione: Cass.,
11 agosto 2000, n. 10692, in Giust. civ., 2001, I, 418.
33
Trattasi di un’impostazione che è stata sostenuta da un’isolata (a quanto consta) dottrina74 a
proposito dell’analogo problema che si pone nel procedimento sommario di cognizione rispetto alla
disposizione dell’art. 702-ter, quarto comma, c.p.c., secondo la quale, quando la domanda
riconvenzionale richiede un’istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione75. Essa
non pare soddisfacente perché, in primo luogo, non esclude il rischio che si diano pronunce tra esse
obiettivamente incompatibili: anche volendo negare che quella emanata nel giudizio di
impugnazione del licenziamento estenda la sua autorità al rapporto giuridico (quello di lavoro
subordinato) controverso, resta comunque che, se la successiva sentenza pronunciata nella causa
avente ad oggetto altro diritto fondato sulla pretesa esistenza del medesimo rapporto giuridico
pervenga a conclusione diversa appunto sull’esistenza di tale rapporto, si viene comunque a
determinare una situazione che, seppure non sarebbe qualificabile come contrasto di giudicati in
senso tecnico, è comunque intollerabile per l’ordinamento, poiché le controversie svolte hanno, in
un caso, accordato ciò che presuppone l’esistenza di un certo rapporto contrattuale e, in un altro,
negato l’esistenza di tale rapporto.
Senza contare il fatto che, considerato che anche il procedimento di impugnazione dei
licenziamenti consente (a partire dal giudizio di opposizione in poi) un accertamento pieno ed
approfondito dei fatti controversi nella causa, non si comprende davvero cosa giustificherebbe la
negazione, al provvedimento conclusivo di tale procedimento che abbia acquisito il carattere della
definitività, dell’autorità del giudicato nell’estensione generalmente riconosciuta alle sentenze
definitive, mentre tale autorità sarebbe conservata alla sentenza conclusiva dell’altra controversia
tra le stesse parti ed avente ad oggetto diritti diversi da quelli riconosciuti dall’art. 18 della legge n.
300 del 1970.
A fronte di simili difficoltà, l’unica strada percorribile resta allora quella di ritenere
applicabile l’istituto della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
Vale a dire che, riconosciuto che il giudicato formatosi nella controversia di impugnazione
del licenziamento si estende (alle condizioni prima viste) anche all’accertamento dell’esistenza o
inesistenza del rapporto di lavoro subordinato, ne consegue che, tutte le volte in cui tra le due parti
sia controversa l’esistenza di quel rapporto: a) nelle controversie aventi ad oggetto altri diritti
scaturenti da quel rapporto promosse dalle stesse parti successivamente alla formazione del
giudicato nella causa di impugnativa del licenziamento, il giudice è vincolato al predetto giudicato
che si estende anche all’esistenza (ovvero, alle condizioni sopra precisate, all’inesistenza) del
rapporto di lavoro subordinato; b) in caso di contemporanea pendenza delle due cause, se in una sia
già stata pronunciata una sentenza sottoposta ad impugnazione, il giudice dell’altra può sospenderla
ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c.; c) nel caso in cui le due cause pendano entrambe in
primo grado, quella avente ad oggetto diritti diversi da quelli di cui all’art. 18 deve essere sospesa in
attesa della definizione di quella di impugnazione del licenziamento.
Non ci si nascondono, peraltro, le difficoltà nelle quali incorre anche la soluzione qui
proposta.
In primo luogo, si deve riconoscere che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità,
l’art. 295 c.p.c. prevede la sospensione necessaria solamente in caso di pregiudizialità in senso
tecnico e non anche in quello di pregiudizialità in senso meramente logico76. E nel nostro caso –
come si è visto – è proprio quest’ultima l’ipotesi configurabile. E tale constatazione, tra l’altro, pone
il problema dell’individuazione di quale, tra le due cause, debba essere sospesa.
In secondo luogo, la stessa Suprema Corte ripete ormai da anni: che, nel quadro della nuova
disciplina di cui all’art. 42 c.p.c., come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non vi è più
spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal
74
G. SCARSELLI, Le altre impugnazioni e il giudicato, in Giur. it., 2010, 743.
Problema che, come si è visto (supra, n. 2) la dottrina assolutamente prevalente (v. nota 31) risolve in altra maniera,
inapplicabile al procedimento di cui qui si tratta.
76
Cass., 21 dicembre 2011, n. 27932; Cass., 25 maggio 2007, n. 12233; Cass., 16 marzo 2007, n. 6159.
75
34
giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale; che, dalla esclusione della configurabilità
di una sospensione facoltativa ope iudicis del giudizio, deriva come corollario l’impugnabilità, ai
sensi del citato art. 42, di ogni provvedimento di sospensione del processo, quale che ne sia la
motivazione; e che il ricorso deve essere accolto ogniqualvolta non si sia in presenza di un caso di
sospensione ex lege77.
Le considerazioni appena svolte, tuttavia, costituiscono un problema solamente rispetto
all’ipotesi enunciata in precedenza sub lettera c), cioè per il caso in cui la causa di impugnazione del
licenziamento e quella avente ad oggetto un diverso diritto in cui sia controversa l’esistenza del
rapporto di lavoro subordinato siano contemporaneamente pendenti in primo grado78.
Così limitato l’àmbito di rilevanza pratica del problema, si deve anche riconoscere la
sostanziale impossibilità di individuare una soluzione che sia allo stesso tempo coerente con tutti i
principi affermati dalla giurisprudenza in caso di pregiudizialità logica e rispettosa delle indicazioni
derivanti dal tenore letterale delle norme che compongono la disciplina del nuovo procedimento
introdotto dalla legge n. 92 del 2012. In effetti, l’esclusione del potere del giudice di sospendere il
processo al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 295 e la restrizione dell’àmbito di applicabilità di
quest’ultima disposizione alle ipotesi di pregiudizialità tecnica, appaiono del tutto logici e coerenti
in un sistema che, per le fattispecie di pregiudizialità logica, assicura, in caso di contemporanea
pendenza in primo grado delle due cause, il simultaneus processus (art. 39, secondo comma, c.p.c.)
e, nel caso invece in cui in una delle cause sia già stata pronunciata una sentenza, prevede – ove
questa sia non più impugnabile – il vincolo del giudicato a carico del giudice dell’altra causa e –
ove invece sia pendente un giudizio di impugnazione avverso quella sentenza – la sospensione ex
art. 337, secondo comma, c.p.c.
Ma la coerenza di un simile sistema è irrimediabilmente compromessa se la disciplina
propria del rito di cui si tratti, non solamente non assicura sempre e comunque il simultaneus
processus in caso di contemporanea pendenza in primo grado delle due cause legate dal vincolo
della pregiudizialità logica, ma, anzi, addirittura impone il processo separato.
Ed allora, tanto vale prendere atto dell’impossibilità della quadratura del cerchio e
rassegnarsi a sacrificare qualcuno dei tasselli che compongono il sistema congegnato dalle norme
del codice di rito, al fine di salvaguardare l’esigenza che appare irrinunciabile, vale a dire quella di
evitare il formarsi di giudicati contrastanti. Al riguardo sembra che il male minore sia appunto
quello di ammettere la possibilità di sospensione di una delle due cause, provvedimento che,
nell’àmbito del rito oggetto della presente trattazione appare consentito proprio perché,
contrariamente a quanto avviene rispetto alla disciplina processuale generale, esso non compromette
l’intima coerenza del sistema, ma, al contrario, la preserva. Quanto, poi, alla scelta di quale, tra le
due cause, debba essere quella soggetta a sospensione, si ritiene che essa debba essere quella in cui
non si faccia questione della legittimità del licenziamento e ciò per due motivi: primo, perché quella
soggetta al rito di cui alla legge n. 92 del 2012 dovrebbe tendenzialmente esaurirsi in tempi più
ristretti, in considerazione delle misure acceleratorie previste dal legislatore che, in parte, sono già
state esaminate e, in parte, saranno oggetto di analisi nel paragrafo 13; secondo, perché, in ragione
degli interessi coinvolti, è indubbio che la controversia sulla legittimità del licenziamento tollera
meno di qualsiasi altra causa di lavoro, una sospensione.
7. Questioni di rito.
77
Tra le tante, v. Cass., 25 novembre 2010, n. 23906; Cass., 31 gennaio 2007, n. 2089, in Dir. prat. soc., 2007, n. 19,
82; Cass., sez. un., 1° ottobre 2003, n. 14670, in Foro it., 2004, I, 1474.
78
Non sembra, invece, che vi siano ostacoli all’accettazione della soluzione indicata nel testo per l’ipotesi sub lettera b),
considerato che la giurisprudenza di legittimità afferma l’applicabilità dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., pure nei
casi in cui tra i due giudizi esista un nesso di pregiudizialità anche soltanto logico: Cass., 3 maggio 2007, n. 10185;
Cass., sez. un., 26 luglio 2004, n.14060, in Riv. giur. lav., 2005, 740.
35
7.1. L’applicabilità in via analogica dell’art. 4 d. lgs. n. 150 del 2011. – Nulla è disposto dal
legislatore per il caso in cui domande soggette al nuovo rito siano azionate con un ricorso ex art.
414 c.p.c., né per quello (inverso) in cui domande diverse da quella di impugnativa del
licenziamento siano proposte con ricorso formulato ai sensi dell’art. 1, comma 48, della legge n. 92
del 2012.
Al riguardo occorre anzitutto avvertire che l’erronea adozione del nuovo rito speciale
piuttosto che di quello lavoristico del codice di rito (e viceversa) non comporta, di per sé, alcun
conseguente problema di competenza, posto che, come segnalato, l’individuazione del giudice
competente a decidere la controversia avviene, nelle due ipotesi, sulla base dei medesimi criteri.
Ciò premesso, nel silenzio della legge n. 92 del 2012, si può volgere lo sguardo verso le
soluzioni adottate dal legislatore al fine di risolvere gli analoghi problemi che possono porsi in
controversie soggette a riti che presentano affinità con quello di cui qui si discute. Si tratta, in primo
luogo, degli artt. 426 e 427 c.p.c., i quali prevedono meccanismi diretti ad assicurare il semplice
mutamento di rito, tutte le volte in cui una causa relativa ad uno dei rapporti previsti dall’art. 409 sia
promossa nelle forme ordinarie ovvero una causa promossa secondo il rito del lavoro riguardi un
rapporto diverso da quelli di cui al citato art. 409. In secondo luogo, del secondo e del terzo comma
dell’art. 702-ter c.p.c.; la prima di tali disposizioni, nel caso di ricorso, da parte dell’attore, al
procedimento sommario di cognizione per far valere una domanda diversa da quelle per le quali tale
rito è applicabile, prevede la declaratoria di inammissibilità della domanda, con conseguente
conclusione del processo con una decisione in rito; la seconda, nel caso in cui il giudice si convinca
che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruttoria non sommaria, stabilisce la conversione del
rito. In terzo luogo, rileva la scelta operata dal legislatore del 2011 in sede di semplificazione dei riti
civili, il quale, all’art. 4 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, ha optato per la soluzione
del mutamento di rito tutte le volte in cui una delle controversie da trattare secondo uno dei modelli
considerati dal decreto sia promossa seguendo un rito diverso da quello stabilito dallo stesso decreto
legislativo per quella categoria di controversie.
E proprio quest’ultima disposizione assume rilevanza sotto un duplice profilo.
Innanzitutto, da essa può trarsi una conferma della tesi secondo la quale nel nostro
ordinamento è individuabile il principio generale per cui, in caso di erronea scelta del rito, opera la
regola del mutamento, invece che quella della conclusione della causa con una decisione di
inammissibilità79.
Inoltre, tra le diverse normative prima menzionate, l’unica che sembrerebbe attagliarsi ai
rapporti tra nuovo rito speciale e rito codicistico del lavoro sembra essere proprio l’art. 4 d. lgs. n.
150 del 2011. Ed invero, gli artt. 426 e 427 regolano i rapporti tra rito ordinario e rito del lavoro,
mentre qui quello che viene in rilievo è un rito a cognizione sommaria. L’art. 702-ter, dal canto suo,
disciplina solamente l’ipotesi in cui una domanda che avrebbe dovuto essere trattata seguendo il rito
ordinario o del lavoro (perché estranea a quelle sulle quali il tribunale giudica in composizione
monocratico ovvero perché richiedente una istruttoria non sommaria) sia stata invece proposta
secondo le regole del procedimento sommario di cognizione; inoltre la disciplina dettata da tale
norma si giustifica con il fatto che il procedimento sommario di cognizione è contemplato dal
codice di rito come oggetto di una scelta opzionale dell’attore, mentre invece, come si è detto
(supra, n. 1), il rito introdotto dalla legge n. 92 del 2012 è configurato dal legislatore come l’unico
cui le parti possono ricorrere in caso di impugnazione di un licenziamento ricadente nell’area di
applicabilità dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 (così come il rito codici stico del lavoro è
imposto dal legislatore alle parti in tutti gli altri casi di controversie in materia di rapporti di lavoro
subordinato).
79
A. CHIZZINI, Commento all’art. 1, in C. CONSOLO (diretto da), Codice di procedura civile commentato. La
«semplificazione dei riti» e le altre riforme processuali 2010-2011, Ipsoa, 2012, 19; BALENA, Le conseguenze
dell’errore sul modello formale dell’atto introduttivo (traendo spunto da un obiter dictum delle sezioni unite), in Giusto
proc., 2009, 661 ss.
36
Invece l’art. 4 del d. lgs. n. 150 del 2011, essendo diretto a risolvere le questioni di rito che
possono porsi in riferimento a qualsiasi ipotizzabile combinazione tra i tre riti presi in
considerazione dal decreto (quello ordinario, quello del lavoro e quello sommario di cognizione),
tutti concepiti dal legislatore come gli unici cui la parte può ricorrere nelle singole controversie
contemplate dallo stesso decreto legislativo, può ragionevolmente essere considerato come
espressione di principi sufficientemente generali da poter essere applicati in via analogica pure alle
questioni di rito connesse con il nuovo procedimento di impugnazione dei licenziamenti. Anche
perché i criteri che hanno ispirato il legislatore del 2011, così come si leggono nella Relazione
illustrativa al detto decreto legislativo80, appaiono sicuramente coerenti con la ratio dell’intervento
della legge n. 92 in materia processuale.
Non sembra che possa costituire ostacolo alla conclusione ora raggiunta l’orientamento
espresso dalla Suprema Corte a proposito del procedimento speciale ex artt. 28 e 29 della legge n.
794 del 1942, in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato, secondo il quale, quando
risulti l’inesistenza dei presupposti per l’applicazione di tale procedimento, deve essere dichiarata
esclusivamente l’inammissibilità del ricorso senza possibilità per il giudice di disporre la
conversione del rito in un ordinario giudizio di cognizione, presupponendo il mutamento del rito
l’esistenza di due procedimenti a cognizione piena, mentre lo speciale procedimento per la
liquidazione degli onorari è sommario e ha un oggetto diverso rispetto a quello per il quale si
procede con cognizione ordinaria81.
Ed in effetti, in primo luogo, è evidente la diversità della fattispecie oggetto delle pronunce
di legittimità appena richiamate con i casi, che qui interessano, dell’impugnazione del
licenziamento con ricorso ex art. 414 e della proposizione di domande estranee a quelle di cui
all’art. 1, comma 47, della legge n. 92 del 2012 con il ricorso di cui al successivo comma 48; in
questi casi, invero, non viene in rilievo alcun mutamento dell’oggetto del giudizio così come
inizialmente instaurato (seppur utilizzando un rito errato) dal lavoratore, onde non sussiste quello
che, nell’opinione dei giudici di legittimità, rappresenta il vero ostacolo alla conversione del rito
nell’ipotesi della liquidazione dei diritti ed onorari di avvocato.
In secondo luogo, si deve riconoscere che l’orientamento della Corte di cassazione in
questione si è formato in un contesto normativo che non comprendeva la fondamentale disposizione
dettata dall’art. 4 del d. lgs. n. 50 del 2011 successivamente introdotta dal legislatore, la quale ben
può essere considerata espressiva di un principio fondamentale dell’ordinamento
processualcivilistico al quale si può derogare solamente in presenza di norme che depongono
espressamente in senso diverso ovvero in caso di incompatibilità con la specifica natura del
procedimento di cui volta per volta si tratta.
Neppure paiono decisive le argomentazioni svolte in dottrina per sostenere che, nel
procedimento di cui trattasi, l’errore del rito dovrebbe condurre necessariamente a decisione in rito,
senza alcuna possibilità di pronuncia sul merito della controversia; ciò sulla base dell’elemento di
novità (rispetto agli altri casi in cui le parti possono incorrere in analoghi errori) rappresentato
dall’esistenza della “corsia preferenziale” prevista a favore delle cause relative alle impugnative dei
licenziamenti assistiti dalle tutele di cui all’art. 18 della legge n. 300 del 1970 che, favorendo chi
introduca tali tipi cause rispetto a chi ne introduca di diverse, assumerebbe una connotazione
accentuatamente pubblicistica, con l’ulteriore corollario secondo cui il giudice sarebbe abilitato a
80
«Nell’emanare una disciplina del mutamento di rito comune a tutte le fattispecie […] si è tenuto conto, per un verso,
dell’assenza di ragioni tali da dar luogo ad un favor assoluto per uno specifico modello procedimentale, e, per altro
verso, dell’esigenza di ridurre al minimo l’ambito temporale di incertezza sulle regole destinate a disciplinare il
processo, al fine di scongiurare vizi procedurali che, riverberandosi a catena su tutta l’attività successiva, possano far
regredire il processo, in contraddizione con i principi di economia processuale e di ragionevole durata sanciti dall’art.
111 della Costituzione».
81
Cass., 5 agosto 2011, n. 17053; Cass., 9 settembre 2008, n. 23344. Contra, in precedenza, Cass., 24 febbraio 2004, n.
3637; Cass., 27 febbraio 1995, n. 2229.
37
qualificare l’oggetto della controversia – ai fini dell’individuazione del rito correttamente
utilizzabile – anche in sede di decisione della causa82.
Si può replicare che nessuno nega la necessità di evitare abusivi e strumentali ricorsi al
nuovo rito; si tratta solamente di individuare la soluzione più corretta alla luce dei principi generali
dell’ordinamento e non si può mancare di osservare che sarebbe davvero singolare che un
ordinamento processuale che prevede meccanismi diretti a consentire la prosecuzione della causa
anche quando la parte attrice abbia errato addirittura nell’individuazione del giudice munito di
giurisdizione, impongano invece la chiusura della controversia con una decisione di mero rito
quando, nella ricorrenza di tutti i presupposti processuali, la parte abbia sbagliato solamente nella
scelta del modello dell’atto introduttivo della lite. La tesi qui propugnata, del resto, imponendo
l’immediata (vale a dire entro la prima udienza: v. infra) conversione del rito, impedisce alla parte
che abbia strumentalmente fatto ricorso al rito ex legge n. 92 del 2012 di approfittare in maniera
significativa del proprio volontario errore, posto che, come si vedrà, il giudice, nel mutare il rito,
dovrà comunque assegnare alle parti termine per l’integrazione degli atti con conseguente rinvio
dell’udienza e perdita del vantaggio eventualmente conseguito dal ricorrente in sede di fissazione
dell’udienza di comparizione.
7.2. Il contenuto dell’ordinanza di mutamento di rito. – Venendo ora alla disciplina
contenuta nell’art. 4 del d. lgs. n. 150 del 2011, essa prevede, quale regola generale, che, quando
una controversia è promossa in forme diverse da quelle per essa prescritte, «il giudice dispone il
mutamento di rito con ordinanza» (comma 1) e, quale regola particolare, che, nel caso in cui la
controversia debba essere trattata applicando il rito del lavoro, «il giudice fissa l’udienza di cui
all’articolo 420 del codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti devono
provvedere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante il deposito di memorie e
documenti in cancelleria» (comma 3).
Entrambe tali disposizioni sono suscettibili di applicazione alle questioni di rito che possono
presentarsi in riferimento al nuovo procedimento di impugnazione dei licenziamenti.
Precisamente: il comma 3 viene in rilievo nell’ipotesi in cui la domanda formulata nel
ricorso proposto ai sensi dell’art. 1, comma 48, della legge n. 92 del 2012 sia diversa
dall’impugnazione di un licenziamento rientrante nelle ipotesi regolate dall’art. 18 della legge n.
300 del 1970 e, concernendo uno dei rapporti di cui all’art. 409 c.p.c., debba essere trattata con il
rito previsto dal codice di rito per le controversie individuali di lavoro; in tal caso, pertanto, il
giudice fisserà l’udienza di discussione di cui all’art. 420 c.p.c., assegnando un primo termine
perentorio al ricorrente per l’integrazione degli atti difensivi e dei documenti ed un secondo termine
al convenuto per replicare a tale integrazione.
Invece la regola espressa dal comma 1 si applica nel caso in cui l’impugnazione di un
licenziamento soggetta al nuovo rito sia proposta con un ricorso formulato ai sensi dell’art. 414
c.p.c. In questo caso non vi sarà alcuna necessità di fissare una nuova udienza, né tantomeno di
concedere termine per eventuali integrazioni difensive. Infatti, in virtù delle disposizioni che
regolano la costituzione delle parti nel rito del lavoro codicistico, le parti avranno già
esaurientemente svolto le loro argomentazioni difensive e formulato le loro richieste istruttorie. E
comunque, se pure intendessero proporne di ulteriori (ammissibili, come s’è detto, nel nuovo rito:
v., supra, n. 4), non v’è alcuna necessità di fissare all’uopo una nuova udienza, ben potendo la parte
esercitare tale facoltà nel corso della stessa prima udienza di comparizione.
A questo punto, tuttavia, le parti potranno eventualmente manifestare al giudice la loro
comune volontà di omettere la prima fase “urgente” del nuovo rito e di proseguire la causa, sempre
in ossequio alle regole dettate dalla legge n. 92 del 2012, ma a partire dalla fase regolata dai commi
51 ss. dell’art. 1. Se si concorda con quanto esposto nel paragrafo 1 circa la facoltà che deve essere
riconosciuta alle parti al riguardo, il giudice, a fronte dell’esercizio di una simile opzione, disporrà
82
L. DE ANGELIS, op. cit., 15.
38
di conseguenza (vale a dire che, pur convertendo il rito, procederà secondo le regole della fase di
opposizione che, come detto, in poco si distinguono da quelle proprie dell’ordinario rito codici stico
del lavoro).
Nel caso di contumacia del convenuto, l’ordinanza di mutamento del rito deve essere
comunicata alla parte contumace, in applicazione del principio espresso dalla giurisprudenza di
legittimità83 e costituzionale84 rispetto all’analogo provvedimento pronunciato ai sensi dell’art. 426
c.p.c.
7.3. Il regime dell’ordinanza di mutamento del rito. – Se si ammette l’applicazione in via
analogica della disciplina prevista dal d. lgs. n. 150 del 2011, dovrebbero ritenersi estese alla
fattispecie qui esaminata anche le disposizioni dettate dagli altri commi dell’art. 4.
In particolare, il comma 2 definisce il regime dell’ordinanza di mutamento del rito,
disponendo che essa «viene pronunciata dal giudice, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di
comparizione delle parti». Questo limite temporale è stato variamente interpretato in dottrina.
Precisamente, accanto a chi sostiene che la chiara lettera della norma imporrebbe di ritenere che la
prima udienza di comparizione delle parti costituisce il momento oltre il quale è precluso, non
solamente alle parti formulare eccezioni circa la correttezza del rito adottato, ma anche al giudice di
disporre il mutamento del rito85, vi è chi, mosso dalla preoccupazione di evitare che i ritardi del
giudice ricadano sulla parte che abbia tempestivamente eccepito l’erroneità del rito, propone
un’interpretazione che ammette che, in tutti i casi in cui la questione della correttezza del rito sia
stata tempestivamente sollevata alla prima udienza, l’ordinanza di mutamento del rito possa essere
pronunciata anche fuori udienza se, entro la prima udienza, il giudice si riservi la decisione sul
punto86; ancor più radicalmente contrastante con la lettera della norma è, poi, la tesi, largamente
diffusa, secondo cui il giudice potrebbe pronunciare sull’eccezione tempestivamente sollevata
anche in un’udienza successiva «eventualmente fissata dal giudice per provvedere sul tema»87 o
addirittura in sede di decisione della causa88.
Analoghe divergenze sono riscontabili in dottrina circa la revocabilità dell’ordinanza di
mutamento del rito89 e la possibilità per le parti di dolersi in sede di gravame dell’ordinanza
pronunciata sulla questione di rito (purché tempestivamente sollevata)90.
83
Cass., 8 gennaio 2010, n. 77; Cass., 6 novembre 2008, n. 26611 (che ha precisato che la mancata comunicazione può
essere eccepita solo dal soggetto interessato – ossia il contumace che si costituisca successivamente – e non dalla parte
già costituita, che non vi ha interesse se non è compromesso il suo diritto di difesa); Cass., 13 febbraio 1985, n. 1209.
84
Corte cost., 14 febbraio 1977, n. 14, in Foro it., 1977, I, 259, con riferimento, peraltro, alle cause pendenti al
momento dell’entrata in vigore della legge n. 533 del 1973 per le quali era pronunciata l’ordinanza che fissava l’udienza
di discussione ex art. 420 c.p.c. ed il termine perentorio per l’integrazione degli atti.
85
R. TISCINI, Commento all’art. 4, in B. SASSANI-R. TISCINI (a cura di), La semplificazione dei riti civili, Dike,
2011, 47 (la quale evidenzia anche aspetti dei lavori preparatori che deporrebbero per la sicura volontà del legislatore in
tal senso), e, sembra, anche F. COSSIGNANI, Note sul mutamento del rito ex art. 4 D.Lgs. n. 150/2011, in Giur. it.,
2012, 1389.
86
C. CONSOLO, Prime osservazioni introduttive sul d. lgs. n. 150/2011 di riordino (e relativa «semplificazione») dei
riti settoriali, in Corr. giur., 2011, 1489; L. PENASA, Commento all’art. 4, in C. CONSOLO (diretto da), Codice di
procedura civile commentato, cit., 50.
87
Così A. SALETTI, La semplificazione dei riti, in Dir. proc., 2012, 737.
88
Affermano che, più in generale, il giudice possa decidere sulla questione del mutamento di rito, tempestivamente
rilevata, in un momento successivo alla prima udienza: F.P. LUISO, Diritto processuale civile, IV, Giuffré, 2011, 110;
M. BOVE, Applicazione del rito lavoro nel d. lg. n. 150 del 2011, in Giusto proc., 2011, 1003; S. IZZO, Mutamento di
rito, in Foro it., 2012, V, 85; A. CARATTA, La «semplificazione» dei riti e le nuove modifiche del processo civile,
Giappichelli, 2012, 76, nt. 117.
89
Negata da C. CONSOLO, op. cit., 1489; F. COSSIGNANI, op. cit., 1389; L. PENASA, op. cit., 54. Ammessa,
invece, da A. SALETTI, op. cit., 738; S. IZZO, op. cit., 85; M. BOVE, op. cit., 1003.
90
Anche al riguardo, negativa l’opinione di C. CONSOLO, op. cit., 1489, che ammette la possibilità per la parte di
dolersi in sede di impugnazione solamente della omessa pronuncia del giudice sulla eccezione di erroneità del rito da
essa tempestivamente sollevata (conforme L. PENASA, op. cit., 51). Positiva quella di A. SALETTI, op. cit., 738;
BOVE, op. cit., 1003. Di quest’ultima opinione sono anche F.P. LUISO, op. ult. cit., 111, F. COSSIGNANI, op. cit.,
39
Si può ricordare, in proposito, l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità in
riferimento ad analoghe disposizioni legislative che individuano nella «prima udienza di
discussione» il limite entro il quale il giudice può “rilevare” l’improcedibilità della domanda per il
mancato esperimento di adempimenti che debbono precedere l’instaurazione della controversia91.
Rispetto a tali disposizioni la Suprema Corte ha costantemente affermato che ove l’improcedibilità
dell’azione, ancorché segnalata dalla parte, non venga rilevata dal giudice entro il suddetto termine
la questione non può essere riproposta nei successivi gradi del giudizio92.
Non si può negare la diversità delle fattispecie ora menzionate rispetto a quella della corretta
scelta del rito. Invero, nei casi di mancato adempimento dell’onere del preventivo tentativo di
conciliazione o mancato esaurimento del procedimento amministrativo, si è in presenza solamente
dell’omissione di una condizione di procedibilità dell’azione che non si può riverberare in alcuna
maniera su attività e facoltà defensionali delle parti nel processo; si giustifica, pertanto, la
prevalenza riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità all’esercizio dell’azione (nel senso,
appunto, che, se il giudice non abbia tempestivamente rilevato la causa di – temporanea –
improcedibilità ed abbia dato corso alla trattazione della causa – il cui svolgimento è regolato dalle
medesime norme tanto nel caso in cui il tentativo di conciliazione sia stato esperito, quanto nel caso
in cui non lo sia stato – non v’è ragione per far regredire il processo).
Proprio tale constatazione, tuttavia, rende evidente come il predetto orientamento di
legittimità sia espressivo di una tendenza giurisprudenziale diretta a privilegiare soluzioni
interpretative che, senza incidere sulla esplicazione del diritto di difesa delle parti, “sterilizzino”,
una volta esaurita la fase dei primi adempimenti preliminari alla trattazione della causa, questioni
estranee al merito della controversia la cui risoluzione in un verso o nell’altro, è del tutto neutra
rispetto all’attività difensiva delle parti, evitando così che esse possano determinare rallentamenti o
regressioni del procedimento difficilmente compatibili con il principio costituzionale del giusto
processo e della sua ragionevole durata.
In un simile quadro, allora, ci si deve chiedere se il fatto che il giudice del lavoro,
nonostante la tempestiva eccezione sollevata sul punto dalla parte, abbia trattato con il rito ex legge
n. 92 del 2012 domande diverse da quelle proponibili secondo tale rito ovvero abbia trattato
secondo la disciplina codicistica un’impugnazione di licenziamento ricadente nell’area di
applicabilità dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, sia idoneo a condizionare i poteri e i diritti di
difesa delle parti.
La risposta all’interrogativo dovrebbe essere negativa, considerato che, con specifico
riferimento all’attività difensiva delle parti, la diversità tra i due riti (quello ex legge n. 92 del 2012
e quello codicistico del lavoro), si riduce a poco più che la previsione, nel primo, della iniziale fase
“urgente”, le differenze quasi annullandosi dalla fase di opposizione in poi. Onde si può
tranquillamente escludere che possano darsi casi in cui l’adozione di un rito piuttosto che un altro
giochi un ruolo determinante nella soccombenza di una delle parti.
Ed allora, in coerenza con il già segnalato elemento testuale offerto dall’art. 4 d. lgs. n. 150
del 2011 (che, con formulazione ancor più pregnante rispetto a quelle delle norme in tema di
esaurimento del procedimento amministrativo e di tentativo obbligatorio di conciliazione prima
1389, e IZZO, op. cit., 85, che però limitano la possibilità di censurare in sede di gravame l’ordinanza sul rito alle sole
ipotesi in cui l’erroneità del rito non rilevata dal giudice nonostante la tempestiva proposizione della questione abbia in
concreto svolto un ruolo nella soccombenza della parte, avendone limitato l’attività difensiva. Anche L. DE ANGELIS,
op. cit., 16, seppure nell’ottica della sua particolare impostazione della quale si è dato conto in precedenza (v. nota 95),
sostiene che la questione dell’erroneità del rito possa essere dedotta quale motivo di opposizione solamente quando
l’errore abbia cagionato uno specifico pregiudizio alla parte.
91
Art. 443 c.p.c., in tema di esaurimento dei procedimenti amministrativi in materia di previdenza e assistenza
obbligatorie; art. 5 legge 11 maggio 1990, n. 108, in tema di tentativo obbligatorio di conciliazione per l’impugnazione
del licenziamento nelle piccole imprese.
92
V., in riferimento all’art. 5 della legge n. 108 del 1990, tra le altre, Cass., 8 agosto 2003, n. 12010, e Cass., 1° agosto
2000, n. 10089, in Giur. it., 2002, 74. Rispetto all’art. 443 c.p.c., Cass., 9 maggio 2002, n. 6673, e Cass. 6 febbraio
1988, n. 1312.
40
menzionate, impone che alla prima udienza il giudice, non si limiti a “rilevare” la questione, ma
addirittura pronunci il conseguente provvedimento di conversione del rito), sembra possibile
concludere nel senso che l’ordinanza di conversione del rito (da art. 1 legge n. 92 del 2012 ad artt.
409 ss c.p.c. e viceversa) non sia né revocabile, né suscettibile di rimeditazione nei successivi fasi e
gradi della causa.
E’ stato segnalato come l’art. 4 del d. lgs. n. 150 del 2011 nulla disponga in ordine al dies ad
quem per la pronuncia sul rito, onde si pone il problema se il giudice possa stabilire il mutamento di
rito anche prima dell’udienza e, in particolare, con lo stesso decreto che fissa la prima udienza93.
Al riguardo si segnala l’esistenza di qualche precedente nel senso, appunto, secondo il quale
l’art. 4 consentirebbe la pronuncia dell’ordinanza di mutamento del rito anche d’ufficio, prima
dell’udienza, senza che sia necessaria la preventiva instaurazione del contraddittorio94.
La dottrina ha assunto una posizione generalmente critica nei confronti di tale orientamento
giurisprudenziale, sulla base di argomenti che appaiono pienamente condivisibili. In particolare, si è
giustamente sottolineato come la norma richiami espressamente la forma dell’ordinanza (che, in
generale, presuppone l’instaurazione del contraddittorio) e come non vi sia ragione per sacrificare la
esigenza (fondamentale nel processo) di salvaguardare il contraddittorio, a mente dell’art. 101,
secondo comma, c.p.c., anche su tale specifico profilo95. Trattasi di considerazioni pienamente
valide anche nel caso di mutamento di rito nelle ipotesi qui esaminate e dunque si deve escludere
che il giudice possa disporre al riguardo già in sede di fissazione della prima udienza ai sensi
dell’art. 1, comma 48, legge n. 92 del 2012 o dell’art. 415 c.p.c.
7.4. Il cumulo di domande. – Quanto detto sinora vale per i casi in cui il rito scelto dal
ricorrente sia erroneo rispetto a tutte le domande proposte dalla parte (onde l’ordinanza di
mutamento del rito ha necessariamente l’effetto di individuare il rito corretto per tutte le domande
oggetto del giudizio).
Ma può ben darsi che, invece, il lavoratore proponga con il suo unico ricorso una pluralità di
domande, alcune delle quali soggette al rito ex legge n. 92 e altre soggette al rito lavoristico
codicistico (ad esempio, impugnazione del licenziamento con richiesta di applicazione di una o più
delle tutele di cui all’art. 18 e, contestualmente, domanda di condanna del datore di lavoro al
pagamento di differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori). In tal caso, quale che
sia il rito prescelto, esso sarà corretto per alcune domande ed erroneo per altre.
Si tratta di chiarire quali siano i rimedi in simili evenienze.
Si può tranquillamente escludere, anzitutto, la possibilità di far ricorso alla disciplina dettata
dall’art. 40 c.p.c., la quale, come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, si
applica, non in qualsiasi caso di processo cumulato, ma solamente nelle ipotesi di connessione
qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. (ipotesi a nessuna delle quali possono essere
ricondotte le fattispecie di cui si sta parlando); in particolare, l’art. 40 non si applica nell’ipotesi di
cui all’art. 104 c.p.c., in cui il cumulo delle domande dipende solamente dalla volontà delle parti (e
tale è, appunto, il caso che qui interessa); con l’ulteriore conseguenza che, ove siano proposte nello
stesso processo più domande contro lo stesso convenuto che però non siano legate dai vincoli di cui
ai predetti artt. 31, 32, 34, 35 e 36, non si può dar luogo ad alcun mutamento di rito per qualcuna di
esse96.
La soluzione si deve dunque fondare su altre disposizioni ed è diversa a seconda dei casi.
93
A.CARATTA, op. cit., 76.
Trib. Varese, 10 novembre 2011, in Foro it., 2011, I, 3449; Trib. Lamezia Terme, 9 novembre 2011, in Giur. it.,
2012, 1384.
95
A. CARATTA, op. cit., 78; F.P. LUISO, op. ult. cit., 110; S. IZZO, op. cit., 85; M. BOVE, op. cit., 1003; L.
PENASA, op. cit., 51. V. anche le considerazioni svolte da F. COSSIGNANI, op. cit., 1387.
96
Cass., 29 gennaio 2010, n. 2155, in Dir. fam., 2011, 93; Cass., 25 marzo 2003, n. 4367; Cass., 19 dicembre 1996, n.
11390.
94
41
In particolare, nell’ipotesi in cui un ricorso formulato ai sensi dell’art. 1, comma 48, legge n.
92 del 2012 contenga, oltre all’impugnazione del licenziamento, altre domande non fondate sui
medesimi fatti costitutivi, l’unica soluzione che sembra coerente con la disciplina del nuovo rito
definita dal legislatore è quella in base alla quale il giudice, con l’ordinanza conclusiva della fase
“urgente”, decide nel merito le domande ammissibili e dichiara l’inammissibilità di tutte le altre.
Non appare possibile, invece, una separazione delle cause con conversione del rito per quelle extra
art. 1, comma 48. Infatti, come segnalato (supra, n. 7), la separazione delle cause è prevista
unicamente per il caso in cui, nella fase di opposizione, siano proposte domande riconvenzionali
non fondate su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale (comma 56).
Invece la disciplina del nuovo rito depone chiaramente nel senso dell’assoluta inammissibilità, nella
prima fase, di domande riconvenzionali (fondate o meno che siano su fatti costitutivi identici a
quelli della domanda di impugnativa del licenziamento). La normativa dettata dalla legge n. 92 del
2012, dunque, offre chiari ed inequivoci elementi che depongono nel senso dell’incompatibilità con
il nuovo rito di qualsiasi “complicazione” della prima fase, la quale è finalizzata esclusivamente alla
delibazione della domanda di impugnazione del recesso datoriale (e, per comprensibili ragioni di
economia processuale, di quelle fondate sui medesimi fatti costitutivi), con inevitabile dichiarazione
di inammissibilità per tutte le altre domande eventualmente formulate dalle parti97.
Anche il capo dell’ordinanza conclusiva della fase “urgente” contenente la dichiarazione
dell’inammissibilità delle domande estranee al rito ex legge n. 92 del 2012 dovrebbe essere
opponibile98. L’impugnazione, infatti, che ben potrebbe essere respinta, ove fosse accolta
determinerebbe non certo la regressione del giudizio alla fase “urgente”, bensì la semplice
trattazione delle domande in questione nel giudizio di opposizione, cioè in un procedimento
largamente sovrapponibile a quello proprio del giudizio di primo grado secondo l’ordinaria
disciplina codicistica delle controversie individuali di lavoro; ad allora appare evidente la
convenienza per la parte di presentare direttamente un ordinario ricorso ex art. 414 c.p.c., potendo
in questa maniere ottenere sicuramente il medesimo risultato che, impugnando invece il relativo
capo dell’ordinanza conclusiva della prima fase, sarebbe meramente eventuale, rimesso com’è alla
decisione del giudice dell’opposizione. L’unico vantaggio che la parte consegue scegliendo questa
seconda strada è quello (comunque non trascurabile) di concentrare nello stesso procedimento
giudiziario tutte le proprie domande.
Nel caso opposto in cui, invece, il lavoratore proponga un ricorso ex art. 414 c.p.c. nel quale,
oltre a domande alle quali si applica il rito codicistico delle controversie individuali di lavoro,
formuli anche domande di impugnazione del licenziamento, non sembra che sussistano ostacoli
affinché il giudice (dopo aver fissato l’udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. con il decreto di cui
all’art. 415 c.p.c.) disponga, alla prima udienza, la separazione delle cause e, quindi, proceda alla
conversione del rito limitatamente alla causa avente ad oggetto la domanda di applicazione delle
tutele di cui all’art. 18 della legge n. 300 del 1970 e le altre eventualmente consentite dall’art. 1,
comma 48, legge n. 92 del 2012 (e, anche qui, le parti potranno manifestare la volontà di omettere
la fase “urgente”), proseguendo la trattazione secondo il rito codicistico per tutte le altre domande.
7.5. Il regime degli effetti della domanda. – Ribadito che nel caso dell’impugnazione dei
licenziamenti l’errore nel rito non può mai comportare conseguenze sulla competenza del giudice
adito (con connessa inapplicabilità alla fattispecie del comma 4 dell’art. 4 del d. lgs. n. 150 del
2011, il quale disciplina appunto tale evenienza), resta da esaminare il comma 5 del predetto art. 4,
composto da due periodi.
97
Conforme, sulla base di argomentazioni analoghe, L. CAVALLARO, op. cit., 6.
Al riguardo, se si vuole, può valorizzarsi anche la differenza rispetto alla disposizione dettata dall’art. 702-ter,
secondo comma, c.p.c., che, nell’analoga fattispecie che si verifica quando, nel procedimento a cognizione sommaria
vengono proposte domande che non possono essere trattate con tale rito, qualifica espressamente come non impugnabile
l’ordinanza con la quale il giudice dichiara inammissibili tali domande.
98
42
A norma del primo, «gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono
secondo le norme del rito seguito prima del mutamento». Ciò comporta, tra l’altro, che l’erronea
scelta del rito per la proposizione dell’impugnazione giudiziale di un licenziamento (impugnazione
con ricorso ex art. 414 c.p.c. di un licenziamento che rientra nell’ambito di applicabilità dell’art. 18
della legge n. 300 del 1970, ovvero impugnazione con ricorso ex legge n. 92 del 2012 di un
licenziamento estraneo alle tutele offerte dalla predetta norma statutaria) non ha conseguenze
sull’impedimento della decadenza prevista dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966, effetto che non
viene meno in caso di conversione del rito (a condizione, ovviamente, che il ricorso introduttivo
rispetti le altre condizioni di validità previste dall’ordinamento per quell’atto).
7.6. Il regime delle preclusioni e delle decadenze. – Il secondo periodo del comma 5
stabilisce invece che «restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del
rito seguito prima del mutamento». Una simile disposizione non ha alcuna pratica conseguenza in
caso di conversione del rito da quello speciale di cui alla legge n. 92 del 2012 a quello codicistico
del lavoro (appunto perché il primo non prevede decadenze e preclusioni collegate ai primi atti
defensionali di ricorrente e resistente, onde è impossibile che, nel momento in cui il giudice
pronuncia l’ordinanza di mutamento del rito, si siano verificati effetti preclusivi a danno delle parti).
Discorso diverso vale, ovviamente, nel caso opposto, le parti ben potendo essere già incorse
in preclusioni e decadenze ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c. La rigida applicazione dell’art. 4,
comma 5, d. lgs. n. 150 del 2011, comporterebbe la conseguenza secondo la quale le preclusioni già
maturate in applicazione delle predette norme codicistiche rimarrebbero ferme anche dopo la
conversione del rito (con conseguente impossibilità per le parti di formulare, ad esempio, nuove
richieste istruttorie).
Orbene, in sede di commento del citato art. 4, comma 5, la dottrina ha unanimemente
criticato la disposizione, evidenziando come essa finisca per ledere il diritto di difesa soprattutto del
convenuto, il quale, pur avendo semplicemente subito (e non determinato) l’errore sulla scelta del
rito compiuto dall’avversario, è costretto a sopportare anche le conseguenze – per lui eventualmente
sfavorevoli – sul piano delle preclusioni che derivano da quell’errore, il quale potrebbe esser stato
anche non involontario (avendo il ricorrente inteso agire con il ricorso laburistico al fine di ottenere
effetti massimamente preclusivi)99.
Non sembra, però, che un simile effetto si possa produrre anche nelle controversie regolate
dal nuovo rito per l’impugnazione dei licenziamenti (e ciò indipendentemente dall’adesione o meno
alle soluzioni escogitate da una parte della dottrina per ridurre, in generale, la portata del precetto
espresso dall’art. 4, comma 5, d. lgs. n. 150 del 2011100). Ed infatti, non si vede come possa essere
ritenuta compatibile con un rito nel quale le parti sono ammesse, nella fase di opposizione, a
sollevare eccezioni e formulare istanze istruttorie trascurate nella fase “urgente”, una norma (quella
espressa dall’art. 4, comma 5, secondo periodo) che precluderebbe alle parti di proporre le
medesime eccezioni e richieste istruttorie già nella fase “urgente” per il solo fatto che tali facoltà
non siano state esercitate nei rispettivi primi atti difensivi compiuti (per errore) secondo il rito delle
controversie individuali di lavoro.
99
A. CARATTA, op. cit., 81; A. SALETTI, op. cit., 739; C. CONSOLO, op. cit., 1490.
V. F. COSSIGNANI, op. cit., 1389, che prospetta un’interpretazione secondo la quale il predetto comma 5 sarebbe
applicabile solamente all’attore, trattandosi di comportamento autoresponsabile, mentre per il convenuto dovrebbe
valere la regola secondo la quale il passaggio da un rito all’altro non consentirà il compimento solamente degli atti
ormai preclusi in entrambi i riti interessati, non anche di quelli ancora possibili per il rito ad quem; ove una simile
interpretazione fosse rifiutata, lo stesso Autore sostiene che dovrebbe allora essere consentito al convenuto di
recuperare le facoltà precluse in base al rito a quo mediante l’istituto della rimessione in termini ai sensi dell’art. 153,
ultimo comma, c.p.c. Per L. PENASA, op. cit., 60, resterebbero ferme le sole preclusioni che trovano una loro esatta
corrispondenza nel rito ad quem. Maggiormente persuasiva l’opinione di A. CHIZZINI, op. cit., 19, secondo il quale
nessuna preclusione processuale potrebbe maturarsi a danno del convenuto che già nel primo scritto difensivo abbia
sollevato la questione del rito, senza attendere la prima udienza.
100
43
Altrimenti detto: ricordato che l’art. 4 del d. lgs. n. 150 del 2011 si applica alle questioni di
rito relative alla scelta tra nuovo procedimento giudiziale di impugnazione dei licenziamenti e rito
codicistico del lavoro non in via diretta, ma solamente per analogia, è corretto escludere tale
possibilità di applicazione per quei precetti contenuti nel predetto art. 4 che appaiono incompatibili
con la specifica disciplina del nuovo rito ex legge n. 92 del 2012. Tra questi ultimi va annoverata,
per la ragione appena detta, anche la disposizione secondo la quale restano ferme preclusioni e
decadenze maturate, prima della pronuncia di mutamento del rito, sulla base del rito erroneamente
scelto dal ricorrente.
8. Rapporti con gli altri riti previsti dall’ordinamento.
Quanto ai rapporti del nuovo rito introdotto dal legislatore del 2012 con altri procedimenti
giudiziali, deve dirsi che, contrariamente a quanto sostenuto da qualcuno101, continuano ad essere
ammissibili quelli cautelari disciplinati dagli artt. 669-bis ss. c.p.c. e, in particolare, quelli diretti ad
ottenere la concessione di provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c.102.
In effetti, il provvedimento emanato all’esito della prima fase del procedimento previsto
dall’art. 1 della legge n. 92 del 2012 non ha natura cautelare, potendo il giudice concedere al
lavoratore una delle tutele contemplate nell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 indipendentemente
dalla ricorrenza di esigenze cautelari, le quali, non costituendo uno dei presupposti dell’azione, non
debbono neppure essere dedotte dal ricorrente.
Una rilevanza della nuova procedura sul piano della tutela cautelare cui può aspirare il
lavoratore licenziato può cogliersi, piuttosto che sul piano dell’astratta giuridica ammissibilità di
quest’ultima, sul piano pratico dell’effettiva possibilità di ritenere sussistenti, nelle singole
fattispecie, il requisito del periculum in mora. In effetti, questo indefettibile requisito dei
provvedimenti ex art. 700 c.p.c. potrà ora essere ritenuto sussistente solamente se il lavoratore
dimostri che il proprio diritto è soggetto al rischio di subire un’irrimediabile lesione anche durante il
contenuto periodo di tempo previsto dall’art. 1 della legge n. 92 del 2012 per l’esaurimento della
prima fase del nuovo procedimento103. E’ ovvio, tuttavia, che una simile prognosi dovrà essere
formulata dal giudice, non già tenendo conto del termine stabilito in astratto dalla predetta norma,
bensì dei tempi di definizione della prima fase di tali procedimenti effettivamente riscontrabili nella
prassi dell’ufficio giudiziario di cui volta per volta si tratta, non essendo ovviamente consentito
negare la tutela cautelare sulla base di valutazione di dati puramente astratti e contrastanti con quelli
offerti dalla realtà.
Ciò posto, occorre ora chiedersi se, una volta esperita l’azione cautelare, la parte interessata
(vale a dire il lavoratore, in caso di esito per lui sfavorevole della procedura cautelare, ovvero il
datore di lavoro che intenda ottenere la rimozione dell’ordine di reintegrazione ottenuto dalla
controparte appunto in sede cautelare) debba promuovere il giudizio di merito seguendo le
disposizioni del rito del lavoro codicistico ovvero quelle proprie dello speciale procedimento
regolato dall’art. 1 della legge n. 92 del 2012 (problema che può porsi anche nel caso in cui il
lavoratore abbia attivato la procedura cautelare prima dell’entrata in vigore della legge n. 92 e il
conseguente ricorso ordinario sia invece proposto dopo il 17 luglio 2012).
Si potrebbe essere indotti a seguire la prima delle due soluzioni prospettate, sulla scorta della
considerazione secondo cui, in simili ipotesi, in realtà si è già svolta tra le parti una causa
caratterizzata da cognizione sommaria e concentrazione dei tempi, onde non avrebbe senso ritenere
applicabile il rito previsto dal legislatore del 2012, il quale comporterebbe la necessità di esperire
101
G. TREGLIA, op. cit., 768.
Così anche A. VALLEBONA, op. cit., 75; D. BORGHESI, op. cit., 916; L. CAVALLARO, op. cit., 4.
103
In tal senso Trib. Roma, 1° ottobre 2012, Est. Buconi, D.G.C. c. B.P.L. s.p.a.
102
44
un’ulteriore fase processuale a cognizione sommaria e dai tempi estremamente concentrati, prima di
poter finalmente accedere ad un giudizio (quello di opposizione) a cognizione piena.
Altre e più significative considerazioni depongono tuttavia nel senso opposto.
Ed in effetti, in primo luogo, sul piano letterale, il tenore dell’art. 1 della legge n. 92 del
2012 non sembra consentire eccezioni di tal genere, stabilendo il comma 47, come già ricordato,
che sono soggette al nuovo rito speciale le «controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei
licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300» ed è
indubbio che anche quelle promosse all’esito di un procedimento cautelare sono «controversie
aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti».
In secondo luogo, e soprattutto, deve considerarsi che la nuova procedura prevede
significativi tratti di specialità rispetto a quella degli artt. 409 ss. c.p.c. anche nelle fasi e nei gradi a
cognizione piena, e ciò sempre in vista dell’obiettivo della riduzione dei tempi processuali, onde
non sembra consentito – nelle vertenze iniziate con la proposizione di un ricorso in via cautelare –
sacrificare radicalmente le esigenze di accelerazione del contenzioso relativo all’art. 18 della legge
n. 300 del 1970 che, come detto, costituiscono la ratio delle novità introdotte dal legislatore del
2012 in materia processuale.
Si potrebbe allora ritenere che, per salvaguardare le esigenze da ultimo menzionate, la parte
ricorrente dovrebbe seguire le disposizioni previste dall’art. 1 della legge n. 92 del 2012, ma
omettendo la prima fase e proponendo così la propria azione nei modi previsti dal comma 51 del
predetto art. 1 per il giudizio di opposizione (ovviamente senza essere vincolata ai termini ivi
stabiliti).
Tuttavia si deve riconoscere che il ricorso cautelare potrebbe esser stato respinto per difetto
del requisito del periculum in mora, onde la soluzione appena prospettata finirebbe per lasciare il
lavoratore privo della possibilità di ottenere un provvedimento favorevole all’esito della prima fase,
pur sussistendone le condizioni.
Ed allora, pur nella consapevolezza del rischio che in alcuni casi si potrà verificare una
duplicazione di giudizi a carattere sommario, sembra che la soluzione maggiormente rispettosa
degli interessi delle parti coinvolte e dell’intento del legislatore (oltre che quella più semplice sul
piano pratico) sia quella di ritenere che, quale che sia l’esito del giudizio cautelare preventivamente
esperito dal lavoratore, la parte interessata alla promozione del giudizio di merito debba comunque
seguire il nuovo rito speciale e ciò fin dalla sua prima fase.
Diversa questione è quella relativa alla persistente ammissibilità di istanze cautelari in corso
di causa.
Per quel che riguarda la prima fase del procedimento, anche qui si deve ripetere quanto già
osservato in generale per i ricorsi cautelari ante causa, e cioè che non sembra ipotizzabile alcuna
incompatibilità in astratto104: in effetti, se il giudice, anziché rispettare il termine di 40 giorni
stabilito per la celebrazione dell’udienza di comparizione delle parti, fissi tale udienza a distanza di
alcuni mesi dalla data di deposito del ricorso, non si vede come possa escludersi, sempre e
comunque, l’eventualità che il diritto azionato dal lavoratore subisca pregiudizi irreparabili nelle
more della definizione della prima fase del nuovo procedimento. Ovviamente, anche in tal caso, si
tratterà piuttosto di valutare, caso per caso e con riferimento alla prassi del singolo Tribunale
interessato, se la presumibile durata di tale fase sia talmente lunga dall’esporre il diritto del
lavoratore al suddetto rischio.
Soluzione diversa deve invece essere adottata rispetto alla possibilità di proporre istanze ex
art. 700 c.p.c. nella fase di opposizione. Infatti, pur volendo tralasciare di considerare che, in simili
104
In senso contrario, con riferimento alla proponibilità di domande cautelari nel corso di una controversia soggetta a
rito sommario di cognizione, Trib. Nola, 8 aprile 2010, in www.ilcaso.it, ma sulla considerazione, del tutto astratta (e,
pertanto, suscettibile in ammissibilmente di sacrificare esigenze cautelari che effettivamente si presentino nel caso
concreto) secondo cui tale rito deve rimanere confinato alle fattispecie di pronta e facile risoluzione (con esclusione di
necessità istruttorie più complesse), e che la sua collocazione nei procedimenti speciali segnala, per converso, la
perdurante attitudine del rito ordinario di cognizione a costituire la via maestra per introdurre domande processuali
45
casi, vi è già stata (con l’ordinanza conclusiva della fase “urgente”) una prima valutazione
giudiziale circa l’apparente fondamento o meno della pretesa del lavoratore, ciò che impone di
escludere in radice qualsiasi possibilità di ottenere in sede cautelare il provvedimento giudiziale che
non è stato concesso nella prima fase del procedimento è la disposizione del comma 50 che, come
detto (supra, n. 5) assicura la stabilità dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza emessa all’esito della
fase “urgente”: volendo ritenere la legittimità costituzionale di una simile previsione (legittimità
sulla quale, come si è visto, possono essere avanzati seri dubbi) deve almeno ammettersi che la
stabilità in questione operi in entrambe le direzioni; vale a dire che non è consentito a nessuna delle
due parti in causa ottenere dal giudice dell’opposizione, prima della definizione di tale fase del
giudizio, alcun provvedimento che contrasti con il contenuto della predetta ordinanza: così come, in
caso di provvedimento favorevole al lavoratore, il datore di lavoro non può chiedere la sospensione
dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza, alla stessa maniera, in ipotesi di provvedimento sfavorevole
al lavoratore, costui non può, nel corso del giudizio di opposizione, ottenere, per mezzo di un
ricorso cautelare, ciò che gli è stato negato nella prima fase del procedimento di impugnazione del
licenziamento.
Quanto alla speciale tutela accordata dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970 al sindacalista
licenziato illegittimamente, essa deve ritenersi ancora vigente e perfettamente compatibile con il
nuovo rito, se non altro perché il legislatore del 2012, lungi dal sopprimere i commi dell’art. 18 che
la disciplinano, l’ha invece implicitamente, ma chiaramente, confermata, modificando il riferimento
al comma che prevede l’ordinanza a favore del sindacalista da «quarto» ad «undicesimo», tale
essendo divenuto, dopo le sostituzioni dei primi sei commi con altri dieci commi contestualmente
operata dal legislatore, la collocazione della disposizione che contempla l’ordinanza in questione
(v. art. 1, comma 42, lettera c), della legge n. 92 del 2012).
Ovviamente resta fermo che anche l’azione di impugnazione del licenziamento del
sindacalista interno deve essere promossa nelle forme previste dal nuovo rito. Tuttavia, «in ogni
stato e grado del giudizio di merito» il giudice, ricorrendo le condizioni previste dall’undicesimo
comma dell’art. 18, potrà emanare l’ordinanza di reintegrazione del sindacalista. L’ampia
formulazione utilizzata dal legislatore impone di ritenere che l’ordinanza in questione possa essere
pronunciata anche nella prima fase del nuovo procedimento, così come nel giudizio di opposizione
e anche se il provvedimento conclusivo della prima fase sia risultato sfavorevole al lavoratore (in
questa maniera realizzandosi un’eccezione alla regola appena illustrata dell’immodificabilità
dell’ordinanza emessa all’esito della prima fase).
Altrettanto certamente è confermata la possibilità per i sindacati nazionali di proporre azione
ex art. 28 legge n. 300 del 1970 lamentando l’antisindacalità di un licenziamento. Invero, gli
argomenti in base ai quali si è ritenuta l’ammissibilità di simili iniziative giudiziali prima della
innovazione processuale del 2012 rimangono valide anche oggi, posto che quella disciplinata
dall’art. 1 della legge n. 92 non è altro che la nuova modalità di proposizione dell’impugnazione
giudiziale del licenziamento da parte del lavoratore che, pertanto, non rileva sul procedimento
disciplinato dall’art. 28 della legge n. 300 del 1970, il quale riguarda l’azione promuovibile dal
sindacato a tutela del proprio interesse.
Resta da verificare, infine, se il lavoratore che deduca la natura discriminatoria del proprio
licenziamento possa promuovere azione ai sensi dell’art. 28 d. lgs. n. 150 del 2011, ovvero se tale
possibilità sia venuta meno a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, con
conseguente necessità di utilizzare il nuovo rito per l’impugnazione del licenziamento anche nelle
ipotesi in cui questo sia viziato per uno dei motivi discriminatori presi in considerazione dall’art. 44
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall’art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n.
215, dall’art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e dall’art. 3 della legge 1° marzo 2006,
n. 67 (che sono i motivi cui fa riferimento il d. lgs. n. 150 del 2011, unitamente all’art. 55-quinquies
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il quale però non può rilevare in materia di
licenziamenti). Orbene, se si ammette che i provvedimenti previsti dal d. lgs. n. 150 del 2011
prescindono dal contenuto dell’art. 18 e si distinguono da questo, essendo oggetto di una specifica
46
definizione e previsione da parte del comma 5 del predetto art. 28, si dovrebbe anche convenire sul
fatto che il rito che il lavoratore deve seguire nel caso in cui denunci il carattere discriminatorio del
recesso datoriale dipende dal tipo di tutela da lui invocata: se propone domanda di applicazione
dell’art. 18 legge n. 300 del 1970, dovrà azionare il rito ex legge n. 92 del 2012; se propone
domanda di concessione dei provvedimenti di cui all’art. 28 d. lgs. n. 150 del 2011, dovrà rispettare
le relative regole processuali105.
9. Le misure organizzative.
A norma del comma 65 dell’art. 1 della legge n. 92 del 2012, «alla trattazione delle
controversie regolate dai commi da 47 a 64 devono essere riservati particolari giorni nel calendario
delle udienze».
Il riferimento all’intera disciplina del nuovo rito dettata dai commi precedenti impone di
ritenere che la disposizione si riferisca a tutti i gradi in cui si articola il procedimento e, dunque,
valga, oltre che per le due fasi del primo grado, anche per i successivi gradi di giudizio.
Il successivo comma 66 attribuisce ai capi degli uffici giudiziari il potere di vigilanza sul
rispetto della disposizione dettata dal comma 65.
Potere che, a norma del comma 68, si estende anche all’osservanza di quanto previsto dal
comma 67, il quale stabilisce che «i commi da 47 a 66 si applicano alle controversie instaurate
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge». Poiché si può escludere
tranquillamente che tale norma attribuisca ai capi degli uffici il potere di vigilare su come i
magistrati dell’ufficio applichino in ciascuna causa ogni singola norma che compone la disciplina
del nuovo procedimento (e ciò sia perché un simile controllo sarebbe praticamente impossibile, sia
perché rischierebbe di sfociare in un inammissibile controllo sull’esercizio della giurisdizione), si
deve ritenere che la vigilanza in questione concerna il rispetto delle uniche prescrizioni che, da un
lato, sono suscettibili di una agevole verifica “oggettiva” e, dall’altro, non implicano, in sede di loro
applicazione, l’esercizio di quell’attività interpretativa propria dell’esercizio del potere
giurisdizionale. Vale a dire, dei precetti della nuova disciplina processuale relativi ai termini
imposti all’attività del giudice.
In sostanza, ciò che il legislatore ha imposto ai capi degli uffici di sorvegliare è l’osservanza,
da parte dei magistrati componenti l’ufficio, dei termini stabiliti per lo svolgimento delle
controversie in questione.
E proprio alla luce di tale precisazione deve essere correttamente interpretato anche il
comma 65 ricordato all’inizio, il cui tenore testuale sembrerebbe deporre nel senso che esso
imponga la preventiva individuazione di giornate di udienza da destinare integralmente alla
trattazione delle cause in questione106. La diseconomicità della norma, intesa in tal senso, è di una
evidenza assoluta: per quanti sforzi si facciano per pervenire ad un’attendibile stima del numero e
della frequenza delle udienze necessarie per una trattazione del contenzioso in questione rispettosa
dei tempi previsti dal legislatore, è evidente che l’intrinseca variabilità del numero delle
controversie e della loro complessità comporterebbe il rischio sia di udienze utilizzate solo in
misura parziale (per mancanza di sufficienti cause di impugnazione di licenziamenti), sia
dell’indisponibilità di udienze sufficienti per far fronte ad un eventuale “picco” di sopravvenienze.
Ed allora, prendendo le mosse dalla chiara ratio delle disposizioni dettate dal legislatore in
tema di potere di vigilanza dei capi degli uffici – che è quella di assicurare l’osservanza, nella
pratica, dei termini entro i quali debbono essere fissate le udienze di discussione stabiliti nei commi
105
Contra, nel senso che l’azione di impugnazione del licenziamento discriminatorio deve ormai essere proposta
secondo le regole processuali di cui all’art. 1, commi 47 ss., legge n. 92 del 2012, potendo essere trattate con il rito ex
art. 28 d. lgs. n. 150 del 2011 solamente le azioni giudiziarie contro altri atti discriminatori, A. BOLLANI, op. cit., 314.
106
Così, infatti, L. CAVALLARO, op. cit., 8.
47
precedenti per ciascun grado del giudizio e la possibilità che entro quell’udienza la causa
possibilmente sia anche decisa – sembra ragionevole ritenere che ciò che è necessario, ma anche
sufficiente, è organizzare il complessivo lavoro del giudice affinché quei tempi siano, appunto,
rispettati. E ciò, eventualmente, anche riservando al contenzioso in questione solamente alcune
fasce orarie all’interno delle udienze oppure, semplicemente, fissando tali controversie in qualsiasi
udienza e qualsiasi orario, purché l’organizzazione adottata dal singolo giudice sia funzionale alla
salvaguardia dell’esigenza di celere definizione delle controversie medesime così come definita
dalla legge n. 92107.
L’obiezione secondo la quale, così intese, le norme che qui si stanno esaminando sarebbero
sostanzialmente inutili108 non sembra condivisibile: al contrario, esse esprimono con grande
chiarezza l’esigenza che alle controversie in questione venga data precedenza rispetto alle altre e
che il giudice organizzi il proprio lavoro in maniera di assicurare il rispetto dei termini stabiliti nei
commi precedenti.
Sono stati prospettati dubbi circa la legittimità costituzionale della differenziazione
introdotta dal legislatore, quanto ad accesso alla “corsia preferenziale”, tra licenziamenti cui si
applica l’art. 18 e quelli non assistiti da tale norma109. Non sembra, tuttavia, che tale
differenziazione sia tale da consentire alla Corte di definire addirittura irrazionale e foriera di
ingiustificate diversità di trattamento la scelta selettiva operata dal legislatore del 2012. Invero,
muovendo da una valutazione generale degli interventi compiuti dalla legge n. 92 sul piano
sostanziale (modifiche all’art. 18 legge n. 300 del 1970) e su quello processuale, si deve riconoscere
che le norme dirette a favorire le controversie ex art. 18 riguardano o fattispecie radicalmente
diverse da quelle disciplinate dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966 (quelle regolate dai commi dal
primo al quarto e settimo, primi due periodi, dell’art. 18) ovvero fattispecie che, sia sul piano della
disciplina legislativa, sia su quello della prassi giudiziaria, sono normalmente strettamente
intrecciate con le prime (commi quarto, quinto e settimo, secondo periodo dell’art. 18), onde è
razionale che siano soggette alle medesime regole processuali.
107
Sostanzialmente nello stesso senso L. DE ANGELIS, op. cit., 20.
L. CAVALLARO, op.loc. ult. cit.
109
In tal senso: C. CONSOLO-D. RIZZARDO, op. cit., 735, nt. 29 (che ipotizzano la violazione dell’art. 3 Cost.); L.
DE ANGELIS, op. cit., 5 (che prospetta la violazione degli artt. 3 e 24).
108
48