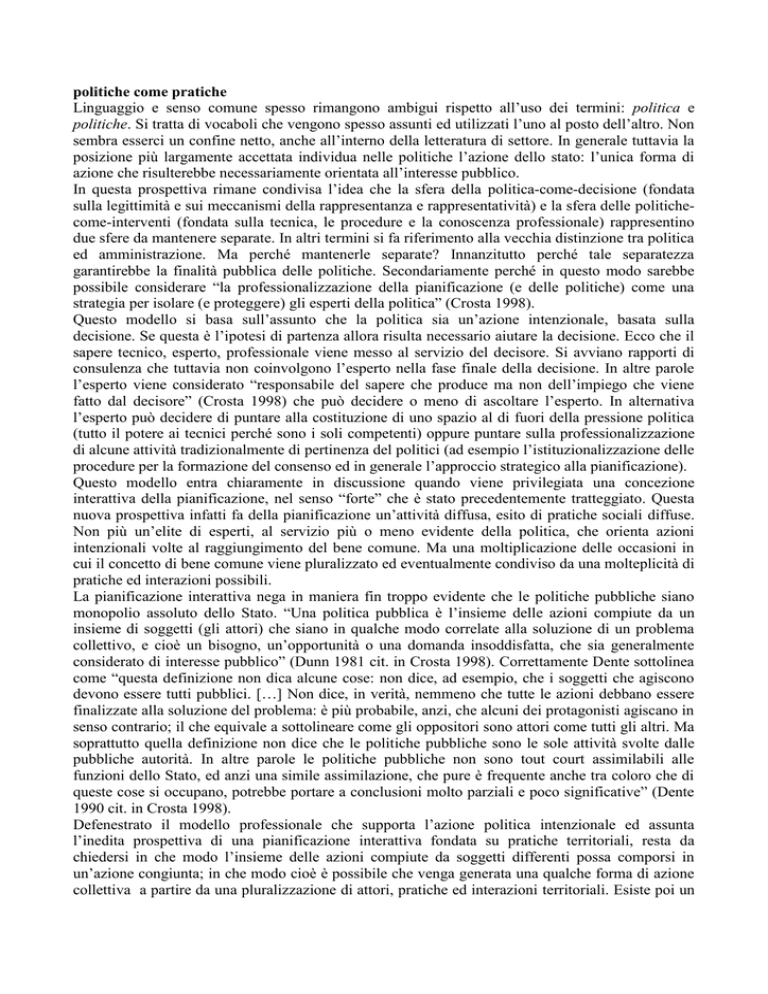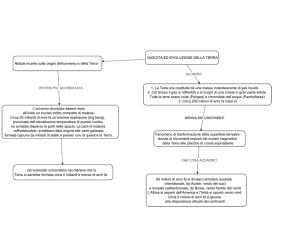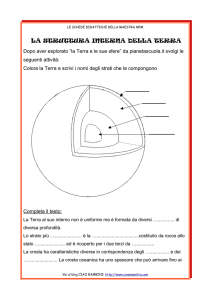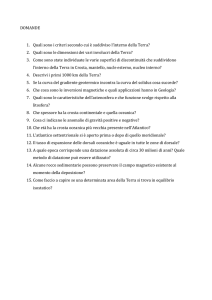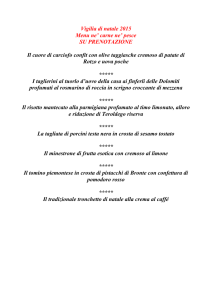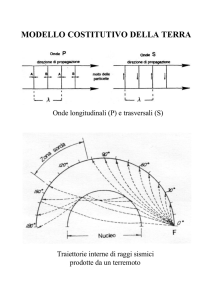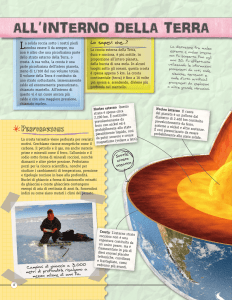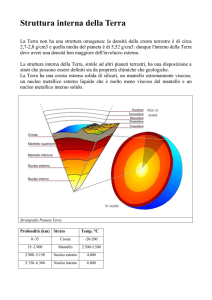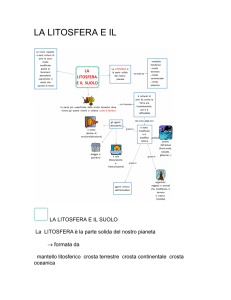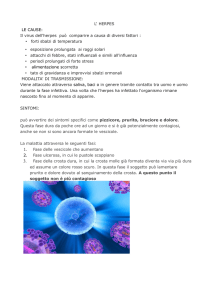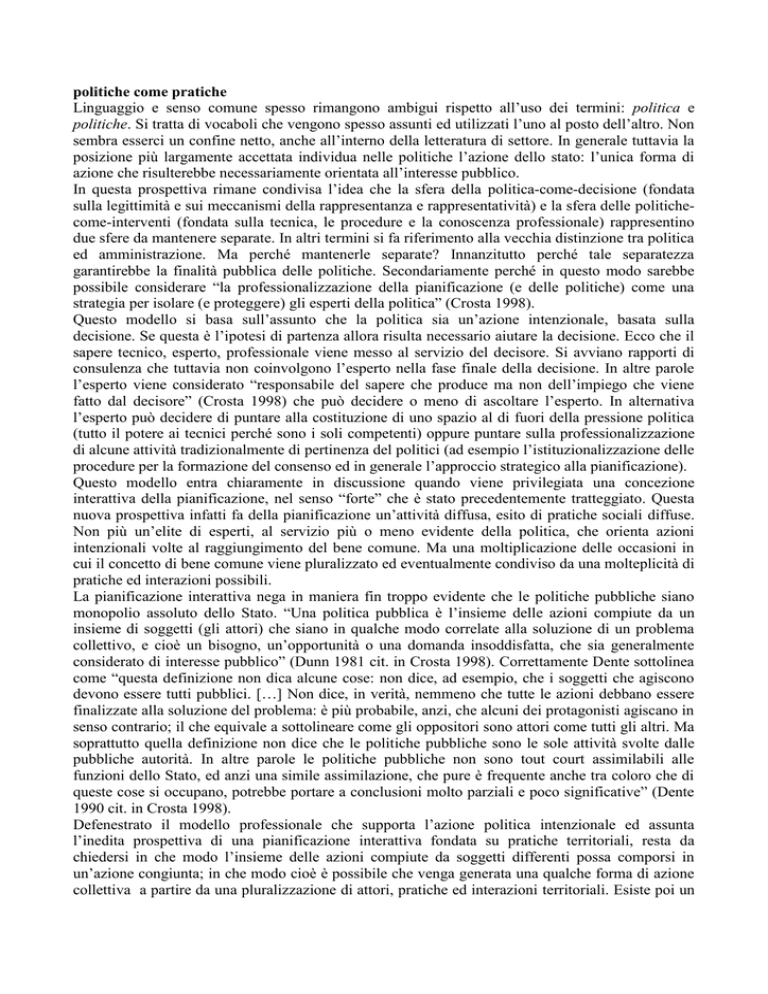
politiche come pratiche
Linguaggio e senso comune spesso rimangono ambigui rispetto all’uso dei termini: politica e
politiche. Si tratta di vocaboli che vengono spesso assunti ed utilizzati l’uno al posto dell’altro. Non
sembra esserci un confine netto, anche all’interno della letteratura di settore. In generale tuttavia la
posizione più largamente accettata individua nelle politiche l’azione dello stato: l’unica forma di
azione che risulterebbe necessariamente orientata all’interesse pubblico.
In questa prospettiva rimane condivisa l’idea che la sfera della politica-come-decisione (fondata
sulla legittimità e sui meccanismi della rappresentanza e rappresentatività) e la sfera delle politichecome-interventi (fondata sulla tecnica, le procedure e la conoscenza professionale) rappresentino
due sfere da mantenere separate. In altri termini si fa riferimento alla vecchia distinzione tra politica
ed amministrazione. Ma perché mantenerle separate? Innanzitutto perché tale separatezza
garantirebbe la finalità pubblica delle politiche. Secondariamente perché in questo modo sarebbe
possibile considerare “la professionalizzazione della pianificazione (e delle politiche) come una
strategia per isolare (e proteggere) gli esperti della politica” (Crosta 1998).
Questo modello si basa sull’assunto che la politica sia un’azione intenzionale, basata sulla
decisione. Se questa è l’ipotesi di partenza allora risulta necessario aiutare la decisione. Ecco che il
sapere tecnico, esperto, professionale viene messo al servizio del decisore. Si avviano rapporti di
consulenza che tuttavia non coinvolgono l’esperto nella fase finale della decisione. In altre parole
l’esperto viene considerato “responsabile del sapere che produce ma non dell’impiego che viene
fatto dal decisore” (Crosta 1998) che può decidere o meno di ascoltare l’esperto. In alternativa
l’esperto può decidere di puntare alla costituzione di uno spazio al di fuori della pressione politica
(tutto il potere ai tecnici perché sono i soli competenti) oppure puntare sulla professionalizzazione
di alcune attività tradizionalmente di pertinenza del politici (ad esempio l’istituzionalizzazione delle
procedure per la formazione del consenso ed in generale l’approccio strategico alla pianificazione).
Questo modello entra chiaramente in discussione quando viene privilegiata una concezione
interattiva della pianificazione, nel senso “forte” che è stato precedentemente tratteggiato. Questa
nuova prospettiva infatti fa della pianificazione un’attività diffusa, esito di pratiche sociali diffuse.
Non più un’elite di esperti, al servizio più o meno evidente della politica, che orienta azioni
intenzionali volte al raggiungimento del bene comune. Ma una moltiplicazione delle occasioni in
cui il concetto di bene comune viene pluralizzato ed eventualmente condiviso da una molteplicità di
pratiche ed interazioni possibili.
La pianificazione interattiva nega in maniera fin troppo evidente che le politiche pubbliche siano
monopolio assoluto dello Stato. “Una politica pubblica è l’insieme delle azioni compiute da un
insieme di soggetti (gli attori) che siano in qualche modo correlate alla soluzione di un problema
collettivo, e cioè un bisogno, un’opportunità o una domanda insoddisfatta, che sia generalmente
considerato di interesse pubblico” (Dunn 1981 cit. in Crosta 1998). Correttamente Dente sottolinea
come “questa definizione non dica alcune cose: non dice, ad esempio, che i soggetti che agiscono
devono essere tutti pubblici. […] Non dice, in verità, nemmeno che tutte le azioni debbano essere
finalizzate alla soluzione del problema: è più probabile, anzi, che alcuni dei protagonisti agiscano in
senso contrario; il che equivale a sottolineare come gli oppositori sono attori come tutti gli altri. Ma
soprattutto quella definizione non dice che le politiche pubbliche sono le sole attività svolte dalle
pubbliche autorità. In altre parole le politiche pubbliche non sono tout court assimilabili alle
funzioni dello Stato, ed anzi una simile assimilazione, che pure è frequente anche tra coloro che di
queste cose si occupano, potrebbe portare a conclusioni molto parziali e poco significative” (Dente
1990 cit. in Crosta 1998).
Defenestrato il modello professionale che supporta l’azione politica intenzionale ed assunta
l’inedita prospettiva di una pianificazione interattiva fondata su pratiche territoriali, resta da
chiedersi in che modo l’insieme delle azioni compiute da soggetti differenti possa comporsi in
un’azione congiunta; in che modo cioè è possibile che venga generata una qualche forma di azione
collettiva a partire da una pluralizzazione di attori, pratiche ed interazioni territoriali. Esiste poi un
altro interrogativo legato al precedente: in che modo e quando è possibile che tale azione congiunta
possa incarnare un problema collettivo ed essere per questo definita di interesse pubblico?
Al primo punto sembra rispondere Dewey: “l’azione congiunta, combinata, associata produce dei
risultati. Alcuni dei risultati sono oggetto di percezione, ossia si possono osservare in maniera tale
che è possibile poi tenerne conto. Sorgono quindi propositi, piani, provvedimenti e mezzi per
conseguire conseguenze gradite ed eliminare quelle che si ritengano nocive. La percezione genera
dunque un comune interesse; ossia chi subisce l’influenza delle conseguenze s’interessa
necessariamente al modo di comportarsi di tutti coloro i quali, unendo la loro opera alla sua,
contribuiscono anch’essi a determinare i risultati. A volte, le conseguenze sono limitate a chi
partecipa direttamente alla transazione che le produce, mentre in altri casi, esse si estendono ben
oltre chi ha direttamente contribuito a determinarle” (Dewey 1971 cit. in Crosta 1998).
Parliamo della stessa dinamica che viene potenzialmente a definirsi all’interno di contesti interattivi
centrati sull’elaborazione e la condivisione di storie di vita. I racconti e l’interazione che li
accompagna, finiscono col produrre oggetti, mondi, quadri di significati, problemi e
rappresentazioni che vengono fatti oggetto di percezione da parte dei soggetti che partecipano di
alcuni specifici contesti d’interazione. Tale percezione è poi lo stimolo per orientare e costruire
l’azione. Lo stimolo per far germinare nuove pratiche territoriali (ciò che la gente fa ed insieme
l’elaborazione dei significati che informano l’azione che si produce) potenzialmente capaci di
intercettare nuovi attori e nuovi mondi.
Pizzorno individua nella teoria dei giochi una possibile spiegazione di come l’azione congiunta
possa essere interpretata come prodotto d’intesa tra due o più attori: nei giochi di coordinazione
infatti “i partecipanti perseguono i medesimi fini, e nessuno può conseguire il proprio fine se anche
tutti gli altri non lo conseguono a loro volta. Perché ciò avvenga, i partecipanti debbono poter
comunicare tra loro; debbono cioè inviarsi segnali, ed essere capaci di capire cosa questi vogliano
dire […]. In altre parole si tratterà, per i partecipanti all’azione, di individuare, quando serve, i segni
giusti” (Pizzorno 1996 cit. in Crosta 1998). I segni d’intesa sono dunque i prodotti dell’interazione
intersoggettiva, gli oggetti che vengono fatti oggetto di percezione, gli input e la motivazione ad
agire. La nuova prospettiva pianificatoria che viene a delinearsi abbandona definitivamente l’ottica
della decisione individuale per muoversi nel campo dell’interazione sociale e della relazionalità
degli attori territoriali. Una strada nuova viene battuta nella convinzione che “ il processo di
politiche coinvolga (debba coinvolgere) l’intera società, e che questo fatto (o questo obbiettivo) sia
rilevante per l’efficienza e l’efficacia delle politiche” (Crosta 1998).
Da questo punto di vista le politiche non possono essere più intese come azioni intenzionali di pochi
esperti ma come pratiche diffuse a cui viene riconosciuto il carattere pubblico (Crosta 2000). Tale
riconoscimento, occorre ribadirlo, è eventuale. L’idea di fondo rimane quella di stimolare la
costruzione di “politiche come pratiche di beni comuni” o meglio di “politiche come pratiche – che
e se – producono beni pubblici”. Quest’ultima definizione pone in evidenza il fatto che non
necessariamente le pratiche diventano politiche e quindi la costruzione di queste non può essere
considerato un obiettivo da raggiungere. L’obiettivo del planner non è dunque quello di costruire
politiche intese come strumenti di governo, piuttosto quello di sperimentare, stimolare e attivare
contesti interattivi ed incubatori di pratiche territoriali, intese come espressioni della società a
regolare la co-presenza.
Ma cosa si intende quando viene riconosciuto ad una pratica il carattere pubblico? In altre parole,
quando le pratiche diventano politiche? La questione ruota intorno alla definizione di bene comune.
Ferma restando la già sottolineata necessità di pluralizzare la nozione di bene comune cerchiamo di
capire in termini più approfonditi cosa si intende quando si parla di bene comune. A questo
proposito Donolo individua una serie di attributi relazionali dei beni comuni: “in quanto presupposti
(dell’agire) ed esiti (dell’interazione), i beni comuni rinviano al processo sociale nel suo insieme; la
loro funzione di produzione non è nota se non per segmenti ed aspetti, e comunque non è quasi mai
progettabile; i beni comuni hanno la natura di stati sottoprodotto, cioè di esiti risultanti come
ridondanza di processi orientati ad altri scopi; non sono solo beni oggettivati in oggetti, ma anche
beni che stanno nella dimensione astratta e virtuale di ogni tipo di bene;ai beni comuni inserisce
sempre una dimensione normativa, in quanto beni che sono legati a pretese di fattibilità e di
qualificazione dell’interazione sociale; allo stesso modo essi sono la modalità empiricamente
accertabile in cui si manifesta la natura del legame sociale e la costituzione reale della società; la
dinamica dei beni comuni non dipende solo da innovazione e tecnologie, ma anche e specialmente
dalla natura della comunicazione sociale vigente (conflitti, compromessi, negoziazioni, poteri,
gerarchie, imperativi, aspettative, speranze e timori, processi di apprendimento,…); sono in essenza
e principalmente, beni virtuali legati al linguaggio, alla conoscenza, al sapere e al potere” (Donolo
1997 cit. in Crosta 1998)
Le politiche “come pratiche di beni comuni” hanno dunque come presupposto e come esito beni
comuni: presupposto necessario ed esito eventuale. I beni comuni vengono inevitabilmente
consumati e problematicamente riprodotti. Problematicamente perché rappresentano l’esito
eventuale di pratiche diffuse e plurali. Crosta considera “le politiche come dei costrutti che vengono
elaborati da attori che, impegnati o coinvolti in trasformazioni (di diversa natura, quindi anche)
della città e del territorio, interagendo tra loro attivano dei contesti di senso entro i quali acquista
significato ciò che fanno e gli effetti di ciò che fanno; significato che è conferito all’agire (e ai suoi
effetti) dai contesti attivati (è, quindi, presupposto dell’agire); e al tempo stesso costruito
(riprodotto) insieme con i contesti ad esso relativi, dall’agire ( e dai suoi effetti) (è quindi esito
dell’agire)” (Crosta 1998).
oltre la partecipazione
La città contemporanea incarna orizzonti esplosi e frammentati dove convivono progetti migratori,
storie di vita, spazialità, temporalità, ritmi di appropriazione dello spazio, permanenze e
transitorietà, processi di significazione, modalità relazionali, bisogni, aspettative, dimensioni
conflittuali e desideri differenti. Pensare alle politiche come a “pratiche che – e se – producono beni
comuni” (Crosta 1998) significa avere consapevolezza di questi inediti scenari urbani: significa
voler sperimentare nuove forme di costruzione di politiche in grado di rispondere alle fin troppo
evidenti lacune del paradigma della domanda politica incarnata dallo stato: uno stato unitario che
sarebbe l’unico depositario della possibilità di agire intenzionalmente per raggiungere il bene
pubblico. La nostra società è una società delle differenze ed in quanto tale richiama necessariamente
una concezione plurale del bene pubblico. Le differenze impongono dunque di transitare dall’idea
di un bene pubblico a quella di tanti beni pubblici. Ma in che modo possono essere definiti e
costruiti questi beni pubblici? Abbiamo tratteggiato un’ipotesi e cioè la costruzione di contesti
interattivi tesi ad incubare una molteplicità di pratiche territoriali e di azioni congiunte il cui esito
eventuale è la definizione di un qualche bene comune. Bene comune e non pubblico, laddove
l’attributo “pubblico” è riferibile solo a quel tipo di bene che viene riprodotto intenzionalmente. I
beni comuni al contrario sono l’esito potenziale di interazioni non predeterminate tra soggetti
diversificati, esperti e non esperti, in generale attori che utilizzano forme ibride di conoscenza:
professionale ed ordinaria.
Dicevamo che tale prospettiva mette in discussione il paradigma della domanda politica: “decade
cioè l’aspettativa che le esigenze della società vengano rivolte (domanda) per la loro soddisfazione
allo stato (politica) che le tratterebbe (a mezzo di politiche) in quanto riconoscerebbe loro (in base
ad una qualche definizione di interesse generale) il carattere di esigenze pubbliche” (Crosta 2000).
Viene soprattutto messo in crisi il tipo di risposta del sistema politico: l’unitarismo dell’intervento
dello stato. Si tratta di una risposta insoddisfacente per una società caratterizzata da gruppi e
soggettività che incarnano domande ed aspettative diversificate. Quello che viene richiesto è il
riconoscimento dei bisogni e delle specificità. Quello che invece viene concesso è un trattamento
generalizzato ed unitario che rinvia “al carattere centralistico-autoreferenziale del trattamento dei
bisogni tipico della tradizione amministrativa e visibilmente coerente con le prospettive strutturalistituzionali della tradizione sociologica” (Tosi 1994). Gli accenti, le distanze ed in genere la
variabilità sociale e territoriale non sono prese in considerazione dallo Stato e dalla politica che esso
rappresenta. Questo è il motivo per cui la società tende a ritirare la delega al sistema politico e ad
agire per proprio conto per tutelare i propri interessi e definire quelli che sono i propri beni comuni.
Tradizionalmente la strada che viene percorsa per rispondere alla disfatta dello stato è quella che
“propone la sostituzione/integrazione allo stato, dei diretti interessati all’esito delle politiche, nei
processi decisionali e attuativi delle politiche” (Crosta 2000). In altre parole ciò che lo stato non
riesce a fare si spera possano farlo altri soggetti maggiormente coinvolti nella costruzione delle
politiche che li riguardano. Ecco allora che se il problema del fallimento dello stato è legato
all’efficienza, la soluzione è ricercabile nella sostituzione del mercato (o del terzo settore) allo stato:
l’obbiettivo è dunque quello di configurare lo stato come un’impresa efficiente. Se il problema
riguarda invece la crisi politica del rapporto stato/società allora il tentativo che verrà è solitamente
quello legato alla partecipazione dei diversi gruppi sociali che hanno interessi nella costruzione di
determinate politiche. La loro presenza in questi processi garantirebbe loro di gestire direttamente,
senza intermediari depositari di domande spesso inascoltate, i loro specifici interessi. “In definitiva,
la prospettiva offerta dalle strategie partecipatorie è essenzialmente quella che i partecipanti,
attraverso forme di persuasione, mediazione, negoziato – delle quali tutti sono diretti attori –
arrivino ad individuare ciò che è nel loro interesse comune di fare: il consenso che lo stato è
incapace (ovvero, viene ritenuto incapace di formare, viene raggiunto (ciò che continua ad essere
visto come prerequisito del passaggio all’azione) in quanto è un processo di riconoscimento degli
interessi congiunti (che in quanto tali, costituiscono ovvero sono portati a coincidere con l’interesse
comune)” (Crosta 2000).
Questi risultati sono chiaramente raggiungibili se il processo partecipatorio viene organizzato in
maniera efficiente e se le differenze che entrano in gioco possono mediare e ricomporsi nella
formazione del consenso tra i partecipanti. Più spesso tuttavia le differenze sono incommensurabili
e difficilmente riescono a raggiungere compromessi: i molteplici interessi in gioco non riescono a
dialogare tra di loro. L’esito della partecipazione si affossa e di all’azione (alle politiche) risulta
impossibile. Proprio come lo stato la partecipazione spesso non riesce a sintetizzare le diverse
posizioni in una qualche unitaria definizione di interesse comune. Il suo ruolo è inefficiente e gli
obbiettivi non vengono perseguiti.
Si può dire che la partecipazione destabilizzi in parte il paradigma della domanda politica, nel
momento in cui il ruolo dello stato come unico depositario dell’azione politica viene messo in
discussione dall’apertura del processo partecipatorio verso altre soggettività e gruppi di interesse.
Allo stesso tempo e in maniera più significativa tuttavia la partecipazione implementa il vecchio
paradigma della domanda politica. Essa risulta conservativa in “ciò che la parziale
sostituzione/integrazione degli attori, mantiene la funzione di formazione del consenso, come
antecedente necessario all’azione, al processo cui tali attori «vengono fatti partecipare». In
definitiva, il processo di politiche partecipato persiste nel considerare l’obbiettivo della formazione
del consenso come esterno e preliminare all’azione, e conseguibile attraverso una strategia di
unificazione/riduzione della diversità dei punti di vista esposti dai partecipanti (permane la clausola
della commensurabilità dei punti di vista). Altrimenti detto l’interesse generale esiste, ed è
raggiungibile attraverso l’innovazione del modo di arrivarci (la negoziazione partecipata del
consenso appunto)” (Crosta 2000). La partecipazione allarga lo spettro dei soggetti coinvolti, ma
riproduce la logica della riduzione consensuale delle differenze nel tentativo di raggiungere il
consenso come preliminare necessario all’azione.
Occorre dunque andare oltre l’idea della partecipazione operando un cambio di prospettiva più
radicale. Occorre fare della differenza non un limite alle strategie di ricerca del consenso ma
un’opportunità per sperimentare inedite modalità di costruzione delle politiche. La necessaria
pluralizzazione del concetto di bene comune e la costruzione di nuove politiche intese “come
pratiche che – e se – producono beni comuni” cercano di rispondere a queste sfide. Le politiche
infatti non dovrebbero essere più intese come azioni intenzionali fondate sulla ricerca del consenso
per il consenso: un mito “democratico” che fa della mediazione e dell’appiattimento delle
differenze un proprio cavallo di battaglia, col rischio di trasformare le scimmie in uomini. E’
necessario “considerare le politiche non come azioni (chiunque le compia) che hanno come
presupposto una qualche definizione di bene pubblico (comunque unificato) ma come pratiche (di
tutti, quindi: pratica è ciò che la gente fa e, insieme, il motivo per cui fa quello che fa) che, e se,
producono beni comuni. Il carattere pubblico è quindi eventuale (non necessariamente le pratiche
diventano politiche). Ne è del tutto intenzionale (può essere l’esito di pratiche autointeressate).
Infine, non sono a priori precisabili ( e quindi la realizzazione di esse non può essere considerata
come un obbiettivo da raggiungere) le condizioni alle quali le pratiche diventano politiche: unica
condizione necessaria – non sufficiente – è la co-presenza dei soggetti di pratiche (in questo senso,
le politiche-eventuali, sono locali in quanto interazioni in condizioni di co-presenza.)” (Crosta
2000). Il carattere pubblico è un esito eventuale dunque: l’interattività e le pratiche territoriali
possono farlo emergere o meno. Di sicuro le pratiche sono interpretabili come espressioni della
società ad orientare se stessa in termini plurali ed auto-promossi. La clausola della
incommensurabilità dei punti di vista può essere rimossa: l’incommensurabilità, nella nostra società
delle differenze, blocca i processi di formazione del consenso, ma non impedisce la ricerca di forme
di convivenza tra diversi.
Particolarmente eloquenti risultano essere le riflessioni di Pellizzoni fondate sul riconoscimento
della necessità di costruire occasioni pre-politiche di interazione come sfida all’incommensurabilità
delle differenze. Secondo l’autore, occorre dunque superare la sfera politica attraverso cui “la
società tenta sperimentalmente di elaborare e risolvere i problemi sociali, nel momento in cui la loro
portata supera l’ambito dei diretti partecipanti all’interazione” (Pellizzoni 1998 cit. in Crosta 2000)
ed avventurarsi in una dimensione prepolitica: una dimensione cioè dove diviene centrale “l’azione
congiunta di risorse individuali in risposta ad un problema. L’esperienza dell’intersoggettività, della
cooperazione, deve cioè realizzarsi prima e al di fuori della politica: la motivazione individuale
verso il bene collettivo si determina nei limiti in cui ciascuno vede la propria attività come un
contributo a un processo cooperativo. L’orientamento all’intesa politica si basa sull’esperienza
condivisa di una partecipazione alla soluzione dei problemi” (Pellizzoni 1998 cit. in Crosta 2000)
che va colta prima della dimensione politica, nell’interazione sociale. Pellizzoni infatti sottolinea
come lo scambio intersoggettivo sia prima che un valore politico, un valore sociale.
Ed è in questo scambio che va letta la possibilità di rispondere ad una questione cruciale: se la
ragione è plurale, è possibile la cooperazione tra soggetti che hanno punti di vista completamente
diversi sul mondo? L’incommensurabilità delle differenze può portare eventualmente solo ad un
accordo di tipo strategico: l’individuazione di un terreno comune dove le differenze rimarrebbero
ben distinte. Un processo questo che può essere incoraggiato da una cooperazione preopolitica. In
quest’interazione risiede infatti l’eventualità di elaborare una soluzione accettabile per ragioni che
possono restare differenti. L’incommensurabilità delle differenze sul piano politica può quindi
trasformarsi in una commensurabilità empirica e contestuale delle diverse ragioni dove coesistono
principi e conoscenze distinte, ciascuna delle quali ha una sua validità. C’è quindi un livello
empirico, contestuale, dove l’incommensurabilità tra quadri cognitivi e di valore non è totale
(Pellizzoni 1998 cit. in Crosta 2000).
La pianificazione potrebbe assumere questo inedito orizzonte pre-politico, stimolando occasioni
d’interazione e scambio intersoggettivo dove possa emergere una diversa modalità di intendere le
differenze. Ed in questo, superare il paradigma della domanda politica, problematizzare l’unitarietà
della risposta partecipativa ed aprirsi ad una nuova immagine della società, in grado di orientarsi da
sé, assumendo la pluralità come nuovo orizzonte pratico e territoriale. Può la società regolare se
stessa?