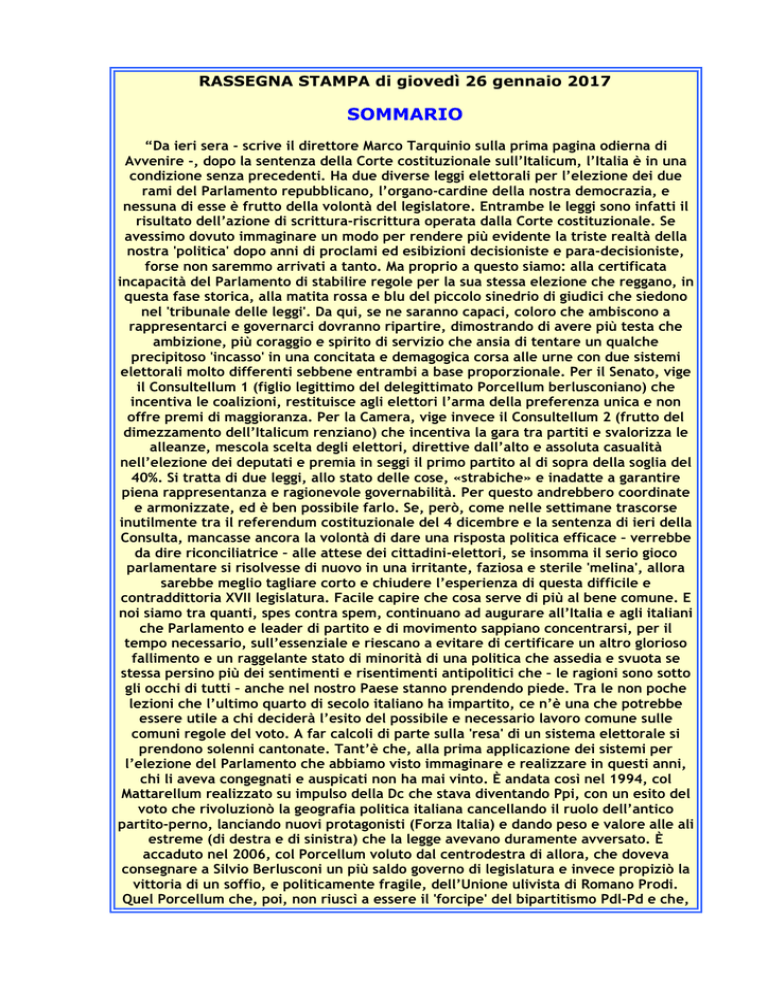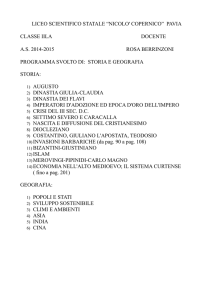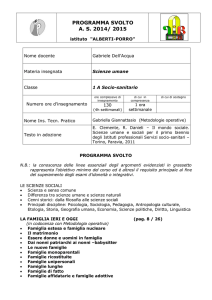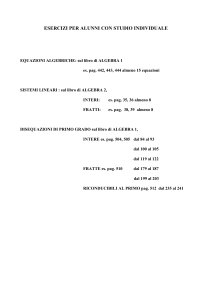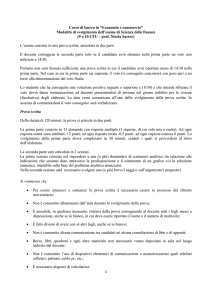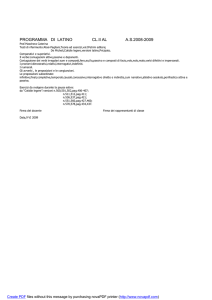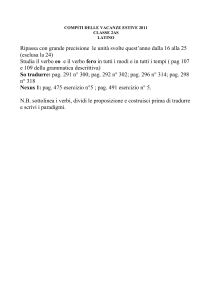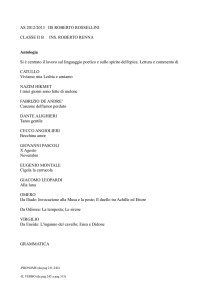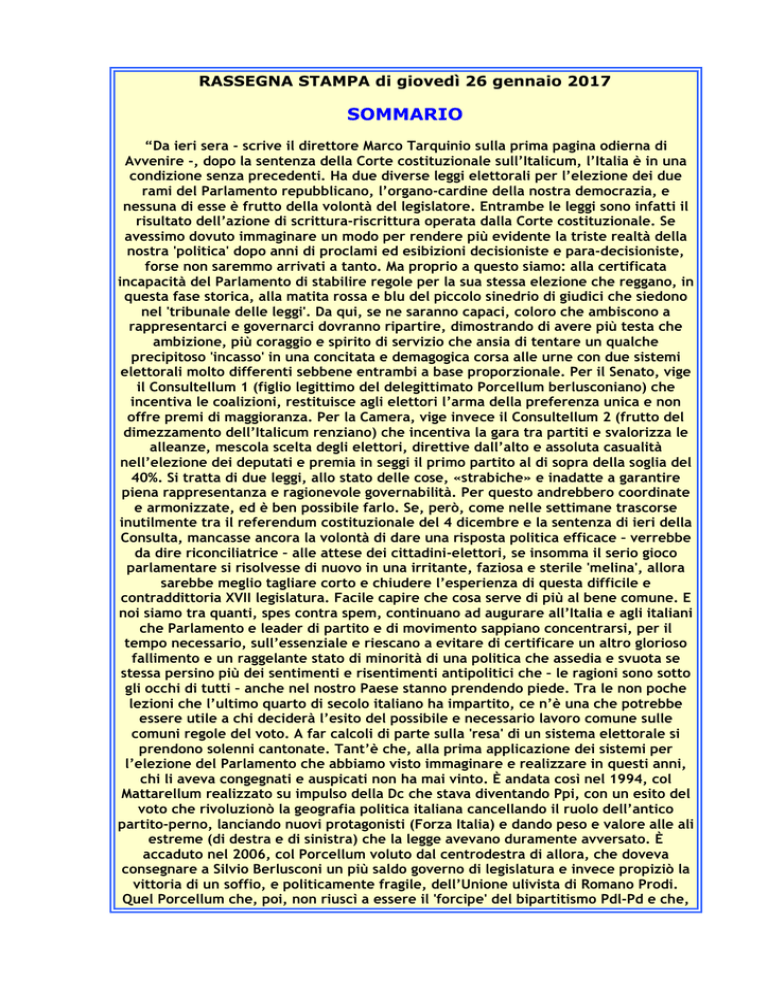
RASSEGNA STAMPA di giovedì 26 gennaio 2017
SOMMARIO
“Da ieri sera - scrive il direttore Marco Tarquinio sulla prima pagina odierna di
Avvenire -, dopo la sentenza della Corte costituzionale sull’Italicum, l’Italia è in una
condizione senza precedenti. Ha due diverse leggi elettorali per l’elezione dei due
rami del Parlamento repubblicano, l’organo-cardine della nostra democrazia, e
nessuna di esse è frutto della volontà del legislatore. Entrambe le leggi sono infatti il
risultato dell’azione di scrittura-riscrittura operata dalla Corte costituzionale. Se
avessimo dovuto immaginare un modo per rendere più evidente la triste realtà della
nostra 'politica' dopo anni di proclami ed esibizioni decisioniste e para-decisioniste,
forse non saremmo arrivati a tanto. Ma proprio a questo siamo: alla certificata
incapacità del Parlamento di stabilire regole per la sua stessa elezione che reggano, in
questa fase storica, alla matita rossa e blu del piccolo sinedrio di giudici che siedono
nel 'tribunale delle leggi'. Da qui, se ne saranno capaci, coloro che ambiscono a
rappresentarci e governarci dovranno ripartire, dimostrando di avere più testa che
ambizione, più coraggio e spirito di servizio che ansia di tentare un qualche
precipitoso 'incasso' in una concitata e demagogica corsa alle urne con due sistemi
elettorali molto differenti sebbene entrambi a base proporzionale. Per il Senato, vige
il Consultellum 1 (figlio legittimo del delegittimato Porcellum berlusconiano) che
incentiva le coalizioni, restituisce agli elettori l’arma della preferenza unica e non
offre premi di maggioranza. Per la Camera, vige invece il Consultellum 2 (frutto del
dimezzamento dell’Italicum renziano) che incentiva la gara tra partiti e svalorizza le
alleanze, mescola scelta degli elettori, direttive dall’alto e assoluta casualità
nell’elezione dei deputati e premia in seggi il primo partito al di sopra della soglia del
40%. Si tratta di due leggi, allo stato delle cose, «strabiche» e inadatte a garantire
piena rappresentanza e ragionevole governabilità. Per questo andrebbero coordinate
e armonizzate, ed è ben possibile farlo. Se, però, come nelle settimane trascorse
inutilmente tra il referendum costituzionale del 4 dicembre e la sentenza di ieri della
Consulta, mancasse ancora la volontà di dare una risposta politica efficace – verrebbe
da dire riconciliatrice – alle attese dei cittadini-elettori, se insomma il serio gioco
parlamentare si risolvesse di nuovo in una irritante, faziosa e sterile 'melina', allora
sarebbe meglio tagliare corto e chiudere l’esperienza di questa difficile e
contraddittoria XVII legislatura. Facile capire che cosa serve di più al bene comune. E
noi siamo tra quanti, spes contra spem, continuano ad augurare all’Italia e agli italiani
che Parlamento e leader di partito e di movimento sappiano concentrarsi, per il
tempo necessario, sull’essenziale e riescano a evitare di certificare un altro glorioso
fallimento e un raggelante stato di minorità di una politica che assedia e svuota se
stessa persino più dei sentimenti e risentimenti antipolitici che – le ragioni sono sotto
gli occhi di tutti – anche nel nostro Paese stanno prendendo piede. Tra le non poche
lezioni che l’ultimo quarto di secolo italiano ha impartito, ce n’è una che potrebbe
essere utile a chi deciderà l’esito del possibile e necessario lavoro comune sulle
comuni regole del voto. A far calcoli di parte sulla 'resa' di un sistema elettorale si
prendono solenni cantonate. Tant’è che, alla prima applicazione dei sistemi per
l’elezione del Parlamento che abbiamo visto immaginare e realizzare in questi anni,
chi li aveva congegnati e auspicati non ha mai vinto. È andata così nel 1994, col
Mattarellum realizzato su impulso della Dc che stava diventando Ppi, con un esito del
voto che rivoluzionò la geografia politica italiana cancellando il ruolo dell’antico
partito-perno, lanciando nuovi protagonisti (Forza Italia) e dando peso e valore alle ali
estreme (di destra e di sinistra) che la legge avevano duramente avversato. È
accaduto nel 2006, col Porcellum voluto dal centrodestra di allora, che doveva
consegnare a Silvio Berlusconi un più saldo governo di legislatura e invece propiziò la
vittoria di un soffio, e politicamente fragile, dell’Unione ulivista di Romano Prodi.
Quel Porcellum che, poi, non riuscì a essere il 'forcipe' del bipartitismo Pdl-Pd e che,
nel 2013, accompagnò l’esplosione del Movimento 5 Stelle, l’implosione della meteora
montiana e la nascita dell’attuale tripolarismo imperfetto. È accaduto persino nel
2016, con l’Italicum, che non è servito nella sua versione originale a far vincere
elezioni (e il M5S di Beppe Grillo aveva ben presto capito di poterlo fare in solitudine
proprio con quelle regole), ma ha contribuito moltissimo a far perdere un referendum
(e la guida del governo) a Matteo Renzi che l’aveva caldeggiato dopo lo spettacolare
(ma non inscalfibile) 41% ottenuto alle Europee del 2014. Ora le regole le hanno
stabilite i giudici costituzionali con sentenze che hanno fatto, e faranno, giustamente
e liberamente discutere. E che sanciscono non solo la fine di una stagione politica, ma
la solenne 'sconfitta' della politica, e una sua drammatica e paradossalmente
arrogante inanità addirittura sulla materia che più la riguarda: i modi del rapporto
elettorale con i cittadini. Chi siede in Parlamento e ha davvero a cuore il futuro della
nostra democrazia e crede che possa essere equilibrato e buono, può rassegnarsi a
questo?” (a.p.)
2 – DIOCESI E PARROCCHIE
LA NUOVA
Pag 22 Parrocchia della Cita, Marghera: domenica la festa delle arance della
legalità
3 – VITA DELLA CHIESA
AVVENIRE
Pag 14 L’omaggio di Francesco al coraggio delle donne
“Secondo me ne hanno più degli uomini. Dio sa meglio di noi quello di cui abbiamo
bisogno”
Pag 15 Ordine di Malta. Lascia il Gran Maestro, previsto un delegato pontificio di
Gianni Cardinale
CORRIERE DELLA SERA
Pag 21 Veleni nell’Ordine di Malta e il Gran Maestro si dimette di Gian Guido
Vecchi
L’incontro con il papa dopo mesi di caos. Il ruolo di Burke
IL FOGLIO
Pag 2 E’ vero, la dottrina non basta, ma anche il bergoglismo serve a poco di
Luca Diotallevi
La confusione nella chiesa, tra i testi e i gesti del Papa
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO
AVVENIRE
Pag 3 La media del sei atto di trasparenza di Elena Ugolini
Servono più chiarezza e uniformità nei giudizi
Pag 3 Difendere il senso della valutazione di Roberto Carnero
Cosa salvare e cosa no della riforma scolastica
LIBERO
«Sono una suora rompiballe, caccio i sindacati dalla scuola» di Lucia Esposito
Anna Monia Alfieri: «Prof sempre malati? Indaghiamo sui medici che firmano i certificati.
Diamo i voti agli insegnanti». L'esperta di politiche scolastiche: possiamo risparmiare 17
miliardi
CORRIERE DEL VENETO
Pag 1 La generazione del cellulare di Alessandro Russello
Fra (giusti) divieti e opportunità
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA
CORRIERE DELLA SERA
Pag 31 “Neghite, scemo, Africa!”. Il migrante annega davvero (lettere al giornale)
AVVENIRE
Pag 2 Noi solo spettatori, serviva un vero eroe di Alessandro Zaccuri
Il suicidio di un migrante a Venezia
CORRIERE DEL VENETO
Pag 2 Migrante suicida, il cugino piange. Nuova polemica: “Per lui nessuno si è
tuffato” di Eleonora Biral
Pag 2 Le urla, il video e nessun eroe. I telefonini riprendevano la nostra apatia
di Emilio Randon
LA NUOVA
Pagg 2 – 3 Le chiese chiudono con i loro tesori di Enrico Tantucci
Tesserin, procuratore della Basilica di S. Marco: “Mancano parroci e risorse economiche.
E le opere restano nascoste”. Fondazione Cini: “Avvicinarla alla città per farla crescere”
IL GAZZETTINO DI VENEZIA
Pag XXV Sfratto del Cavanis. La Municipalità è sempre assente (lettera di Franco
Vianello, già consigliere di Municipalità)
8 – VENETO / NORDEST
IL GAZZETTINO
Pag 13 Giustizia, Veneto “abbandonato” di Gianluca Amadori
Sabato inaugurazione dell’Anno Giudiziario. Il procuratore generale Condorelli e le nuove
emergenze: arretratezza tecnologica e rischio paralisi in Corte d’Appello
10 – GENTE VENETA
Gli articoli segnalati di seguito sono pubblicati sul n. 4 di Gente Veneta in uscita venerdì
27 gennaio 2017:
Pagg 1, 3, 11 L’unità, un sogno oggi possibile di Giorgio Malavasi e Giorgio Nordio
Il punto sul cammino convergente delle Chiese cristiane nelle interviste a due grandi
protagonisti. Il cardinal Kasper e il vescovo Siluan: «Grandi progressi»
Pag 1 Né angeli né eroi: la lezione di Mattia di Giorgio Malavasi
Pag 5 Un “cielo stellato” e una “stufetta di cemento”: nuove tecnologie per il
riuso della chiesa di San Fantin di Giorgio Malavasi
Pochi soldi, a pioggia? Non servono a nessuno. Per le chiese meglio unificare e
coordinare. Le ragioni del nuovo ufficio diocesano per i Beni ecclesiastici e l’Edilizia di
culto diretto da don Gianmatteo Caputo
Pag 10 Don Giorgio Bagagiolo, un prete sulle frontiere della carità di Giorgio
Malavasi
E’ mancato sabato 21 sera, nella casa di riposo dell’ospedale Fatebenefratelli a Venezia,
dove dimorava da qualche tempo. Ricordava come straordinari gli anni lontani in cui, da
parroco, si era conquistato la simpatia dei “mangiapreti”, a Castello. Il Patriarca Cè gli
affidò la neonata mensa Betania. Il ricordo di don Fausto Bonini: un prete “inquieto”
Pag 12 La Pastorale universitaria? «Si fa in aula»
Idee per i cristiani all’università, presso la sede dello Iusve, a margine del convegno su
Henry Newman ed Edith Stein. Mons. Enrico Dal Covolo, Rettore della Lateranense,
all’incontro dei docenti veneziani: «Non è qualcosa che si aggiunge, ma è essenziale. Ed
è bene che sia sobria nelle parole e ricca nei gesti»
Pag 16 S. Camillo, 300 bimbi attesi al lancio dei palloncini di Lorenzo Mayer
Il 29 gennaio si vivrà una nuova “Domenica a tempo pieno”. Dopo quella che dà inizio
all’anno pastorale lidense, le sei parrocchie dell’isola passeranno la giornata
coinvolgendo anche bambini e anziani dell’ospedale. Alle 10 il via con la messa
Pagg 22 - 23 Jesolo, città che sognava “in alto” di Pierpaolo Biral
Jesolo ha puntato sui grattacieli, in cambio di verde e servizi. Era il sogno di una Miami
veneziana. Ma si è infranto
… ed inoltre oggi segnaliamo…
CORRIERE DELLA SERA
Pag 1 Le partite che Berlino non gioca di Ernesto Galli della Loggia
Ue e Mediterraneo
Pag 2 Le scorciatoie da evitare di Massimo Franco
Pag 2 No dei giudici al ballottaggio, sì al premio. “La legge elettorale è
applicabile subito” di Giovanni Bianconi
Italicum, la Consulta interviene anche sui capilista con un implicito invito alle Camere ad
agire
Pag 8 I tanti cambi di rotta e la dura vita dell’eletto autorizzato di Pierluigi
Battista
Pag 23 Carinzia, rifugio degli italiani di Andrea Pasqualetto
Meno tasse, servizi efficienti: ecco perché tanti scelgono di trasferirsi Oltreconfine. E le
nostre aziende triplicano
LA REPUBBLICA
Pag 1 Ma l’ultima parola tocca alle Camere di Stefano Folli
AVVENIRE
Pag 1 Chi si rassegna? di Marco Tarquinio
La sconfitta della politica
Pag 2 La ricetta di Trump e la sintesi che manca di Leonardo Becchetti
Smontare i trattati commerciali non scioglie i veri nodi
Pag 23 Crociate. Abusi e pregiudizi di Franco Cardini
IL GAZZETTINO
Pag 1 Ma non è la legge che gli italiani meritano di Alessandro Campi
Pag 3 Ma Renzi non sa come staccare la spina a Gentiloni di Marco Conti
LA NUOVA
Pag 1 Verità e interessi in gioco di Renzo Guolo
Pag 1 Legge elettorale europea per uscire dagli equivoci di Gianfranco Pasquino
Torna al sommario
2 – DIOCESI E PARROCCHIE
LA NUOVA
Pag 22 Parrocchia della Cita, Marghera: domenica la festa delle arance della
legalità
Arance per sentirsi bene. Domenica a partire dalle 10.45, nei locali della parrocchia della
Resurrezione, alla Cita, è in programma la Festa delle arance della legalità, organizzata
dal gruppo Mangiare Informati, che ha proposto alla cittadinanza un acquisto collettivo
di arance biologiche (tarocco e moro Igp di Sicilia) prodotte dalla Cooperativa Beppe
Montana di Lentini, a Siracusa, su terreni confiscati alla mafia. Per il secondo anno
consecutivo è stata, infatti, creata una rete tra produttori e consumatori. Un contributo
per la salute, e, con un piccolo sforzo, un dono in natura ai meno fortunati che sono
sostenuti dalla parrocchia della Cita di Marghera. Sono stati raccolti gli ordini provenienti
direttamente dai privati o da Gruppi di acquisto del circondario: più di 160 sono gli ordini
arrivati tra dicembre e gennaio, per un totale di 3500 chili di arance. La consegna
diventerà una festa aperta a tutti, anche a chi non ha ordinato le arance. L’incontro
prevede una fitta scaletta, ospite d’onore sarà il professor Paolo Pagnoni, componente
comitato provinciale di Libera di Pesaro.
Torna al sommario
3 – VITA DELLA CHIESA
AVVENIRE
Pag 14 L’omaggio di Francesco al coraggio delle donne
“Secondo me ne hanno più degli uomini. Dio sa meglio di noi quello di cui abbiamo
bisogno”
L’udienza
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Tra le figure di donne che l’Antico Testamento ci
presenta, risalta quella di una grande eroina del popolo: Giuditta. Il Libro biblico che
porta il suo nome narra l’imponente campagna militare del re Nabucodonosor, il quale,
regnando in Ninive, allarga i confini dell’impero sconfiggendo e asservendo tutti i popoli
intorno. Il lettore capisce di trovarsi davanti ad un grande, invincibile nemico che sta
seminando morte e distruzione e che arriva fino alla Terra Promessa, mettendo in
pericolo la vita dei figli di Israele. L’esercito di Nabucodonosor, infatti, sotto la guida del
generale Oloferne, pone l’assedio a una città della Giudea, Betulia, tagliando il
rifornimento dell’acqua e fiaccando così la resistenza della popolazione. La situazione si
fa drammatica, al punto che gli abitanti della città si rivolgono agli anziani chiedendo di
arrendersi ai nemici. Le loro sono parole disperate: «Non c’è più nessuno che ci possa
aiutare, perché Dio ci ha venduti nelle loro mani per essere abbattuti davanti a loro dalla
sete e da terribili mali. Sono arrivati a dire questo: “Dio ci ha venduti”; la disperazione
era grande in quella gente. Ormai chiamateli e consegnate l’intera città al popolo di
Oloferne e a tutto il suo esercito perché la saccheggino» ( Gdt7,25- 26). La fine sembra
ormai ineluttabile, la capacità di fidarsi di Dio si è esaurita. La capacità di fidarsi di Dio si
è esaurita. E quante volte noi arriviamo a situazioni di limite dove non sentiamo neppure
la capacità di avere fiducia nel Signore. È una tentazione brutta! E, paradossalmente,
sembra che, per sfuggire alla morte, non resti che consegnarsi nelle mani di chi uccide.
Loro sanno che questi soldati entreranno a saccheggiare la città, prendere le donne
come schiave e poi uccidere tutti gli altri. Questo è proprio “il limite”. E davanti a tanta
disperazione, il capo del popolo tenta di proporre un appiglio di speranza: resistere
ancora cinque giorni, aspettando l’intervento salvifico di Dio. Ma è una speranza debole,
che gli fa concludere: «E se proprio passeranno questi giorni e non ci arriverà alcun
aiuto, farò come avete detto voi» (7,31). Povero uomo: era senza uscita. Cinque giorni
vengono concessi a Dio – e qui è il peccato -; cinque giorni vengono concessi a Dio per
intervenire; cinque giorni di attesa, ma già con la prospettiva della fine. Concedono
cinque giorni a Dio per salvarli, ma sanno che non hanno fiducia, attendono il peggio. In
realtà, nessuno più, tra il popolo, è ancora capace di sperare. Erano disperati. È in tale
situazione che compare sulla scena Giuditta. Vedova, donna di grande bellezza e
saggezza, ella parla al popolo con il linguaggio della fede. Coraggiosa, rimprovera in
faccia il popolo (dicendo): «Voi volete mettere alla prova il Signore onnipotente, […]. No,
fratelli, non provocate l’ira del Signore, nostro Dio. Se non vorrà aiutarci in questi cinque
giorni, egli ha pieno potere di difenderci nei giorni che vuole o anche di farci distruggere
dai nostri nemici. […] Perciò attendiamo fiduciosi la salvezza che viene da lui,
supplichiamolo che venga in nostro aiuto e ascolterà il nostro grido, se a lui piacerà»
(8,13.14-15.17). È il linguaggio della speranza. Bussiamo alle porte del cuore di Dio, Lui
è Padre, lui può salvarci. Questa donna, vedova, rischia di fare anche una brutta figura
davanti agli altri! Ma è coraggiosa! Va avanti! Questa è un’opinione mia: le donne sono
più coraggiose degli uomini. (Applausi in aula). E con la forza di un profeta, Giuditta
richiama gli uomini del suo popolo per riportarli alla fiducia in Dio; con lo sguardo di un
profeta, ella vede al di là dello stretto orizzonte proposto dai capi e che la paura rende
ancora più limitato. Dio agirà di certo – ella afferma –, mentre la proposta dei cinque
giorni di attesa è un modo per tentarlo e per sottrarsi alla sua volontà. Il Signore è Dio
di salvezza, - e lei ci crede -, qualunque forma essa prenda. È salvezza liberare dai
nemici e far vivere, ma, nei suoi piani impenetrabili, può essere salvezza anche
consegnare alla morte. Donna di fede, lei lo sa. Poi conosciamo la fine, come è finita la
storia: Dio salva. Cari fratelli e sorelle, non mettiamo mai condizioni a Dio e lasciamo
invece che la speranza vinca i nostri timori. Fidarsi di Dio vuol dire entrare nei suoi
disegni senza nulla pretendere, anche accettando che la sua salvezza e il suo aiuto
giungano a noi in modo diverso dalle nostre aspettative. Noi chiediamo al Signore vita,
salute, affetti, felicità; ed è giusto farlo, ma nella consapevolezza che Dio sa trarre vita
anche dalla morte, che si può sperimentare la pace anche nella malattia, e che ci può
essere serenità anche nella solitudine e beatitudine anche nel pianto. Non siamo noi che
possiamo insegnare a Dio quello che deve fare, ciò di cui noi abbiamo bisogno. Lui lo sa
meglio di noi, e dobbiamo fidarci, perché le sue vie e i suoi pensieri sono diversi dai
nostri. Il cammino che Giuditta ci indica è quello della fiducia, dell’attesa nella pace,
della preghiera e dell’obbedienza. È il cammino della speranza. Senza facili
rassegnazioni, facendo tutto quanto è nelle nostre possibilità, ma sempre rimanendo nel
solco della volontà del Signore, perché – lo sappiamo – ha pregato tan- to, ha parlato
tanto al popolo e poi, coraggiosa, se ne è andata, ha cercato il modo di avvicinarsi al
capo dell’esercito ed è riuscita a tagliargli il capo, a sgozzarlo. È coraggiosa nella fede e
nelle opere. E cerca sempre il Signore! Giuditta, di fatto, ha un suo piano, lo attua con
successo e porta il popolo alla vittoria, ma sempre nell’atteggiamento di fede di chi tutto
accetta dalla mano di Dio, sicura della sua bontà. Così, una donna piena di fede e di
coraggio ridà forza al suo popolo in pericolo mortale e lo conduce sulle vie della
speranza, indicandole anche a noi. E noi, se facciamo un po’ di memoria, quante volte
abbiamo sentito parole sagge, coraggiose, da persone umili, da donne umili che uno
pensa che - senza disprezzarle – fossero ignoranti … Ma sono parole delle saggezza di
Dio! Le parole delle nonne .. Quante volte le nonne sanno dire la parola giusta, la parola
di speranza, perché hanno l’esperienza della vita, hanno sofferto tanto, si sono affidate a
Dio e il Signore fa questo dono di darci il consiglio di speranza. E, andando per quelle
vie, sarà gioia e luce pasquale affidarsi al Signore con le parole di Gesù: «Padre, se vuoi,
allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà » ( Lc
22,42). E questa è la preghiera della saggezza, della fiducia e della speranza.
Pag 15 Ordine di Malta. Lascia il Gran Maestro, previsto un delegato pontificio di
Gianni Cardinale
Roma. L’inglese Matthew Festing ha lasciato la carica di Gran Maestro del Sovrano
Militare Ordine di Malta (Smom). La notizia è stata annunciata ieri con una nota della
Sala Stampa vaticana in cui si spiega che martedì nel corso di una udienza con papa
Francesco, Festing «ha rassegnato le dimissioni» e che ieri il Pontefice «ha accettato tali
dimissioni», esprimendogli «apprezzamento e riconoscenza per i sentimenti di lealtà e
devozione nei confronti del Successore di Pietro e la disponibilità a servire umilmente il
bene dell’Ordine e della Chiesa». La nota vaticana aggiunge inoltre che «il governo
dell’Ordine sarà assunto ad interim dal Gran Commendatore» Ludwig Hoffmann von
Rumerstein «finché verrà nominato il delegato pontificio». Le dimissioni di Festing erano
state precedentemente annunciate con una dichiarazione di un portavoce dell’Ordine
ripreso dalla Reuters: «Il Papa gli ha chiesto di rinunciare e lui ha accettato». Mentre il
successivamente al comunicato vaticano lo Smom ha diffuso un comunicato ufficiale in
cui si puntualizza che Festing «ha convocato il Sovrano Consiglio in seduta straordinaria
per il giorno 28 gennaio per l’accettazione della sua rinuncia all’ufficio di Gran Maestro»
secondo quanto «prevede la carta costituzionale del Sovrano Ordine di Malta all’articolo
16». I fatti susseguitisi nelle ultime ore costituiscono l’ultimo eclatante capitolo di una
vicenda iniziata negli ultimi mesi dello scorso anno e che il 22 dicembre aveva visto la
nascita di un “Gruppo” della Santa Sede, composto da cinque membri e presieduto
dall’arcivescovo Silvano Tomasi, incaricato di riferire al Pontefice riguardo alla
destituzione forzata e respinta dall’interessato del Gran Cancelliere dell’Ordine (numero
tre della gerarchia), il tedesco Albrecht von Boeselager. Una decisione, questa di creare
il Gruppo, che è stata rigettata dal vertice dello Smom in quanto, aveva replicato il Gran
Magistero con una nota del 23 dicembre, «la sostituzione del precedente Gran
Cancelliere è un atto di amministrazione interna al governo del Sovrano Ordine di Malta
e di conseguenza ricade esclusivamente nelle sue competenze». Ad inizio di quest’anno
era filtrata sui media l’esistenza di una lettera riservata del Gran Maestro Festing, in cui
si sollevano dubbi su presunti «conflitti di interesse» di tre membri del Gruppo
prospettando la creazione di una specie di contro-commissione di inchiesta. Secca la
risposta della Santa Sede che aveva confermato «la sua fiducia nei cinque componenti
del Gruppo» – costituito da papa Francesco «allo scopo di informarlo sulla crisi
dell’attuale direzione centrale» – e aveva rifiutato «in base alla documentazione in suo
possesso, ogni tentativo di screditarne le figure e l’opera». In quello stessocomunicato
vaticano si sottolineava comunque che in relazione agli avvenimenti di queste ultime
settimane riguardanti l’Ordine di Malta, la Santa Sede desiderava «ribadire il suo
appoggio ed incoraggiamento all’encomiabile lavoro che membri e volontari realizzano in
varie parti del mondo, in compimento delle finalità dell’Ordine: la tuitio fidei (la difesa
della fede) e l’obsequium pauperum (il servizio ai poveri, ai malati e alle persone più
vulnerabili)». E per questo, «a sostegno e incremento di questa generosa missione», la
Santa Sede confidava «nella piena collaborazione di tutti in questa fase così delicata e
attende la relazione del suddetto gruppo per adottare, in ciò che le compete, le decisioni
più opportune per il bene del Sovrano Ordine Militare di Malta e della Chiesa». Nelle
ultime ore però la situazione è precipitata.
CORRIERE DELLA SERA
Pag 21 Veleni nell’Ordine di Malta e il Gran Maestro si dimette di Gian Guido
Vecchi
L’incontro con il papa dopo mesi di caos. Il ruolo di Burke
Città del Vaticano. La nota ufficiale informa, diplomatica, che il Papa ha accettato le
dimissioni esprimendo «apprezzamento e riconoscenza per i sentimenti di lealtà e
devozione nei confronti del Successore di Pietro», la realtà è un po’ diversa. Fra’
Matthew Festing, Gran Maestro dell’Ordine di Malta, nominato a vita, ha dovuto lasciare
il suo «ufficio» dopo un’udienza con Francesco, martedì. Del resto la faccenda durava da
quasi tre mesi e, più che imbarazzante, stava diventando surreale. Lo scontro di potere
interno all’Ordine di Malta. Il Papa che sollecita il dialogo. Il Gran Maestro (inglese)
Matthew Festing che invece, il 6 dicembre, caccia il Gran Cancelliere (tedesco) Albrecht
Freiherr von Boeselager. Francesco che attraverso il suo Segretario di Stato invita di
nuovo al dialogo, invano. Il Vaticano che nomina una commissione di indagine per
chiarire e comporre la vicenda. E il Gran Maestro del più antico ordine cavalleresco - si
fa risalire agli ospedalieri nati a Gerusalemme nell’XI secolo - che alza le barricate e
risponde picche al pontefice e alla Santa Sede: rivendicando in nome del diritto
internazionale l’«autonomia» e la «sovranità» dell’Ordine rispetto al Papa, cui in teoria
dovrebbe obbedienza assoluta. Alla fine Matthew Festing ha dovuto obbedire, e
dimettersi. Verrà nominato un Delegato pontificio in attesa della nomina del successore.
Si tratta di rimettere insieme i cocci. Sullo sfondo, le spaccature fra britannici (e italiani)
da una parte e tedeschi dall’altra, tra i «professi» religiosi e i «laici» (i tedeschi lo sono
in gran parte), tra chi resiste alla linea di Francesco e chi la segue. Un ruolo
determinante, nel precipitare della vicenda, lo ha svolto il cardinale americano
ultraconservatore Raymond Leo Burke, «patrono» dell’Ordine, che assieme a Fra’
Festing (religioso) ha voluto la destituzione del Gran Cancelliere (laico). Il cardinale
Burke è anche il capofila degli oppositori espliciti di Francesco: dopo il Sinodo e
l’esortazione di Francesco Amoris Laetitia , inorridito dalle aperture sui divorziati e
risposati, era arrivato ad annunciare un «atto formale» per «correggere il Papa».
Festing, per motivare la cacciata, aveva accusato von Boeselager di aver permesso che
una Ong collaboratrice dell’Ordine distribuisse preservativi in Africa e nel Myanmar. Von
Boeselager aveva replicato che l’iniziativa era locale, ne era all’oscuro e l’aveva bloccata
appena saputo. Tutto risaliva a diversi anni prima, peraltro. Un pretesto per regolare
conti interni? Il 10 novembre Burke era andato in udienza da Francesco. Il Papa aveva
scritto una lettera al patrono e all’Ordine nella quale, fermo restando il rispetto della
morale cattolica, chiedeva di risolvere il problema con il dialogo. Il 6 dicembre, invece,
Festing ha cacciato von Boeselager. A quel punto il cardinale Pietro Parolin ha scritto due
lettere, il 12 e il 21 dicembre: «Sull’uso e sulla diffusione di metodi e mezzi contrari alla
legge morale, Sua Santità ha chiesto un dialogo sul modo in cui possano essere
affrontati e risolti eventuali problemi, ma non ha mai detto di cacciare qualcuno». Non è
successo niente, il Papa ha nominato la commissione d’indagine e il Gran Maestro l’ha
rifiutata, fino ad adombrare «conflitti di interesse» di tre membri. Quando la Santa
Sede, una settimana fa, ha respinto «ogni tentativo di screditarne le figure e l’opera» e
intimato «la piena collaborazione di tutti», si è capito che Fra’ Festing era arrivato al
capolinea.
IL FOGLIO
Pag 2 E’ vero, la dottrina non basta, ma anche il bergoglismo serve a poco di
Luca Diotallevi
La confusione nella chiesa, tra i testi e i gesti del Papa
La confusione in cui versa la Chiesa cattolica è sotto gli occhi di tutti. Merita rispetto. Va
guardata in faccia. Se lo si fa, si comprende che nella vita cristiana e nella Chiesa la
confusione e il dubbio sono un peso di cui non ci si può mai liberare del tutto. Dal quale
non si è mai stati liberi, neppure agli inizi. Oggi, poi, mentre giunge a fine corsa la forma
confessionale del cristianesimo (moderna e continetale), la confusione percepita è
esasperata dal fatto che la domanda di verità conserva spesso la forma di una domanda
di dottrina: forma storicamente datata, nobile e ora inadeguata. Il fatto che nella sua
purezza la forma-dottrina sia stata ignota a quindici secoli di cristianesimo, che
altrimenti hanno pensato e cercato ortoprassi ed ortodossìa, non va vissuto come un
dramma. Il motore e il registro delle domande, utilissime e rispettabilissime, riproposte
dal card. Caffarra nella recente intervista al Foglio è quello di una logica imperniata sul
principio di "non contraddizione" applicata a una verità cristiana come un insieme di
proposizioni universali, ovvero: come una dottrina. Se si chiede alla Chiesa di dare al
proprio insegnamento la forma esclusiva della dottrina, fatalmente si resta delusi. Quello
che la Chiesa insegna è sempre stato molto meno e molto più. Finché ci si aspetta una
dottrina si patisce una sovrastima della confusione e del dubbio che fino all' Ultimo
Giorno affiancheranno la fede e la Chiesa. Il principio di contraddizione vale quando il
tempo non scorre. Al contrario, la "verità esistenziale" (Caffarra) del Vangelo ci è venuta
incontro nel corso del tempo e anzi ha reso questo un intreccio instabile di molteplici
temporalità. La verità cristiana ci è venuta incontro nel se colo, durante esso ci salva, ci
accompagna e ci orienta. Nella complessità, contingenza e inestricabile connessione di
ciascun momento del secolo non c'è più modo di separare atti, circostanze e coscienza
(se non in sede analitica: utilissima e astratta). Per questa ragione (ma non fatelo
sapere ai cinici sempre in cerca di scuse) sant' Agostino ha scritto che "Dio può chiedere
oggi cose che ieri vietava" e von Balthasar che la "la verità cristiana è in questo come la
manna del deserto: non la si può mettere da parte e conservare; oggi è fresca, domani
è marcia". Ciò non cancella il fatto che "tutto ciò che è genuinamente vero rimane" (von
Balthasar), ma ci aiuta a capire perché a esso non sempre si arriva con il solo ausilio del
principio di contraddizione applicato a proposizioni universali. Questo non vale solo per
la teologia morale, ma per ogni forma di ricerca della verità. Ciò non significa che dot
trina e logica non abbiano un ruolo nel vivere, pensare e comunicare la fede, tutt' altro.
Aiutano, correggono, mettono in guardia, a volte mettono salutarmente con le spalle al
muro. Debbono avere la parola, ma non la prima né l'ultima. Il principio di
contraddizione è sempre utile, non di rado necessario, a volte fuorviane. L' orizzonte
resta quello del discernimento, non quello della deduzione. Il dramma del cattolicesimo e
più in generale del cristianesimo contemporaneo è che ha vinto. A partire dall'Occidente
(piaccia o no), ha fatto uscire una grande parte dell' umanità dalla minorità. Quello che
ieri bastava capissero pochi teologi, qualche vescovo e un piao di laici illuminati, oggi estremizziamo - o lo capisci, e lo accogli come una Grazia, oppure non ce la fai a credere
(e trasformi la fede in sentimento, dottrina o merce). Di questo prende coscienza il
Vaticano II. Questa è la du rissima profezia di Paolo VI: "la vita cristiana (...) domanderà
a noi cristiani moderni non minori, anzi forse maggiori energie morali che non ai cristiani
di ieri". Una percentuale di cristiani (senza precedenti per lo meno dal III secolo) deve
fare i conti che con il fatto che seguire Gesù e vivere la Chiesa non esenta da dubbio e
confusione. "Non molle e vile è il cristiano, ma forte e fedele" (Paolo VI): questa nuova
condizione richiede più vita di Chiesa, non meno. Più magistero, non meno. Alcuni testi
di Francesco non sono all'altezza dei suoi gesti. A che servirebbero, però, testi (migliori)
senza gesti? Guardare a Francesco attraverso il varco di rinnovamento aperto dal gesto
di rinuncia di Benedetto XVI aiuta ad apprezzare ancor più i gesti di Francesco stesso.
Purtuttavia servono anche testi. Testi che non negano, ma che aiutano a riconoscere e
portare la confusione e il dubbio che accompagniamo il credere reale, condizione che
oggi è di tanti e non di pochi. Anche qui la lezione da non dimenticare è quella di Paolo
VI, il papa della Dignitatis humanae (decreto sulla libertà religiosa) e della Humanae
vitae (e delle catechesi sulla coscienza che le dedicò). Testi non semplici. Tuttavia, oggi
pappette e slogan non nutrono più. Serve pasto solido. Che intorno ai pontefici sorgano
corti è inevitabile, ma è un dovere combatterle e disperderle. Come la dottrina non
basta, così il "bergoglismo" non serve. Altrimenti, quando i gesti saranno passato, i testi
saranno ancora presente e la nostalgia della verità in forma di sola dottrina avrà la
meglio. Valutare caso per caso richiede più rigore, disciplina e comunione di quelle che
servono per dedurre. Chi vende al pubblico la presunta "dottrina-Bergoglio del rompete
le righe" è un pericolo letale.
Torna al sommario
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO
AVVENIRE
Pag 3 La media del sei atto di trasparenza di Elena Ugolini
Servono più chiarezza e uniformità nei giudizi
In questi giorni in molti hanno gridato allo scandalo perché la legge di riforma della
maturità prevede l’ammissione all’esame con la media del sei. Quella che
apparentemente sembra una perdita di rigore, in realtà, non è altro che la richiesta di
mettere in chiaro nello scrutinio di ammissione le eventuali insufficienze dei candidati,
come succedeva prima del 2010. Chi può avere il coraggio di affermare che 'tutti' gli
studenti ammessi all’esame dello scorso anno (96%) avessero conseguito la sufficienza
piena in 'tutte' le materie? Meglio la trasparenza davanti ai membri esterni della
commissione che mettersi il cuore in pace per rispettare 'formalmente' una legge che
può sembrare più rigorosa, ma, di fatto, non lo è. Un altro tema ricorrente è quello che
riguarda l’alta percentuale di promossi fra gli ammessi alla maturità (circa il 99,7%).
Spesso si ironizza su questo dato, come se l’efficacia dell’esame dipendesse dal numero
dei bocciati. In quinta superiore arriva circa l’85% degli studenti che ha iniziato gli studi
e la maturità dovrebbe servire a verificare e certificare il percorso fatto, mettendo alla
prova gli alunni con dei criteri chiari. Siamo talmente lontani da questo obiettivo che
attualmente nessuna università italiana tiene conto degli esiti della maturità per
l’accesso ai corsi di laurea a numero chiuso. Il voto d’esame è invece importante per gli
studenti italiani che desiderano frequentare le università inglesi (Oxford, ad esempio,
chiede di aver conseguito 98 punti su 100). D’altra parte, come riconoscere un valore
comparabile a voti che nascono da 12.554 commissioni diverse (maturità 2016), che
usano 12.554 criteri diversi? Lo sanno bene i ragazzi che si sentono trattati
diversamente dalle commissioni presenti all’interno di una stessa scuola, lo sanno i
docenti, i dirigenti e i genitori. La polemica sulla distribuzione dei '100 e lode' a livello
territoriale che viene fuori puntualmente ogni estate mette in evidenza questo
paradosso. Per avere '100 e lode' gli studenti devono aver conseguito una media
superiore al 9 nel triennio e il massimo in tutte le prove d’esame. È mai possibile che in
certe regioni il tasso di '100 e lode' sia tre volte superiore a quello di altre? Leggendo la
norma approvata in prima lettura al Consiglio dei ministri del 17 gennaio si vede chiaro
l’intento di cambiare questa situazione. Si chiede di elaborare dei quadri di riferimento
su cui verranno costruite le prove di maturità e le relative griglie di valutazione
nazionale; si introduce per la prima volta l’obbligo di svolgere le prove Invalsi di Italiano,
Matematica e Inglese in quinta per poter essere ammessi all’esame; si dice che le
università potranno tener conto dei punteggi conseguiti per l’accesso ai percorsi
accademici a numero chiuso. Da tempo si parlava della possibilità di introdurre delle
prove standardizzate nazionali in sostituzione della terza prova d’esame costruita dalla
commissione; la scelta del legislatore è stata quella di far svolgere i test Invalsi fuori
dalla maturità, utilizzando il computer, anche in modalità adattiva. In questo modo si
potrebbero ottenere tre effetti: garantire le stesse condizioni di svolgimento delle prove
standardizzate per tutti gli alunni, evitando il cheating (l’imbroglio scolastico), dare la
possibilità a ogni singolo studente di mettersi in gioco su una scala diversa di difficoltà
dimostrando le proprie competenze (ci sono alunni bravissimi in tutti i corsi di studio e
fare un’unica prova per testare un valore medio non li intercetterebbe), avere nel
certificato finale i punteggi conseguiti in ogni prova, in modo distinto. Quello che si
riesce a verificare con prove esterne standardizzate è sicuramente diverso da quello che
una commissione d’esame può valutare attraverso delle prove aperte, un colloquio orale
o delle prove pratiche, ma sarebbe negativo per i nostri studenti non potersi cimentare
su tutti e due questi fronti, con serietà. Penso sia molto positivo il fatto che la legge
preveda ancora la presenza di membri esterni nella commissione: non c’è niente di più
assurdo di un esame da sostenere due settimane dopo la fine della scuola, con le stesse
persone da cui i ragazzi sono stati valutati ogni giorno, durante l’anno, ma sono convinta
ci sia un problema culturale da vincere a tutti i livelli (a cominciare da chi interverrà
nell’iter parlamentare per l’approvazione definitiva del provvedimento): pensare che la
valutazione sia un nemico da aggirare e non un modo per valorizzare il percorso di
apprendimento che si è fatto in 13 anni di scuola.
Pag 3 Difendere il senso della valutazione di Roberto Carnero
Cosa salvare e cosa no della riforma scolastica
Chi sperava che, con il cambio ufficiale di governo, le novità introdotte dalla legge sulla
Buona Scuola (n:107/2015) potessero essere cancellate, ora potrebbe rimanere deluso.
Il fatto che la precedente titolare dell’Istruzione, Stefania Giannini, fosse stata sostituita
da una nuova ministra, Valeria Fedeli, aveva lasciato balenare la prospettiva di un
sensibile cambio di rotta in questa materia. Nei giorni scorsi, invece, almeno a prima
vista, è arrivata la doccia fredda degli otto decreti di attuazione della legge stessa
trasmessi dal Consiglio dei ministri al Parlamento. Evidentemente si è deciso di non
gettare alle ortiche il ponderoso lavoro svolto dal precedente esecutivo. Come dobbiamo
valutare questa scelta? Pur nella determinazione di andare avanti con le riforme già
impostate, abbiamo l’impressione che un cambio di passo ci sia stato. La ministra Fedeli,
infatti, ha intrapreso un confronto che appare non solamente formale con il mondo della
scuola e con le sue rappresentanze sindacali. Ha inoltre dichiarato che nelle Commissioni
parlamentari verrà assicurata la condivisione delle decisioni finali con tutti i soggetti
coinvolti: docenti, dirigenti scolastici, studenti, famiglie, associazioni. È opportuno,
perciò, continuare a offrire un contributo costruttivo alla discussione. Ed è utile farlo
partendo dal testo che in questi giorni ha destato maggiormente scalpore sui media,
quello, cioè, denominato 'Schema di decreto legislativo recante norme in materia di
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato'. Quello,
insomma, che tra le altre cose prevede, dal 2018, alcuni cambiamenti sostanziali
nell’esame di maturità. La nuova normativa stabilisce l’assegnazione di un peso
maggiore al curriculum scolastico degli ultimi tre anni (fino a 40 punti su 100), rispetto a
quanto accade oggi (fino a 25 punti su 100), nella composizione del voto finale: ciò
genera qualche perplessità, perché rischia di svuotare di significato il momento
dell’esame. Prevede inoltre che gli studenti debbano sottoporsi alle prove Invalsi di
Italiano, Inglese e Matematica, il cui risultato, pur non incidendo sul voto finale, sarà
riportato sul diploma. Sappiamo che questi test standardizzati non sono visti di buon
occhio da studenti e docenti, ma è anche vero che essi forniscono dati oggettivi in
termini di misurazione delle competenze acquisite, informazioni tutt’altro che inutili per
un discernimento ai fini della continuazione degli studi all’università o per l’ingresso nel
mondo del lavoro. Bene anche che sia rientrata l’idea, più volte ventilata negli ultimi
mesi, di una commissione esaminatrice tutta interna, cosa che avrebbe comportato il
rischio di un’inadeguata uniformità di criteri nella valutazione delle prove tra i diversi
istituti. Verrà eliminata la cosiddetta 'tesina', il percorso interdisciplinare scelto dal
candidato con la cui discussione oggi ha inizio il colloquio: nessuno rimpiangerà lavori
spesso raffazzonati e magari scopiazzati da Internet (hai voglia a istruire gli studenti
sull’illiceità del plagio, ma il malcostume è diffuso e radicato...). Positiva l’abolizione
della terza prova scritta, oggi confezionata dalle singole commissioni, spesso sulla base
di parametri troppo diversi da un caso all’altro, mentre non è ancora chiaro come
cambierà la prima prova scritta, quella di Italiano. Su quest’ultimo punto urgono
informazioni più precise, affinché gli studenti possano esercitarsi con adeguato anticipo
su modelli reali: la preparazione alle prove d’esame non si svolge soltanto al quinto
anno, ma ha inizio almeno già dal terzo. Non è invece accettabile - e su questo
bisognerà che in Commissione Cultura si svolga un’ulteriore riflessione - il criterio ora
previsto per quanto riguarda l’ammissione all’esame: oltre ad avere svolto le ore di
alternanza scuola-lavoro (200 nei licei, il doppio negli istituti tecnici e professionali), si
stabilisce che basterà avere la media di 6/10 tra le diverse discipline (compresa
Educazione fisica e condotta), mentre nella normativa attualmente in vigore è necessario
avere la sufficienza in tutte le discipline. In tal modo basterebbe avere, poniamo, 9 in
Educazione fisica e in condotta, per potersi 'permettere' sei insufficienze in altrettante
materie senza che venga impedito l’accesso all’esame. Spesso si è discusso, negli ultimi
anni, se valga o meno la pena mantenere in vita il 'rito di passaggio' della maturità. Non
dubitiamo che si continuerà a dibattere, ma una cosa è certa: se l’esame di Stato deve
avere un senso, non può essere ridotto a una farsa.
LIBERO
«Sono una suora rompiballe, caccio i sindacati dalla scuola» di Lucia Esposito
Anna Monia Alfieri: «Prof sempre malati? Indaghiamo sui medici che firmano i certificati.
Diamo i voti agli insegnanti». L'esperta di politiche scolastiche: possiamo risparmiare 17
miliardi
Il mondo della scuola conosce bene questa suora «rompiballe» (è lei stessa a definirsi
così ma, precisa, «lo faccio per il futuro dei nostri studenti»). Una che afferra l'osso e
non lo molla più anche a costo di farsi male e fare del male, contro ogni stereotipo che
vuole le religiose docili e remissive. Lo scorso settembre ha partecipato alla convention
«Energia per l' Italia» di Stefano Parisi ed è stata la più applaudita. Suor Anna Monia
Alfieri ha tre lauree, grinta da vendere, ed è una delle maggiori esperte di politiche
scolastiche in Italia. Nel suo ultimo saggio sulla scuola spiega una cosa semplice: che lo
Stato può risparmiare 17 miliardi di euro l' anno. Come? Con quello che lei chiama
«costo standard di sostenibilità per allievo». Attualmente ogni alunno, quello della scuola
materna e quello del liceo, costa 8mila euro solo di spese correnti. Ma lei ha dimostrato
come in realtà un bimbo che frequenta la scuola dell' infanzia costi 3.200 euro. Se le
condizioni della famiglia sono disagiate la cifra sale a 4.573 euro. Se in classe c'è un
disabile il costo aumenta ancora. Ma comunque molto meno degli 8mila euro che lo
Stato spende in modo indifferenziato per tutti gli allievi. Suor Anna Monia propone di
dare a ogni alunno (di tutte le scuole, statali e paritarie) un buono-spesa prestabilito
diverso per ogni tipo di scuola. In questo modo, il Paese risparmierebbe tanti soldi, le
famiglie avrebbero libertà di scelta (perché anche chi non ha soldi potrebbe scegliere
una scuola paritaria) e, spiega, si creerebbe una sana competizione tra scuole «sotto lo
sguardo garante dello Stato». La notizia, che non è rimbalzata sui giornali, è di qualche
giorno fa: il consiglio dei ministri ha approvato una nota in cui parla dell'introduzione del
costo standard. In pratica, una volta completato l'iter legislativo, in poi i trasferimenti
dallo Stato agli enti locali per la scuola verranno fatti secondo i criteri indidivuati dalla
religiosa.
Suor Anna Monia a furia di insistere, o - come dice lei - di rompere le scatole, qualcosa
si muove?
«È un primo passo. Molti passaggi del provvedimento del governo riportano stralci del
saggio che ho scritto con Marco Grumo e Maria Chiara Parola. La strada è lunga ma
finalmente è stato recepito il principio secondo cui l' asilo nido non ci deve costare
quanto il liceo e soprattutto deve essere omogeneo in tutto il Paese, non possono esserci
differenze macroscopiche da una regione all'altra».
Come giudica l'ammissione all'esame di maturità anche senza la sufficienza in tutte le
materie?
«Sono sfavorevole. Perché sforneremo ragazzi impreparati. Passa il messaggio che non
occorre studiare, che il sapere è qualcosa di opzionale. Puntiamo al ribasso, invece
dobbiamo mirare all'eccellenza e chiedere il massimo sia ai docenti che agli studenti».
Richieste di trasferimento dal Nord al Sud, certificati medici, parenti malati da assistere.
Suor Anna Monia Alfieri che cosa succede nella scuola?
«Le possibilità sono due: o c'è un'epidemia oppure andiamo a controllare uno ad uno
questi certificati medici. Da uno Stato serio mi aspetto che indaghi sui medici che li
firmano. Possibile che i prof assunti lontano da casa siano tutti malati?
E che abbiamo tutti parenti da assistere?».
Per il prossimo anno la situazione rischia di peggiorare: il ministro Fedeli ha firmato un
accordo con i sindacati secondo cui i prof che hanno accettato un incarico di tre anni,
potranno chiedere il trasferimento.
«Al ministro - che mi dicono capace di ascolto - chiedo di fermarsi, di pensare al bene
degli studenti».
I prof dicono che sono pagati poco.
«Hanno ragione. Ma nel nostro sistema scolastico la voce che pesa di più è quella del
personale. Perché sono tanti. Se introducessimo la meritocrazia, se scardinassimo l'idea
diffusa e scandalosa per cui la scuola debba essere un ammortizzatore sociale, gli
insegnanti guadagnerebbero di più e avremmo buoni docenti per una buona scuola».
Ma la «Buona scuola» di Renzi è davvero buona?
«Era nata con intenti buoni perché introduceva principi come la meritocrazia, la
leadership del preside che non deve più accettare i docenti che gli manda il ministero ma
li sceglie a seconda del fabbisogno educativo specifico e, terzo, la valutazione della
scuola».
Poi cosa è successo?
«I sindacati si sono scatenati perché la scuola è schiava di una cultura ipersindacalizzata
per cui non si può ipotizzare di valutare i docenti.
Prof e sindacati sono scesi in piazza contro la meritocrazia. E contro la leadership del
preside, ma in tutte le aziende c'è una guida».
Temevano che il potere nelle mani di un solo uomo creasse clientelismo.
«Questo è un falso problema perché la riforma di Renzi prevede una commissione di
valutazione composta da docenti, alunni e genitori».
Che soluzioni vede?
«Prima però dobbiamo ricordare che l'Italia ha ricevuto un richiamo dall'Europa per le
famose Gae (graduatorie ad esaurimento). Persone che avevano vinto un concorso ma
non avevano un lavoro. C'è stata quindi la famosa infornata di oltre 100mila docenti a
cui è stato dato una cattedra anche a centinaia di chilometri di distanza. Prendere o
lasciare».
E tutti hanno preso «Come si fa oggi a rinunciare a un posto di tre anni? Mettiamoci nei
panni di queste persone. Forse hanno fatto una scelta poco etica. Ma il danno l'ha fatto
chi ha creato quelle graduatorie, chi ha permesso che si sfornassero centinaia e
centinaia di docenti senza che ci fossero i posti».
Molti hanno preso il posto e non si sono presentati. E torniamo ai famosi certificati Un
cane che si morde la coda. Come se ne esce?
«Limitare l'accesso alla professione. A Medicina c'è il numero chiuso, adesso per
laurearsi in Scienze della Formazione bisogna superare un esame ma non basta. Per
altre lauree che aprono le porte all'insegnamento non c'è il numero chiuso. A che cosa
servono altri docenti se il tasso di natalità è in calo?».
Come si dovrebbe diventare insegnante?
«Solo in Italia diventi insegnante (alias, posto fisso a tutti i costi) solo perché ti sei
laureato e poi abilitato, cioè hai superato un concorso o hai frequentato per due anni un
corso di specializzazione, il Tfa. Il percorso dovrebbe essere diverso: ti laurei, fai un
tirocinio di tre anni in una scuola (previsto anche dalla riforma di Renzi), dopo il primo
anno una commissione stabilisce se sei idoneo. In questo caso ti abiliti attraverso il
concorso e, se sei capace, insegni. Ma attenzione».
Suora, lei è cattivissima..
«No, penso al bene degli studenti. La valutazione va fatta anno dopo anno. Non si è
insegnante a vita. Solo in questo modo la qualità della scuola migliora. Pensi solo per un
attimo a come si sente il prof che ogni giorno lavora con tenacia ed entusiasmo mentre il
suo collega nullafacente è sempre in malattia e guadagna quanto lui». La legge di Renzi
prevede anche che i docenti siano pagati per formarsi.
«Salta agli occhi è che non è prevista una formazione anche per gli insegnanti delle
paritarie».
Perché al Sud ci sono tanti prof e pochi studenti? C'è qualcosa che non va (o che non
torna..)
«Al Sud per anni l'insegnamento è stato considerato uno sbocco sicuro. E poi il problema
del Meridione, e lo dico da pugliese, è che c' è un alto tasso di dispersione scolastica».
Alla convention di Parisi lei è stata la più applaudita. Vuole diventare ministro dell'
Istruzione?
«No, perché quello è il modo migliore per legare le mani, le buone idee sembra che non
abbiano lo spazio per essere attuate. E soprattutto perché ognuno dà un senso alla sua
vita e il mio l'ho già trovato e cerco di viverlo. Mi chieda cosa direi se la Fedeli mi
chiedesse un consiglio».
Cosa direbbe?
«Di restituire alla famiglia il diritto alla scelta della scuola. Possiamo scegliere in quale
ospedale curaci ed eventualmente morire ma non possiamo decidere, se non abbiamo
soldi, dove studiare. Le direi che bisogna partire da progetti educativi ad hoc. Fare
scuola a Milano non è come farla a Scampia e farla in centro a Milano non è come in
periferia. I dirigenti debbono poter scegliere i propri docenti. Se una scuola vuole portare
avanti un progetto di educazione civica, non ha bisogno che il ministero gli mandi un
prof di musica...».
Ma si può fare tutto questo?
«La proposta c'è: il costo standard di sostenibilità, ma... non si può fare a braccetto con
i sindacati che pensano solo a far lavorare la gente».
CORRIERE DEL VENETO
Pag 1 La generazione del cellulare di Alessandro Russello
Fra (giusti) divieti e opportunità
Siamo in classe, a lezione. Un cellulare squilla. Quello di una ragazza. Non serve
un’istruttoria, il suono svela la colpevole e scatta il sequestro. Scena vista mille volte,
nelle scuole venete e italiane. Mai vista, invece, la reazione. Non da studentessa ma da
«cittadina». A suo dire danneggiata, colpita con quel sequestro nel presunto diritto di
esercitare la proprietà extraterritoriale (del cellulare) che prevarrebbe rispetto al dirittodovere del «contratto educativo» della scuola fatto di regole e didattica. Contratto
peraltro condiviso, regole comprese, con l’iscrizione all’istituto, il liceo Duca degli Abruzzi
di Treviso. Cosa «seria». Perché quella della studentessa, maggiorenne, non è una
protesta che finisce nel tazebao di un’autogestione ma in una caserma dei carabinieri in
forma di denuncia. Per abuso di potere. Il potere della «cattiva scuola» che sequestra un
telefonino durante una lezione. Un caso giuridico, quindi? Anche. Ma ancor prima un
caso educativo, didattico, culturale. E antropologico, in una civiltà nella quale il cellulare
- non solo per i ragazzi - è diventato una sorta di prolungamento del corpo e della
mente. Al punto da creare un sesto senso. O forse il primo. Virtuale e reale. Un nuovo
dna, una frontiera neuronale oltre che sociale. Cellulare padrone del nostro tempo. Nel
bene e nel male. Tempo particolarmente «sospeso» in quella zona franca - di formazione
ed educazione - che è rimasta la scuola, dove il cellulare viene «blindato» ed è appunto
«sospesa» la vita dei ragazzi. Che si consuma quasi tutta, nel resto della giornata, una
volta a casa - con il cellulare di nuovo a portata - in una marmellata fatta di chat,
distrazioni, frivolezze, ma anche compiti condivisi, informazioni, relazioni. Sul caso in
specie non abbiamo dubbi. Bene ha fatto il professore a sequestrare quel cellulare. Non
si disturba e non si offende una lezione. E non si fa finire dai carabinieri un atto
sanzionatorio che trova la sua ragione educativa nella richiesta di rispetto verso il
docente, gli altri ragazzi e una regola (il sequestro) contenuta nel patto scolastico
sottoscritto. Detto questo, estendendo il problema del cellulare a quello dell’utilizzo della
tecnologia digitale in genere (tablet e pc), nella scuola italiana esiste il tema oggettivo
della separazione netta fra i due «tempi» e i due «linguaggi» dei ragazzi. Quelli del
mattino e quelli del pomeriggio. Separazione per certi aspetti salvifica e per altri
cortocircuitante per la generazione dei nativi digitali. Non si può non fare i conti con le
modalità di apprendimento dei ragazzi di oggi, sia per quanto riguarda l’hardware - la
tecnologia dura, lo smartphone, i tablet - sia il software, i linguaggi e tutto ciò che
attraverso di essi viene prodotto, comunità reali o virtuali che siano. In poche parole la
tecnologia, il «medium», non va delegittimato ma usato (non abusato) con intelligenza.
Va capito, condiviso e riempito di contenuti, reso parte e strumento della normale
didattica e dell’apprendimento,fatto sempre e comunque di impegno tra fatica e piacere.
Per dire: lungi da farne un’apologia, a volte si può insegnare persino con un cellulare,
che nei pochi caratteri di scrittura minimal e «fratta» di un tweet o un semplice sms può
riservare l’esperienza di una forma poetica o di un’ancora psicologica. Al mattino è il
«M’illumino d’immenso» di Ungaretti, al pomeriggio una frase tra innamorati o amici in
crisi che si confrontano sulle loro vite. Fatta la media, il risultato è la consapevolezza che
lo strumento tecnologico non è solo o tanto il vettore per la banalità quotidiana ma
anche una piattaforma di ricerca e scrittura, di creatività e sfida a se stessi. Fatti salvi la
decenza e l’accesso democratico alle tecnologie (molti istituti non hanno computer,
latitano le risorse) conta ciò che si scrive, non dove si scrive. Siamo sicuri che in più di
qualche scuola questo e altro ancora già si faccia (magari anche in quella della stessa
denunciante) ma crediamo che la separazione dei «tempi» esista e sia purtroppo netta.
Fissato il confine con la maleducazione dei ragazzi (e dei genitori) che reagiscono con le
carte bollate alla giustezza e alla bontà di provvedimenti educativi (per non parlare della
delegittimazione degli stessi insegnanti), l’uso delle piattaforme digitali deve entrare in
aula sempre più. Diventando una modalità e un linguaggio condivisi con i ragazzi. I
professori, specie quelli più restii e meno «alfabetizzati», pur mantenendo dritta la barra
della didattica devono avere il coraggio di riallineare i tempi della vita e
dell’apprendimento dei nostri giovani. Non per portare la «ricreazione pomeridiana»
nelle lezioni del mattino, ma per non escludere le modalità operative che noi stessi adulti
utilizziamo nella vita lavorativa senza alcuna forma di scissione culturale e temporale.
Con questa modalità, e una volta capiti l’eventuale «forza» oltre che l’uso improprio di
uno smartphone, forse nessun ragazzo si permetterebbe di fare squillare la
maleducazione a scuola.
Torna al sommario
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA
CORRIERE DELLA SERA
Pag 31 “Neghite, scemo, Africa!”. Il migrante annega davvero (lettere al giornale)
Caro Aldo, ho letto sul Corriere del Veneto la storia del migrante del Gambia suicida nel
Canal Grande a Venezia. Un vaporetto si è fermato, gli sono stati lanciati salvagente. Ma
tanti gli hanno gridato «neghite!» (annega), «Africa!», «dai che te torni a casa tua», e
anche «insemenìo» (scemo). Nessuno si è tuffato a soccorrerlo, ma quattro hanno fatto
il video con i telefonini. Aveva 22 anni. Mi chiedo cosa siamo diventati!
(Franco
M, Mestre)
Risponde Aldo Cazzullo: Caro Franco, anch’io sono rimasto colpito dall’articolo. Si fa
anche un’altra ipotesi: alcuni tra coloro che hanno gridato volevano incoraggiare il
ragazzo, come a dire «guarda che così anneghi». Resta la drammaticità dell’episodio: un
migrante sopravvissuto alla rotta del Mediterraneo che conosce la morte per acqua nel
mare urbano di Venezia. E l’indifferenza, se non il divertimento o l’odio, di alcuni tra i
testimoni. È ovvio ma non inutile ricordare che le vite umane vanno salvate; sempre. E
possiamo essere orgogliosi dei tanti italiani che lo fanno ogni giorno. L’omissione di
soccorso non può essere giustificata; mai. Se siamo diventati davvero così, dobbiamo
avere spavento di noi stessi, non rassegnarci. Ma dobbiamo anche chiederci per quale
motivo un popolo ospitale e ricco di umanità come il nostro sia arrivato a questo punto
di esasperazione, confermato anche dalle moltissime lettere che ricevo sull’argomento.
Non esiste nessun Paese al mondo dove mentre sei seduto al tavolino di un bar si
avvicinano in mezz’ora tre o cinque o sette stranieri a chiedere l’elemosina, in modo più
o meno cortese o insistente. A Venezia ce n’è uno per ogni ponte, a Roma e Milano uno
per ogni bar; e ognuno ha la sua signora anziana che l’ha «adottato», che gli lascia
qualcosa ogni giorno, che lo aiuta a tirare avanti. Ma questo alla lunga non è dignitoso
né per loro, né per noi. Che prospettive possono avere questi ragazzi? Quale avvenire
riserva un Paese dove il lavoro è poco, e spesso precario, mal pagato, in nero, esposto
allo sfruttamento e alle infiltrazioni della criminalità organizzata più capillare d’Europa?
La rotta di Lampedusa sta sanando la povertà africana o sta costruendo nuove
sofferenze, altre infelicità? È davvero impossibile salvare noi i profughi di guerra, senza
far prosperare i criminali, e fermare un traffico odioso che finirà per inasprire gli italiani
già illividiti dalla crisi?
AVVENIRE
Pag 2 Noi solo spettatori, serviva un vero eroe di Alessandro Zaccuri
Il suicidio di un migrante a Venezia
Forse non ce l’avrebbe fatta comunque. Perché non voleva farcela, questo purtroppo è
chiaro. Un ragazzo di 22 anni, Pateh Sabally, originario del Gambia, scampato alla
traversata del Mediterraneo e annegato domenica pomeriggio nel Canal Grande di
Venezia, sotto gli occhi di tanti turisti, di tanti abitanti della città. È la determinazione
inspiegabile dei suicidi, la loro contraddittoria caparbietà: rinunciano a vivere perché non
sopportano la solitudine e scelgono di andarsene coinvolgendo gli altri nel modo più
clamoroso possibile, rendendoli testimoni di tanta disperazione. Non ce l’avrebbe fatta
comunque, forse. Anche se non fosse stato nero («Africa», lo chiamano, e non si capisce
se ci sia cattiveria o se nell’epiteto agisca solo la forza di una triste abitudine), anche se
anziché lanciargli un salvagente qualcuno si fosse buttato in acqua e lo avesse
agganciato per le spalle, costringendolo a tornare in salvo. Non si può saperlo, quasi non
si riesce a domandarselo. Ma c’è un video, uno dei tanti che pullulano nel web, girato
con il telefonino tenuto in verticale da una mano un po’ traballante, fino a quando
un’altra mano interviene bruscamente a oscurare l’obiettivo. La voce di chi interrompe la
ripresa non ha l’accento veneziano, è pressoché certo che sia un migrante anche lui. Uno
che chiede pietà, probabilmente. A meno che non si tratti di un tentativo di spegnere
l’attenzione. Non c’è niente da vedere, lasciate perdere. Vediamo tutto, invece, nella
proiezione digitale che il mondo offre instancabilmente di sé. E non siamo mai sicuri di
quello che abbiamo appena visto, perché dentro di noi qualcosa ci avverte che di una
proiezione, appunto, si tratta. Certo, un eroe avrebbe fatto la differenza, ammesso che
vada chiamato eroe chi, obbedendo a un semplice sentimento di solidarietà, provi a
salvare un uomo che sta per affogare. Anche se l’altro è un nero, che magari si è buttato
per fare scena (questo, si sospetta, uno dei motivi che ha rallentato i soccorsi). Si fa
fatica a interpretarla, questa tragedia veneziana. Ma si abbia il coraggio, se non altro, di
accettare che di una tragedia si tratta. Non un caso, non un argomento di sondaggio.
Qualcosa che ci riguarda, non qualcosa di cui discutere come se davvero fossimo solo
spettatori.
CORRIERE DEL VENETO
Pag 2 Migrante suicida, il cugino piange. Nuova polemica: “Per lui nessuno si è
tuffato” di Eleonora Biral
Venezia. «Ho visto il video, è una cosa così triste». Riesce a dire solo queste parole il
cugino del profugo 22enne del Gambia che domenica scorsa si è tolto la vita tuffandosi
nel Canal Grande a Venezia. Lui ha saputo solo l’altro ieri, contattato dal Corriere del
Veneto , che il parente aveva deciso di mettere fine alla disperazione del non riuscire a
trovare un lavoro e una stabilità in Italia, il Paese che nel 2015 gli aveva rilasciato un
permesso di soggiorno umanitario. Si è subito messo in contatto con la questura di
Venezia e lunedì arriverà in laguna. Il pm Massimo Michelozzi ha disposto l’autopsia,
anche per escludere l’assunzione di sostanze nelle ore precedenti all’annegamento,
avvenuto di fronte a centinaia di persone. Una folla che da una parte gli ha lanciato
invano quattro salvagenti e che dall’altra ha guardato da lontano. Il 22enne era arrivato
il giorno prima da Milano. A settembre era tornato dal Gambia e si era spostato in
Svizzera e poi ancora in Italia. «Non riesco a smettere di piangere», dice il cugino dopo
aver guardato e riguardato quel video che immortala il suicidio. Il ragazzo alza le braccia
e si lascia trasportare dalla corrente sotto un vaporetto e a nessuno viene d’istinto di
tuffarsi. Su questo si è scatenata una polemica. Inizialmente si era ipotizzato il reato di
omissione di soccorso ma la procura ha stabilito che non c’erano le basi. Intanto il web si
divide tra chi sostiene che il giovane non voleva farsi aiutare e chi pensa che si sarebbe
potuto fare qualcosa in più. Ieri anche Selvaggia Lucarelli ha detto la sua: «Per una
donna, un bambino, un uomo bianco qualcuno si sarebbe buttato. Ma era solo un
profugo. L’avete guardato andare a fondo e l’avete fatto morire». Il video ha fatto il giro
d’Italia. «Le persone intorno forse pensavano fosse una bravata e poi era troppo tardi»,
dice Gianfranco Bettin, presidente della municipalità di Marghera, secondo cui questa è
una polemica fuori luogo. «La vera polemica andrebbe fatta sulla capacità del nostro
sistema di sostenere chi ha una storia tragica e si è sentito così disperato da morire in
quel modo, forse non a caso plateale, per rendere più forte il proprio grido - aggiunge
Bettin -. Non voleva essere salvato, lo scandalo è questo. Il nostro mondo in cui cercava
salvezza lo ha reso più disperato». In quel luogo che il 22enne ha scelto, davanti alla
stazione Santa Lucia, domani alle 17 sarà deposta una corona di fiori con i colori del
Gambia. Il parroco di Marghera don Nandino Capovilla attende le disposizioni della
questura. «Il salvagente dei diritti, dell’accoglienza ti è stato lanciato tardi, o male, o
chissà - ha detto -. Vorremmo averti conosciuto il giorno prima. Ti avremmo
abbracciato, ti avremmo tenuto stretto. Forse, ma non lo sapremo mai, ti sarebbe
bastato sapere di non essere solo».
Pag 2 Le urla, il video e nessun eroe. I telefonini riprendevano la nostra apatia
di Emilio Randon
«Africa», «dai che ora torni a casa tua». «E ora, neghite». Fortunatamente non si
sentono solo queste parole nel video, ci sono anche invocazioni, urla di raccapriccio e
persino suppliche ad uscire dall’acqua. Ma che Dio dimentichi le prime e tenga conto solo
delle seconde perché domenica scorsa, in vaporetto, avevano tutti le mani troppo
occupate sul telefonino per trovare il tempo di bagnarsi e salvarlo. Che Dio infine parli
con Brecht e vedano insieme se vale ancora la celebre frase del drammaturgo, «beato il
popolo che non ha bisogno di eroi». Domenica, a Venezia, quando il giovane immigrato
affogava di sua volontà, non c’erano eroi e Venezia, con noi, dimostrava di non averne
bisogno. Di bisogno invece ce n’è, eccome, tanto è vero che non smettiamo di
fabbricarceli a buon mercato gli eroi, in prima serata, ogni volta che serve, siano i
soccorritori di Rigopiano o i vigili del fuoco di Amatricie, tutti professionisti del
salvataggio addestrati per farlo: ne abbiamo tanto bisogno che al posto degli originali ci
accontentiamo anche dei succedanei e la commozione ci comprende tutti quando ad
essere tirati fuori dalla slavina non sono due persone ma i cuccioli della coppia di pastori
abruzzesi. L’eroismo, ovvero l’atto di chi rischia la propria vita per salvarne un’altra, non
è obbligatorio, è l’eccezione senza ricompensa, l’atto supremo della solidarietà umana
non richiesto, la sua mancanza non viene punita e nessuno sarà biasimato per aver
anteposto il proprio istinto di sopravvivenza alla vita di un altro. Specie se è un
estraneo. Inoltre «uno il coraggio non se lo può dare» ed è per questo che amiamo tanto
quello degli altri. Quel ragazzo nero non aveva padri né fratelli a bordo del vaporetto, è
gennaio poi e anche se a Venezia i turisti cretini non mancano, con tutti buontemponi e
gli ubriachi che si tuffano per diletto, l’idea di un bagno gelato non è venuta ad alcuno e
se è venuta è stata subito scartata. I salvagente sono stati buttati e le regole marinare
rispettate, ma oltre a queste ho l’impressione che domenica, con il migrante gambiano
di 22 anni, siano andate affogate le nostre consolazioni e con esse tutti i nostri
compiacimenti serali andati a fondo con un suicida liberamente lasciato annegare. C’è un
altro video che girava su You Tube tempo fa, mostra l’esecuzione per annegamento di
un gruppo di «infedeli» da parte dell’Isis. Vengono calati nell’Eufrate in una gabbia e poi
ripescati. E’ orribile. Dove sta l’analogia? Da nessuna parte se non negli estremi ribaltati
della stessa percezione, in mezzo c’è il medesimo orrore: quelli non volevano morire, il
giovane migrante lo voleva, i suoi aguzzini volevano ucciderli, noi non volevamo certo
che morisse, semplicemente non gli credevamo, pensavamo che non ne fosse capace,
anzi qualcuno lo ha incoraggiato a farlo. In mezzo all’impossibile discorso ci siamo noi, il
nostro ruolo di spettatori apatici e anaffettivi quando non divertiti, incapaci di vedere e
di immaginare, di ascoltare l’urlo di una vita che finisce. Non importa se l’immigrato lo
volesse o lo volesse fino ad un certo punto, in Iraq i carnefici gridavano di giubilo, qui da
noi qualcuno gli ha gridato «Africa», «dai che torni a casa» e anche quelli che gli
gridavano «esci dall’acqua» mettevano il telefonino in modalità video, qui come in Iraq,
per rivederlo, perché lo potessero vedere tutti. Con una sola differenza: a Venezia i
telefonini puntati su quel giovane riprendevano noi, tutti noi, ripresi in un orribile selfie
collettivo.
LA NUOVA
Pagg 2 – 3 Le chiese chiudono con i loro tesori di Enrico Tantucci
Tesserin, procuratore della Basilica di S. Marco: “Mancano parroci e risorse economiche.
E le opere restano nascoste”. Fondazione Cini: “Avvicinarla alla città per farla crescere”
Venezia. Allarme per le chiese veneziane a rischio di chiusura e per il patrimonio di
capolavori che contengono al proprio interno. A lanciarlo è il primo procuratore della
Basilica di San Marco Carlo Alberto Tesserin, che ha la responsabilità diretta della sola
chiesa marciana, ma che parla spesso anche con il Patriarca Francesco Moraglia della
situazione generale delle chiese veneziane, sempre più in difficoltà per la mancanza di
risorse per la loro manutenzione - dopo il venir meno delle risorse della Legge speciale
anche per il patrimonio ecclesiastico - ma anche per la diminuzione del numero dei
parroci e il loro invecchiamento, conseguenza anche della crisi delle vocazioni. Il timore
è che il futuro possa riservare una progressiva e imposta chiusure di nuove chiese
veneziane - come è già avvenuto per una parte di esse - mettendo a rischio anche la
conservazione delle opere d’arte che si trovano al loro interno. Procuratore Tesserin, la
situazione del mantenimento delle chiese veneziane è veramente così grave? Sono sorte
anche iniziative, come il circuito di Chorus, con le chiese che applicano il prezzo del
biglietto per le visite turistiche che sembrava una risposta al problema dei costi di
manutenzione e delle aperture. «Anche Chorus è attualmente in difficoltà, perché il
costo del biglietto non basta a garantire guardianìa e manutenzione delle chiese. Diventa
poi difficile stabilire quando chi entra lo fa per funzioni di culto - che devono essere
garantite - o per turismo. Ma va detto che sia il Papa, sia il Patriarca, hanno più volte
ribadito la necessità del libero accesso alle chiese e va trovata dunque una soluzione
condivisa. Io sono ottimista per natura, ma il problema è serio e da cattolico oltre che da
procuratore di San Marco, me lo pongo». Quali rischi intravede? «Non solo quello della
chiusura di molte chiese - per il venir meno dei parroci in grado di occuparsene sottraendo così alla vista di veneziani e turisti la ricchezza di capolavori d’arte e di
architettura che conservano al loro interno. Ma anche un problema oggettivo di
sicurezza, perché le chiese non sono casseforti e limitarsi a chiudere il portone non le
pone certo al sicuro da furti e razzìe, specie se conservano opere importanti al loro
interno». È anche un problema di risorse. «Certamente, perché sono venuti meno i fondi
della Legge speciale destinati anche al Patriarcato, ma anche ad esempio in buona parte
quelli della Regione, che in passato garantivano risorse importanti. Aggiungo che le
chiese - compresa quindi la Basilica di San Marco - non possono usufruire dell’Art Bonus
istituto dal ministero dei Beni culturali che prevede detrazioni fino al 65% delle somme
che i privati investono sul patrimonio culturale. I Beni ecclesiastici sono ad oggi esclusi
dal beneficio, pur essendo sul suolo italiano e conservando un patrimonio di beni
culturali straordinario che è a disposizione di tutti. Una contraddizione che stiamo
cercando di sanare con un’azione forte proprio sui Beni culturali». Quali allora le
soluzioni? «Non è compito mio indicarle, ma non c’è dubbio che vadano trovasti nuovi
canali di risorse per il sistema chiese. Anche il contributo dei Comitati privati
internazionali per la salvaguardia di Venezia, pur importantissimo, si è molto ridotto
negli ultimi anni. Sarebbe bello, idealmente, che ogni Comitato “adottasse” una chiesa
veneziana, contribuendo al suo mantenimento, con le opere che conserva al suo interno,
ma mi rendo conto che non è facile. Ma anche il problema del mantenimento delle chiese
veneziane si inquadra in quello generale della salvaguardia di Venezia e del suo
patrimonio che deve essere un problema anche nazionale, con il sostegno dello Stato».
È quello che avete chiesto, sembra con successo, anche per la salvaguardia del nartece l’ingresso con il pavimento in mosaici - della Basilica di San Marco, che va regolarmente
sott’acqua a quota 65 centimetri di marea, rendendo così inutile da questo punto di vista
anche l’entrata in funzione del Mose. «È così, ed è stato molto proficuo, da questo punto
di vista, l’incontro che ho già avuto con il nuovo presidente del Provveditorato alle opere
pubbliche Roberto Linetti, perché realizzi con fondi statali il nostro progetto di
impermeabilizzazione. Noi ci accolleremo il costo del progetto esecutivo, messo a punto
oltre che dal proto della Basilica di San Marco, l’architetto Mario Piana dall’ingegner
Paolo Campostrini e i test già eseguiti dimostrano che è realizzabile. Consiste nell’isolare
con delle valvole i canali di uscita e gli scoli dell'acqua piovana che in caso di marea
sostenuta portano all’interno l’acqua dai tombini. In questo modo si recupererebbero
almeno 20 centimetri, in attesa degli interventi di isolamento sulla superficie della
Piazza».
A Venezia ci sono oggi quasi 160 chiese. Un’altra quarantina sono andate distrutte e
oltre 30 risultano invece “chiuse al culto”. Una progressiva riduzione delle aperture che è
il risultato del combinato-disposto tra il calo demografico dei residenti che ha svuotato
anche le parrocchie e la crisi delle vocazioni religiose che ha sempre più ridotto il
numero dei preti della Diocesi veneziana. Nel 1990 erano circa 240 mentre oggi sono
poco più di 170, tra cui ci sono anche quelli impegnati in missione e quelli ormai troppo
anziani per svolgere a tempo pieno il ruolo di parroci. Un problema che è destinato ad
aggravarsi nei prossimi anni anche per parrocchie importanti della città. Ad esempio don
Silvano Brusamento, 74 anni che “regge” insieme le parrocchie della chiesa dei Carmini
e di quella di San Trovaso è ormai vicino al limite teorico della pensione dei 75 anni,
anche se le prosecuzioni dell’incarico dipendono poi dalle condizioni di salute e dalla
disponibilità del singolo. Don Luigi Battaggia, ad esempio, a 78 anni, è ancora alla guida
della chiesa dei Santi Apostoli, sia pure con il ruolo di assistente parrocchiale. Vicino al
limite virtuale della pensione è anche don Giancarlo Iannotta, 74 anni, che ha la
responsabilità al Lido della parrocchia di Santa Maria Elisabetta e della chiesa di San
Nicolò. Ma sono molti i parroci che hanno la responsabilità di più di una chiesa, come
Don Antonio Biancotto, parroco di San Silvestro e di San Cassiano o Don Paolo Bellio,
che si occupa insieme di San Nicolò dei Mendicoli e della chiesa dell’Angelo Raffaele.
Complessivamente attualmente i parroci del centro storico con il Lido sono 49, ma il
numero delle chiese di cui si occupano è decisamente superiore. Anche perché il numero
dei parrocchiani è sceso in proporzioni a quello dei residenti e parrocchie come quella di
San Luca, hanno ad esempio solo circa 170 fedeli. E proprio i laici sono chiamati sempre
più spesso a collaborare per tenere in piedi le parrocchie.
Venezia. «La Fondazione Cini, anche per merito del suo presidente Giovanni Bazoli, ha
saputo creare intorno a sé una rete di sostegni privati che le hanno permesso di
trasformare letteralmente l’isola, facendo un centro per la cultura, le arti e la musica
all’avanguardia non solo in Italia. Se posso dare un modesto suggerimento, il passo
successivo deve essere quello di creare un rapporto più stretto con la città e con i
veneziani». Carlo Alberto Tesserin, primo procuratore della Basilica di San Marco è da
circa un mese anche vicepresidente vicario della fondazione che ha sede sull’isola di San
Giorgio e, da politico navigato di scuola democristiana, conosce bene il “punto debole”
dell’istituzione, da sempre sentita un po’ distante, e non solo per la sua sede insulare,
ma di fronte all’area marciana, dall’altro lato del Bacino. «È ancora troppo poco
frequentata dai veneziani», insiste, «e in questo caso forse dipende un po’ da entrambe
le parti, la città e l’istituzione. La prima si sente forse poco coinvolta nelle attività della
Cini che sono invece di altissimo livello. Credo che sia un problema certamente
risolvibile, anche perché nel Consiglio generale della Fondazione sono già rappresentate
praticamente tutte le principali istituzioni veneziane, a cominciare dalle università e dal
Comune, che possono giocare da questo punto di vista un ruolo importante. Ma da un
altro punto di vista la Cini può rappresentare un esempio per le stesse istituzioni che a
volte sono economicamente in difficoltà, proprio perché ha saputo creare un sistema di
relazioni con soggetti pubblici e privati e sponsor che hanno permesso la realizzazione di
strutture straordinarie, dalla biblioteca ricavata nella Manica Lunga dell’ex convento di
San Giorgio, all’Auditorium recentemente ricavato in quello che era lo Squero dell’isola.
La Fondazione è sotto questo aspetto uno dei punti di forza della città, ma si può fare di
più perché tutti la percepiscano come tale. Non riguardo ai programmi e alle attività, che
sono già di prim’ordine, ma proprio al rapporto con i veneziani da rendere più stretto».
Pare di capire che è proprio questo uno dei ruoli che Tesserin vorrà giocare nel suo
nuovo incarico di vicepresidente all’interno dell’istituzione, considerando anche che il
presidente Bazoli per collocazione e per impegni non può certo svolgerlo direttamente.
IL GAZZETTINO DI VENEZIA
Pag XXV Sfratto del Cavanis. La Municipalità è sempre assente (lettera di Franco
Vianello, già consigliere di Municipalità)
Mi sono da sempre occupato del problema della residenza a Venezia e, nel mentre
ringrazio l'attivismo di Venessia.com e dell'Assemblea sociale per la casa, sempre
presenti nelle situazioni più delicate, noto il silenzio assordante della municipalità del
centro storico. Un'assenza, sia in termini di presenza agli sfratti che di impegno politico,
che non va a deporre favorevolmente in merito ad un organismo istituzionale locale, il
quale dovrebbe invece svolgere la sua opera a fianco del cittadino, nella pessima
situazione che conta 5 sfratti al giorno nel comune, di cui uno con la presenza delle forze
dell'ordine. Per quanto riguarda la notizia riportata da Il Gazzettino, dello sfratto da
parte dei Cavanis ad una famiglia veneziana, chiedo all'economo dei padri Cavanis,
nell'anno appena trascorso della Misericordia e della Famiglia, a quale passo del Vangelo
si ispiri nel chiedere soldi ad una sua famiglia affittuaria incolpevolmente morosa, fino ad
intimarne lo sfratto. Spero che anche il Patriarca possa farsi carico della questione,
invitandolo ad esprimersi in merito. L'episodio dello sfratto da parte dei Cavanis
potrebbe essere occasione per un monitoraggio sui lasciti dei quali godono i Cavanis e
l'intera Curia. Il patrimonio abitativo della Chiesa veneziana rappresenta, infatti, un
aspetto non secondario nell'intero problema della residenza, perché i lasciti sono stati
messi a disposizione della collettività e solo in favore di questa dovrebbero essere
impegnati, con il possibile sentimento di Carità nei confronti dei più bisognosi.
Torna al sommario
8 – VENETO / NORDEST
IL GAZZETTINO
Pag 13 Giustizia, Veneto “abbandonato” di Gianluca Amadori
Sabato inaugurazione dell’Anno Giudiziario. Il procuratore generale Condorelli e le nuove
emergenze: arretratezza tecnologica e rischio paralisi in Corte d’Appello
Quasi metà delle sentenze penali di condanna emesse in primo grado nei vari Tribunali
del Veneto finisce in prescrizione, ovvero cancellata per il troppo tempo trascorso. Il
dato fornito ieri mattina dal procuratore generale Antonino Condorelli è sicuramente
quello maggiormente sintomatico della grave situazione in cui annaspa la giustizia della
nostra regione, che ancora soffre dei mali denunciati da tanti, troppi anni: carenza di
personale amministrativo e di strutture, innanzitutto, a fronte di un contenzioso che ha
ripreso a crescere. Mali che rischiano di rendere inutili gli sforzi che hanno portato ad un
aumento di produttività e alla riduzione dei tempi necessari per giungere a sentenza.
L'analisi della situazione relativa ai dodici mesi compresi tra il luglio 2015 e il giugno
2016 è stata anticipata ieri, nel corso di una conferenza stampa alla quale ha preso
parte anche il presidente reggente della Corte d'Appello, Mario Bazzo, che sabato
mattina inaugurerà il nuovo anno giudiziario, dopo il pensionamento, il 31 dicembre, del
presidente Antonino Mazzei Rinaldi. Ai tanti problemi che si trascinano da anni, se ne
aggiunge uno parzialmente nuovo: l'abbandono nel quale gli uffici giudiziari veneti
vengono lasciati dal ministero sul fronte tecnologico, con ripercussioni gravi,
considerato, ad esempio, che il processo civile ormai si svolge unicamente in via
telematica. Dunque, se si bloccano i computer si ferma l'attività. Ebbene, i tecnici che si
occupano di garantire il funzionamento del sistema informatico sono 17 per tutti gli uffici
giudiziari relativi alle Corti d'appello di Venezia, Trento, Trieste e Brescia, che servono
oltre 10 milioni di abitanti. Nella sola Sicilia ve ne sono in servizio 77. A Roma 55.
Sintomatico dell'abbandono in cui vengono lasciati gli uffici giudiziari di una delle regioni
motore dell'economia nazionale. Tra i dati anticipati ieri ce n'è anche qualcuno positivo: i
40 magistrati in più che dovrebbero arrivare presto in Veneto. Tutti saranno però
assegnati a procure e ad uffici giudicanti di primo grado, con l'effetto di aumentare il
numero di sentenze e paralizzare ancor di più la Corte d'Appello, e dunque l'intera
attività. Per comprendere la gravità della situazione basti pensare che, nell'ultimo anno,
di circa 16mila sentenze penali emesso di primo grado in Veneto, ne sono state
impugnate circa 5 mila (quasi tutte quelle di condanna) e le prescrizioni sono state
2.340, quasi 500 in più rispetto all'anno precedente. Condorelli e Bazzo hanno lanciato
un appello affinché l'aumento di organici riguardi presto anche la Corte d'appello. Sul
fronte del personale amministrativo, oggi carente mediamente del 25 per cento (manca,
insomma, un cancelliere su quattro) è stato ricordato il concorso da poco bandito per
coprire 800 posti in tutta Italia, al quale hanno presentato domanda ben 308mila
persone. Ci vorranno anni, insomma, per poter inserire i necessari nuovi cancellieri: nel
frattempo altre centinaia di vecchi ed esperti dipendenti sono in procinto di andarsene in
pensione con risultati facilmente immaginabili. Senza cancellieri che depositano le
sentenze e si occupano della notifica degli atti giudiziari gran parte degli sforzi rischiano
di essere vanificati.
Aumenta la produttività dei giudici e i fascicoli civili vengono definiti sempre più
rapidamente, ma è come cercare di svuotare il mare con un cucchiaino: nel corso
dell'ultimo anno, infatti, sui tribunali del Veneto si sono riversate 154.556 cause, 10mila
in più dell'anno precedente e quelle rimaste pendenti al 30 giugno del 2016 erano 6mila
in più a 12 mesi prima. La nuove emergenze riguardano in particolare gli uffici giudiziari
di Venezia che in qualità di Tribunale distrettuale, hanno competenza sul contenzioso
riguardante le imprese e sui ricorsi presentati dai migranti che si sono visti respingere le
richieste di asilo dalla Commissione amministrativa che ha sede a Verona. Il Tribunale
delle imprese ha iniziato ad essere sommerso dalle cause avviate dagli azionisti dei due
istituti bancari finiti nell'occhio del ciclone, Veneto Banca e Popolare di Vicenza, i quali
reclamano risarcimenti per le consistenti perdite conseguenti alla notevole riduzione di
valore dei titoli posseduti: nei ricorsi chiedono la nullità del contratto di vendita delle
azioni per violazione delle normativa societaria, anche con la pratica dell'acquisto di
partecipazioni con i cosiddetti mutui baciati. Quanto ai ricorsi dei migranti, sono in
aumento esponenziale: nel primo semestre del 2016 ne sono stati presentati ben 1672,
a fronte dei 1040 dell'ultimo semestre 2015. Per far fronte alla superlavoro (la legge
prevede che questi ricorsi vengano decisi entro sei mesi) è stato applicato un giudice,
ma ovviamente non basta. E i ricorsi sono stati suddivisi tra tutti i giudici del Tribunale
civile.
Torna al sommario
… ed inoltre oggi segnaliamo…
CORRIERE DELLA SERA
Pag 1 Le partite che Berlino non gioca di Ernesto Galli della Loggia
Ue e Mediterraneo
Basta qualche buon libro di storia per sapere che nel giugno del 1941, se Hitler, dopo
aver sconfitto la Francia ed esteso il proprio dominio sui Balcani, invece di muovere
guerra all’Unione Sovietica avesse deciso di lanciare le armate naziste verso il
Mediterraneo orientale, verso Suez e poi il Medio Oriente, avrebbe potuto colpire il cuore
indifeso dell’impero britannico e molto probabilmente il secondo conflitto mondiale
avrebbe avuto un esito molto diverso da quello che sappiamo. Per quale ragione Hitler
invece attaccò a Est? Per il suo fanatico odio ideologico-razziale contro il «giudeobolscevismo», naturalmente, ma anche per un’altra ragione non meno importante.
Perché in lui agiva una radicata tradizione tedesca che vedeva il destino storico della
Germania nell’Europa orientale e ancora più a Oriente, nella prospettiva di un incontroscontro con il mondo slavo-russo. Una tradizione fatta di ricordi storici - dai viaggi dei
vichinghi nella Rus’ di Kiev, alla spinta conquistatrice dei cavalieri teutonici lungo le rive
del Baltico - rinvigoriti da una sorta di attrazione fatale maturata nel corso dell’800 tra la
cultura germanica e quella russa, tese quasi alla ricerca di un reciproco completamento.
Dopo la fine dell’impero sovietico questa tradizione di «spinta verso Oriente» ha ripreso
a farsi sentire. Non più naturalmente come desiderio di espansione territoriale (sul
modello del ’14 o del ‘41) o nella forma di un ambiguo richiamo tra sensibilità culturali
eguali e diverse. Bensì come ricerca da parte della Germania di approvvigionamenti
energetici e di mercati per i manufatti tedeschi, come possibilità d’insediamento di reti
commerciali e di penetrazione culturale. Tutto ciò peraltro, per quanto riguarda la
Russia, senza la fastidiosa necessità di fare i conti con un’opinione pubblica
indipendente: anzi al contrario potendo trattare direttamente con un potere centrale
unico e onnipotente. Quello che siede al Cremlino e comanda su tutto. Ma guardare a
Oriente significa distogliere lo sguardo dal Mezzogiorno, non guardare cioè al
Mediterraneo. Chiudere gli occhi davanti al fatto che oggi è proprio nel Mediterraneo che
si giocano le due partite decisive del continente. Dal cui esito, tra l’altro, anche gli
equilibri all’Est dipendono in misura decisiva. La prima partita è quella dell’avvenire
dell’Unione Europea. Se Spagna, Italia e Grecia non riescono a restare nel progetto Ue a
pieno titolo, se le regole dell’Unione non riescono a essere compatibili vuoi con le attuali
difficoltà economiche di questi Paesi vuoi con le loro necessità di sviluppo, se - come
finora è accaduto - essi vengono lasciati virtualmente soli a sbrigarsela con il gigantesco
problema delle migrazioni dall’Africa, ebbene, allora è davvero difficile pensare che una
qualunque costruzione europea possa alla lunga continuare ad essere vitale. Ancor più
difficile diventa pensare che quella costruzione possa mai evolvere nella nascita di un
autentico soggetto politico. E d’altra parte, come è noto, senza una tale prospettiva
diventa problematico altresì credere che la stessa moneta unica, lo stesso euro, possa
alla lunga riuscire a tenere. Pensare, secondo quanto da decenni pensano i circoli politici
tedeschi, che per tenere agganciata l’Europa meridionale all’Ue basti tenere agganciata
la Francia in una sorta di finto condominio franco-tedesco dell’Unione, pensare ancora
oggi ciò è destinato a rivelarsi sempre più un’illusione. Per il semplice motivo che la
Francia, afflitta anch’essa da gravi problemi economico-sociali e da oscure prospettive
politiche, rischia sempre più di assomigliare all’Italia anziché alla Germania. La seconda
partita decisiva - decisiva innanzi tutto per l’Ue - che si gioca nel Mediterraneo è quella
politico-militare. È tra Istanbul e Tangeri, infatti, che oggi passa il confine dei conflitti,
delle guerre, delle rivoluzioni, delle tensioni di ogni tipo, che dall’Afghanistan al Golfo
Persico, all’Africa subsahariana, stanno ripercuotendosi nei modi più pericolosi
sull’Europa. Pensare di non presidiare politicamente e militarmente un tale confine con
tutto il vigore necessario, pensare che un qualunque soggetto politico europeo possa
evitare di farlo, lasciando la situazione andare per conto suo, equivale semplicemente a
una miopia suicida. Ma dell’importanza cruciale delle due partite ora dette la Germania
non sembra accorgersi né curarsi troppo. Il Mediterraneo sembra essere per lei solo un
fastidioso inciampo nella trionfale marcia economico-manifatturiera a cui si sente
chiamata e che la conduce altrove. In questo sostanziale disinteresse, in questo
sentimento di estraneità e di lontananza nei riguardi del Sud - vanamente compensato
dall’attrazione per il suo volto «esotico» - si esprime tutto il peso profondamente
introiettato di quel modello geopolitico di cui parlavo all’inizio. Un modello che considera
la posizione geografica della Germania nel continente - che è una tipica posizione di
«potenza di centro» - come la premessa di una vocazione europea del Paese tutta e solo
terrestre. Fuori della quale può esserci semmai solo il richiamo fascinoso degli spazi
oceanici, il miraggio di un destino mondiale come quello che per esempio accarezzarono
le élite guglielmine all’inizio del ‘900 impegnandosi nel duello navale con la Gran
Bretagna destinato a sfociare nella guerra. È proprio la profonda incomprensione, venata
magari da un qualche sottile disprezzo antropologico, circa il ruolo e il significato del
Mediterraneo, è proprio l’incapacità di cogliere il carattere essenziale di questo limes
geo-politico marino ai fini dello statuto storico-culturale dell’Europa, e dunque in vista di
una sua autentica esistenza come soggetto politico (non solo continentale ma
mondiale): sono proprio questi fattori che in ultima analisi rendono la Germania
incapace tuttora di divenire l’effettivo centro motore dell’Unione Europea. Cioè il Paese in
grado di esercitare un ruolo di effettiva guida politica perché in grado di accogliere,
d’interpretare e di ricondurre le varie parti che costituiscono l’Unione a una sintesi
accettabile da ciascuna di esse.
Pag 2 Le scorciatoie da evitare di Massimo Franco
Era inevitabile che una legge elettorale modellata su un Parlamento composto da una
sola Camera venisse picconata. La sentenza emessa ieri pomeriggio dalla Consulta è
figlia legittima di una stagione di riforme scritte e imposte dal Pd in una realtà virtuale.
Una realtà virtuale smentita bruscamente dal referendum del 4 dicembre. La domanda,
adesso, non riguarda solo le indicazioni che la Corte costituzionale ha dato per
riplasmare il sistema del voto. Rimanda soprattutto a come i partiti le piegheranno ai
proprio obiettivi, dopo avere atteso per mesi, passivamente, il responso. Il problema
non è tanto quello di evitare a ogni costo le elezioni. Ma prima ancora che votare presto,
l’esigenza è di votare bene. Significa dare al sistema una legge elettorale approvata col
consenso di un insieme di forze più largo di quello governativo, perché altrimenti
sarebbe condannata a essere effimera. E in grado di evitare la creazione di maggioranze
diverse tra Camera e Senato, come ha segnalato nel discorso di Capodanno il presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella: perché è sempre più evidente che a rallentare le
decisioni e creare instabilità sono due rami del Parlamento con coalizioni sfalsate, non il
bicameralismo in sé. Finora il sistema politico ha aspettato con una miscela di ansia e
rassegnazione il responso della Consulta. Da oggi, però, dovrà assumersi la
responsabilità di cercare un’intesa che cancelli la sensazione di un pericoloso
immobilismo. Il Parlamento dovrà fare i conti con due spinte opposte. La prima è di chi
vuole elezioni subito e corre contro il tempo. Lo confermano le prime reazioni degli
uomini di Matteo Renzi e, con foga ma forse minore convinzione, di Beppe Grillo e di
Matteo Salvini. Premono per un accordo comunque, e insistono sul voto anticipato:
strana convergenza, che fa pensare. Quanti invece puntano a una riforma più meditata,
affidata al Parlamento, e respingono l’idea di un governo già sull’orlo delle dimissioni,
useranno la decisione della Corte per arrivare al 2018. Non è un gioco fra schieramenti,
ma al loro interno. Attraversa la sinistra e il centrodestra. E nel momento in cui prefigura
di fatto una spinta a dare al sistema un carattere più proporzionale, perché difficilmente
un partito raggiungerà da solo il 40 per cento dei voti che garantisce il premio di
maggioranza, rimette in discussione anche le leadership: non solo dal punto di vista dei
nomi. Se la dinamica è questa, renderà naturale una interpretazione del governo più
incline alla mediazione e ai compromessi; e la ricerca di capi partito maestri di
compromesso e di alleanze. In fondo, alcuni dei pilastri dell’Italicum che sono stati
sbriciolati dalla Consulta, portano in quella direzione. Avere ritenuto incostituzionali il
ballottaggio e la possibilità di optare per il collegio per chi si presenta in più città, è un
parziale colpo a oligarchie e segretari di partito tendenzialmente onnipotenti. Parziale,
perché rimangono i capilista bloccati: una pattuglia di parlamentari iper-fedeli a leader
che possono predeterminarne l’elezione. Ma lo spirito di un Italicum che la sera dopo il
voto doveva permettere di sapere chi aveva vinto e chi no, è evaporato. E il premio di
maggioranza alla Camera ma non al Senato riconsegna un’incognita vistosa, da
sciogliere prima di tornare alle urne. È il momento di ricostruire un simulacro di
credibilità istituzionale. Inseguire scorciatoie elettorali che porterebbero a leggi di parte
e a ulteriori convulsioni, o allungare inutilmente i tempi, significherebbe sciuparla. E,
oltre a tradire gli orientamenti così attesi della Corte costituzionale, vorrebbe dire
sottomettere il sistema politico a una nuova, lunga stagione di subalternità a poteri
esterni .
Pag 2 No dei giudici al ballottaggio, sì al premio. “La legge elettorale è
applicabile subito” di Giovanni Bianconi
Italicum, la Consulta interviene anche sui capilista con un implicito invito alle Camere ad
agire
In attesa che le motivazioni del verdetto con cui la Corte costituzionale ha tagliato via
due pezzi qualificanti dell’Italicum (il ballottaggio e la possibilità dei capilista eletti in più
collegi di sceglierne uno a propria discrezione), gran parte dell’attenzione si concentra
sull’ultima riga del comunicato uscito ieri pomeriggio dal palazzo della Consulta:
«All’esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione».
Un’ovvietà dal punto di vista tecnico, inserita per tenere fuori la Corte dalle zuffe
politiche sul punto. Tuttavia c’è un altro passaggio del comunicato altrettanto e forse più
importante, da cui si deduce che non è quella la strada indicata dai «giudici delle leggi»
con la loro decisione. È un inciso, inserito nella parte in cui si spiega che è stata
cancellata la norma «che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua
discrezione il proprio collegio d’elezione». Regola considerata incostituzionale perché
lasciava al plurieletto la decisione su chi sarebbe entrato alla Camera al suo posto negli
altri collegi, senza alcun nesso con il voto espresso dai cittadini.
L’inciso - Bocciata la norma, però, restava il problema del criterio con il quale assegnare
i seggi scartati dal capolista: uno deve essercene, per evitare di creare un vuoto
normativo che avrebbe costretto i giudici a dichiarare l’inammissibilità della questione.
Non spetta però alla Corte selezionarlo, bensì al legislatore. Ecco allora la via d’uscita
trovata alla Consulta: «Sopravvive comunque, allo stato , il criterio residuale del
sorteggio», previsto dalla legge elettorale del 1957; quella che «rivive» con
l’abrogazione delle precedenti. Con quelle due parole, «allo stato», i giudici chiariscono
che questo sistema è solo ciò che resta dopo il loro lavoro, non certo il meglio. Anzi, lo
qualificano come «criterio residuale» che non hanno valutato perché nessuna delle
istanze giunta sul loro tavolo lo richiedeva. Se lo avessero fatto chissà che ne sarebbe
venuto fuori. Risultato: al momento il sistema vigente è questo, ma probabilmente
sarebbe opportuno che il Parlamento ne trovasse uno migliore. Un invito per adesso
implicito nel comunicato, ma che potrebbe diventare esplicito nelle motivazioni della
sentenza.
Diritto e politica - Sempre in punto di diritto e di principi costituzionali da salvaguardare,
non per considerazioni politiche che non competono alla Corte. Così come è per motivi
fondati sulla Costituzione che sarebbe opportuno avere «sistemi omogenei e compatibili»
per Camera e Senato. Ma i giudici della Consulta non si sono addentrati su questo
argomento, dal momento che l’unica istanza che lo affrontava è stata dichiarata
inammissibile per altri motivi. Dunque nessun monito in quella direzione, sebbene sia
possibile che nelle motivazioni della decisione qualcosa venga detto. I giudici hanno
votato più volte, su ogni singola questione; si sono divisi ma determinando sempre
maggioranze piuttosto ampie. Anche sugli altri due punti messi «sotto processo» dagli
avversari dell’Italicum: il premio di maggioranza e il ballottaggio. Il primo s’è salvato, il
secondo è saltato. Secondo le previsioni. Qualche componente del collegio avrebbe
preferito cancellare anche l’attribuzione del 55 per cento dei seggi al partito che, al
primo turno, supera il 40 per cento dei voti; troppa sproporzione con la lista arrivata
seconda. Ma hanno vinto gli altri; quella norma è figlia della sentenza che spazzò via il
Porcellum nel 2014, e con una soglia sufficientemente alta il premio è stato dichiarato
legittimo.
Legge scritta male - Anche sul ballottaggio c’era una minoranza che avrebbe voluto
mantenerlo, sulla scorta delle argomentazioni portate dall’Avvocatura dello Stato: è
previsto e funziona bene in tante democrazie occidentali a noi vicine. Ma non con la
formula inserita nell’Italicum, ha sostenuto e stabilito la maggioranza dei giudici. Il voto
della Corte non ha bocciato il ballottaggio in sé, che se ben congegnato sarebbe
compatibile con la Costituzione, ma quello senza nemmeno la previsione di una soglia
minima di partecipanti al voto che porta con sé il rischio di sacrificare troppo il principio
della rappresentanza a vantaggio della governabilità. Alla fine si ritorna sul lavoro svolto
dal Parlamento: il problema sono le leggi scritte male, non i principi da cui derivano o
che vorrebbero introdurre. Una ragione in più perché il Parlamento rimetta mano a ciò
che resta dell’Italicum.
Pag 8 I tanti cambi di rotta e la dura vita dell’eletto autorizzato di Pierluigi
Battista
Dura la vita dell’esponente 5 Stelle che, secondo diktat del Capo supremo, può
esprimersi solo dietro permesso vidimato e sempre in sintonia con la linea fissata da chi
ha il potere autocratico di dire ciò che è giusto e ciò che non lo è. Un esempio di
settimana tipo: il disciplinato esponente 5 Stelle, debitamente autorizzato, dovrebbe fare
dichiarazioni solo molto critiche nei confronti di Farage, poi, debitamente autorizzato,
deve parlare bene dei liberali europei, poi, debitamente autorizzato, deve tornate
indietro e dichiarare cose tremende sui liberali europei e cose meravigliose su Farage. I
vecchi partiti che non conoscevano democrazia interna avevano almeno un pregio:
erano pachidermici e burocratici, cambiavano linea molto lentamente e dunque il cambio
di stagione dell’apparato dottrinario doveva avvenire di rado e con ritmi molto blandi.
Beppe Grillo cambia idea vorticosamente, i giorni dispari forcaiolo, i giorni pari
garantista, la mattina filo-Trump, il pomeriggio rettificato. L’esponente 5 Stelle ha una
ragione in più per tenersi sempre connesso: deve sapere a che punto è la linea da
sostenere per calibrare le sue dichiarazioni sugli umori del leader che dovrà concedergli
il permesso di parlare. Che il Movimento 5 Stelle avesse le caratteristiche di una setta,
non c’era bisogno del decalogo autoritario stilato da Beppe Grillo per capirlo. Il guaio è
che questo modello del tutto estraneo ai sistemi non della vecchia politica ma
semplicemente della democrazia viene preso dagli esponenti dei 5 Stelle come se fosse
normale. Roberto Fico dice al nostro giornale che a lui Trump non piace? Ecco la
mannaia, la strada stretta della rettifica e dell’autocritica e la garanzia che un simile
errore non verrà più commesso. Una setta appunto: che si regge sulla sottomissione
volontaria e incondizionata degli adepti e sull’assunzione delle parole del Capo come
dogma indiscutibile. La novità grillina è che adesso si ha a che fare con un dogma
mutevole, cangiante, sottoposto a cambiamenti frenetici. Quello che valeva ieri e che era
stato proclamato solennemente oggi può non valere più, il nemico di ieri può diventare
l’amico di domani e allora se uno sbaglia la sincronizzazione che succede? Meglio tenere
un profilo basso. O tacere. Che è quello che vuole il Capo.
Pag 23 Carinzia, rifugio degli italiani di Andrea Pasqualetto
Meno tasse, servizi efficienti: ecco perché tanti scelgono di trasferirsi Oltreconfine. E le
nostre aziende triplicano
Klagenfurt (Austria). Fra i verdi laghi della Carinzia, nel cuore delle nuove aree
industriali e abitative di questo land austriaco di confine, ci sono due Italie in grande
movimento. Una che arriva e una che fugge, entrambe protagoniste di una sorta di
mutazione genetica nella terra che diede i natali al controverso Haider. Da una parte
mettono radici creativi, imprenditori e professionisti partiti dalla Penisola per sviluppare
un’idea in un luogo che promette rapidità di insediamento e fiscalità più leggera, e con
loro anche una vasta schiera di pensionati in cerca di pace e sicurezza. Dall’altra, molto
meno appariscente, si agita invece un gruppone di avventurieri, evasori e faccendieri
che sta levando le ancore da un Paese diventato di colpo a rischio, nonostante il
salvataggio della Hypo Bank abbia scacciato fantasmi da Piccola Grecia. Il motivo?
Semplice: è caduto il segreto bancario. In nome di quell’Europa voluta ardentemente dal
nuovo presidente austriaco, l’ambientalista Van der Bellen, l’Austria ha detto no a conti e
depositi anonimi dietro i quali si è nascosto per decenni il mondo dei fondi neri. Due
flussi di segno opposto, uno che sbarca con progetti e sogni, l’altro che chiude e scappa
con i milioni mai dichiarati. Succede così che chi sponsorizza i primi esibisce numeri,
nomi e volti in una sorta di new age carinziana. L’Agenzia governativa Aba parla di oltre
438 imprese di proprietà italiana presenti sul territorio, più del triplo rispetto a dieci anni
fa. In mezzo c’è di tutto, dai gelatai alle medie industrie, passando per pizzaioli,
commercianti, ristoratori, albergatori, startupper. Chi promuove gli investimenti (Babeg)
fa i nomi di Scm Zanussi, Bifrangi, Danieli service engineering, Refrion, Skyplastic,
Petraglas, Europlast, Hiper Cast, Feinmechanik, Fassbinderei, Schlauchtechnik, Nilab...
Fra i fuggitivi domina invece l’opacità. Il «settore» lavora nell’ombra e loro inviano
emissari, commercialisti, mediatori. Anche perché la maggior parte di costoro in Carinzia
ha messo solo i soldi. Insomma, un via vai di italiani dai volti più diversi.
Volti nuovi e vecchi faccendieri - Per esempio, al parco tecnologico di Villach (Villaco),
cittadina appena oltre il confine, è arrivata gente seria come il nordestino Enrico
Boaretto. Dopo aver lavorato tre anni con il Nobel Carlo Rubbia alla Sincotrone ha
provato ad aprire una sua attività in Friuli per poi decidere di trasferirsi in Carinzia con
moglie e figlia: «Qui ci sono poche e semplici regole applicate velocemente, per il
business e per la vita. Hai un credito fiscale? Il mese dopo te lo ritrovi sul conto. Il tuo
progetto piace? Un anno e mezzo di uffici gratuiti». Tornerà in Italia? «No». A Klagenfurt
sta nascendo il capannone della Dmc di Fernando De Filippo, attiva da 16 anni a San
Marino nell’home shopping televisivo. «In Austria siamo startup - spiega entusiasta il Cfo
Tarcisio Pagnozzi -. Noi paghiamo più tasse rispetto a San Marino ma i tempi di risposta
delle amministrazioni sono eccezionali. E poi, diciamolo, non esistono mazzette». Non è
però tutto un Eldorado. In Carinzia mancano buona cucina, clima e una certa italica
poesia che fa a pugni con l’asburgica rigidità. Ragione per cui se n’è andato, con gli
evasori, anche qualche insofferente uomo d’impresa. E così, mentre da Boaretto e
Pagnozzi l’attività ferve, nel centralissimo Rathaus Cafe di Villach, ti puoi imbattere in un
occhialuto signore che parla sottovoce al telefonino. Ha una cadenza friulana e dopo
qualche esitazione concede una chiacchiera chiedendo l’anonimato: «Bisogno?... Sono
pazzi gli austriaci, non hanno capito che senza segreto bancario si svuotano le casse
delle banche... Lavoro per commercialisti e imprenditori italiani che hanno i conti...». E
ci allunga un bigliettino con nome e cognome, cellulare e appuntamento per il giorno
dopo, al Kaffee Keinfein: «Ti racconterò due cosucce, qui non posso». Aspettando Mister
X incontriamo il vicesindaco di Villach, Petra Oberrahauner, che agli italiani stende un
tappeto rosso. «Sono i benvenuti, molto preparati, simpatici, gentili e di buongusto»,
sorride in un ottimo italiano. Un difetto? «Tenderebbero a non rispettare le regole».
Lasciamo Villach e andiamo nella vicina Bad Kleinkirchheim, paesino dove l’Italia ha
stabilito un primato: 659 case acquistate su circa 1.700 abitanti. Un’invasione iniziata
dieci anni fa e capitanata da Maurizio Zamparini, il patron del Palermo calcio che a Klein
«ha due palazzi e altre cose», sussurra Martin Nedwed, spettinato agente immobiliare
del posto: «Corro dalla mattina alla sera per gli italiani. Zamparini è un caso a parte, gli
altri sono soprattutto professionisti e pensionati che cercano costi contenuti, verde e
sicurezza». Molti contratti li conclude la vulcanica avvocata trevigiana Enrica Maggi, altro
personaggio di questa terra di confine: faceva la violinista in giro per il mondo, ora è
avvocato a Klagenfurt: «Concludo ogni anno centinaia di costituzioni di società. In
Carinzia si apre in meno di 15 giorni». Non le manca nulla? «La fantasia della musica».
Con lei andiamo alla Taverna di Peppo Zorgno, cento chili tatuati e suscettibili. A Zorgno
è meglio non parlare dell’Italia: «Pagavo tasse e tangenti e avevo solo rogne».
Corrompeva? «Sì». Tangenti? «Sì». Quante? «Tante». A chi? «A chi non faceva nulla».
Uno spreco, insomma. Zorgno non è esattamente un esempio di rettitudine ma è
persona schietta, pratica e intraprendente. Ha chiuso due locali a Conegliano per aprirne
altrettanti in Carinzia, l’ultimo due settimane fa a Bad Kleinkirchheim. Più a sud, in un
grigio edificio di Klagenfurt, dopo qualche resistenza appare il teutonico console onorario
d’Italia Wolfgang Mandl. Vorrebbe parlare dei 2.954 italiani residenti in Carinzia che
arrivano a 4.000 con i domiciliati, quasi il doppio rispetto al 2009.
Il segreto di Klagenfurt - Ma lui è un membro del board della Bks, uno dei principali
istituti di credito, e c’è in ballo la questione «segreto». La funzionaria che lo accompagna
spiega che dal 30 giugno del 2017 le banche austriache dovranno consegnare all’Agenzia
delle entrate di Vienna la lista dei correntisti italiani con nomi e capitali depositati alla
data del 31 dicembre 2016; e dal primo ottobre successivo l’agenzia li riverserà al Fisco
di Roma, che avrà così modo di vedere chi non li aveva dichiarati. «Ci sarà più
trasparenza», taglia corto Mandl. Più pulizia? Silenzio... «Possiamo fare una pausa, per
favore?». È giunta l’ora di Mister X. Il Kaffee Keinfein è un buco dove parlano solo
tedesco: «Almeno non ci sono orecchie indiscrete. Le cose stanno così: la scadenza per
estinguere conti e libretti era il 31 dicembre. Molti l’hanno fatto, so di 250 clienti di una
banca d’affari che sono venuti a prendersi i soldi. Gli altri sperano in una nuova
sanatoria con penale al 10 per cento, in quel caso il nero diventerebbe bianco. C’è
comunque tanta paura». E se la banca non facesse il nome, dietro compenso? «Non
molti sono corruttibili qui. Bisogna cercare l’uomo giusto». Mister X è veloce e
circospetto. Si aggiusta la cravatta, infila gli occhiali e saluta: «Noi non ci siamo mai
visti, mi raccomando».
LA REPUBBLICA
Pag 1 Ma l’ultima parola tocca alle Camere di Stefano Folli
Per una delle frequenti bizzarrie della politica, la morte dell'Italicum, la legge elettorale
«che l'Europa ci avrebbe copiato», viene festeggiata con gioia dal Pd renziano, il partito
che più di tutti l'aveva voluta (salvo singole eccezioni). La ragione è ovvia: oggi
l'obiettivo del segretario-ex premier è il ritorno alle urne in tempi stretti, dunque ben
venga qualunque spinta in quella direzione. La decisione della Consulta è
«immediatamente applicabile » e tanto basta per considerarla il viatico decisivo per
votare entro giugno. Che si tratti di un modello di fatto proporzionale, salvo
l'improbabile ipotesi che uno dei contendenti superi il 40 per cento dei voti, è ormai
secondario. In realtà l'entusiasmo dei collaboratori di Renzi, di Grillo e di Salvini è
alquanto prematuro. È vero, la Corte avrebbe potuto rivolgere una raccomandazione al
Parlamento, coinvolgendolo nel dopo-Italicum, e non lo ha fatto. Tuttavia non stupisce
che sul piano tecnico-giuridico il suo verdetto sia già pronto all' uso. Il contrario sarebbe
impossibile, considerando che i giudici hanno sempre cura di evitare qualsiasi vuoto
normativo, tanto più in una materia spinosa come la legge elettorale. Ciò vuol dire che il
presidente della Repubblica non può essere privato nemmeno per un momento della sua
prerogativa fondamentale, quella di sciogliere il Parlamento. In altre parole, sotto il
profilo costituzionale Mattarella potrebbe indire elezioni anticipate anche nei prossimi
giorni, sulla base del doppio Consultellum emerso dalle decisioni della Corte. Uno - per la
Camera dei deputati - è scaturito ieri dall'affossamento dell'Italicum; l'altro riguarda il
Senato ed è figlio di una precedente decisione, quella che sgombrò dal tavolo il famoso
"Porcellum". Come è evidente, in questa giungla dei sistemi elettorali è difficile muoversi
e non stupisce che il capo dello Stato abbia chiesto con insistenza al Parlamento di
intervenire per rendere più logici e meno eterogenei i modelli di Montecitorio e di Palazzo
Madama. La sentenza della Corte non ha risolto il problema, anzi obbliga le due
assemblee a prendere un'iniziativa in tempi brevi. Lo devono al Paese e anche a se
stesse, visto che la Consulta ha dimostrato tutta l' insipienza della politica in materia di
leggi elettorali. Non è un caso, del resto, se i più solleciti a chiedere lo scioglimento e il
voto sulla base della sentenza di ieri sono i Cinquestelle e la Lega, i due gruppi
interessati a sottolineare il fallimento dei partiti tradizionali, anzi dell' intero sistema, e a
delegittimare lo stesso Parlamento. Ne deriva che il Pd dovrebbe porsi il problema: è più
che legittimo sollecitare il voto, interpretando un sentimento diffuso nell'opinione
pubblica; ma è rischioso farlo mettendosi nella scia di Salvini e Grillo, i campioni della
cosiddetta anti-politica che hanno tutto da guadagnare dal suicidio di un
"establishment". Già il referendum del 4 dicembre ha dimostrato quanto sia azzardato
per un leader di governo impersonare allo stesso tempo le istituzioni e il populismo, il
bianco e il nero. Quindi oggi non conta tanto quando si va a votare, ma come ci si va:
con quale idea del Paese, quali proposte e certo anche quale legge elettorale. Ecco
perché ora la parola passa al Parlamento. Non perché lo dice Bersani, cioè la minoranza
del Pd, o perché qualcuno vuole perdere tempo. Il passaggio parlamentare è
indispensabile per rispettare l'indicazione di Mattarella; per non lasciare ai giudici
costituzionali lo scomodo titolo di legislatori anomali; per rendere più coerente la legge
elettorale. Renzi intende verificare l'esistenza di una maggioranza per il ripristino del
Mattarellum, un modello equilibrato con più pregi che difetti. Si può sperare che tale
maggioranza si manifesti, ma lo scetticismo è lecito. Ciò non toglie che il punto politico
di fondo sia chiaro: esiste in Parlamento una tendenza reale a favore delle elezioni
subito, vale a dire in giugno? E nel caso, i fautori di tale orientamento sono disponibili a
votare con la legge uscita dal palazzo della Consulta? Da oggi ci sono ottimi argomenti a
favore dello scioglimento, ma ce ne sono altrettanti che consigliano una riflessione più
approfondita. È noto, ad esempio, che Berlusconi e Forza Italia preferiscono di gran
lunga concludere la legislatura. E sappiamo che il presidente del Senato, Grasso, si è
espresso in modo esplicito per il voto a scadenza, nel 2018. Possibile ma poco probabile
che egli abbia parlato senza interpretare almeno in parte il pensiero del Quirinale.
Verosimilmente dobbiamo attenderci un periodo di forti tensioni istituzionali se Renzi
dovesse forzare per sciogliere il Parlamento nei prossimi tre mesi. Il gioco è agli inizi, il
suo esito non è scontato.
AVVENIRE
Pag 1 Chi si rassegna? di Marco Tarquinio
La sconfitta della politica
Da ieri sera, dopo la sentenza della Corte costituzionale sull’Italicum, l’Italia è in una
condizione senza precedenti. Ha due diverse leggi elettorali per l’elezione dei due rami
del Parlamento repubblicano, l’organo-cardine della nostra democrazia, e nessuna di
esse è frutto della volontà del legislatore. Entrambe le leggi sono infatti il risultato
dell’azione di scrittura-riscrittura operata dalla Corte costituzionale. Se avessimo dovuto
immaginare un modo per rendere più evidente la triste realtà della nostra 'politica' dopo
anni di proclami ed esibizioni decisioniste e para-decisioniste, forse non saremmo
arrivati a tanto. Ma proprio a questo siamo: alla certificata incapacità del Parlamento di
stabilire regole per la sua stessa elezione che reggano, in questa fase storica, alla matita
rossa e blu del piccolo sinedrio di giudici che siedono nel 'tribunale delle leggi'. Da qui,
se ne saranno capaci, coloro che ambiscono a rappresentarci e governarci dovranno
ripartire, dimostrando di avere più testa che ambizione, più coraggio e spirito di servizio
che ansia di tentare un qualche precipitoso 'incasso' in una concitata e demagogica corsa
alle urne con due sistemi elettorali molto differenti sebbene entrambi a base
proporzionale. Per il Senato, vige il Consultellum 1 (figlio legittimo del delegittimato
Porcellum berlusconiano) che incentiva le coalizioni, restituisce agli elettori l’arma della
preferenza unica e non offre premi di maggioranza. Per la Camera, vige invece il
Consultellum 2 (frutto del dimezzamento dell’Italicum renziano) che incentiva la gara tra
partiti e svalorizza le alleanze, mescola scelta degli elettori, direttive dall’alto e assoluta
casualità nell’elezione dei deputati e premia in seggi il primo partito al di sopra della
soglia del 40%. Si tratta di due leggi, allo stato delle cose, «strabiche» e inadatte a
garantire piena rappresentanza e ragionevole governabilità. Per questo andrebbero
coordinate e armonizzate, ed è ben possibile farlo. Se, però, come nelle settimane
trascorse inutilmente tra il referendum costituzionale del 4 dicembre e la sentenza di ieri
della Consulta, mancasse ancora la volontà di dare una risposta politica efficace –
verrebbe da dire riconciliatrice – alle attese dei cittadini-elettori, se insomma il serio
gioco parlamentare si risolvesse di nuovo in una irritante, faziosa e sterile 'melina',
allora sarebbe meglio tagliare corto e chiudere l’esperienza di questa difficile e
contraddittoria XVII legislatura. Facile capire che cosa serve di più al bene comune. E noi
siamo tra quanti, spes contra spem, continuano ad augurare all’Italia e agli italiani che
Parlamento e leader di partito e di movimento sappiano concentrarsi, per il tempo
necessario, sull’essenziale e riescano a evitare di certificare un altro glorioso fallimento e
un raggelante stato di minorità di una politica che assedia e svuota se stessa persino più
dei sentimenti e risentimenti antipolitici che – le ragioni sono sotto gli occhi di tutti –
anche nel nostro Paese stanno prendendo piede. Tra le non poche lezioni che l’ultimo
quarto di secolo italiano ha impartito, ce n’è una che potrebbe essere utile a chi deciderà
l’esito del possibile e necessario lavoro comune sulle comuni regole del voto. A far calcoli
di parte sulla 'resa' di un sistema elettorale si prendono solenni cantonate. Tant’è che,
alla prima applicazione dei sistemi per l’elezione del Parlamento che abbiamo visto
immaginare e realizzare in questi anni, chi li aveva congegnati e auspicati non ha mai
vinto. È andata così nel 1994, col Mattarellum realizzato su impulso della Dc che stava
diventando Ppi, con un esito del voto che rivoluzionò la geografia politica italiana
cancellando il ruolo dell’antico partito-perno, lanciando nuovi protagonisti (Forza Italia) e
dando peso e valore alle ali estreme (di destra e di sinistra) che la legge avevano
duramente avversato. È accaduto nel 2006, col Porcellum voluto dal centrodestra di
allora, che doveva consegnare a Silvio Berlusconi un più saldo governo di legislatura e
invece propiziò la vittoria di un soffio, e politicamente fragile, dell’Unione ulivista di
Romano Prodi. Quel Porcellum che, poi, non riuscì a essere il 'forcipe' del bipartitismo
Pdl-Pd e che, nel 2013, accompagnò l’esplosione del Movimento 5 Stelle, l’implosione
della meteora montiana e la nascita dell’attuale tripolarismo imperfetto. È accaduto
persino nel 2016, con l’Italicum, che non è servito nella sua versione originale a far
vincere elezioni (e il M5S di Beppe Grillo aveva ben presto capito di poterlo fare in
solitudine proprio con quelle regole), ma ha contribuito moltissimo a far perdere un
referendum (e la guida del governo) a Matteo Renzi che l’aveva caldeggiato dopo lo
spettacolare (ma non inscalfibile) 41% ottenuto alle Europee del 2014. Ora le regole le
hanno stabilite i giudici costituzionali con sentenze che hanno fatto, e faranno,
giustamente e liberamente discutere. E che sanciscono non solo la fine di una stagione
politica, ma la solenne 'sconfitta' della politica, e una sua drammatica e
paradossalmente arrogante inanità addirittura sulla materia che più la riguarda: i modi
del rapporto elettorale con i cittadini. Chi siede in Parlamento e ha davvero a cuore il
futuro della nostra democrazia e crede che possa essere equilibrato e buono, può
rassegnarsi a questo?
Pag 2 La ricetta di Trump e la sintesi che manca di Leonardo Becchetti
Smontare i trattati commerciali non scioglie i veri nodi
Con la decisione di far saltare l’accordo commerciale transpacifico, di ridiscutere quello
con Messico e Canada (il Nafta), di far saltare definitivamente il tavolo negoziale sul Ttip
con la Ue minacciando allo stesso tempo dazi per i prodotti delocalizzati e reimportati
negli Stati Uniti il presidente Donald Trump entra – ed era ampiamente previsto – come
un elefante nella già malmessa cristalleria del commercio internazionale. È sempre più
chiaro che le prime prove sul campo del populismo al potere stanno scompaginando gli
assetti esistenti aprendo un processo dall’esito incerto che porterà alla definizione di
nuovi e diversi equilibri. Prendendo a prestito le categorie della dialettica hegeliana per
interpretare queste novità possiamo identificare una tesi, un’antitesi e una possibile
sintesi. Prima del 'tempo dei populismi', la tesi sugli accordi commerciali è che
l’abbattimento dei limiti agli scambi aumenta la prosperità misurata dal volume dei
commerci e dalla crescita del Pil. Tale risultato si ottiene riducendo dazi, ove sussistono,
e semplificando o eliminando le cosiddette 'barriere non tariffarie', ovvero quei
regolamenti che dietro lo schermo delle esigenze della salute, dell’ambiente o delle
specificità culturali sono in realtà protezioni a produzioni nazionali inefficienti. La
sollevazione popolare contro il Ttip ha coagulato una vibrante critica di diverse
componenti della società civile a questa tesi. Mettendola in discussione sul duplice fronte
dei risultati e dei fini. Quanto ai risultati, gli effetti dell’abbattimento delle barriere sulla
crescita del Pil non sono sempre così forti ed evidenti quando si parte già da scambi
sostanzialmente liberi (l’esempio è il Ttip, gli stessi fautori dell’accordo stimano un
beneficio complessivo attorno allo 0,5% in dieci anni). Ma la critica più radicale è quella
sul fronte dei fini e dell’indicatore di sviluppo adottato. Se l’obiettivo della vita
economica e sociale è quello del benvivere, della soddisfazione di vita, della ricchezza di
senso e generatività, del bene comune, il saldo tra vantaggi e svantaggi degli accordi
come il Ttip non appare affatto favorevole al progresso umano. Il rischio che
l’abbattimento delle barriere generi in realtà una corsa al ribasso sulla dignità del lavoro,
sulla sostenibilità ambientale e sulla salute ha generato quella protesta su cui i populisti
si sono abilmente innestati. Elaborando però un’antitesi che presenta forti limiti dal
punto di vista valoriale e degli obiettivi promessi. La sintesi brutale di questo pensiero
alternativo sta nel 'compra nazionale' e 'assumi nazionale' stabilendo di fatto che la
dignità di una persona cambia sostanzialmente se due individui vivono a poca distanza
divisi da un confine nazionale che li rende o meno elettori in quel Paese (e quindi
interessanti o meno per i leader politici). Con l’ulteriore implicazione che la gravità delle
condizioni di partenza non conta affatto quando chi sta peggio si trova al di là del
confine. Anche sul piano degli esiti (che saranno valutabili solo a distanza di tempo
perché da misurare sulle dinamiche di variabili di economia reale come commerci e
crescita che mutano lentamente) l’efficacia della deriva nazionalista sarà tutta da
verificare. Non è possibile infatti ipotizzare che gli altri Paesi non risponderanno alle
mosse dei 'neonazionalisti' e, dunque, il rischio di spirale di dazi e ritorsioni, all’ordine
del giorno, ridurrà significativamente i promessi effetti su occupazione e ricchezza
nazionale. L’unica ragionevole sintesi, purtroppo non particolarmente attraente dal punto
di vista elettorale, è che gli scambi internazionali, come tutto il resto dell’economia,
devono essere orientati alla dignità della persona, alla tutela dell’ambiente, alla salute e
al perseguimento del bene comune. E che la persona umana ha lo stesso valore
indipendentemente dalla nazionalità ed esiste una maggiore urgenza di intervento a
favore degli ultimi, dovunque essi si trovino. Questo non vuol dire ovviamente che un
politico nazionale non debba preoccuparsi in primo luogo di coloro che gli sono più vicini.
Ciò in virtù del mandato ricevuto e coerentemente con il principio valoriale del prossimo
e della prossimità. Si dà il caso però che il prossimo coincida in larga parte ma non in
toto con il nazionale. È prossimo anche il disperato che chiede asilo arrivando sulle
nostre rive in fuga da Paesi con condizioni politiche ed economiche di gran lunga
peggiori delle nostre. Nella confusione dei nostri giorni, la vecchia sintesi che fa
riferimento all’intuizione dei pionieri equosolidali, è un seme ancora perfettamente valido
che dovrebbe ispirare i nostri passi. Non un voto col portafoglio solo per il 'prodotto
nazionale', ma per ogni 'prodotto ad alta dignità' del lavoro, che tutela l’ambiente e la
salute, ovunque esso sia stato realizzato. E dunque, nella filiera tradizionale del sud del
mondo da cui provenivano i primi tradizionali prodotti equosolidali, ma anche nella linea
più recente del solidale italiano. Perché i Nord e i Sud sono ormai mescolati e non più
corrispondenti a coordinate geografiche. Il bracciante sfruttato dai caporali in Sicilia o in
Puglia e il contadino sfruttato in Africa o in Asia indipendentemente dal fatto che le filiere
si trovino in Italia o all’estero sono un’insulto alla dignità del lavoro e una minaccia alle
tutele conquistate. E questo voto col portafoglio intelligente può e deve essere favorito
dal potenziamento dell’infrastruttura informativa (a costo zero per lo Stato) sulla
'patente' socioambientale dei prodotti e da una rimodulazione dell’imposta sui consumi
che premi le filiere migliori. Oltre i limiti evidenti della tesi e dell’antitesi, questa sintesi è
anche la risposta più cooperativa, intelligente e lungimirante ai dilemmi della fase
attuale della globalizzazione.
Pag 23 Crociate. Abusi e pregiudizi di Franco Cardini
Ebreo e libanese di nascita, Gad Lerner ama Gerusalemme e “da sempre” è attratto dal
problema delle crociate al quale anni fa, anche avvalendosi della collaborazione di uno
storico, aveva dedicato un saggio. Ha ripensato ora, tre lustri più tardi - questi tre lustri:
le Torri Gemelle, le guerre in Afghanistan e in Iraq, Charlie Hebdo, il Bataclan, il Daesh…
- al tema frainteso e abusato delle crociate, alla loro sostanza storica e ai
fraintendimenti contemporanei ma anche al dramma persistente di una terra che non sa
trovar pace e di un mondo nel quale la guerra magari non santifica più nessuno (del
resto, non lo ha mai fatto) ma è diventata un fenomeno endemico e onnipresente, una
minaccia continua ma anche, per molti, un business redditizio e un irrinunziabile alibi
politico. Mai come oggi si è tanto parlato al mondo di pace, mai essa è parsa tanto
lontana. Nell’Occidente moderno, o se preferite nella Modernità occidentale, Dio è morto.
O quanto meno si fa di tutto per vivere, per pensare e per arricchirsi come se non ci
fosse più o non ci fosse mai stato. Più che negarLo, che non è in, Lo s’ignora: si vive
come se Lui non ci fosse; e, se e quando Lo s’incontra (càpita…), ci si volta dall’altra
parte. Eppure ed è ciò che ha sconvolto Lerner e lo ha indotto a ripubblicare in veste
aggiornata il suo libro - il califfo del Daesh Abu Bakhr al-Baghdadi (ammesso che sia
ancora vivo) ci chiama ancora “crociati”; e d’altro canto, tanto per risponderli ribattendo
con asinerie ad altre asinerie, noi lo trattiamo da personaggio degno «del buio
Medioevo». Al contrario. Il califfo del Daesh è un personaggio postmoderno, appartiene
al XXI secolo esattamente come il suo sedicente stato retto dall’occulto sostegno altrui e
dalla propaganda mediatica. Quando parla tanto di crociate, attribuendole ai crociati,
ignora il fatto che il suo bisnonno non avrebbe mai potuto fare discorsi analoghi ai suoi
in quanto nel lessico ordinario arabo il termine “crociata” ( harb al-salibyya) non esiste:
è un neologismo affermatosi solo in pieno Ottocento, quando i colonialisti di allora
cominciarono a pensar utile informare le élite appunto arabe che quel che accadeva in
quel momento aveva avuto illustri precedenti secoli prima. Non era vero: eppure le
analogie spazio-temporali non mancano. E, se gli islamisti possono chiamarci ancora
“crociati”, non manca - al contrario! chi nel nostro Occidente invoca “nuove crociate”,
evidentemente del tutto all’oscuro al pari del califfo al-Baghdadi, anche se su altre basi,
di quel che fu il fenomeno la sostanza del quale nacque più o meno un millennio fa,
mentre la parola si andò lentamente costruendo da allora ai due-tre secoli successivi. In
Crociate. Il millennio dell’odio Edizione aggiornata. Perché gli islamisti ci chiamano
ancora “crociati” (Rizzoli, pp. 105), Lerner abbraccia un intero millennio di storia per
chinarsi su questa bizzarra illusione ottica della storia, questo gioco di specchi tra parole
e cose che ha determinato, ad est come ad ovest, una sorta di «riflesso condizionato,
una specie di déjà-vu: richiamo istintivo a una contrapposizione atavica, sempiterna».
Ma più che istintivo il richiamo è dettato dal miscuglio abbastanza miserabile di
maldigerite reminiscenze scolastiche e di contrapposte mistificazioni paraideologiche: il
pregiudizio delle crociate eterno e irremissibile prodotto di uno “scontro di civiltà” che
non c’era prima, in quanto tra XI e XVIII secolo (le crociate, come diceva Cesare Pavese
in La luna e i falò, furono molte più di sette) le guerre dei cristiani contro i musulmani
molte meno e molto meno sanguinose di quanto non siano state quelle dei cristiani
contro altri cristiani e di musulmani contro altri musulmani - altro non furono se non il
volto militare di un rapporto complesso, sostanziato da una robusta a continua circolarità
di scambi economici, diplomatici, culturali, artistici. Prendiamo il “secolo d’oro” del
nostro Mediterraneo, il Duecento di Federico II, delle città marinare, del fiorino e del
ducato d’oro, dei traffici che hanno reso ricchi e operosi i nostri comuni: eppure quello fu
il tempo più denso di crociate, quattro - la IV, la V, la VI, la VII e l’VIII, più altre
“minori” - in meno di un settantennio, fra 1204 e 1270. Ma le crociate non erano guerre
totali: erano guerre episodiche, limitate, stagionali, “permeabili” alle opere della pace a
cominciare dai commerci. Attraverso le crociate, nonostante ad esse o magari grazie ad
esse, si diventava anche amici: ci si scambiavano merci, alleanze, libri, temi culturali. Il
personaggio delle crociate più popolare in Occidente è un principe saraceno, il “feroce”
Saladino (che feroce non era). Ma dopo i tempi del letargo e dell’oblìo, dopo i secoli di
quella storia coloniale che da noi finora mai nessuno o quasi ha studiato (ed è per
questo che ci crediamo tanto innocenti dinanzi all’Oriente che ci accusa…), ecco che
tutto sembra tornar come allora, come mille anni fa, tra grida di “Allahu akbar!” alle
quali tanti vorrebbero rispondere con un non meno stentoreo «Dio lo vuole!». Eppure ci
viene ripetuto da tante parti che ammazzare e ammazzarci nel nome di Dio è orribile:
come se, peraltro, ammazzare e ammazzarci nel nome del petrolio o del potere fosse
invece chic. Le crociate, dopo le grandi rievocazioni romantiche alla Walter Scott passate
magari al cinema hollywoodiano dei kolossal medievali tra ferraglie e calzamaglie, erano
da tempo cadute nel dimenticatoio scolastico. Passato il tempo nel quale esse venivano
voltairianamente accusate di essere guerre dettate dall’ignoranza, dal fanatismo e dalla
superstizione, una “vulgata” di segno grossolanamente marxiano ne avevano fatto l’alibi
o, al massimo, la “sovrastruttura” di concrete necessità socioeconomiche. Poi, di colpo, il
sorgere del fondamentalismo detto quindi jihadismo e più propriamente (ma non senza
malintesi lessicali) «islamismo», insomma lo stravolgimento ideologico-politico di un
credo religioso: in modo che, commenta limpidamente Lerner, «gli agguati che ledono la
nostra serenità fisica ed esistenziale sollecitano il dubbio che si annidi nell’Islam una
misteriosa forza satanica, tale da riproporcelo come nemico assoluto, irredimibile» e
«costringerci a indossare metaforicamente di nuovo l’armatura dei guerrieri medievali
crucesignati». Ed ecco Lerner, figlio di un Libano che per tanti versi è scaturito proprio
dall’esperienza crociata dei secoli XII-XIII e di un ebraismo che di certe crociate è
rimasto invece vittima, partire in una sua crociata culturale e sentimentale verso quel
Vicino Oriente che ama, quell’Israele che sente con forza sua-enon- sua al tempo stesso.
Israele, dove paradossalmente i crociati (quelli veri, della storia) sono al tempo stesso
odiati come massacratori di ebrei e usurpatori di Eretz Israel e quasi amati al tempo
stesso in quanto appunto a cavallo tra XII e XIII secolo il prodotto della crociata fu uno
stato laico, feudale e occidentale, che a lungo resse circondato dalla marea dei poteri
musulmani: e la propaganda palestinese, ancora oggi, ripete che gli israeliani sono un
corpo estraneo nel Vicino Oriente di oggi esattamente come i crociati lo furono in quello
di otto-nove secoli fa e faranno quindi al stessa fine, saranno ricacciati in mare. Paragoni
improponibili; analogie illusorie; eppure, parole d’ordine che debbono proprio al loro
semplicismo volgare il successo. Per smascherare e disincantare queste illusioni, ma
anche per mettere in guardia contro pericoli del presente (e del futuro) che si
presentano tanto simili nei luoghi e nelle parole a quelli del passato, Gad Lerner
ripercorse nell’estate di diciassette anni fa, tra il luglio e l’agosto del 1999, alcune delle
tappe delle crociate: dalla Borgogna ai Balcani, a Costantinopoli/Istanbul, ad Antiochia, a
Gerusalemme, ad Acri. Percorrendo quei luoghi, Lerner ne raccontò succintamente la
storia crociata: una storia di battaglie e di orrore, di odio eppure nonostante tutto
d’incontro: una storia che sa di sangue e d’oro, di sudore e di cardamomo, di lacrime e
d’incenso. Ora ripensa a quei viaggi per il Vicino Oriente, che appena qualche lustro fa
era ancora abbastanza possibile far liberamente e pacificamente mentre oggi tutto è
diventato più difficile. Eppure, il buon vecchio Vico qualche ragione ce l’aveva: “corsi e
ricorsi”. Chi sa un po’ di storia apprezza somiglianze e analogie ma è in grado di cogliere
differenze e contraddizioni; chi non la sa è solo destinato a riviverla. Come tragedia o
come farsa. Ed è quanto oggi, purtroppo, molto spesso succede.
IL GAZZETTINO
Pag 1 Ma non è la legge che gli italiani meritano di Alessandro Campi
Eccola dunque la legge elettorale auto applicativa decisa dalla Consulta e che pezzi
importanti del mondo politico italiano invocavano con l'idea (meglio, la speranza) di non
doversi assumere la responsabilità in Parlamento di farne una diversa da quella
eventualmente bocciata ed emendata dai giudici. Ma si può davvero utilizzare, con
beneficio reale per la collettività, un sistema di voto come quello uscito ieri dalla
decisione della Corte Costituzionale, che rappresenta letta politicamente certo un
apparente via libera all'ipotesi di elezioni anticipate, ma anche (forse soprattutto) un
colpo ulteriore assestato al disegno innovatore perseguito da Renzi? Chi vuole il voto
subito diciamo entro il prossimo giugno, dallo stesso Renzi a Grillo e Salvini risponde di
sì senza remore. L'argomento è che dall'Italicum è stato cassato il ballottaggio tra le due
liste con più voti al primo turno (meccanismo che ben si addiceva ad un sistema
monocamerale, ma inadatto al bicameralismo che gli italiani hanno voluto conservare col
voto al referendum dello scorso 4 dicembre), ma lasciando il premio di maggioranza al
partito che dovesse raccogliere almeno il 40% dei consensi. Col primo meccanismo,
espunto, una minoranza avrebbe potuto ottenere un numero di saggi esorbitante
rispetto alla sua effettiva forza elettorale, distorcendo così la volontà popolare. Col
secondo, mantenuto, non si trasformerebbe, in modo artificiale, una minoranza
numerica in maggioranza politica, ma si darebbe al partito che già gode di un vasto
seguito nel Paese, appunto superiore al 40%, la possibilità di rafforzarsi all'interno del
Parlamento grazie ai seggi assegnatigli in premio in modo da dare vita ad un esecutivo a
sua volta stabile e durevole. E dunque, fatta questa necessaria correzione alla legge che
ne salva l'impianto maggioritario, si vada alle urne con quello che dopo il Mattarellum, il
Porcellum e l'Italicum già si è indicato come il Consultellum. Ma la geografia politica
attuale ci consegna, come tutti ben sanno ma come i fautori del voto immediato
sembrano irresponsabilmente trascurare, un Paese politicamente diviso in tre e in via di
crescente frammentazione: tre blocchi, pressoché equivalenti dal punto di vista dei
consensi potenziali e comunque lontani dalla soglia del 40%, e formazioni minori di
contorno la cui aggregazione questa legge (sebbene permanga la soglia di sbarramento
del 3%) certamente favorirà. Se si votasse col sistema che la Consulta ha confezionato
un proporzionale de facto con un premio formale di maggioranza che nessuno
prevedibilmente otterrà ne verrebbe fuori un Parlamento a sua volta frazionato, diviso e
privo di una maggioranza netta (sempre che non risultino due maggioranze diverse tra
Camera e Senato vista la difformità al momento esistente tra i rispettivi sistemi di voto).
Non sarebbe il caos o l'ingovernabilità, ma certamente il ritorno alle contrattazioni e agli
accordi post-voto. Oltre al ballottaggio è stato ritenuto incostituzionale anche il
meccanismo delle pluricandidature, che avrebbe consentito al capolista eletto in più
collegi di scegliere a sua discrezione quello da rappresentare. Ma è una bocciatura
parziale. Le pluricandidature nella sostanza rimangono con la differenza, rispetto a
quanto previsto dall'Italicum originario, che la scelta del collegio nel quale si risulterà
eletti verrà affidata ad un sorteggio. La mancanza di preferenze (e dunque lo scarso
potere di scelta concesso agli elettori, ai quali sempre bisognerebbe pensare quando si
mette a punto un sistema di voto) era una delle ragioni che aveva portato la Corte
Costituzionale a smantellare il Porcellum. Cosa è cambiato, sul piano del giudizio
tecnico-politico, rispetto all'Italicum? Se si ritiene che una legge elettorale debba servire,
tra le altre cose, anche a selezionare un ceto politico che sia competente, autorevole e
non autoreferenziale, la sentenza di ieri se presa come immediatamente applicabile non
va assolutamente in questa direzione. Essa infatti ci consegna una legge (certo gradita
alle oligarchie di partito) che favorisce le designazioni dall'alto e la cooptazione dei
parlamentari secondo criteri che facilmente si possono intuire: la fedeltà, il conformismo,
l'obbedienza e lo spirito gregario. Niente dunque che abbia a che vedere con la
competenza, l'autonomia di giudizio e la capacità d'iniziativa politica. Se ne deve
concludere che, per quanto difficile, una soluzione politica innovativa, in materia di legge
elettorale, i partiti da domani dovranno cercarla all'interno del Parlamento, prendendosi
tutto il tempo che sarà necessario. Non c'è dunque un bel nulla di immediatamente
applicabile. C'è semmai da applicarsi, questo sì, nel lavoro di mediazione parlamentare
per dotarsi sulla base dei paletti costituzionali fissati dalla Corte di una nuova legge
elettorale che per quanto possibile possa garantire queste tre cose (in quest'ordine): il
potere di scelta dei cittadini, la qualità del ceto parlamentare, la stabilità dell'esecutivo al
quale quest'ultimo dovrà concedere la propria fiducia. Esattamente quel che le due leggi
attualmente in vigore non garantiscono.
Pag 3 Ma Renzi non sa come staccare la spina a Gentiloni di Marco Conti
“No, vabbè! Francesco, cancella quel tweet”. E’ toccato ieri pomeriggio a Renzi gettare
secchiate di acqua gelata sull’entusiasmo dei suoi e soprattutto del tesoriere del Pd
Francesco Bonifazi che pochi minuti dopo la sentenza della Consulta sull'Italicum scrive:
«Non ci sono più alibi, votiamo». Nel nuovo stile renziano il tifo va calibrato con la
politica e calato con molto più tatto e cautela non solo nel Palazzo ma anche nel Paese.
Urlare chiedendo «elezioni-elezioni» quando si stanno ancora tirando fuori le vittime a
Rigopiano e si deve accelerare la ricostruzione nelle zone del terremoto, non è certo
opportuno. Senza contare che il problema della legge elettorale in questo momento
interessa poco o nulla non solo ai terremotati ma anche al resto del Paese alle prese con
ben altri problemi. Ovvio che l'impatto della sentenza sui partiti, Pd in testa, è forte ma
per il nuovo-Renzi che andrà in scena per la prima volta sabato a Rimini all'assemblea
degli amministratori locali organizzata da Matteo Ricci, l'argomento della legge elettorale
e del voto anticipato va posto in subordine all'agenda delle emergenze. «Adelante con
jucio», sostiene quindi l'ex premier con i suoi sostenendo che di data del voto non vuol
sentir parlare mentre riconferma la disponibilità del Pd a discutere di legge elettorale
«senza perdere tempo». Nella cautela renziana si legge anche l'attenzione con la quale
al Nazareno si intende regolare il rapporto con il governo Gentiloni. Staccare la spina ad
un esecutivo di marca Pd non è operazione semplice e la road map renziana deve fare i
conti non solo con le raccomandazioni del Colle - che alla fine sarà l'arbitro tra coloro
che sostengono l'immediata applicabilità della legge e chi no - ma anche con una
enorme pattuglia di eletti che il Pd ha al Senato ma soprattutto alla Camera e che solo in
parte hanno la speranza di tornare. Resta però il fatto che da ieri al segretario del Pd è
tornato il coltello dalla parte del manico non solo perché sarà lui a fare le liste, ma anche
perché con il premio alla Camera e lo sbarramento all'8% al Senato le ipotesi di
scissione sono molto più faticose. La soddisfazione incassata ieri non compensa la
delusione per il referendum perso, ma certamente riconsegna a Renzi molte delle carte
che opposizione e minoranza interna pensavano di potergli sfilare. «Hanno urlato per
mesi di incostituzionalità dell'Italicum ed invece la legge esce di fatto integra dal vaglio
della Consulta», sostiene l'ex premier secondo il quale «il ballottaggio era già morto
dopo il risultato del referendum». D'altra parte, come accade in Francia, il ballottaggio
calza su un sistema monocamerale, mentre il premio, le candidature plurime e i
capolista bloccati restano e, a suo giudizio «consegnano al Paese un sistema elettorale
simile a quello del Senato» dove lo sbarramento spinge al maggioritario come a
Montecitorio il premio di maggioranza. Il sigillo posto dalla Corte Costituzionale sull'autoapplicatività dell'Italicum è quindi per il segretario del Pd la conferma che il sistema
funziona. «Al punto - fanno notare al Nazareno - che i grillini da un lato sparano contro
la legge e dall'altro ne chiedono l'estensione a palazzo Madama». Per le urne a giugno
sono i grillini, la Lega e FdI mentre resistenze vengono da tutti i partitini che lo
sbarramento alto a palazzo Madama e il premio alla Camera rischiano di mettere fuori
gioco. Resistenze vengono anche da Forza Italia che spera di scavallare il mese di
novembre confidando nella riabilitazione di Berlusconi ad opera della corte di
Strasburgo. Renzi non intende però forzare la mano. Non solo per non irritare il
Quirinale che attende di leggere le motivazioni della sentenza della Consulta, ma anche
per non gettarsi di nuovo in una competizione elettorale tagliandosi tutti i ponti alle
spalle. Ponti che potrebbero invece tornare utili dopo il voto qualora il Pd non riuscisse a
raggiungere il 40% e la grande coalizione con il centrodestra a trazione berlusconiana
potrebbe diventare l'unica prospettiva di governo di un Paese nuovamente impantanato
nel bicameralismo che non ha voluto cancellare. Ovviamente grillini permettendo.
LA NUOVA
Pag 1 Verità e interessi in gioco di Renzo Guolo
A un anno dalla morte di Giulio Regeni, le relazioni tra Italia e Egitto oscillano ancora tra
gli imperativi di realpolitik tipici della politica estera e la ricerca, almeno da parte
italiana, della verità sulla tragica fine del giovane ricercatore friulano. Non a caso il
nuovo ambasciatore indicato dalla Farnesina, Giampaolo Cantini, non si è ancora
insediato al Cairo. Da parte sua l’Egitto non ha ancora inviato le credenziali per il nuovo
ambasciatore in Italia, Hesham Badr. Sono, però, in molti, a Roma, politici, diplomatici e
uomini d’azienda a premere perché si ponga fine allo stallo delle relazioni bilaterali
deflagrata con il caso Regeni. Un passo che, secondo i realisti, permetterebbe di
superare una crisi che proprio sul terreno diplomatico aveva generato seri contraccolpi.
Del resto, era stata la determinazione del precedente ambasciatore Maurizio Massari, nei
drammatici giorni della scomparsa di Giulio, a metterespalle al muro il regime egiziano.
Impedendo, con la sua risoluta condotta, che il rapimento e l’assassinio di Regeni
venissero mascherati da impresentabili versioni di comodo. Un anno dopo, però, cresce il
partito di quanti ritengono che, nonostante l’auspicio della famiglia Regeni, che vorrebbe
il congelamento dello scambio di ambasciatori sino all’avvio di una piena collaborazione
mirata a fare chiarezza sulla morte di Giulio, l’Italia debba tutelare i suoi interessi
nazionali anche con la ripresa, al massimo livello, dei rapporti diplomatici. Le questioni
aperte tra i due paesi sono, infatti, molte e di grande rilevanza. A partire da quella libica,
solo apparentemente estranea. Nell’ex-Quarta Sponda Roma appoggia il governo Serraj
ma, anche dopo la cacciata dell’Is da Sirte, nessuna stabilità appare possibile senza
un’intesa, per ora assai lontana, tra il governo di Tripoli e quello di Tobruk guidato dal
generale Haftar e sponsorizzato dall’Egitto. Insomma, la soluzione della crisi libica, vitale
per gli interessi nazionali italiani in materia di terrorismo, energia e immigrazione, passa
anche per il Cairo. L’Egitto svolge poi un ruolo chiave negli equlibri mediorientali. Non a
caso l’Italia è stata il primo paese europeo a ricevere il generale Al Sisi dopo la sua
ascesa nel luglio 2013, e Renzi il primo capo di governo europeo a visitare l’Egitto,
offrendo una rilevante legittimazione politica al nuovo regime nato dalla deposizione di
Morsi per mano dei militari. Vi è poi la vicenda energetica. L’Eni, sin dai tempi di Mattei
braccio ufficioso della politica estera italiana in Medioriente e nel Nordafrica, ha investito
in Egitto 14 miliardi di dollari. 2,7 solo l’ultimo anno nel bacino di Zohr, il giacimento
offshore nel Delta del Nilo scoperto dal nostro ente petrolifero, che ha un potenziale
stimato di 850 miliardi di metri cubi di gas. Numeri destinati a stravolgere gli equilibri
energetici, e politici, della regione. E tanto più capaci di condizionare le relazioni italoegiziane. Per l’Eni si aggiunge anche il peso del giacimento di Nooros, dal quale da
quest’anno estrarrà quotidianamente 25 milioni di metri cubi di gas. Il “cane a sei
zampe” resta, poi, il primo produttore di petrolio in Egitto: 230 mila barili al giorno. L’Eni
non è il solo colosso presente nel paese: anche la Edison, azienda italiana controllata dai
francesi, opera con investimenti importanti nel mercato energetico locale. E nel tessuto
economico egiziano sono presenti altre grandi imprese - Italcementi, Pirelli, Italgen,
Danieli, Techint, Gruppo Caltagirone -, oltre che numerosissime imprese di taglia
minore. Un tessuto produttivo e commerciale diffuso, che preme per la stabilità delle
relazioni tra i due paesi. È sulla scorta di questi imperativi politici ed economici che conta
Al Sisi per rendere meno efficaci le pressioni italiane sul caso Regeni. Ciò che il Cairo
intende offrire alle autorità di Roma risente, dunque, non solo degli equlibri interni al
regime e dei rapporti di forza tra i diversi apparati di sicurezza, ma anche del peso degli
interessi in gioco in una partita che ha come posta la verità sulla drammatica fine di
Giulio.
Pag 1 Legge elettorale europea per uscire dagli equivoci di Gianfranco Pasquino
Nelle democrazie, le leggi elettorali le scrivono i parlamentari, non i governi, meno che
mai i giudici, neppure quando sono giudici costituzionali. Tuttavia, è sempre opportuno e
giusto che i giudici valutino la costituzionalità delle leggi elettorali, come le due più
recenti leggi italiane, Porcellum e Italicum, relativamente alla loro conformità ai principi
sui quali si regge e secondo i quali deve funzionare la Repubblica. Congegnata per
compiacere Berlusconi ai tempi del patto del Nazareno, formulata dal governo Renzi e
poi imposta con addirittura tre voti di fiducia, la legge nota come Italicum era poco
meno che un Porcellum rivisto e solo parzialmente corretto. Smantellato dalla Corte
costituzionale il Porcellum con la sentenza numero 1/2014, apparve subito ovvio che
l’Italicum non era esente da vizietti di incostituzionalità molto simili a quelli del suo
predecessore. Piovvero i ricorsi sui quali, chiamata a decidere, la Corte prese tempo in
attesa dell’esito referendario che, mantenendo in vita il Senato, rende indispensabile
anche una nuova legge per la sua (ri-)elezione. La laboriosa decisione della Corte, che
segnala significative differenze sia tecniche, vale a dire sui meccanismi, sia politiche,
ovvero sull’impatto che la sentenza avrà sul governo, sul Parlamento sul sistema
politico, è stata resa ancora più difficile dall’esistenza di una precedente indicazione di
fondo della Corte stessa. Nessun organismo costituzionale può rimanere privo della
legge che ne consente l’elezione. Dunque, quando la Corte smantellò il Porcellum, quello
che rimase in piedi, detto Consultellum, era una legge elettorale, del tutto proporzionale,
che molti ritennero immediatamente applicabile. Dichiarati incostituzionali il ballottaggio
e la norma che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere quello d’elezione,
quello che rimane è quasi certamente una legge altrettanto applicabile, ma migliorabile
da più punti di vista, anche grazie alla necessità di estenderla e, come ha chiesto il
presidente della Repubblica Mattarella, in maniera armonica, al Senato. Adesso, nulla
osta che il Parlamento, non il governo, rimetta le mani nella comunque ingarbugliata
matassa della legislazione elettorale. Formalmente, non c’è fretta poiché la legislatura
può durare fino a febbraio-marzo 2018. Politicamente, alcuni dirigenti di partito vogliono
anticipare il ritorno alle urne perché pensano di trarne qualche profitto, ma raramente gli
elettori italiani hanno premiato chi ha interrotto la vita di un Parlamento. Per di più,
come dovrebbe essere noto anche a chi vive nel Palazzo, la gatta frettolosa fa i gattini
ciechi. Non sembra proprio il caso che i partiti continuino ad anteporre i loro interessi di
breve respiro, calcolati sulla base dei sondaggi, per scrivere una legge elettorale che un
eventuale ricorso potrebbe fare tornare alla valutazione della Corte. Nelle democrazie,
non solo europee, di lunga durata, soltanto in rarissimi casi (uno dei quali,
importantissimo, è la Francia, che nel 1958 fece un cambio di regime), le leggi elettorali
sono state cambiate. Sarebbe bello e utile conoscere le opinioni, non solo dissenzienti,
dei giudici per sfruttarne la ratio al fine di formulare una buona legge elettorale.
Comunque, adesso è augurabile che, con due obiettivi fondamentali in mente: potere
degli elettori e rappresentanza dei cittadini, i parlamentari in carica scrivano una legge
elettorale di stampo europeo, vale a dire già vista all’opera, che venga accettata da tutti,
o quasi, perché equa, perché non garantisce vantaggi a nessun partito esistente, non
impedisce la nascita di partiti nuovi, purché godano di un adeguato consenso elettorale,
offre ai cittadini la possibilità di scegliere il partito e i candidati preferiti, incoraggia la
formazione di coalizioni di governo, consente di sperare che la sua vita sia lunga e che il
sistema non si blocchi ancora a causa di incompetenza e partigianeria.
Torna al sommario