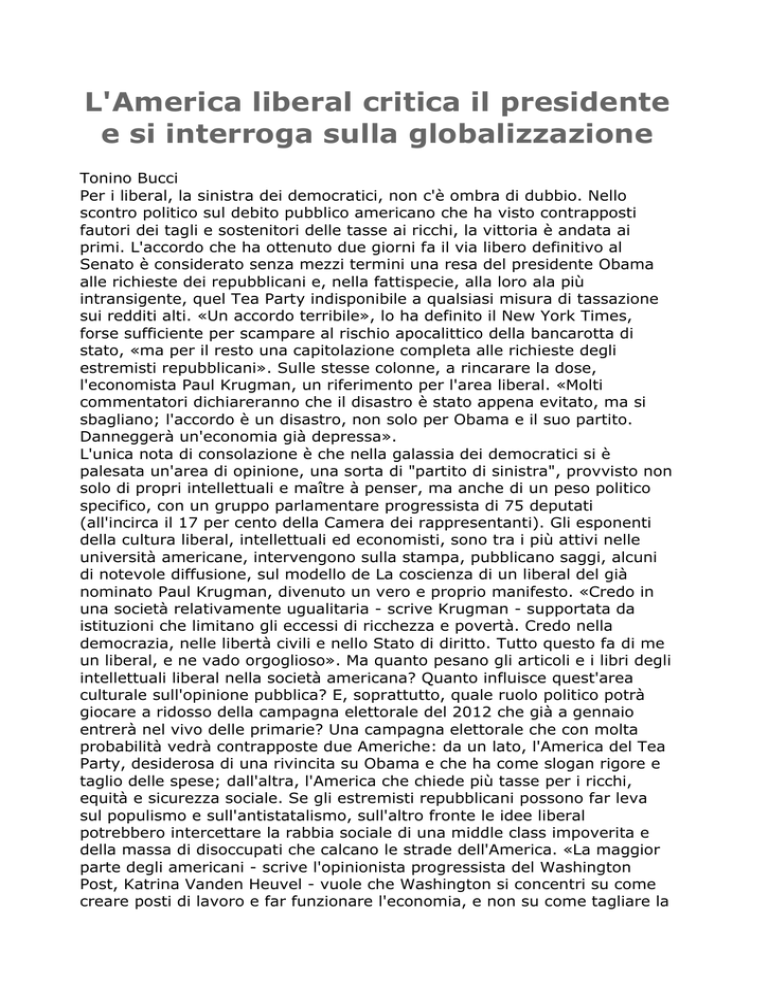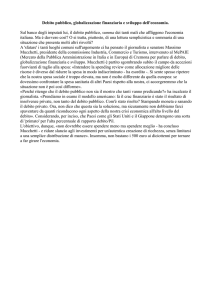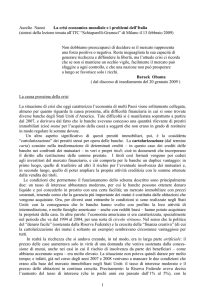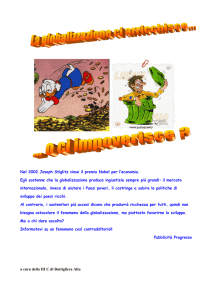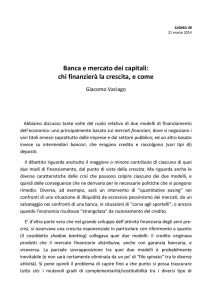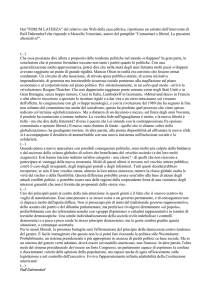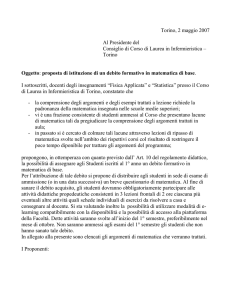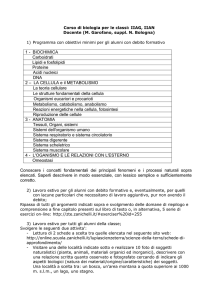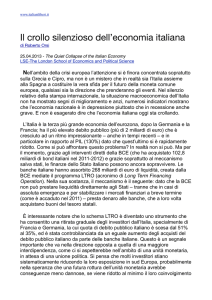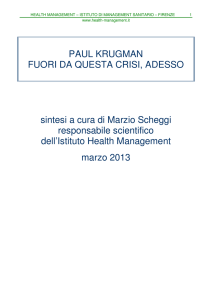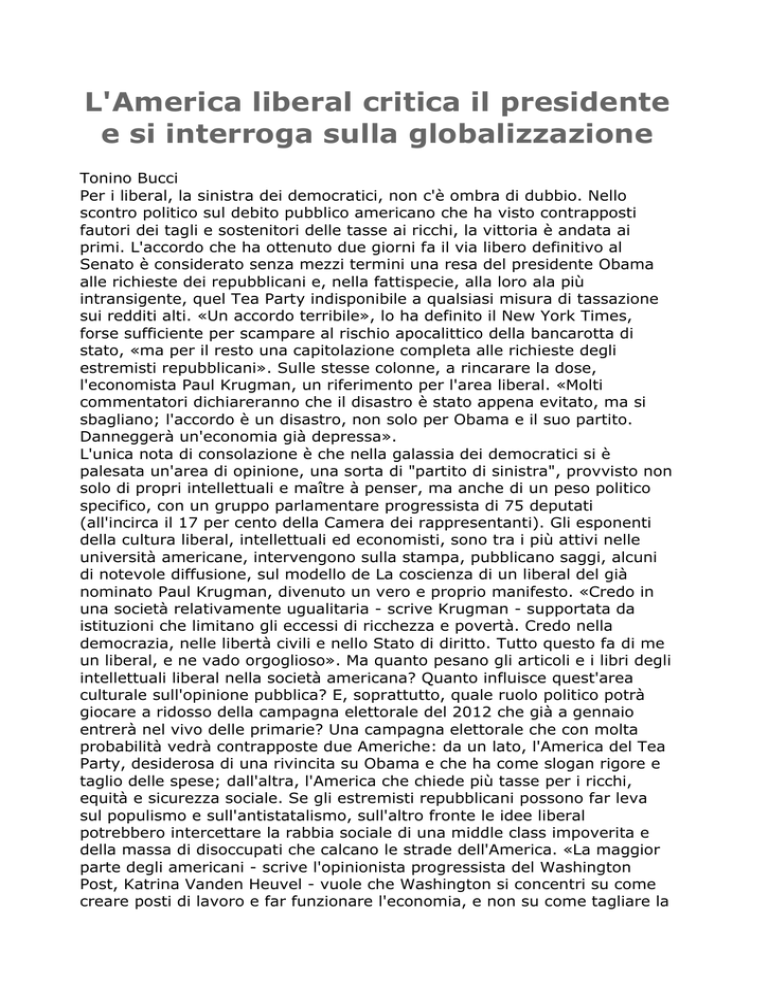
L'America liberal critica il presidente
e si interroga sulla globalizzazione
Tonino Bucci
Per i liberal, la sinistra dei democratici, non c'è ombra di dubbio. Nello
scontro politico sul debito pubblico americano che ha visto contrapposti
fautori dei tagli e sostenitori delle tasse ai ricchi, la vittoria è andata ai
primi. L'accordo che ha ottenuto due giorni fa il via libero definitivo al
Senato è considerato senza mezzi termini una resa del presidente Obama
alle richieste dei repubblicani e, nella fattispecie, alla loro ala più
intransigente, quel Tea Party indisponibile a qualsiasi misura di tassazione
sui redditi alti. «Un accordo terribile», lo ha definito il New York Times,
forse sufficiente per scampare al rischio apocalittico della bancarotta di
stato, «ma per il resto una capitolazione completa alle richieste degli
estremisti repubblicani». Sulle stesse colonne, a rincarare la dose,
l'economista Paul Krugman, un riferimento per l'area liberal. «Molti
commentatori dichiareranno che il disastro è stato appena evitato, ma si
sbagliano; l'accordo è un disastro, non solo per Obama e il suo partito.
Danneggerà un'economia già depressa».
L'unica nota di consolazione è che nella galassia dei democratici si è
palesata un'area di opinione, una sorta di "partito di sinistra", provvisto non
solo di propri intellettuali e maître à penser, ma anche di un peso politico
specifico, con un gruppo parlamentare progressista di 75 deputati
(all'incirca il 17 per cento della Camera dei rappresentanti). Gli esponenti
della cultura liberal, intellettuali ed economisti, sono tra i più attivi nelle
università americane, intervengono sulla stampa, pubblicano saggi, alcuni
di notevole diffusione, sul modello de La coscienza di un liberal del già
nominato Paul Krugman, divenuto un vero e proprio manifesto. «Credo in
una società relativamente ugualitaria - scrive Krugman - supportata da
istituzioni che limitano gli eccessi di ricchezza e povertà. Credo nella
democrazia, nelle libertà civili e nello Stato di diritto. Tutto questo fa di me
un liberal, e ne vado orgoglioso». Ma quanto pesano gli articoli e i libri degli
intellettuali liberal nella società americana? Quanto influisce quest'area
culturale sull'opinione pubblica? E, soprattutto, quale ruolo politico potrà
giocare a ridosso della campagna elettorale del 2012 che già a gennaio
entrerà nel vivo delle primarie? Una campagna elettorale che con molta
probabilità vedrà contrapposte due Americhe: da un lato, l'America del Tea
Party, desiderosa di una rivincita su Obama e che ha come slogan rigore e
taglio delle spese; dall'altra, l'America che chiede più tasse per i ricchi,
equità e sicurezza sociale. Se gli estremisti repubblicani possono far leva
sul populismo e sull'antistatalismo, sull'altro fronte le idee liberal
potrebbero intercettare la rabbia sociale di una middle class impoverita e
della massa di disoccupati che calcano le strade dell'America. «La maggior
parte degli americani - scrive l'opinionista progressista del Washington
Post, Katrina Vanden Heuvel - vuole che Washington si concentri su come
creare posti di lavoro e far funzionare l'economia, e non su come tagliare la
spesa destinata al sempre maggior numero di bambini poveri mentre si
tengono al riparo i paradisi fiscali per i milionari». Quanto all'accordo
taglierà «all'incirca 1000 miliardi di dollari in dieci anni a programmi come
scuole, acqua pulita, trasporti di massa, energie pulite e sanità pubblica,
con zero contributi dai benestanti e dalle multinazionali tramite l'aumento
delle tasse o la chiusura delle scappatoie fiscali». «Un cattivo accordo che
prende di mira la sicurezza sociale e protegge i paradisi fiscali aziendali». E
ancora: «questo accordo bipartisan alimenterà soltanto rabbia
pubblica».Ora «i democratici e il presidente avranno più difficoltà a
convincere i lavoratori americani di essere dalla loro parte».
C'è, però, sullo sfondo degli interventi di questi giorni sull'accordo sul
debito pubblico un dibattito che già da qualche anno a questa parte anima
la produzione teorica dei liberal. All'indomani della crisi del 2008 una
significativa rappresentanza di intellettuali americani ha iniziato a
interrogarsi sugli effetti della globalizzazione finanziaria e sul ruolo
strutturale che l'indebitamento - privato e pubblico - ha giocato nel sistema
economico dominante. Il debito pubblico americano - di cui da tempo si
conosceva l'entità - non è un incidente di percorso o l'effetto di una
patologia passeggera. Il denaro è il «quartier generale» del capitalismo per usare una formula di Schumpeter del secolo scorso - e banche e finanza
sono istituzioni senza le quali il sistema capitalistico non potrebbe
funzionare. Detto in altre parole, il debito (di cittadini, banche e governi) è
stato il motore della globalizzazione finanziaria. «Il denaro - prendiamo a
prestito la spiegazione dell'economista Geoffrey Ingham, autore del saggio
Capitalismo - è costituito da una relazione sociale di credito-debito... Il
denaro stesso (al contrario delle merci di scambio) non può essere creato
senza che si crei un debito». «Inteso nella sua struttura di rete, il sistema
bancario è in grado di generare una produzione elastica di denaro con un
processo di creazione del debito che si alimenta da sé; infatti, una banca
può sempre concedere prestiti ulteriori, perché la crescita delle somme che
offre determina una corrispondente crescita di quelle che le sono dovute».
E' il film visto negli anni ruggenti della globalizzazione finanziaria. Gli stati
hanno fatto sempre più ricorso a banche e investitori privati per finanziare il
proprio debito pubblico. Allo stesso modo, a far temere per la tenuta dei
conti italiani è la fuga di banche e operatori di mercato dai nostri titoli di
stato. L'ampliarsi del famigerato spread (la differenza di rendimento dai
titoli tedeschi) fa sì che per rifinanziare il nostro debito pubblico dobbiamo
garantire a chi ci presta i soldi quasi quattro punti percentuali in più dei
tedeschi. Vicenda analoga a quanto avvenuto in Grecia. Col risultato di
assoggettare le politiche fiscali ed economiche degli stati alle banche e alle
istituzioni private della finanza.
Il tema - si accennava prima - è da tempo sotto la lente d'ingrandimento
dell'intellettualità americana progressista. «La globalizzazione finanziaria scrive ne La globalizzazione intelligente Dani Rodrik, economista di origini
turche e docente all'università americana di Harvard - ha consentito a
banche, aziende e governi di gonfiare a dismisura i finanziamenti a breve
termine da loro ottenuti e di aumentare l'indebitamento nell'ambito
dell'intero sistema. Inoltre ha creato un contagio assai più esteso attraverso
i confini nazionali poiché le difficoltà finanziarie di un paese adesso
contaminavano rapidamente i bilanci bancari degli altri paesi».
L'America progressista dovrà interrogarsi sulle alternative. Dani Rodrik
accenna a una nuova governance, a «un nuovo istituto finanziario
internazionale con obiettivi limitati» e a «un'imposta globale sulle
transazioni finanziarie», che quand'anche esigua (per esempio un decimo
dell'1 per cento) produrrebbe «decine di miliardi di dollari che servirebbero
ad affrontare, con un costo economico ridotto, le sfide globali del tipo
cambiamenti climatici». Paul Krugman, invece, giudica più urgente ridurre
la disuguaglianza sociale ed economica e introdurre un sistema fiscale
progressivo. Chissà che queste proposte non entrino nella campagna
elettorale 2012.
04/08/2011