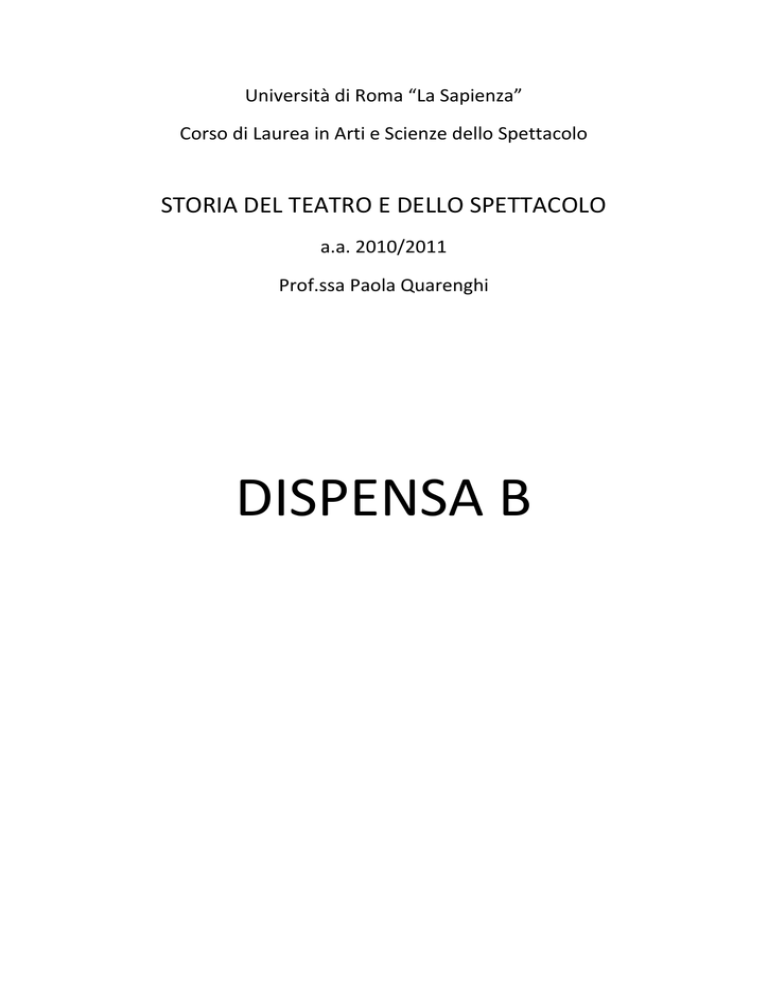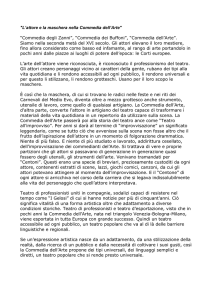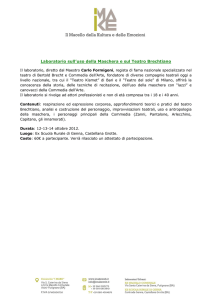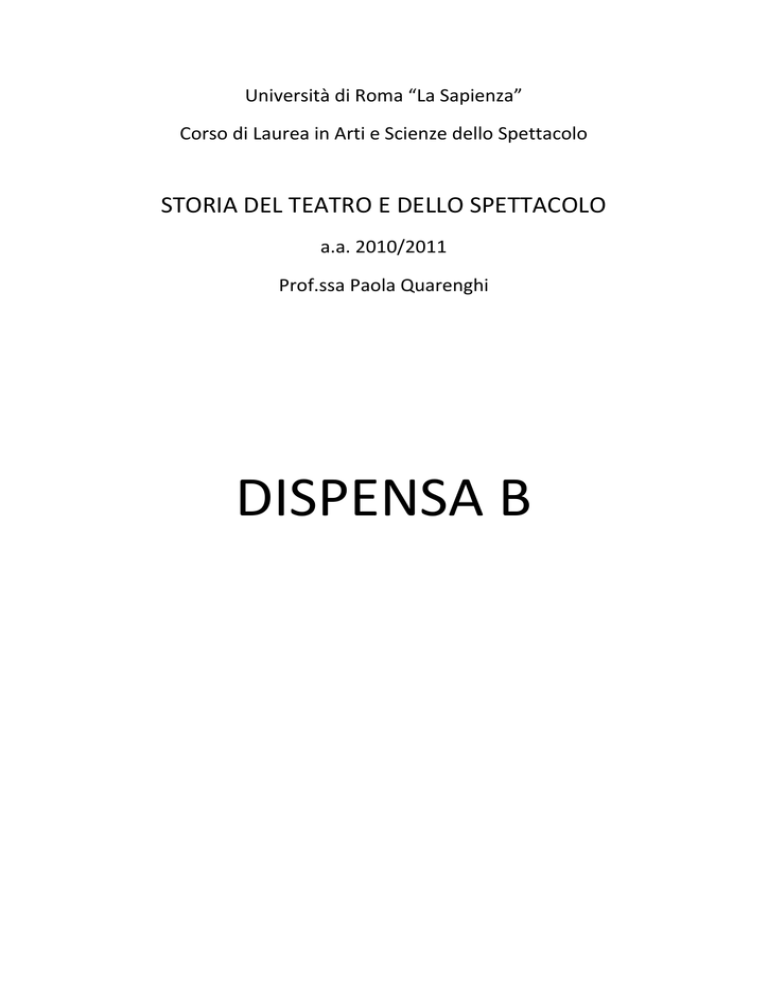
Università di Roma “La Sapienza” Corso di Laurea in Arti e Scienze dello Spettacolo STORIA DEL TEATRO E DELLO SPETTACOLO a.a. 2010/2011 Prof.ssa Paola Quarenghi DISPENSA B 1
1. Estratti dallo Ione di Platone
Come scrive Luciano Canfora nella sua Storia della letteratura greca (Laterza, Bari 2001, pp. 32-33),
aedi e rapsodi sono figure chiave della tradizione epica: cantori e al tempo stesso compositori o
rielaboratori di una cospicua materia tradizionale, sono figure socialmente rilevanti. Quando
nell’Odissea Agamennone parte per la guerra, affida a un aedo la sorveglianza della regina Clitemestra
(Odissea, III, 265-68). E quando Odisseo torna a Itaca e massacra i “proci” che infestano la sua casa,
salva Femio, l’aedo che aveva sempre cantato per loro, giustificandolo perché lo ha fatto “per necessità”.
(Ivi, XXII, 331).
Dopo la scomparsa dei palazzi micenei, i rapsodi non solo sopravvivono come tutori della tradizione
epica, cioè del sapere, ma si organizzano in corporazioni: ad esempio gli autorevolissimi “Omeridi” di
Chio, che pretendevano di essere addirittura discendenti di Omero. Il loro prestigio dipendeva dalle loro
cononoscenze del “testo”, l’epos. Erano depositari della tradizione scritta dei poemi, che era alla base
delle loro recitazioni e rielaborazioni. Non essendoci una circolazione “libraria” questa loro prerogativa
era evidentemente importante e le reazioni al loro potere non furono infrequenti. Per esempio Erodoto
racconta che attorno al 600 a.C., Clistene, tiranno di Sicione, nel quadro di una dura campagna contro
l’influenza argivo-dorica, vietò nella sua città gli agoni dei rapsodi che recitavano poemi omerici, perché
in essi erano spesso esaltati Argo e gli Argivi. È possibile però che con questo divieto Clistene avesse
cercato di colpire non solo i contenuti dell’epos, ma anche la potente corporazione che li amministrava.
Circa un secolo dopo Clistene, si ricorda l’invettiva di Eraclito, secondo cui bisognava «scacciare via a
frustate Omero dagli agoni» (Eraclito, Sulla natura, frammento 42). L’invettiva è ricordata da Diogene
Laerzio, nella sua Vita di Eraclito (Vite dei filosofi, IX, 1), insieme con il duro giudizio sulla falsa
scienza (polymathìe) di coloro che descrivono la terra, falsa scienza così simile alla onnivora
onniscienza dell’«enciclopedia» epica. Col tempo il ceto dei rapsodi si trovò a essere depositario di un
sapere sempre più vecchio e deriso. Si pensi alla ironia che Platone destina al rapsodo Ione. Nonostante
una certa disitima, i rapsodi continuarono a praticare la loro arte negli agoni e nelle feste almeno fino al
III secolo d.C. E nei secoli che precedono la formazione di strutture culturali decisive come la scuola di
Aristotele e la biblioteca di Alessandria, il loro ruolo nella conservazione del testo omerico è rilevante.
Ancora nei Memorabili di Senofonte (430-355 a.C.) Socrate chiede a Eutidemo, che ha comprato un
Omero “completo” se voglia fare il mestiere di rapsodo (IV, 2, 10); il che dimostra che ancora nel IV
secolo il possesso dei testi omerici era un’eccezione riservata appunto ai rapsodi.
Oltre che nei Memorabili, Senofonte parla dei rapsodi anche nel Convito (III, 6), definendoli: «gente
goffa e ignorante, più d’ogni altra incapace di intendere il sentimento della poesia che recita».
Il ruolo dei rapsodi nella conservazione del testo omerico dovette essere probabilmente analogo a quello
degli attori nei confronti delle opere dei grandi tragediografi del V secolo: quanto più quelle tragedie
entravano in uno stabile repertorio di grande successo, tanto più erano esposte alle modifiche e agli
adattamenti suggeriti dal gusto del pubblico. Così i rapsodi, “detentori” del testo omerico, poterono
introdurre rielaborazioni o elementi confacenti a determinate “realtà” locali.
Scritto fra il 394 e il 391, lo Ione di Platone è un dialogo fra Socrate e il rapsodo Ione di Efeso, che ha
appena vinto a Epidauro, alla festa di Asclepio, un premio a una gara poetica.
[...] SOCRATE: Ione, certo spesso ho invidiato voi rapsodi per la vostra arte: infatti
desta invidia il fatto che andiate sempre adorni nel corpo in modo appropriato alla
vostra arte, che siate al massimo della vostra bellezza e nel contempo è da invidiare la
necessità che vi porta a frequentare molti altri bravi poeti e soprattutto Omero, il
migliore e il più divino tra i poeti, e a comprenderne non solo le parole ma anche il
pensiero. Poiché mai si potrebbe essere rapsodi se non si comprendessero le parole
del poeta, del cui pensiero il rapsodo deve farsi interprete per gli ascoltatori: è
impossibile interpretarlo correttamente senza capire ciò che il poeta dice. Pertanto
tutto questo è degno di essere invidiato.
[Socrate fonda il suo ragionamento su una verità incontrovertibile: per essere un buon
interprete bisogna comprendere bene non solo la parola (lexix), ma anche il pensiero
(dianoia) del poeta e partendo da questo presupposto comincia il suo ragionamento che
porterà esattamente alla conclusione opposta, cioè che il rapsodo non è in grado di
comprendere davvero la parola del poeta].
1
Estratti dall’edizione IntraText CT, a cura di Diego Fusaro, Copyright Èulogos 2005, Filosofico.net
http://www.filosofico.net.
IONE: È vero, Socrate: questa necessità imposta dalla mia arte è quella che mi ha
dato più da fare e credo di saper trattare di Omero molto meglio degli altri, poiché né
Metrodoro di Lampsaco né Stesimbroto di Taso né Glaucone,2 nessuno insomma di
quanti sono mai esistiti, ha saputo esprimere così tanti bei pensieri su Omero come
me.
[Ione è lusingato dall’interesse di Socrate e vorrebbe subito dargli una dimostrazione
del suo sapere e della sua arte, ma il filosofo lo blocca e inizia il suo ragionamento
cominciando a chiedergli se la sua competenza nell’arte poetica riguardi solo Omero o
anche Esiodo o Archiloco. Ione gli risponde che riguarda solo Omero. E allora Socrate,
prima di tutto mette in discussione la sua reale competenza sugli argomenti di cui si
tratta nella poesia e gli fa ammettere che, per esempio, sull’arte divinatoria un indovino
avrebbe più competenza di lui, e che sulla medicina un medico saprebbe distinguere
meglio di lui tra ciò che è buono e ciò che non lo è. E poi continua dicendo che se il
suo ambito di competenza è la poesia dovrebbe essere almeno in grado di distinguere,
come fanno il medico o l’indovino nei loro rispettivi campi, tra chi è poeta migliore o
peggiore, dimostrando così di possedere una vera conoscenza. E tanto più se, come
ammette lo stesso Ione, poeti diversi hanno trattato gli stessi argomenti, lui dovrebbe
avere competenza su tutti questi poeti e non solo su Omero.]
IONE: Qual è mai dunque il motivo per cui io, Socrate, quando si parla di qualche
altro poeta neanche presto attenzione e non sono capace di mettere insieme nulla che
si possa definire un discorso, ma a dire la verità sonnecchio e invece ogni volta che
qualcuno menziona Omero mi sveglio subito, faccio attenzione e ho molte cose da
dire?
SOCRATE: Non è difficile capire ciò, amico mio, ma è chiaro a tutti che tu non sei in
grado di parlare di Omero per capacità artistica e per scienza: se infatti tu fossi
capace di parlarne per una virtù artistica, saresti capace di parlare anche di tutti gli
altri poeti, poiché l'insieme in qualche modo costituisce l'arte poetica. Oppure no?
[Ione deve ammettere che Socrate ha ragione. E il filosofo, dopo aver specificato che
questo problema non riguarda le arti come la pittura, la scultura e la musica, dà a Ione
la sua spiegazione.]
SOCRATE: Lo vedo, Ione, e vengo da te per dimostrarti perché mi sembra che accada.
Infatti questa che ti permette di recitare bene Omero e di cui appunto parlavo non è
una capacità artistica, ma è una forza divina a spingerti, come avviene nella pietra che
Euripide chiamò Magnete e la gente chiama Eraclea.3 E infatti questa pietra non solo
attrae gli stessi anelli di ferro, ma infonde agli anelli anche una forza tale che
permette loro di esercitare a loro volta questo stesso potere esercitato dalla pietra,
cioè di attrarre altri anelli, di modo che talvolta si forma una fila assai lunga di anelli
di ferro collegati l'uno con l'altro, ma per tutti questi la forza dipende da quella della
pietra. Così è la Musa stessa a rendere ispirati e attraverso questi ispirati si riunisce
una catena di altri ispirati. Infatti tutti i bravi poeti epici non per capacità artistica ma
in quanto ispirati e posseduti compongono tutti questi bei poemi, e la cosa vale anche
2
Metrodoro di Lampsaco e Stesimbroto di Taso (quinto secolo) cercarono di dare un'interpretazione
allegorica di Omero; di Glaucone non si hanno notizie.
3
La pietra in questione è la nostra calamita, che Euripide chiamò Magnete - probabilmente in una
tragedia per noi perduta - perché pare che ne fosse ricca Magnesia, città della Lidia, mentre altri la
chiamavano Eraclea dall'omonima città della Caria, in Asia Minore.
per i bravi poeti melici; come i coribanti4 danzano solo quando sono fuori di senno,
così anche i poeti melici compongono queste belle poesie solo quando sono fuori di
senno. Ma una volta che siano entrati nella sfera dell'armonia e del ritmo, [4]
cadono in preda a furore bacchico e a invasamento, così come le baccanti5 che
attingono miele e latte dai fiumi quando sono possedute, ma quando sono in sé non lo
fanno; e l'anima dei poeti melici si comporta allo stesso modo, come appunto essi
dicono. Infatti i poeti certo ci raccontano che, attingendo i loro versi da fontane di
miele, da giardini e dalle valli boscose delle Muse, li portano a noi come le api,
volando anche loro come esse, e dicono la verità, poiché il poeta è un essere etereo,
alato e sacro e non è capace di comporre prima di essere ispirato e fuori di sé e prima
che non vi sia più in lui il senno. Finché lo possiede, ogni uomo è incapace di poetare
e di vaticinare. Perciò dunque, componendo molti bei versi per cantare vari argomenti
come tu reciti Omero, non per una virtù artistica ma per dono divino ciascuno è
capace di comporre bene solo nel genere a cui la Musa lo ha indirizzato: uno compone
ditirambi,6 un altro encomi, un altro iporchemi,7 un altro poi compone poemi epici, un
altro ancora giambi, ma negli altri generi ciascuno di essi non vale nulla. Infatti non
compongono i loro versi per capacità artistica ma per una forza divina poiché, se
sapessero parlare bene per arte di un argomento, saprebbero parlare bene anche di
tutti gli altri. Per questi motivi il dio, facendoli uscire di senno, si serve di questi vati e
dei profeti divini come ministri, perché noi ascoltatori possiamo comprendere che non
sono costoro nei quali non c'è senno coloro che compongono versi tanto pregevoli, ma
è proprio il dio che parla e per mezzo di questi poeti ci fa sentire la sua voce. [...] Non
ti pare che io dica il vero, Ione?
IONE: Per Zeus, a me sembra proprio di sì : infatti in qualche modo con le tue parole
tocchi la mia anima e mi sembra che i buoni poeti interpretino per noi, per un dono di
natura divina, queste parole che vengono dagli dèi.
SOCRATE: Dunque, per parte vostra, voi che siete rapsodi non interpretate forse le
opere dei poeti?
IONE: Dici anche questo secondo verità.
SOCRATE: Quindi non siete interpreti di interpreti?
IONE: Senza dubbio.
SOCRATE: Su, dimmi questo, Ione, e non mascherare ciò che ti domando: quando
reciti bene i poemi e rendi attoniti gli spettatori e quando canti Odisseo che balza sulla
soglia rendendosi visibile ai Proci e gettando i dardi ai loro piedi,8 o Achille che si
lancia contro Ettore9 o anche qualche passo sui lamenti di Andromaca10 o di Ecuba11
o di Priamo,12 allora sei in te, o sei fuori di te e l'anima ispirata crede di assistere ai
fatti che dici avvengono o a Itaca o a Troia o dovunque si svolgano i poemi?
4
Sacerdoti e seguaci della dea Cibele, la Magna mater, una divinità frigia i cui riti erano accompagnati
da danze orgiastiche.
5
Le seguaci di Dioniso che, nel delirio orgiastico, si abbandonavano a danze frenetiche al suono dei
flauto e credevano di attingere latte e miele dai fiumi.
6
Canti in onore di Dioniso.
7
Canti accompagnati da danza e mimica.
8
Omero, Odyssea, libro 12, verso 1 e seguenti.
9
Omero, Ilias, libro 12, verso 312 e seguenti.
10
Omero, Ilias, libro 6, versi 407-439; libro 22, versi 437-515; libro 24, versi 723-746.
11
Omero, Ilias, libro 22, versi 79-89; 405 e seguenti; libro 24, versi 747-760.
12
Omero, Ilias, libro 22, versi 33-78 e 408-428; libro 24, versi 224-227; 253-264; 486-508.
IONE: Socrate, che spiegazione chiara mi hai dato riguardo a questa prova! Dunque
parlerò senza nasconderti nulla. Infatti quando recito qualche avvenimento pietoso i
miei occhi si riempiono di lacrime e quando recito un evento spaventoso e terribile mi
si drizzano i capelli per la paura e il cuore batte forte.
SOCRATE: E allora, Ione? Diremo che è in sé quest'uomo che, adornato di una veste
variopinta e di corone d'oro, piange durante sacrifici e feste, pur non avendo perso
nulla di questi ornamenti, o che dà segni di paura pur essendo in mezzo a più di
ventimila persone ben disposte nei suoi confronti, senza che nessuno lo spogli di questi
ornamenti o gli faccia del male?
IONE: No, per Zeus, certamente no, a dire il vero, Socrate.
SOCRATE: Dunque sai che voi create questi stessi effetti sulla maggioranza degli
spettatori?
IONE: Lo so e molto bene: infatti ogni volta che dall'alto della tribuna [i rapsodi
recitavano su una tribuna, detta bema, che doveva essere molto simile al palcoscenico
mobile dei comici] li vedo piangere, fare la faccia atterrita o stupefatta per quel che
racconto, devo prestare molta attenzione a loro, poiché se li farò piangere riderò io
intascando denaro, se invece li farò ridere, piangerò io perdendo denaro.
SOCRATE: Ora, sai che costui, lo spettatore, è l'ultimo degli anelli che, dicevo,
prendono l'uno dall'altro la forza che deriva dalla pietra di Eraclea? Tu invece,
rapsodo e attore, sei l'anello di mezzo, mentre il primo è il poeta stesso; il dio, per
mezzo di tutti questi, trascina l'anima degli uomini dove vuole, trasmettendo la potenza
dall'uno all'altro. E, come accade con quella pietra, una lunga catena di coreuti,
maestri e sottomaestri di cori, appesi di lato, dipende dagli anelli sospesi che
dipendono dalla Musa; un poeta poi dipende da una Musa, l'altro da un'altra (e noi
diciamo "è posseduto", il che è quasi lo stesso: infatti è posseduto); quindi da questi
primi anelli, i poeti, altri poeti a loro volta dipendono chi dall'uno e chi dall'altro e
sono ispirati alcuni da Orfeo, altri da Museo13 e molti sono invasati e posseduti da
Omero.
Tu sei uno di quelli, Ione, e sei posseduto da Omero e ogni volta che qualcuno canta
versi di qualche altro poeta ti addormenti e non sai cosa dire; quando invece si
declama un canto di questo poeta, subiti ti desti, l'anima tua si mette a danzare e hai
un mucchio di cose da dire. Infatti tu dici tutto quello che sai dire di Omero non per
capacità artistica né per conoscenza ma per un dono divino e in preda a esaltazione.
Come coloro che danzano al modo dei coribanti sentono profondamente solo quel
canto proprio del dio dal quale sono posseduti e improvvisano a quel canto figure di
danza e versi, mentre non si curano degli altri canti, così fai anche tu, Ione, quando
qualcuno menziona Omero, mentre non sai cosa dire degli altri: e la causa di ciò che
mi chiedi, cioè della tua fecondità di pensiero e di parola a proposito di Omero e non
degli altri poeti è il fatto che sei un eccellente intenditore di Omero non per arte ma
per dono divino.
[Dopo aver consentito a questa conclusione di Socrate, Ione cerca poi di replicare che
se è d’accordo sul fatto che la possessione divina valga per i momenti in cui recita i
versi di Omero, non crede debba valere per quando disserta su Omero. In questo caso
rivendica una competenza che Socrate si affretta subito a negare, col solito argomento
13
Altro mitico cantore tracio.
della mancanza di competenza di Ione riguardo agli argomenti (i più disparati) che il
poeta tratta: lui può avere competenza infatti solo sull’arte rapsodica, quella che
esercita, ma non certo sugli argomenti e le situazioni che i poemi trattano, il che di
fatto annulla qualunque reale competenza. Messo alle strette dalla dialettica socratica,
dopo aver cercato di difendere la popria autorevolezza nel campo strategico, dicendo
che un buon rapsodo è anche un buon stratega (perché conosce il modo di infervorare
gli animi di coloro che deve guidare) ed essere stato, per l’ennesima volta, smentito da
Socrate, alla fine Ione deve consentire che è meglio essere considerato un essere divino
piuttosto che un uomo scorretto, e subisce fino all’ultimo il ragionamento del filosofo.]
SOCRATE: [...] Pertanto scegli se vuoi essere considerato da noi un uomo scorretto o
un essere divino.
IONE: C'è molta differenza, Socrate, dal momento che l'essere considerato divino è
molto più bello.
SOCRATE: Ebbene, questa definizione più bella, cioè di essere un declamatore divino
di Omero e non un abile tecnico, da parte nostra ti spetta, Ione.
[Il dialogo rivela il sostanziale disprezzo di Socrate nei confronti del rapsodo Ione,
“gestore” di un patrimonio culturale di cui non è all’altezza. Non va dimenticato,
infatti, che ai rapsodi era affidata non solo la comunicazione pubblica, ma anche
l’esegesi dell’epica. Socrate gioca con Ione come il gatto col topo: comincia prima ad
adularlo, a mettersi dalla sua parte (usa per esempio la prima persona plurale), poi, a
poco a poco, ne demolisce ogni competenza tecnica o artistica, che viene attribuita solo
ad una possessione di secondo grado. Anche la palma di «essere divino» che gli
attribuisce suona davvero più come una beffa che come una effettiva lode. Nasce da
qui, si può dire, il mito dell’artista inconsapevole e ispirato, che agisce solo per estro o
per divino invasamento, ma che non conosce i mezzi e le risorse della propria arte.
L’ingenuo e un po’ patetico Ione asseconda l’autorevole interlocutore, arrivando a
confessare di sentirsi davvero posseduto: e descrive le sue reazioni in quel momento,
ma poi aggiunge anche che, mentre piange in preda alla passione, osserva contento le
reazioni del pubblico che piange con lui, pensando che in questo modo riuscirà a
ottenere il guadagno della vittoria.
Secondo Giovanni Calendoli (L’attore. Storia di un’arte, Edizioni dell’Ateneo, Roma
1959), in questo dialogo per la prima volta viene posto con consapevolezza critica un
problema che resterà sempre fondamentale nella storia dell’attore e che molti secoli
dopo sarà svolto in termini sostanzialmente opposti da Denis Diderot in un altro
celebre dialogo: Le Paradoxe sur le Comédien (1773-78, pubblicato nel 1830).
Secondo Calendoli, poiché Platone assimila il rapsodo al poeta, «riconoscendolo
invaso dallo stesso divino furore, afferma anche la natura artistica dell’attività
dell’attore. Ma al tempo stesso esprime decisamente la esigenza che
nell’interpretazione sia presente un contenuto conoscitivo e critico». A me sembra
piuttosto che vanificando le conoscenze tecniche, scientifiche, dell’arte del rapsodo e
attribuendo la buona qualità delle sue prestazioni artistiche e della sua capacità critica
alla possessione divina, Platone più che altro anticipi l’idea della non utiltà, anzi della
pericolosità degli artisti mimetici nel contesto di quella società civile, di quella politéia
di cui parla nel famoso dialogo La repubblica (c. 390 a.C.). Riconoscendo l’intervento
divino nell’esperienza artistica del rapsodo, Platone sembra però anche sottolineare
quel legame tra recitazione, teatro, e rito, molto più forte nel secolo precedente, ma di
cui rimane traccia anche nella società del suo tempo. Molto bello è il modo in cui
descrive quel fenomeno di possessione collettiva, che, anche in termini laici, è
certamente alla base di qualunque esperienza teatrale che voglia definirsi tale. Il
dialogo di Platone mette anche molto bene in luce il nascere di un conflitto che nei
secoli successivi vedrà spesso contrapposti, da un lato, filosofi, teologi, letterati,
uomini di chiesa e di pensiero, dall’altro gli attori; conflitto che comincia a
manifestarsi nel momento in cui si assiste alla separazione tra colui che scrive o crea e
colui che interpreta. Qui la questione sembra riguardare, in modo sotterraneo, la
competenza e quindi il diritto alla gestione di un patrimonio culturale (in questo caso i
poemi omerici, in altri casi i testi degli autori). Altro elemento interessante da
sottolineare è anche la descrizione vividamente performativa dell’arte del rapsodo e dei
suoi effetti sugli spettatori.
Estratti da Tertulliano, De Spectaculis1 (197-202 d.C.)
Apologeta e scrittore latino cristiano, Tertulliano nacque a Cartagine verso il 155-160 d.C. da genitori
pagani e fu lui stesso fieramente avverso al cristianesimo fino al momento della conversione, avvenuta
intorno al 193. Ebbe un’ottima formazione letteraria, filosofica, storica e giuridica. Presi gli ordini
sacerdotali, adottò posizioni religiose molto intransigenti e nel 213 aderì alla setta religiosa dei
Montanisti, da cui si distaccò per creare un movimento ancora più estremista, quello dei Tertullianisti.
Le ultime notizie che si possiedono su di lui risalgono al 220. La sua morte si data dopo il 220. Al 197 o
202 si data lo scritto di carattere disciplinare De Spectaculis, in cui fa divieto assoluto ai cristinai di
assistere agli spettacoli pagani, legati all’idolatria e fonte di corruzione morale.
CAPITOLO III
Gli spettacoli sono proibiti dalle Sacre Scritture. [...]
Noi non troviamo che venga detto: tu non ti recherai nel Circo, non nel teatro, tu non
assisterai alle gare o agli spettacoli. Ma noi sappiamo che ben si attagliano a simili
manifestazioni quella prima parola di David : felice l’uomo, egli disse infatti, che non
s’è recato nel concilio degli empi, che non s’è indugiato per la strada dei peccatori,
che non si fermò nella sede degli scellerati.
[...] Egli [Cristo] chiamò concilio di empi, allora, la riunione di pochi Giudei; ebbene,
con quanta maggior ragione avrebbe potuto usare tale denominazione per una folla così
numerosa di pagani? L’empietà è forse minore nei pagani? sono essi forse meno
peccatori, meno nemici di Cristo di quel che allora non fossero i Giudei? Eppoi tutte le
espressioni del passo non rispondono e non s’attagliano perfettamente? Agli spettacoli
infatti s’assiste anche dalla strada, e vie, appunto si chiamano gli spazi in giro tra le
divisioni dei recinti che stabiliscono una divisione fra i posti riservati al popolo. Si
chiama poi cathedra in teatro lo spazio nel quale questa folla di popolo sta seduta in
giro. Così, usando l’espressione citata, inversamente, si potrebbe chiamare infelice
chiunque si sarà recato in un concilio di empi, chiunque si sarà indugiato nella via dei
colpevoli, chi si sarà fermato nei seggi dei perversi: comprendiamo così in senso
generale, se anche l’espressione Davidica risponda ad una interpetrazione limitata e
particolare. [...] per quel che riguarda l’origine degli spettacoli, da quando furono essi
istituiti, non c’è spettacolo che non venga considerato come una riunione di gente
empia e sacrilega, passando qui dal generale al particolare.
[...]
CAPITOLO XV
Lo spirito prova un turbamento e una commozione grande, di fronte alle impurità e alle
vergogne cui si assiste negli spettacoli. [...]
Questi [Dio] ci ordina di seguire lo Spirito Santo, in tutta tranquillità, serenità, con un
senso di pace, di quiete, come ciò che, per sua stessa natura, è tutto bontà ed amore:
nulla può accordarsi con lui che sia ispirato a furore, ad ira, a sentimenti di sdegno;
nulla che abbia un carattere d’inquietudine, di risentimento, di dolore. Come è dunque
possibile presenziare agli spettacoli? Non c’è genere di spettacolo nel quale il nostro
1
Da Quintus Septimius Florens Tertullianus, I trattati : De spectaculis, De idolatria, De poenitentia,
tradotti da Gino Mazzoni, Cantagalli, Siena 1934.
spirito non abbia scosse e fremiti. Dove può esistere soddisfazione, deve pur esserci un
certo interesse, una certa passione che alimenta questo nostro godimento; ma dove c’è
una certa opposizione, deve per forza affiorare un principio di contrasto e ardore di
desiderio, e dove, quindi, si riscontri ciò, esiste anche una certa febbre, sorgono
sentimenti d’ira, di sdegno, scoppia talvolta il furore e regna un motivo doloroso; cose
tutte, queste, che sono in |64 perfetto contrasto colla serenità della disciplina cristiana.
[...]
Il divertimento è qualcosa che presuppone in certo modo l’interessamento e la
passione, e questi adescamenti portano necessariamente ad errori e a traviamenti, ed
essi a loro volta allo sviluppo di altre passioni; del resto, se questa specie di intimo
fuoco venisse a sparire, non esisterebbe più il piacere e sarebbe tacciabile di
sciocchezza e di follia, se taluno corresse colà, dove egli pensasse di non poter in certo
modo conseguire nulla che gli fosse d’intima soddisfazione. [...]
CAPITOLO XVII
I teatri sono sentine d’impurità e di disonestà.
Nello stesso modo ci vien fatta proibizione assoluta di tenerci lontani da ogni forma di
vergognosa scompostezza e di abbandono: è per questo che noi stiamo ben lungi dal
teatro ed, infatti, che cosa è esso mai, se non un luogo dove ogni forma d’impudicizia e
di disonestà viene ad essere tacitamente accolta e dove non si mena buono nulla, se non
tutto quello che altrove riscuote la maggiore riprovazione e condanna? Quello che fa
riscuotere al teatro, il favore più grande, risulta da tutto un insieme di immoralità: ogni
cosa è basata su di esse: uno di |68 Atella2 s’abbandona a gesti ridicoli ed immorali;
ecco una rappresentazione mimica; vi sono anche donne che recitano, portando proprio
fino all’ultimo gradino quel senso di dignità e di pudore che è pure proprio della
donna: è più facile che una arrossisca in casa... ma sulla scena non sarà mai. Il
pantomimo finalmente ha vissuto sulla propria persona l’onta della vergogna più turpe,
ancora fanciullo, per poi esser capace di rappresentarla sulla scena in un modo, così
efficace. Si portano sulla scena donne da trivio, avanzi della corruzione e del pubblico
più bestiale capriccio; più disgraziate lì, sotto gli occhi stessi delle matrone alle quali
sole erano rimaste forse nascoste: eccole lì, ora, portate in bocca di tutti: gente d’ogni
età e di ogni qualità e grado: si sa il luogo della loro vergogna, il prezzo del loro
disonore, le loro abilità e i loro pregi!... sono proclamati... anche a chi non li vorrebbe
sapere. [...]
Gli occhi e l’orecchio sono, in certo modo, i custodi del nostro spirito, e come è
possibile che esso sia qualcosa di puro e di integro, quando un principio di corruzione
prenda questi organi che lo sorvegliano? Se ci è dunque proibita ogni forma
d’impudicizia e di corruzione, anche il teatro stia ben lontano da noi. |70
2
Da Atella, trasse origine una delle forme primitive di drammatica popolare: la materia buffonesca
prendeva origine dalla vita politica, da quella letteraria e dalle credenze religiose: ma traeva i suoi
soggetti anche dal mondo eroico e mitologico: vi erano tipi possiamo dir fissi, come quello del vecchio
spilorcio, pappus; il ghiottone sciocco, maccus; il chiaccherone, bucco; il gobbo imbroglione, dossenus:
i mimi e i pantomimi furono forme di drammatica popolare piuttosto libera e scomposta. Furono
rinomati scrittori di mimi Decimo Labeno e P. Publilio Syro: pantomimo fu in genere l’arte di
rappresentare con la danza, coi gesti e con le figure un’intera azione drammatica: salì questa arte a
grande altezza ai tempi di Augusto: pantomimi famosi furono Badilo e Pilade.
CAPITOLO XVIII
Le tragedie, le commedie hanno in loro qualcosa d’illecito e di empio.
Se noi proviamo un senso di dispregio per i dettami della letteratura profana, come di
quella che non può esser giudicata da Dio se non come qualcosa di stolto e di sacrilego,
mi sembra anche che siano implicitamente proibiti a noi tutti quei generi di
rappresentazioni che trovano motivo e ripetono la loro natura dalla letteratura stessa e
che pongono sulla scena o elementi di ridicolo o caratteri di forza e di violenza. Se
infatti le tragedie o le commedie mettono dinanzi ai nostri occhi lo svolgersi di azioni
atroci, o di violente passioni che trovano loro sfogo nel sangue o nelle più volgari
bassezze, non senza empietà e dilagare di altre colpe; non può darsi che esse siano m
certo modo più tollerabili delle azioni stesse. Ciò che viene respinto e stimato degno di
condanna, nell’atto stesso di compierlo, non si può neppure accettarlo in parole.
CAPITOLO XIX
Quali crudeltà sono quelle che si vedono compiute nell’anfiteatro!
[...] Chi poi purtroppo mi può assicurare e garantire che coloro, che sono destinati ad
esser vittima delle belve o che sono condannati a qualunque altro supplizio, non siano
innocenti? Ma che questa loro incolpabilità venga, disgraziatamente, ad esser
compromessa o da un senso di vendetta di chi è preposto al giudizio, o per la poca
energia e risolutezza di chi deve difendere, o per falsità di procedimento? E non è
meglio allora non sapere quando i malvagi siano giustamente puniti, per potere
ignorare anche, quando i buoni vengono immeritatamente colpiti, sempre ammettendo,
s’intende, che pur qualche elemento di bene possa germogliare anche fra loro? Ed è
cosa sicura, senza dubbio, che vi siano gladiatori, talvolta, in cui non c’è |73 ombra di
colpa e che pure si presentano nel circo per il crudele piacere degli spettatori! Ma poi,
anche quelli che vengono esposti al pubblico per qualche colpa, come può avvenire che
in certo modo trovino ammenda alla loro minor colpa, col rendersi dopo, omicidi? [...]
CAPITOLO XXII
[...] Da parte di coloro stessi che a proprie spese |78 preparano e regolano il
procedimento degli spettacoli, i guidatori delle quadrighe, gli attori scenici, i lottatori, i
gladiatori sono soggetti a manifesta riprovazione e vengono mal giudicati per quelle
medesime facoltà per le quali, sotto un’altro punto di vista, sono ricercati e magnifìcati:
costoro sono proprio quei gladiatori che suscitano fervore di passioni nel cuore di
uomini e di donne che sono pronte a dar loro, gli uni tutto il loro entusiasmo, le altre, e
forse anche i primi, il fiore della loro bellezza e della loro purità; sono quelli per i quali
giungono a commettere quello che poi dicono meritevole e degno di riprovazione, E
questi stessi uomini si vedono dopo colpiti da condanna; vengono diminuiti
nell’esercizio dei loro diritti, sono tenuti lontani dalla curia, dal rostri, esclusi dal
senato, dalla classe dei cavalieri, da tutto quanto possa rappresentare onore, cariche e
dignità personali. Quale sconvolgimento d’idee e di giudizi non è mai questo! Essi
amano quelli che poi condannano; abbassano e vituperano coloro, che prima hanno
lodato ed esaltato. Innalzano il principio e il carattere di una data manifestazione ed
attività; chi la rappresenta va incontro invece a biasimo e a taccia di colpevole. Come
può esservi un giudizio di questa fatta; che cioè quelle facoltà per le quali taluno è
stimato degno di encomio, si trasformino poi in ragioni di riprovazione e di condanna?
Ma anzi è proprio, il riconoscimento più |79 esplicito che una data cosa sia male
quando appunto chi di essa sia parte viva ed essenziale, e ne riscuota plauso e favore,
venga dimostrato poi, anche lui, non scevro di colpa.
CAPITOLO XXIII
[...] È mai possibile che possa piacere a Dio quell’auriga che tiene in ansia e in
tormento tanti spiriti, che tante insane passioni può sollevare, che di tante immagini
false e bugiarde è in certo modo sostenitore e protettore? Eccolo ora, cinta la testa di
corone, ora ammantato di vari colori, come un mezzano volgare che il demonio
trasportò veloce sul carro, quasi per |80 contrapporlo ad Elia3. E potrà forse piacere a
Dio, chi, radendosi colla lama tagliente del rasoio altera i caratteri del suo volto?
Comincia ad essere insincero con sé stesso costui; e non contento poi di aver reso la
sua faccia liscia ed effemminatamente giovanile come quella di Saturno, di Iside, di
Bacco, lascia che su di essa piovano schiaffi in abbondanza, così che pare che sia da lui
quasi posto in ridicolo il precetto del Signore?4 Ciò significa evidentemente che anche
il diavolo insegna ad offrire la guancia alle percosse...5 E così, allorché cogli alti calzari
dei coturni, gli attori tragici sembrano crescere di statura, pare che voglia il demonio
dimostrare falso quanto Gesù ha affermato, che nessuno cioè potrà aggiungere un
cubito alla propria statura6. Del resto io mi vorrei domandare se può |81 riscuotere
l’approvazione del Signore, il ritrovamento delle maschere; ma non è Lui che ci vieta
ogni forma di finzione e di falsità? E tanto più nel falsare l’immagine nostra che è pure
fatta ad immagine sua? Chi ha creato il principio assoluto del vero non può riconoscer
la menzogna e tutto ciò che viene simulato e falsato non può costituire al suo cospetto,
che colpa! Chi mentisce nella sua voce, chi simula diversità di sesso, chi finge e falsa
la propria età; chi va con finzione rappresentando ardore di passione, fremito d’ira,
gemiti di dolore, singulti di pianto, non potrà mai riscuotere l’approvazione di chi ha
pur detto una parola di condanna, per tutto ciò che è ipocrisia e negazione di verità.
Iddio ha fissato nelle sue leggi che sia maledetto colui che si ricoprirà di vesti
femminili7: ebbene che cosa mai dovrà giudicare del pantomimo, che a contraffare
ogni espressione femminile s’adopera? E che forse potrà andare impunito chi, con una
certa sua abilità, colpirà fortemente colle sue mani? Ricevè egli forse, allorché Iddio lo
plasmò, le cicatrici che gli avranno poi fatte i colpi avuti dai cesti? e forse le lividure in
seguito alle percosse? ebbe forse gli orecchi guasti e mal ridotti per i colpi sofferti? E
Iddio gli concesse la grande grazia dell’occhio, perché questo poi divenisse pesto e
rovinato da eccessi bestiali di violenza? |82 Non dico proprio nulla poi di colui che
3
Fu sommo poeta d’Israele, nato a Tesbe, si oppose con tutte le sue forze al culto Fenicio di Baal.
Perseguitato da Acabbo e da Gezabele, sua moglie, riparò presso il torrente Cherit dove fu alimentato dai
corvi: cacciato si ritirò a Zerefath, presso una vedova di cui resuscitò un figlio: dopo due anni riapparve
dinanzi ad Acabbo e vinse la famosa gara coi profeti di Baal, ma per fuggire di nuovo le persecuzioni,
riparò nel deserto a sud di Canaam: si scagliò contro la condotta di Achazia, successore di Acabbo,
perché aveva consultato l’oracolo di Baal Zebub: fu trasportato in cielo da un carro di fuoco.
4
Gli attori scenici privati della loro virilità avevano la faccia sbarbata, come Saturno che era nello stesso
caso, Iside per essere una donna e Bacco per la sua perpetua giovinezza.
5
Si legge in Luca VI. 29: Cui te percutit in maxillam, praebe et alteram.
6
Luca XII 25 : Quis potest adiicere ad staturam suam, cubitum unum?
7
Deuteronomio XII. 5: Non induetur mulier veste virili, nec vir utetur veste feminea: abominabilis enim
apud Deum est, qui facit haec.
espone e spinge un suo simile alle furie di una belva per non sembrare d’essere poco
omicida, dal momento che, se quello sciagurato sfuggirà alle zanne del leone, egli lo
finirà di scannare. [...]
CAPITOLO XXV
Come è possibile nutrire santità di pensieri, in mezzo all’obbrobrio degli spettacoli?
[...] Quando un attore tragico reciterà in tutta la sua esaltazione, ma pensi davvero che
qualcuno possa andar rimuginando in cuor suo, quel che può aver detto un profeta? E
fra i motivi molli ed effemminati di un istrione andrà forse taluno ricordandosi di un
salmo? E quando gli atleti sono nel fervore e nella fierezza della lotta, sarà proprio
possibile che si ricordi quel divino precetto di non rispondere alle offese e alle
ingiurie? E chi avrà dinanzi agli occhi suoi l’orrore delle ferite delle belve e i gladiatori
tergentisi il sangue sgorgante copioso dalle ferite, potrà forse provare sensi di pietà e di
misericordia? Iddio tenga sempre lontana dai suoi una cupidigia così folle e insana di
piacere! [...]
CAPITOLO XXVII
Ogni godimento che può esser dato dagli spettacoli, è intimamente unito con qualcosa
di empio, di sacrilego, di diabolico.
[...] Ammettiamo anche che gli spettacoli ti possano apparire di per sé stessi, come
aventi un carattere di semplicità, di onestà, di rettitudine, di legittima gioia: ebbene? È
naturale tutto ciò: non troverai infatti nessuno che col fiele e coll’elleboro temperi il
veleno: egli cercherà vivande dolci e piacevoli, gustose e quel male che egli vi getterà,
sarà appunto contemperato e, in certo modo, nascosto da quella dolcezza; |88 così,
nello stesso modo, la potenza avversa e diabolica mescolerà a quanto Iddio può aver di
più grato e di accetto, tutto quello che può esservi di più amaro, di tristo e di mortale.
Tutte le cose che riscontri in quelle manifestazioni, abbiano pure attributo di forza e di
onestà, abbiano pure onda di musica e di poesia e si rivelino ingegnose e sottili,
tuttavia rifletti che in nulla queste cose si differenziano da gocce di miele che si
versano in un calice avvelenato: non ti faccia quindi tanta gola il piacere; quanto dovrà
essere invece il timore che sarà suscitato in te da tutto quello che si presenterà ai tuoi
occhi, sotto l’apparenza del piacere e della gioia.
Nicola Savarese
L’orazione di Libanio in difesa della pantomima1
1. Pantomima romana
Con gli scritti di Luciano (II sec.) e di Coricio (V sec.), l’orazione di Libanio in difesa
della pantomima2 (IV sec.) rappresenta una delle rarissime testimonianze del mondo
greco-romano, non solo sullo stato sociale degli attori della tarda latinità ma anche sul
modo in cui essi erano scelti e addestrati per la scena, e sulle notevoli qualità tecniche
della loro, troppo spesso, biasimata professione.
Più che pantomimo (pantómimos), occorrerebbe usare il termine mimo-danzatore, sia
perché Libanio usa il termine orchestés (propriamente danzatore) sia per il fatto che il
termine italiano pantomima non copre l’ampiezza semantica della vigorosa attività
scenica del pantomimo romano3. Il pantomimo romano infatti era tecnicamente un
mimo, cioè un attore che, senza uso della voce, era in grado di rappresentare tramite i
gesti ogni cosa - pantós, tutto, per l’appunto: divinità, uomini, animali, sentimenti, cose
inanimate e quindi anche tutte le storie - ma anche un danzatore, cioè un performer che
agiva ritmicamente su accompagnamento musicale e che possedeva doti di trasformista
(usando maschere e costumi diversi), di giocoliere e talvolta perfino di acrobata4.
Insomma una serie di diverse abilità concentrate in un solo attore talmente efficace sul
piano spettacolare da esibirsi in qualità di solista, come bene attesta in questo passo
Luciano:
In conclusione la pantomima si propone di rappresentare e interpretare i costumi e le passioni mettendo
in scena ora un innamorato, ora un collerico, uno furioso e un altro addolorato, e ognuno di questi
caratteri con moderazione: in realtà il fatto più paradossale è che nello stesso giorno vengono
rappresentati Atamante pazzo, Ino impaurita, Atreo in persona e poco dopo Tieste, poi Egisto o Erope:
tutti questi personaggi sono in un solo uomo5.
L’origine di questo versatile attore solista è controversa. Sappiamo che a Roma, agli
1
N. Savarese – In Dioniso. Annale della Fondazione INDA n. 2, Palumbo, Palermo 2003 e in Teatro
greco postclassico e teatro latino: teorie e prassi drammatica. Atti del Convegno Internazionale. Roma
16-18 ottobre 2001, a cura di A. Martina, Dipartimento di Studi del Mondo antico. Università degli
Studi Roma Tre, Herder Editrice e Libreria, Roma 2003
2
Per l’edizione dell’opera di Luciano Perì orchéseos (De saltatione ) Luciano 1877, 143-70 (ma anche:
Luciano 1992; Kokolakis 1959, 3-56); per l’edizione dell’opera di Coricio: Graux 1877 (cfr. anche
Albini 1997). Per l’edizione dell’orazione di Libanio Upèr tón orchestón (Pro saltatoribus ), giunta
attraverso numerosi codici (se ne contano ben 36): Libanio 1908, 405-98 (ma anche, per una prima
ricognizione, Molloy 1996, con qualche incertezza critica e bibliografia precedente, e Anastasi 1984).
Per la biografia di Libanio cfr. la nota 25.
3
In lingua italiana infatti, per indicare la pantomima romana si usa anche pantomimo : «Lo stesso che
pantomima ; è forma adoperata soprattutto dai filologi classici, con riferimento alle rappresentazioni
pantomimiche antiche» ( Vocabolario della Lingua Italiana Treccani 31, 662). Il termine latino
pantomimus deriva dal greco pantómimos che però non appartiene alla lingua greca classica: infatti
Luciano (che, come Libanio, usa orchestés ) afferma che esso era usato dagli «italioti», le popolazioni
greche dell’Italia meridionale (Luc. De salt. 67: Luciano 1877, 163; Luciano 1992, 93). Il termine latino
pantomimus diviene consueto negli autori del I sec. (Seneca, Petronio, Tacito, Quintiliano) proprio
quando il genere si afferma
4
Sul pantomimo romano (ma non esiste uno studio complessivo soprattutto in relazione alle tecniche e
agli sviluppi del genere nelle differenti culture di Roma, Grecia e Oriente) vedi: Benz 2000, DarembergSaglio IV, 316-18 (s.v. pantomimus ); Garton 1972, Jory 1981, Jory 1996, Leppin 1992, Luciano 1992,
Molloy 1996, Rotolo 1957, Slater 1994, Wuest 1949.
5
Luc. De salt. 67 (Luciano 1877, 163; Luciano 1992, 95).
inizi del periodo imperiale, la pantomima si definisce già come un genere a parte, con
un suo passato che proviene dal mimus ma anche, senza chiare diramazioni, da diversi
tipi di danza6. Se non che, proprio quando la pantomima inizia ad affermarsi,
incominciano a confondersi le acque dei generi spettacolari e sembra non esserci più
una netta distinzione - in molti autori, da Apuleio a Tertulliano, fino a Sant’Agostino fra histrio (attore), saltator (danzatore), mimus (mimo) e il neonato pantomimus. Nel
mondo teatrale romano, una certa confusione di termini, per la verità, c’era sempre
stata. In primo luogo esisteva un’affinità di fondo delle rappresentazioni dei diversi
generi spettacolari: le tragedie, le commedie, le atellane e i mimi si recitavano negli
stessi luoghi, nelle stesse occasioni, con gli stessi protocolli formali (musica, uso di
accessori semplici, assenza di specifiche scenografie) avendo come macrosegni
distintivi il costume, l’eventuale uso della maschera e, ovviamente, le storie. In
secondo luogo il lessico teatrale non era propriamente cristallino. Per esempio, se con
mimus si indicava sia il genere di spettacolo, sia l’interprete, sia il testo letterario da
interpretare, i diversi generi letterari (tragedia, commedia, atellana) erano recitati da
attori che potevano essere definiti sia in base ad essi (tragoedus, comicus, atellanus)
sia in base alle loro specificità tecniche (histrio, saltator, planipedes, actor e anche
chironomus), sia in base al ruolo teatrale o sociale (gregarius, attore di secondo rango;
scaenicus, uomo di scena)7.
Dunque chi scriveva di vicende teatrali, in genere un intellettuale, era spesso
involontariamente ambiguo: lontano dalle pratiche teatrali, non essendo sollecitato dal
contesto a usare un’appropriata terminologia, lo scrittore confidava nel fatto che il
lettore, che condivideva quel contesto, non avrebbe frainteso8. Fatto sta che a partire
dal periodo imperiale, insieme all’ingresso della pantomima si fanno strada altre strane
espressioni come saltare tragediam e cantare tragediam che rendono problematico
capire anche cosa si intendesse all’epoca per tragedia9. In questa indeterminatezza, una
cosa però è certa: con l’ingresso della pantomima nel panorama delle proposte
spettacolari cresce nelle fonti l’attenzione per i performer, le loro abilità, i loro
virtuosismi, e parallelamente decresce l’interesse per gli aspetti letterari. La danza del
mondo greco si affaccia a Roma e da qui rimbalza in tutte le province come una moda
felice per la sua caratteristica di superare, con il suo linguaggio fisico e visivo, le tante
koinè dell’impero. Il poeta drammatico non è più una figura di spicco, nella pratica
diventa un subalterno degli attori e cade nell’anonimato del librettista10.
Nella storia del teatro occidentale, l’immagine dell’attore totale che si esibisce in
virtuosi a solo mimati e danzati, con l’aiuto di acrobazie e prevalendo sui
drammaturghi, è davvero insolita e trova qualche eco solo nelle consuetudini sceniche
più o meno direttamente derivanti dalla pantomima romana, come quelle del mimo e
del pantomimo moderno11, o del ballerino classico, pure appellabile sulla traccia
6
Sia Luciano che Libanio non distinguono danza epantomima (cfr. nota 2) ma fanno risalire la danza
pantomimica alle origini della danza in modo da conferire nobili natali al nuovo genere.
7
Per un approfondimento sulle denominazioni latine dell’attore: Zucchelli 1965.
8
Anche ai nostri giorni, per esempio, la parola attore è usata indistintamente, per brevità, per definire
dei performer che interpretano differenti generi e tecniche come lo sono il teatro, il cinema e la
televisione.
9
Per una buona ricognizione del problema delle nuove forme di rappresentazioni, e quindi dei nuovi tipi
di interpreti nel periodo imperiale cfr. Kelly 1979 (1996).
10
Alcuni studiosi credono che questi libretti avessero il vantaggio di dare al pantomimo il tempo
necessario per cambiare maschera e costume. Ad ogni modo erano canovacci in cui «i canti erano fatti
per la danza, e non la danza per i canti, e i versi contavano poco» (Daremberg-Saglio IV, 316, n. 28).
11
Cfr. De Marinis 1993, 9.
dell’orchestés progenitore. Ma per trovare concrete analogie all’attività scenica del
pantomimo romano, alla figura di un attore totale e solista, occorre spingersi verso
tradizioni più lontane come quelle degli attori-danzatori dell’Asia: un ambito di forme
e di tecniche evocato dalla provenienza orientale dei pantomimi12 e tuttavia assai poco
frequentato sia dai filologi che dagli storici del teatro. La compresenza di tecniche
diverse in uno stesso performer rivela infatti come anche nel pantomimo romano, alle
origini del teatro occidentale, si fosse costruita, proprio come nei teatri dell’Asia, la
figura essenziale dell’attore totale. Le ragioni della sua sparizione, della divaricazione
delle arti performative in Occidente - una ferita che molti attori contemporanei tendono
oggi a risanare13 - e del suo perdurare invece nelle culture tradizionali dell’Asia sono,
allo stesso tempo, la storia dei generi del teatro occidentale e quella delle suggestioni,
degli esotismi e dei fraintendimenti provenienti dal loro storico rapporto con i teatri
dell’Asia14.
Vorrei qui essere chiaro, soprattutto con coloro che si occupano di teatro attraverso le
discipline classiche del «mondo antico»: non solo, come è ormai noto, l’analisi dei testi
drammatici non basta più a capire le modalità del teatro e occorre integrarne lo studio
con fonti finora trascurate - per esempio quelle che attestano le pratiche dell’attore - ma
occorre dilatare l’orizzonte teatrale. Non è più pensabile che uno studioso di teatro
greco o romano conosca oggi poco o nulla sugli statuti generali della scena, su come
«funzioni» realmente il teatro, sia moderno e contemporaneo sia quello delle altre
società antiche, originarie o cosiddette «primitive», sia quello di altre tradizioni etniche
tuttora attive. In molti casi, non solo i problemi di mimesi della realtà e del passaggio
dal fatto rituale al fatto estetico seguono sorprendenti percorsi paralleli, ma dalla
comparazione se ne avvantaggia proprio la riflessione sulle tecniche del corpo e sui
fatti materiali della vita teatrale, in altre parole sulla scienza del teatro15.
Guadagnare questa prospettiva comparativa al teatro classico è stato l’intuito di
prestigiosi specialisti del teatro antico. William Beare avvertiva nella sua introduzione
a The Roman Stage (1950): «prima di dire che qualcosa è impossibile, dobbiamo
considerare se esiste testimonianza di essa sui palcoscenici di altre epoche e di altri
popoli»16. E, nel 1961, Margarete Bieber, autrice di una notissima ricostruzione del
teatro greco-romano considerato giustamente come un unicum, non esitava a ricorrere
al lontano teatro balinese (definito un dance-drama, un teatro-danza) per spiegare le
12
Specialmente da Egitto e Siria. Non è detto, ovviamente, che tutti i pantomimi che si esibirono in varie
epoche sui palcoscenici romani col nome orientale di Paride fossero tutti di provenienza «orientale»:
siamo però certi che ci fu la consuetudine di assumere nomi d’arte esotici, specialmente se nomi di
interpreti famosi. Si può trovare un elenco dei pantomimi romani in Leppin 1992 e in Garton 1972, 23183.
13
Nella storia delle nostre pratiche sceniche occidentali, fra XVI e XVII secolo, si verificano una serie di
scissioni: dopo i comici dell’arte, prima e ultima genia moderna di attori totali, i performer si
specializzarono sempre di più in discipline distinte che assunsero come asse portante o la recitazione dei
testi o la danza o il bel canto o le acrobazie. Si crearono allora i diversi generi spettacolari che tuttora
sussistono - teatro di prosa, balletto, melodramma, circo - sia pur nelle numerose varianti di incroci e
contaminazioni che conosciamo. Solo agli inizi del ‘900, con il recupero incondizionato all’attore della
sua eloquentia corporis, si istaura quel filo rosso che lega la ricerca di Stanislavskij alla biomeccanica di
Mejerchol’d, il lavoro sull’attore di Copeau a quello dei suoi numerosi allievi (Dullin, Barrault, Artaud,
Decroux e loro relativi allievi), il training dei teatri laboratorio del secondo dopoguerra (Grotowski,
Barba, Brook) ai loro numerosi seguaci ed emuli.
14
Per l’approfondimento di questi argomenti rimando ai miei studi: Barba-Savarese 1997 e Savarese
2000 5.
15
Per la «scienza del teatro» cfr. Taviani 1990 e Savarese 1996, XVI-XVII.
16
Beare 1986, 14.
diverse componenti che hanno reso possibile la nascita del teatro in Grecia17. Ancora
più chiaramente Lillian B. Lawler, studiosa di danza greca antica, scrive:
Un dramma in un teatro cinese di Hong Kong può offrire una soluzione per un problema nella danza
della tragedia greca o in quella del pantomimus greco-romano. Una serie di movimenti di mani e di dita
in una danza del tempio in Cambogia o in una danza indiana può suggerire come fosse complicata e
delicata la cheironomia greca. E tutto questo non per dire che esiste una connessione fra queste danze e
quelle dell’antica Grecia: ma perché queste indicazioni possono presentare allo studioso, in modo pratico
e convincente, possibili concezioni della danza che nello studio, nelle biblioteche, nei musei non ha mai
avuto la possibilità di incontrare. E possono soprattutto presentarsi a lui con l’elemento essenziale del
dinamismo così mancante in tutte le altre fonti.18
Negli ultimi trent’anni la scienza del teatro ha fatto passi enormi proprio coinvolgendo
le tradizioni teatrali asiatiche e una conoscenza sommaria del teatro, Brecht avrebbe
detto «parrocchiale», non basta più. Esistono discipline come l’antropologia teatrale
che hanno profondamente modificato il modo di vedere le tecniche e le pratiche
dell’attore. Non tenerne conto non vuol dire lasciare indietro una lacuna o trascurare un
dettaglio, vuol dire non curarsi della dimensione stessa del teatro e della sua
fenomenologia.
Ora, se nella storia del teatro occidentale, la concentrazione degli studi sulla letteratura
drammatica ha emarginato a lungo l’indagine sul teatro materiale e le tecniche
dell’attore, nella storia dei teatri romani in particolare, le indagini sulle derivazioni del
teatro latino da quello greco e l’esaurirsi della letteratura teatrale in epoca repubblicana
hanno determinato una scuola di pensiero ben radicata che il teatro latino abbia fine
con Terenzio e con l’anomala appendice delle tragedie di Seneca19. Posteriormente, in
epoca imperiale, non vi sarebbe stata che stanca ripetizione, se non vera degenerazione,
del modello classico proprio con la pantomima. In realtà, se guardiamo all’esorbitante
moltiplicazione degli edifici teatrali nel periodo imperiale - una serie di grandi e
sontuosi fabbricati che contemplavano migliaia di posti20 - se esaminiamo i progressi
degli aspetti spettacolari - che prevedevano, come nel caso della pantomima, l’impiego
promiscuo di musica, danza, acrobazie, maschere e costumi raffinati, per mettere in
scena storie molto note come quelle tratte dalla mitologia - dobbiamo invece credere ad
uno straordinario sviluppo del teatro romano, molto tempo dopo l’eccellente stagione
del primo teatro latino e delle commedie di Plauto e Terenzio. Un grande teatro in cui
però l’importanza e il peso della rappresentazione si spostava dall’arte poetica alla
seducente arte dell’attore.
Quest’ordine di nuova grandezza promosso da spettacoli con spezzoni di antiche
tragedie e performance di celebrati pantomimi, capovolge il mondo teatrale del periodo
repubblicano ponendo il fuoco dell’attenzione sugli interpreti e relegando
nell’anonimato gli autori dei libretti: un grande mutamento che si afferma unitamente
17
Bieber 1961, 17, 37, 63.
Lawler 1964, 23.
19
In pratica tutte le storie del teatro latino si fermano a Seneca. Cfr. Savarese 1996, XIII.
20
L’ultimo censimento, attorno al bacino del Mediterraneo, dalla Britannia all’Asia Minore, dalla Gallia
all’Africa del Nord, fino al lontano Afghanistan, ha contato «901 edifici, di cui solo 790 sono strutture
teatrali, così suddivise: 167 greci, 311 romani, 48 odea, 89 strutture gallo–romane, 16 greco–romani, 14
teatri-odeon, 14 cavee teatrali, 8 semianfiteatri a scena; 123 non sono stati classificati. I numeri
rispecchiano solo parzialmente la situazione reale, giacché molti dei teatri non classificati – noti solo da
epigrafi o da fonti scritte [...] – sono sicuramente romani, sia per area geografica, che per cronologia» (
Teatri greci e romani 1994, I, 64).
18
ad altri significativi fattori21. Infatti, parallelamente al moltiplicarsi dei grandi edifici e
delle tecniche spettacolari, abbiamo nel calendario un considerevole aumento dei
giorni dedicati agli spettacoli teatrali, mentre i dati archeologici e documentari
testimoniano l’esistenza di investimenti enormi, senza pari, nelle imprese teatrali. A
questi elementi si devono aggiungere le conseguenze: un’intensa attività legislativa che
viene periodicamente a regolare le attività di tutti i generi di attori e il loro mondo
pubblico e privato; le interdizioni cristiane sempre più numerose contro feste pagane e
spettacoli; e infine la crescita di interesse delle fonti - sia storiche che letterarie - per i
fatti di vita teatrale, per i loro protagonisti e le loro pratiche: non ultime alcune
dissertazioni, come quelle di Luciano o di Libanio, che descrivono con buona
competenza le tecniche attoriche trascurate nel periodo repubblicano22.
Il fatto che queste fonti scritte in greco abbiano posto la danza all’origine della
pantomima, l’aver quindi rubricato la pantomima romana semplicemente come danza secondo una divisione balletto/prosa tutta moderna e interna alla tradizione occidentale
- può aver creato quegli ulteriori malintesi che hanno definitivamente allontanato una
ricostruzione più accurata della storia del teatro romano. Luciano e Libanio tracciando
un’evoluzione dalle origini mitiche della danza al pantomimo l’hanno
involontariamente esiliato dal teatro. Se il loro lettore non compie lo sforzo di
comprendere, attraverso esempi concreti, anche lontani, che non esiste differenza tra un
danzatore e un attore che si muove come in una danza, il salto dalla danza alla
pantomima, che pure Luciano e Libanio avvertono chiaro, apparirà vago, confuso e
forse perfino discutibile23.
L’orazione di Libanio in difesa del danzatore conferma non solo gli straordinari
sviluppi dell’arte dell’attore pantomimo nel tardo periodo imperiale ma anche la
parallela trasformazione dei testi drammatici da componimenti poetici a più facili
libretti, riduzioni di opere illustri: un’evoluzione non conforme agli statuti della
precedente drammaturgia repubblicana e tuttavia un’innovazione in linea con la
tradizione del repertorio teatrale che ha sempre visto gli attori appropriarsi del
patrimonio letterario ereditato e modellarlo secondo le loro esigenze. Indagare e
precisare questi testi difformi, che non hanno lasciato esemplari ma solo
testimonianze24, significa dilatare la drammaturgia alle tecniche performative, alla
21
La mancanza di testi drammatici rivela un nuovo modo di sentire il teatro in cui lo spettatore cercava
soprattutto «l’appagamento della vista» (Zucchelli 1995).
22
Non ci è pervenuta nessuna trattazione tecnica sul teatro o sull’attore del periodo repubblicano: solo
notizie, entrambe del I sec. a.C., di una «storia del teatro» ad opera di Giuba II re di Mauritania e di un
«manuale di recitazione» del grande attore Roscio, amico di Cicerone (Macrobio 3, 14, 2).
23
Questa confusione appare, ad esempio, nella traduzione italiana dell’opera di Luciano che a iniziare
dal titolo - La danza - senza dubbio più allettante e che ricalca quello del catalogo latino delle opere
greche - De saltatione, finisce poi col negare alla pantomima romana la sua autonomia e il suo statuto
tecnico agganciandola alla fortuna che l’opera di Luciano ha avuto nel Settecento europeo presso i primi
teorici del balletto che dettero inizio proprio al suo fraintendimento (Luciano 1992, 143-56). La
legittimità di un influsso dell’opera di Luciano sul balletto classico, più che una parentela, testimonia il
fatto che in arte l’equivoco è fertile quanto più è macroscopico. Volendo rifare la tragedia greca a partire
dai suoi semplici ingredienti - musica, attori, cori e danze - la Camerata dei Bardi inventò, come è noto,
il melodramma: ma prendere il melodramma come uno «sviluppo» della tragedia greca appartiene
all’insano modo di vedere l’evoluzionismo in atto anche nelle arti.
24
Non si è conservato nessun libretto di pantomima e le testimonianze antiche fanno solo riferimento ad
un testo per il canto. Non sappiamo dunque se fossero opere nuove, rifacimenti di testi di poeti famosi, o
se i cantori dei pantomimi prendessero direttamente i testi dai poeti così com’erano. Luciano fa un lungo
elenco di titoli di soggetti mitologici usati dai pantomimi e rivela che essi presentavano molteplici
cambiamenti rispetto alla tradizione (Luc. De salt. 37-60: Luciano 1877, 157-161; Luciano 1992, 78-89).
cosiddetta drammaturgia dell’attore, anche nel teatro classico25. Significa soprattutto
diradare le ombre che velano le testimonianze sulle tecniche e sulle pratiche sceniche
perdute attraverso la ricchezza delle diverse culture teatrali.
Del vivace autore dei dialoghi satirici, del conferenziere e viaggiatore Luciano di
Samosata ne sappiamo poco ma ne conosciamo abbastanza: ma chi era il sofista
Libanio, prolifico scrittore, maestro e amico dell’imperatore Giuliano? Secondo i suoi
esegeti, Libanio sarebbe «un autore che, senza essere sconosciuto, non è classificato fra
i più grandi»26.
2. Le buone ragioni di Libanio
Città di re, sebbene colpita dal fuoco e spesso dai terremoti, Antiochia era nel IV sec.
una metropoli riccamente abbellita da templi, palazzi, colonnati, piazze, terme e
teatri27. La città aveva una cultura cosmopolita, oggi diremmo multiculturale, anche per
la sua posizione chiave sulle rotte commerciali verso Oriente, ed era abitata da ebrei,
cristiani e siriani28, una comunità opulenta e ritenuta culturalmente emancipata. Il
teatro e l’ippodromo erano frequentati assiduamente e la città salì più volte agli onori
delle cronache perché vi accadevano quei pubblici disordini, peculiari degli spettacoli
con grandi assembramenti. Non diversamente, si dirà, dal resto del mondo grecoromano: ma le risse di questa rinomata città destavano più scalpore e risonanza perché
Antiochia fu a lungo sede imperiale d’Oriente. Quando Luciano, siriano di Samosata,
scrisse il suo dialogo sulla pantomima citò gli spettatori di Antiochia come il pubblico
più fine e intenditore del suo tempo:
Voglio raccontarti anche delle grida di rimostranza di un popolo che era in grado di giudicare tali
caratteristiche fisiche. Gli abitanti di Antiochia, nobile città che onora la pantomima in modo particolare,
osservano con tale attenzione tutto ciò che viene detto e fatto sulla scena, che non si lasciano sfuggire
nulla. Una volta salì sulla scena un pantomimo piccolo di statura per interpretare il ruolo di Ettore; tutti
Queste modifiche probabilmente aiutavano gli attori ad avere a disposizione storie emozionanti e piene
di sorprese.
25
Una trasformazione del patrimonio letterario classico si era già avuta, per esempio, quando gli attori
greci, a partire dal III sec., avevano iniziato a modificare secondo le loro esigenze i testi del V sec.
creando una forma di spettacolo nuova definita spettacolo-antologia da Bruno Gentili (Gentili 1977;
Savarese 1996, XLIV-XLV).
26
Schouler 1984. Commenteremo qui alcuni brani dell’orazione di Libanio in difesa della pantomima di
cui stiamo curando la traduzione.
27
Antiochia sull’Oronte, moderna Antakya in Turchia, fondata al tempo di Alessandro Magno a 25
chilometri dal Mediterraneo, fu la capitale dei Seleucidi e poi della Siria romana dopo la conquista di
Pompeo. Ai tempi di Libanio, nel IV sec. d.C., era un’importante città ellenistica dell’Asia, la seconda
dopo Alessandria tanto che nel 338, sotto Costantino, quando l’impero fu diviso, dato il declino di
Atene, essa divenne la capitale orientale dell’impero e, per i cristiani, sede del patriarcato orientale: e
servì ancora come capitale durante il soggiorno in Oriente di Costanzo II (337-350) e di Valente (371378) per le operazioni contro i Sassanidi. L’apogeo della città si ebbe proprio nel IV sec. quando la
comunità annoverò fra i suoi abitanti, una popolazione stimata di 250.000 abitanti, prestigiose presenze
culturali, come Libanio e Giovanni Crisostomo. Dalla fine del IV sec., la funzione della città decadde
lentamente, fino a quando, nel 638, non fu occupata dagli arabi. La regione di Antiochia, la Siria, dette
molti scrittori e uomini di cultura: in periodo repubblicano lo scrittore di mimi Publilio Siro; in epoca
imperiale: Luciano, lo scrittore cristiano Ammiano Marcellino, Eliodoro, Adriano di Tiro, Porfirio. Si
conta anche una folta serie di attori e pantomimi anonimi che emigrarono a Roma spesso prendendo
come nome d’arte quello di loro fortunati predecessori. Per Antiochia ai tempi di Libanio: Downey
1961, Petit 1956.
28
In realtà occorre parlare di una popolazione greco-siriana: un misto di greci, macedoni, ebrei orientali
e popolazione indigena.
proruppero in un unico grido: “Tu sei Astianatte, ma dov’è Ettore?”. Un’altra volta, mentre un
pantomimo smisuratamente alto danzava nel ruolo di Capaneo che assaliva le mura di Tebe, dissero:
“Scavalca il muro! Non hai bisogno della scala!”. E di un danzatore grande e grosso che tentava di
spiccare grandi salti dissero: “Ti imploriamo, risparmia il palcoscenico!”. Al contrario urlarono ad uno
magro: “Salute!” come si dice solitamente ad un malato. Ti ho ricordato queste cose non per scherzarci
sopra, ma perché tu ti renda conto che interi popoli tennero in grande considerazione l’arte della
pantomima tanto da poterne riconoscere le qualità positive e negative29.
Libanio nasce in questa Antiochia intorno al 314 e resta orfano di padre all’età di dieci
anni. Per imparare la retorica30, alla quale decide di dedicarsi giovanissimo, si reca
ventenne ad Atene dove non segue i più celebri sofisti dell’epoca ma un oscuro arabo
di nome Diofanto. Nel 340, come professore privato di retorica, va prima a
Costantinopoli, fino al 346, e poi a Nicea e a Nicomedia dove incontra il giovane
Giuliano, futuro imperatore. Nel frattempo i suoi successi di sofista sollevano la
gelosia dei rivali. Dopo un breve soggiorno di nuovo a Costantinopoli, all’età di
quarant’anni, Libanio rientra, nel 354, nella sua città natale31. Qui Libanio si dedica per
dieci anni ad un’intensa attività professionale in una scuola tutta sua, dove è maestro di
eminenti personaggi, pagani e cristiani: Giovanni Crisostomo, Basilio di Cesarea e
forse Gregorio Nazianzeno e Ammiano Marcellino. Indirettamente è maestro anche del
giovane rampollo imperiale Giuliano32. Quando questi salì al trono nel 361,
riconvertito alla cultura classica nella quale era stato educato, Libanio, deciso assertore
della romanità, riconobbe nella politica restauratrice del nuovo imperatore una coerente
scelta culturale e non l’apostasia recriminata dai cristiani. Libanio divenne aperto
sostenitore di quel «partito pagano»33, nato dopo Costantino, nostalgico della lontana
epoca ellenista che iniziava a diventare un po’ mitica. Il suo tuttavia non era un rozzo
conservatorismo: Libanio aveva capito, come Giuliano, che la cultura classica poteva
essere un potente collante di un impero che si andava fatalmente dividendo per vivere
più a lungo. Quando, nel 362, Giuliano si stabilì ad Antiochia, Libanio si legò a lui
entrando a far parte degli intimi del sovrano: l’imperatore lo onorava chiamandolo
«fratello carissimo e amatissimo» e Libanio gli rispondeva dedicandogli alcune belle
orazioni.
L’improvvisa morte in battaglia di Giuliano, nel 364, scatenò la reazione dei suoi
detrattori che tentarono, a quanto sembra, anche di eliminare fisicamente l’esposto
Libanio. Inizia per il maturo sofista un periodo difficile e si sospetta che l’affievolirsi
della sua corrispondenza in questo periodo sia dovuto ad un comportamento prudente.
Dopo l’elezione di Teodosio, nel 379, Libanio, a 64 anni, torna ad essere gradito a
29
Luc. De salt. 76 (Luciano 1877, 166; Luciano 1992, 100).
La retorica rappresentava uno dei pilastri se non la base stessa dell’educazione ( paideia ): le scuole di
retorica fornivano i parametri del «classico» e costituivano il fondamento dell’educazione per le classi
colte in tutto l’impero, il luogo dove avveniva la loro formazione intellettuale e morale. Pertanto la
figura del retore-maestro rappresentava uno degli elementi connettivi tra potere imperiale e classi
intellettuali, tra potere centrale e realtà locali, specialmente in quell’universo municipale particolarmente
vivo della geografia greco-orientale. Da un punto di vista pratico sofista voleva dire anche un
funzionario assunto dalla comunità cittadina, ma con approvazione statale, per professare la retorica:
alcuni di loro si chiudevano nelle scuole, altri, come Libanio, mettevano la propria parola al servizio di
cause extra-scolastiche, sociali, giudiziarie e politiche.
31
Per la biografia di Libanio e una prima ricognizione delle sue opere cfr.: Martin 1979, Petit 1866, Petit
1956,
Schouler
1984.
Un’accurata
bibliografia
anche
nel
sito
perso.clubinternet.fr/pemaloss/index.htlmLitarba curato da Pierre-Louis Malosse.
32
Afferma Libanio a proposito di Giuliano: «Le orazioni [da lui] composte successivamente hanno
qualcosa in comune con le mie: donde egli apparve essere uno dei miei allievi» ( Orazione 18, 15 in
Tantillo 2001, 22).
33
L’espressione è di Paul Petit per indicare quelle persone che non avevano aderito al cristianesimo
sostenendo i valori del paganesimo greco-romano (Petit 1956, 266).
30
corte e indirizza al nuovo imperatore altri discorsi in cui è prodigo di consigli e chiede
nuovamente benefìci per la sua città. L’imperatore, pur non conoscendolo
personalmente, gli conferisce nel 384 il grado onorario di questore, facendo di lui la
figura più insigne della sua comunità.
Non si conosce la data di morte di Libanio, avvenuta di sicuro dopo il 393, data della
sua ultima lettera, quando l’oratore aveva 78 anni, un’età ragguardevole per un uomo
che in vari luoghi della sua opera si era dichiarato cagionevole di salute. [...] Per il
ruolo rispettato di maestro di retorica, per la funzione pubblica svolta nella sua
comunità, per la difesa della cultura classica greco-romana e per il suo stretto rapporto
con gli imperatori Giuliano e Teodosio, Libanio appare un personaggio ricco e
complesso sebbene la sua notorietà di retore greco sia stata a lungo di secondo piano
nel panorama della tarda latinità.
Certamente fu un sofista di rango, considerato uno degli ultimi atticisti, un poligrafo
colto e d’ingegno, vero e degno rappresentante della cultura pagana ben radicata in
Asia Minore: ma a differenza degli altri sofisti, Libanio si prodigò in difesa dei suoi
amici e dei suoi concittadini per interessi concreti, «in un’epoca in cui la cura del
benessere pubblico si lasciava ai vescovi». Il fatto poi che la tradizione bizantina lo
abbia molto stimato, trasmettendone quasi per intero l’abbondantissima e varia opera34,
testimonia un’attenzione non marginale per la sua lingua e per il suo sapere profuso in
ben 1.500 lettere (che lo hanno fatto definire «le modèle épistolaire le plus pratique»),
51 declamazioni su diversi temi (storici, mitologici, etici, spesso scritti come modelli
per i discorsi), 41 corte narrazioni (diegèmata) la maggior parte delle quali su noti
soggetti mitologici. Ma soprattutto Libanio si specchia nel folto corpus delle sue 64
orazioni, inclusa una autobiografica che per il suo tono intimo sembra anticipare quella
di Sant’Agostino. Si tratta di discorsi composti nella posizione di oratore ufficiale della
sua città per intervenire, presso il governatore o lo stesso imperatore, in difesa
dell’onorata popolazione di Antiochia. Proprio fra questi discorsi, viene
sessantaquattresimo, ultimo della lista, quello in difesa dei pantomimi, composto nel
361.
Libanio scriveva, insegnava e seguiva una carriera accademica che lo portava ad una
vita per lo più sedentaria: come tutti gli intellettuali, provava se non aperto fastidio per
il teatro e il circo, considerati divertimenti plebei35, almeno un certo distacco36.
Ciononostante si avventurò in una difesa della popolarissima pantomima dando notizie
e informazioni particolareggiate sul mondo dei suoi interpreti. La sua orazione non
raggiunge la ricchezza e la vivacità di quella di Luciano, ma si tratta di un documento
per nulla secondario, soprattutto quando considera alcuni dettagli tecnici
sull’addestramento del pantomimo trascurati da Luciano. Perché dunque l’insigne
34
Di nessun altro scrittore antico è pervenuto un corpus altrettanto vasto.
Come nota il Foerster «Divenuto più vecchio, Libanio giudicò più severamente i pantomimi tanto da
farli espellere da Antiochia» (Libanio 1908, 407) come risulta da passi di altri discorsi ( Ad Icarium 26,
23; Contra Florentium 46, 31; Ad dicere nolentes 35, 17; Ad Timocratem 41, 7).
36
«Qualcuno contesterà "Come mai, se consideri innocua la pratica della pantomima, tu stesso la eviti e
ne distogli i giovani?" Perché la mia situazione, mio caro amico, è tale che a malapena ho tempo per le
cose essenziali. Infatti quando Ermes si avvicina e mi trascina via dal tavolo di lavoro e dalle terme,
devo tralasciare tutti i piaceri per dedicarmi all’oratoria. Di modo che sembro veramente poco socievole
alla maggior parte della gente, se non si considera il tipo di necessità che mi tiene isolato. Sono diventato
traditore anche della mia salute, e per la frenesia di lavorare e di non seguire per nulla i consigli di
parenti e amici, sembro un esaltato. Quindi come potrei verosimilmente approfittare di uno spettacolo e
rispondere ai pantomimi che mi invitano, quando sono costretto a casa da tali occupazioni domestiche?»
(Lib. De salt. 99: Libanio 1908, 485).
35
sofista di Antiochia decide di schierarsi in difesa dei pantomimi, rischiando un tema a
lui inconsueto? Possiamo indicare alcune motivazioni, di cui soltanto una appare, lo
premettiamo, più credibile delle altre37.
In primo luogo si può considerare l’aspetto di più immediata evidenza. Con questo
discorso, Libanio vuole fare un omaggio al suo venerato modello di retorica, Publio
Elio Aristide che aveva lanciato accuse d’immoralità contro la danza pantomimica
facendone la deplorevole imputata di un processo. Molto ammirato nella tarda latinità
tanto da essere paragonato a Demostene da Longino, Aristide era però un retore vissuto
più di duecento anni prima di Libanio e sebbene la sua fama passasse intatta attraverso
i secoli fino alla scuola retorica di Gaza - la più importante del V sec. - un confronto
con lui significava una sfida del tutto accademica, un contraddittorio ovviamente senza
replica. Quindi si presume che il discorso di Libanio fosse un semplice esercizio
scolastico: a quei tempi, contestare con un’orazione un avversario vissuto in altra
epoca era una pratica comune38, specialmente se fatta usando le argomentazioni
originali39, e i discorsi costruiti come risposte dirette erano incoraggiati, anche se
fittizi, come un utile allenamento quotidiano. Dunque Libanio si lancia in un eccellente
esercizio che non aveva bisogno di particolari sollecitazioni ma che pure arrivava a
sfruttare due utili risorse contingenti: il fatto che l’accusatore fosse un celebrato,
inattaccabile retore e il fatto che la pantomima, attraverso la danza da cui derivava, si
presentasse come argomento dalle storiche, se non mitiche, implicazioni di
immoralità40. Un tema ingombrante, quindi, e assai difficile da difendere e da far
assolvere. [...]
Un secondo motivo che potrebbe aver favorito l’ispirazione di Libanio sarebbe stato di
natura politica. Il discorso fu scritto nel 361, l’anno che vedeva il neo-imperatore
Giuliano fare un serio tentativo di restaurare l’ellenismo e il paganesimo. Naturalmente
questa politica restauratrice privilegiava gli aspetti sociali e cultuali della società
romana e il teatro e i giochi pubblici erano un’attività simbolo della comunità pagana.
Sebbene non amante del teatro, Libanio potrebbe aver considerato gli spettacoli di
pantomima come un valore culturale e sociale da rivalutare, perché esaltavano e
mantenevano viva la mitologia greco-romana. Ricordiamo che una ragione simile è
stata prospettata anche per l’opera di Luciano. Si dice infatti che Luciano abbia scritto
il suo dialogo sulla pantomima per compiacere l’imperatore Lucio Vero, amante degli
spettacoli, quando questi si recò in Siria, nel 162, per una campagna contro le
irrequiete popolazioni orientali. Nelle accoglienti città siriane - Laodicea, Dafne,
Antiochia - l’imperatore si lasciò andare a lussi e divertimenti al punto di tornarsene a
Roma, quattro anni dopo, alla fine della sua campagna, con la nomea di aver condotto
37
È difficile apprezzare il valore storico delle orazioni di Libanio perché la retorica vi introduce molte
deformazioni. Occorre pertanto conoscere, più che in altri casi, le circostanze della loro redazione, la
situazione personale dell’autore, le sue opinioni a riguardo, il suo atteggiamento nei confronti del reale,
le sue intenzioni e gli interessi che difende. In genere, prima di divulgarle, Libanio recitava le sue
composizioni agli amici personali in una sala del bouleuterion : i più intimi poi lo consigliavano e
talvolta lo dissuadevano dalla pubblicazione. Libanio stesso poteva non recitare le parti più
compromettenti o politicamente poco prudenti dei suoi discorsi (Cfr. le sue epistole 33 e 283 in cui
descrive questa prassi).
38
L’intera opera di Libanio è stata definita come la produzione scolastica di un retore «destinata ad un
pubblico che si precipitava a scuola per sentire i suoi antichi maestri, quelli dei loro figli, trattare
eternamente, con gli stessi argomenti e gli stessi esempi, i soggetti di sempre» (Schouler 1984, 25).
39
Secondo alcuni studiosi, Libanio riprenderebbe nel suo discorso interi brani dell’accusa di Aristide
non arrivata fino a noi. Ma su questa ripresa vedi Rotolo 1957, 80.
40
A testimonianza di questo aspetto il fatto che l’orazione 64 fu sempre classificata tra i «discorsi
morali».
una guerra ai pantomimi più che ai Parti, tanto numerosi furono gli attori (histriones)
che riportò con sé a Roma dall’Oriente per trascinarli nel suo trionfo «come se fossero
stati dei re»41.
La correlazione tra Luciano e Libanio trova un nesso concreto, malgrado o forse
proprio in ragione del tempo che intercorre fra i due personaggi, perché le loro opere
sulla pantomima sono state tramandate, con quella di Coricio, dagli stessi codici. È
vero che si usava unire opere con argomenti simili ma qui, sembra dire la stessa
tradizione, siamo di fronte a vere affinità. Le opere di Luciano e di Libanio sono molto
simili e vicine, talvolta complementari, anche se Libanio è meno profondo e dettaglia
più brevemente le origini e i temi mitologici rappresentati dai pantomimi che sembra
non conoscere bene come Luciano. Alcune osservazioni tecniche di Libanio appaiono
però pertinenti, e proprio perché fatte da qualcuno che si dichiarava non appassionato
di teatro, aumentano la probabilità che fossero «luoghi comuni» sull’arte della
pantomima, cioè cose abbastanza risapute quindi con un buon fondamento di realtà.
Libanio scrisse perciò la sua orazione per compiacere il «partito pagano» del suo
imperatore Giuliano? Questa seconda congettura sembra però respinta dalla terza
ipotesi.
Libanio, difensore ufficiale della sua città e autore di molte altre orazioni per
patrocinare la sua comunità di fronte all’irritazione di un imperatore o di un
governatore romano, potrebbe aver scritto questo discorso per difendere realmente un
gruppo di danzatori che era stato bandito da Antiochia, o stava per esserlo, in ragione
di comportamenti licenziosi: ma questa censura potrebbe essere partita dall’imperatore
Giuliano in persona. Nel 363, due anni dopo il discorso di Libanio, Giuliano,
nell’operetta satirica Misopògon (Odiatore della barba), non solo si dichiara insensibile
al fascino degli spettacoli ma rimprovera agli antiochieni la corruzione dei costumi e
una condotta di vita troppo spensierata in una città «dove molti sono i pantomimi,
molti i flautisti, dove i mimi sono più numerosi dei cittadini» (342b): tanto ingombranti
che l’imperatore dichiara di aver sciolto in precedenza molte compagnie lasciando
senza lavoro gli attori (344a). Atti censori che trovano conferma anche in un passo
delle sue Epistole (fr. 304). Se fosse vera questa circostanza, Libanio avrebbe potuto
scrivere questa difesa dei pantomimi contro le sanzioni di Giuliano e non a favore della
sua politica restauratrice. Antiochia, capitale d’oriente, aveva fama di ospitare
spettacoli troppo vivaci e scandalosi e l’imperatore, per quanto pagano, poteva esigere
che la città imperiale mantenesse un suo decoro.
[...]Ma non abbiamo alcuna prova concreta che Libanio abbia scritto in difesa del
pantomimo per convincere l’imperatore che non ci fosse niente di male nelle loro
rappresentazioni: si può solo prendere atto che una città «cristiana» non rinunciava ai
piaceri del teatro mentre un imperatore «pagano» li disprezzava. E comunque, neanche
questa viva contraddizione, segno acuto di un tempo in forte transizione, spiega il
ricorso di Libanio ad un pretesto così lontano come quello offerto dall’accusa del
trapassato Aristide. Così sulla finalità reale di questa orazione non c’è giustificazione
fondata e sicura, e la prima ipotesi, quella di un esercizio retorico fittizio, sembra
essere ancora la più attendibile. Quel rivolgersi di Libanio, a turno, ora direttamente ad
Aristide - Tu dici che… - ora all’auditorio ma indicando l’avversario - Egli afferma
che… - appare proprio una soluzione efficace per istruire gli scolari su come si affronta
un dibattimento avendo per avversario un interlocutore in carne e ossa e non un
41
Dalla biografia di Lucio Vero, ad opera di Giulio Capitolino nella cosiddetta Historia Augusta
(Scrittori 1983, 297).
vecchio rotolo di papiro. Ma d’altra parte, quantunque Libanio intenda rispondere a
Elio Aristide per amore di esercizio oratorio, il suo discorso risente del clima
moralistico degli scrittori cristiani, di quell’energica condanna avanzata dai padri della
chiesa nei confronti del teatro e dei divertimenti profani, a cui talvolta faceva eco
persino il «partito pagano» turbato dagli eccessi delle scene e dei loro fanatici
sostenitori.
3. Le virtù del pantomimo
Seguiamo ora l’impianto dell’orazione di Libanio. All’epoca imperiale la ripartizione
dei discorsi giudiziari era divisa in quattro parti: l’esordio, il racconto o l’esposizione
dei fatti, le argomentazioni, l’epilogo o perorazione42. L’esordio è una captatio
benevolentiae. L’oratore espone il pregiudizio ostile: il suo scopo fondamentale è
rimuovere la cattiva reputazione che pesa sulla danza e sui pantomimi, un marchio
infamante che li affligge e li fa soffrire. Questa condanna è immeritata ed è interamente
dovuta alle accuse immotivate di Aristide, alle sue calunnie che arrivano a definire la
pantomima come «il morbo e la rovina degli spettatori». Le argomentazioni di Aristide,
come abbiamo detto, non ci sono pervenute ma le sue accuse possono essere ricostruite
proprio attraverso le citazioni tirate in campo da Libanio che vuole metterne in risalto
l’assurdità e la scorrettezza43. Aristide si lamenta perché la danza aveva cambiato stile
e non era più «quella di una volta»: e cambiando era diventata, ovviamente, peggiore,
da nobile espressione a numero d’attrazione nel pantomimo. Poi Aristide attacca i canti
e i cori che accompagnano lo spettacolo, i canti perché sono troppo frivoli e poco virili
e i cori perché sono formati da individui degni di biasimo, dal tenore di vita corrotto.
Infine Aristide arriva a sostenere persino la vecchia tesi che la musica penetra
nell’anima e chiunque l’ascolta ne viene corrotto.
Libanio ribatte punto per punto le accuse di Aristide. Dopo aver fatto un rapido
excursus mitologico per provare come la danza fosse amata dai poeti e dagli antichi,
egli dimostra come il progresso della danza abbia prodotto all’uomo benefìci, e difende
la musica e i membri del coro liquidando la loro presunta immoralità come un fatto
irrilevante di fronte al grande fenomeno dello spettacolo pantomimico. Il corpo
dell’orazione è poi tutto indirizzato ad una strenua difesa della pantomima e dei
pantomimi dall’accusa di immoralità e di comportamenti depravati, come
l’omosessualità. Questa parte prevalente dell’orazione - due terzi - sembra puntare a
chiudere definitivamente un argomento ritenuto, per tradizione, indifendibile44. Fra i
pantomimi, come in tutti i gruppi sociali, ci sono individui corrotti ma anche persone
oneste, tanto è vero che le carceri sono riempite di criminali ma non di pantomimi. Se
essi usano lasciarsi crescere i capelli e abbigliarsi con vesti eleganti e sfarzose, molti
altri esempi dimostrano che anche individui eccellenti - i guerrieri, i sacerdoti tengono a queste abitudini: e i comportamenti effeminati ed omosessuali non sono stati
certo inventati e diffusi dai pantomimi.
42
Una partizione che passò intatta alle scuole bizantine e che, a giudicare da quello che ancora si legge,
ha fatto molta strada.
43
«Del resto questo è difetto comune ai retori antichi, e se in genere c’è da dubitare della lezione delle
loro citazioni (non sempre innocentemente errate perché riferite a memoria), ancora di più bisogna
diffidare delle argomentazioni che essi mettono in bocca ai loro avversari» (Rotolo 1957, 80).
44
Proprio questo dilungarsi su un argomento difficile e radicato nell’opinione comune fa pensare che
questa difesa sia una sorta di sfida: quella di patrocinare una causa apparentemente perduta in partenza e
come tale vero test delle norme retoriche e dimostrazione di abilità oratorie.
Qui improvvisamente il discorso devia. Dopo una pausa esilarante in cui Libanio,
ribaltando l’accanimento censorio di Aristide, ridicolizza le sue sanzioni nei confronti
dei pantomimmi45, negli ultimi venti paragrafi - un sesto del discorso - si passa agli
aspetti tecnici della pantomima e alle sue benemerenze. Pur dichiarando la propria
estraneità di spettatore patito del genere46, Libanio dimostra di essere al corrente della
dinamica del doppio apprendistato di un aspirante pantomimo che viene avviato alla
carriera fin da giovanissimo:
103. Dunque, per prima cosa, intraprendere questa professione [di pantomimo] non è nelle facoltà fisiche
di tutti: essa è adatta solo agli adolescenti, ai ragazzi e a coloro che vogliono diventare atleti. Così, chi ha
occhio per questo genere di attività, esamina e sceglie tutti quei giovinetti che per la loro prestanza fisica
promettono di eccellere: ma rifiuta gli altri non abbastanza interessanti per il mestiere. Poi è necessario
che i ragazzi mostrino già che sapranno mantenere nel tempo il giusto peso e che non ingrosseranno. E
devono avere anche un collo diritto, uno sguardo fiero, dita affusolate e, in una parola, la bellezza,
attributo essenziale per chi ha a che fare con spettacoli da palcoscenico, ma specialmente nel caso della
danza. 104. Quando si prende un allievo, il maestro di ginnastica lo contorce con flessioni più numerose
e abbondanti di quelle a cui si sottopone un lottatore: gli tira i piedi dietro la schiena fino alla testa e poi
glieli forza in modo che i talloni si avvicinino ai gomiti, fino a farli sporgere vicino al viso. Quando ha
trasformato il corpo in un cerchio, come un giunco di salice, lo fa correre proprio come un cerchio. E
questi vola. La corsa non farà male agli arti perché tutte le membra sono state addestrate ad essere
flessibili: il maestro, infatti, quasi smembra gli arti l’uno dall’altro e, badando che le giunture siano
disarticolate, gli porta le mani e i piedi in qualsiasi punto del resto del corpo, malleabili come fossero di
cera. 105. In questo modo, il maestro di ginnastica crea un corpo per l’insegnante di danza che
subentrerà e rende la struttura degli arti obbediente all’intento di imitare ogni tipo di figura. Questa
nuova attività è impegnativa, uno dando istruzioni e l’altro facendole sue. In una parte del tempo
l’allievo apprende la pratica, nell’altra la riflessione su ciò che ha praticato. L’allievo che ha cessato di
cimentarsi con i movimenti, deve anche saper trattenere nel cuore ciò che ha conquistato con fatica. In
questo modo gli uomini imparano che gli dei accordano ogni bene ma solo a prezzo di fatica. 106.
Proprio come per coloro la cui passione è scrivere, anche per gli allievi pantomimi la fatica è la maggior
risorsa per avverare i desideri. Com’è impossibile ingrassare il corpo e insieme raffinare l’anima, così
non è possibile che la danza e la gola vadano a braccetto: è essenziale che chi desidera l’una stia lontano
dall’altra. Così, se ti troverai vicino ad un danzatore che pranza e lo vedi esagerato nel mangiare,
ritienilo pure un piombo in scena, perché la voracità distrugge la sua abilità. 107. E c’è più probabilità di
stimare seri i discorsi di un ubriaco che trovare la danza in un corpo con lo stomaco sfondato. Non è
possibile, dunque, intraprendere questo mestiere se non attraverso l’autodisciplina. Per la persona che la
pratica, l’autodisciplina è la salvaguardia di ciò che ha imparato. Per esser chiari: l’uomo che a tavola si
lascia andare diventa un macigno invece che una piuma. Quindi se, come dice il proverbio, un cipriota è
sempre sazio e non può essere cipriota un uomo affamato, coloro che sono vicini alla vera pantomima si
tengono anche lontani dal sesso e in questo sono un esempio buono e non cattivo. È garantito: un
balordo o un impestato non potranno mai varcare la soglia dell’arte pantomimica47.
L’adolescente più adatto ad intraprendere la carriera di pantomimo deve dunque
apparire di costituzione asciutta, deve avere un collo dritto, uno sguardo vivace, le dita
affusolate e non deformi e deve essere bello a vedersi, con la promessa di mantenersi
un giovane attraente. Queste esigenze sono molto simili a quelle indicate per una
recluta dell’esercito romano: l’aspirante soldato deve avere ugualmente occhi vivaci, la
testa eretta, un petto largo, spalle muscolose, braccia forti e dita affusolate48. Non
sembri bizzarro il legame tra l’apprendista pantomimo e chi si appresta al servizio
militare: nei teatri asiatici, in India, in Cina, in Giappone, le nobili arti marziali, con la
loro severa disciplina del corpo e la preparazione a sequenze di azioni concatenate,
sono state a lungo il modello di molte forme di spettacolo e soprattutto del training
degli attori49. Anche la scelta degli allievi che punta ad un’età giovanissima è simile a
45
Vedi più avanti il paragrafo L’arte di battere i piedi.
Vedi nota 29.
47
Lib. Pro salt. 103 - 107 (Libanio 1908, 487-90).
48
Veg. Mil. 1, 6.
49
Cfr. Awashti 1988; Zarrilli 1993.
46
quella che ritroviamo, per esempio, nella scelta degli attori nel teatro indiano e nel
teatro cinese50, compreso il riferimento alla bellezza che sembra essere il requisito più
importante, quasi obbligatorio, e che ricorre sempre in questo genere di stime.
Dopo l’esame dell’aspetto fisico, viene quello per verificare la predisposizione del
corpo all’agilità mentre compie esercizi di acrobazia. In altre parole potremmo
definirlo un test sulla leggerezza, una dote che anche oggi viene molto apprezzata sia
nei danzatori che negli attori, e che non è, ovviamente, semplice agilità ma dote
psicofisica e di durata. Non a caso si tratta di una preparazione preliminare, per
forgiare il corpo dell’allievo, per renderlo flessibile e disarticolato attraverso un
tirocinio curato da un maestro di ginnastica (paidotríbes) e che non decide
dell’espressività del futuro performer ma della sua pre-espressività, cioé di un
condizionamento del corpo prima di passare ad apprendere le figure e le storie della
pantomima. Alla fine di questo training, solo se è stato raggiunto un livello
soddisfacente, il ragazzo passa al maestro di danza (forse un vecchio pantomimo) che
finalmente lo istruisce nei movimenti, nelle azioni e nelle figure che ben conosce e
padroneggia: una laboriosa attività che impegna reciprocamente maestro e allievo. In
questa seconda parte dell’apprendistato, all’allievo viene lasciato, dopo la pratica,
anche il tempo di meditare sulla fatica (pónos, fatica, lavoro, travaglio, sforzo) e
sull’autodisciplina necessaria a dominarla. Forse per la prima volta nella storia del
teatro occidentale, si riconosce all’attore una facoltà intellettuale per valutare il suo
mestiere sulla base dello sforzo profuso e dell’autodeterminazione: nessuna delle diete
previste per mantenere agile il suo corpo e nessuna temperanza sessuale, ugualmente
programmata, potranno mai condurre un attore allo stesso vertice. La Molloy
sottolinea: «Dà l’impressione che il pantomimo-danzatore debba praticare un
autocontrollo di tutti gli appetiti per mantenere sotto completo controllo non solo il
corpo ma anche la mente»51.
Su questa importante alleanza corpo-mente dell’attore, Libanio non si esprime oltre ma
possiamo integrarlo con quanto dice Luciano che sottolinea con forza anche lui come
l’attività del performer superi i puri aspetti fisici. In più punti52 infatti, Luciano
specifica le doti che il pantomimo deve possedere, ciò che deve imparare e come deve
saperlo esercitare e rafforzare. In cima a questo processo di apprendimento che include
musica, ritmo, metrica ma anche filosofia, fisica ed etica - un’educazione del tutto
simile, dice Luciano, a quella dell’oratore e del retore - si collocano due componenti
psichiche o mentali: una ferrea memoria di «tutto» che deve aiutare l’allievo a
conoscere, come Calcante, «le cose che sono, che saranno e che furono», e soprattutto
«parte principale dell’impegno, un sapere (epistéme) mimetico e dimostrativo che sa
esprimere i pensieri e illuminare quello che resta in ombra»53.
Fin dove si deve spingere questa perspicacia del performer, Luciano lo sottolinea
quando suggerisce la misura dell’imitazione in cui il pantomimo non deve esagerare
(kakozelía, eccesso di zelo, cattivo zelo, strafare). Alcuni pantomimi infatti «se devono
imitare qualcosa di grande lo fanno enorme, se rappresentano qualcosa di delicato lo
rendono esageratamente effeminato, se rappresentano qualcosa di virile si spingono a
rappresentarlo come selvaggio o bestiale»54. Segue l’esempio di un pantomimo che
50
Savarese 1988.
Molloy 1996, 69.
52
Luc. De Salt. 35, 36, 74 e 85 (Luciano 1877, 156, 166, 170; Luciano 1992, 76, 78, 98, 108).
53
Luc. De Salt. 36 (Luciano 1877, 156; Luciano 1992, 78).
54
Luc. De Salt. 82 (Luciano 1877, 168; Luciano 1992, 104).
51
interpretando il personaggio di Aiace impazzito, si lascia andare ad una follia che
appare chiaramente dell’uomo più che del personaggio: infatti l’energumeno inizia a
strappare le vesti dei musicisti in scena, colpisce duramente la testa di un compagno
con un flauto e scende dal palco sedendosi fra due spaventati senatori che giustamente
temono altre sue stravaganze. Il pantomimo si pentì poi dei suoi eccessi e non volle più
ripetere il personaggio, specialmente quando seppe che il suo rivale, nell’interpretare lo
stesso Aiace, era stato assai misurato nella mimica. Questo avvertimento di Luciano un eccessivo realismo nuoce all’arte pantomimica - ci riconduce a Libanio e alla sottile
questione dell’interpretazione dei personaggi femminili compromessa da un’esagerata
effeminatezza: come sfuggire alla maggiore accusa di Aristide ai pantomimi, quella di
rovinare intere città e famiglie a causa della loro effeminatezza professionale?55
4. Interpretazione dei personaggi femminili
L’interpretazione di personaggi femminili da parte di attori, mimi e danzatori di sesso
maschile inizia probabilmente con il teatro stesso ed è una prassi del tutto comune in
tutte quelle culture teatrali che non ammettono, per diverse ragioni, dall’etica alle
consuetudini, la presenza delle donne sulla scena: e la faccenda non è mai stata
considerata una stranezza o una calamità artistica neanche nel mondo greco-romano.
Così non ci soffermeremo su questa pratica del tutto normale anche nelle grandi
tradizioni teatrali dell’Asia, limitandoci a rilevare come essa abbia talvolta
condizionato, in Oriente e in Occidente, l’interpretazione di personaggi femminili
spingendo l’attore a comportamenti troppo effeminati, persino fuori scena, nel tentativo
di aderire con più efficacia ai modelli muliebri che doveva impersonare.
Proprio seguendo questo schema un po’ semplice e ovvio ma credibile, Aristide
arrivava a sostenere che la pratica di un uomo che deve interpretare una donna può
diventare, alla lunga, assai perniciosa per gli spettatori per la confusione in cui getta
costume e morale. E l’imputazione di effeminatezza si aggrava, quando l’accusatore
aggiunge che i pantomimi portano abitualmente lunghi capelli, vistosi costumi e
numerosi gioielli e collane56. Da qui all’accusa di prostituzione il passo è breve e
puntualmente Aristide lo compie: i pantomimi hanno stili di vita disonorevoli e
corrompono il pubblico attirandolo verso qualcosa che è poco virtuoso. Ribatte
puntigliosamente Libanio:
Come puoi affermare in modo onesto che tutti i danzatori siano coinvolti nel commercio del sesso? […]
Cosa ti spinge ad attribuire la prostituzione all’intera categoria dei pantomimi? […] Non si può evitare
che se qualcuno impegnato nell’arte della pantomima ha condotto una vita virtuosa, altri pantomimi
abbiano invece venduto le loro grazie. Se quest’aspetto fosse veramente l’unico elemento di quest’arte, e
se non fosse possibile intraprenderla senza disonorare il corpo, il rimprovero sarebbe estendibile a tutti i
pantomimi. Ma se è possibile anche per un uomo virtuoso essere un buon pantomimo e ancor di più per
un uomo che volutamente non si fa tentare dai piaceri, perché consideriamo come parte dell’arte ciò che
è distinto dall’aspetto artistico? Non è giusto accusare una professione intera se è turpe soltanto
qualcuno che la esercita57 .
Sebbene Libanio sia serrato e scrupoloso nella sua puntigliosa difesa che ribatte punto
per punto le diffamazioni di Aristide, si sarebbe tentati di chiudere qui
55
Lo stesso genere di accusa l’aveva fatta anche Luciano all’inizio del suo dialogo (Luc. De Salt. 2:
Luciano 1877, 144; Luciano 1992, 50).
56
Libanio scherza: poiché anche i sacerdoti hanno abiti molto ricchi e ricamati d’oro, allora bisognerà
classificare anche loro come prostituti! (Lib. Pro salt. 52: Libanio 1908, 453).
57
Lib. Pro salt. 38, 39 e 43 (Libanio 1908, 443 e 446).
quest’argomento perché il suo discorso sembra tendere alla solita questione della vita
scandalosa degli attori, alle loro tendenze sessuali più o meno adeguate alle loro
realistiche interpretazioni e ai loro travestimenti58. Ma si può ridurre a questa sola
dimensione la professione di rappresentare personaggi femminili? Poteva un’intera
categoria soccombere ad accuse così generalizzate? Naturalmente ponendo questi
quesiti non vogliamo escludere, e non li escludeva già Libanio, che esistessero
comportamenti omosessuali fra i pantomimi romani, come non possiamo escludere il
fenomeno della prostituzione degli attori nel teatro antico che in questo dominio non si
discostava dai comportamenti di altre società e delle altre classi sociali che
componevano la cittadinanza dell’impero romano, dove l’omosessualità e la
prostituzione, come sappiamo, erano ampiamente praticate. Si tratta di vedere se, al di
là dei più o meno rinomati «limiti» posti dall’imitazione realistica, esistessero
particolari tecniche per rappresentare la donna: se tradizioni teatrali originarie come
quelle del teatro Nô, del Kabuki, dell’Opera di Pechino, del Kathakali hanno fatto
dell’interpretazione della donna da parte di attori maschili un prodigio di tecnica
attorica, è ipotizzabile che anche la grande pantomima romana, avanzato laboratorio di
tecniche fisiche, avesse trovato un percorso in grado di spostare il problema
dell’interpretazione femminile dalla pura sfera sessuale a quella dell’«eterno
femminino»? Come vedremo, un preciso dato riportato da Libanio fa supporre di sì.
Torniamo alle accuse di effeminatezza e di omosessualità avanzate da Aristide:
secondo la sua visione i pantomimi erano effeminati (gunaikeíos) in quanto, sottinteso,
omosessuali e per questo dunque anche socialmente pericolosi. Seguendo le tracce di
queste accuse, Margaret Molloy, che ha compiuto un approfondito studio sul discorso
di Libanio, estende le sue ricerche ad un excursus sulle leggi dell’epoca
sull’omosessualità, sospettando che quella di Libanio, che indugia a lungo sul tema
offerto da Aristide, sia addirittura un’interessata difesa delle pratiche omosessuali del
tempo considerate non illegali59. L’argomento presta il fianco a qualsiasi sviluppo ma è
lo stesso Libanio che, rispondendo ad Aristide, sembra comprendere che alla radice
della «femminilità» dei pantomimi c’è qualcosa di diverso, forse di più complicato, ma
che non riguarda la sfera sessuale. Si tratta di un’altra «qualità»: di questa però la
Molloy nemmeno si accorge.
Libanio non è molto diverso da Aristide: crede anche lui che l’interpretazione continua
della donna, il camminare e il fare gesti da donna, indossare i loro abiti, possa alla fine
indurre negli attori cambiamenti «di fondo». Tuttavia nello stesso modo in cui nota la
disciplina del corpo dei pantomimi, la loro attenzione a diete speciali, ai duri esercizi di
allenamento, ad un tenore di vita moderato, comprende che nel campo della
rappresentazione della donna c’è anche una speciale condotta che non ha a che fare né
con i comportamenti viziosi né tanto meno con il sesso degli attori. Non si tratta di
escludere a priori la possibilità di una condotta femminile quindi corrotta, quanto di
spostare i generi maschile e femminile dagli attori ai loro gesti: nella pantomima non
esistono attori maschi e femmine, bensì afferma Libanio uno stile femminile e uno
maschile, gesti maschili e gesti femminili :
66. Se la pantomima traesse ogni suo elemento dal solo stile femminile evitando quello maschile, e se
facesse dello stile femminile il suo unico interesse e la sua arte consistesse nell’imitare solo delle donne,
neanche in questo modo riuscirebbe a traviare un animo nobile: probabilmente sarebbe biasimata, con
58
Si guardi, solo perché ultimo in ordine d’apparizione, il volume di Senelick (2000) che riconduce il
problema al tema emergente del gender e del teatro femminista.
59
Libanio, sebbene avesse avuto un figlio da una concubina, non era sposato e per questo sono avanzati
sospetti di omosessualità anche nei suoi confronti (Molloy 1996, 93; l’ excursus è a pag. 106).
ragione, ma per non saper includere nella sua arte ogni possibile forma da imitare. Avremmo un
divertimento maggiore ma nessuna traccia di ignominia. Ma se la pantomima mostra ora uno stile ora
l’altro, con frequenti cambi, e prima di mostrare nettamente la donna fa vedere anche l’uomo, perché [o
Aristide] la spezzi in due, tralasci una sua componente e ne porti avanti solo l’altra, scavando un solco
tra i due modi di fare?60
Tutti i successivi passi dell’orazione ribadiscono in vari modi, non senza alcuni
tortuosi passaggi retorici, questo stesso motivo di fondo: il pantomimo interpreta
personaggi sia femminili che maschili, e pertanto mostra gesti di entrambi gli «stili»:
ora perché l’imitazione dei gesti femminili corromperebbe lo spettatore e quella di
gesti maschili no? Dunque agli attori delle tragedie e delle commedie è consentito
interpetrare personaggi maschili e femminili e i pantomimi, sapendo fare bene le stesse
cose, non sono autorizzati a farlo?
Quindi l’attore che entra nel ruolo di Plangone con maschera e costume e rappresenta la donna in tutto e
per tutto, cosa che è assolutamente possibile, non fa sprofondare il teatro in piaceri inconfessabili; se
invece un pantomimo muove solo una mano, i presenti andrebbero via colmi di mollezze e lui stesso
lascerebbe il palcoscenico nello stesso stato?61
[...] Eugenio Barba, studioso di antropologia teatrale, spiega:
[…] Il corpo è ricostruito per la finzione teatrale. Questo «corpo d’arte» – e quindi «non naturale» – non
è di per sé né maschio né femmina: a questo livello poco importa il sesso quotidiano dell’attoredanzatore. Non esiste un’energia tipica degli uomini, né un’energia tipica delle donne. Esiste solo
un’energia specifica di questo o quell’individuo. Compito di un’attore e di un’attrice è scoprire le
propensioni individuali della propria energia, proteggerne le potenzialità, l’unicità.62.
Questi due livelli dell’energia sono presenti in tutte le culture asiatiche. I balinesi
parlano di un intreccio di manis (dolce) e keras (duro). Gli indiani di lasya (delicato) e
tandava (vigoroso). Sono termini che non si riferiscono a donne e uomini o a qualità
femminili o maschili, ma a morbidezza e vigore come sapori dell’energia. Il dio
guerriero Rama, per esempio, è spesso rappresentato secondo la via «morbida» (lasya).
A livello di energia nella tradizione indiana si lavora all’interno della polarità
dell’energia e non della coincidenza tra personaggio e sesso dell’attore-danzatore: gli
stili della danza indiana sono infatti divisi in due grandi categorie, lasya (delicati) e
tandava (vigorosi) in base al modo in cui sono eseguiti i movimenti e non in base al
sesso dell’esecutore. Il mondo della danza indiana ha ripreso questi due versanti di una
stessa unità: non solo gli stili ma anche ciascun elemento di uno stile (movimento,
ritmo, costume, musica) se è forte, vigoroso, agitato è definito tandava, mentre se è
leggero, delicato e gentile è definito lasya. Pertanto, come nella maggior parte
dell’Asia, attori e danzatori interpretano i personaggi non tanto in base all’identità del
sesso ma con il modellamento dell’energia in una direzione ora forte ora delicata.
Così anche Libanio, che definisce la pantomima un movimento vigoroso degli arti e
che precisa che esistono gesti maschili e gesti femminili63, rende esplicita una pratica
di modellamento dell’energia, che i pantomimi romani sicuramente conoscevano: come
quel Menfi che danzava «Dafne come se fosse legno, e Niobe come se fosse pietra»64,
due personaggi femminili due diverse intensità. Non appartiene questa capacità di
plasmare l’energia al mistero dell’attore? Libanio sembra conoscere bene gli attori ma
60
Lib. Pro salt. 66 (Libanio 1908, 461).
Lib. Pro salt. 74 (Libanio 1908, 467).
62
Barba-Savarese 1997, 56.
63
Lib. Pro salt. 66 e 71 (Libanio 1908, 461 e 465).
64
Ant. Pal. 1, 255.
61
anche l’anima degli spettatori:
113. L’arte della pantomima, desiderosa che la mente sia attenta, spesso ferma la voce del coro che canta
e prepara con i gesti gli spettatori a capire quello che sta succedendo. Dare l’idea di Atena quando si
rappresenta Atena, e di Poseidone quando si rappresenta Poseidone, e così di Efesto, non è una gran
virtù: ma far venire in mente Poseidone rappresentando Atena, e Atena recitando Efesto, ed Efesto
attraverso Ares, e Zeus attraverso Ganimede e Paride tramite Achille, non è questa maestria a
conquistare l’anima più di qualsiasi altro tipo di mistero?65
Il fatto che uno stesso attore mostri il volto del personaggio che interpreta e sappia
anticipare l’espressione del suo interlocutore, è il segno di quanto l’arte della
pantomima potesse inoltrarsi nella mente e nel cuore dello spettatore.
5. L’arte di battere i piedi
Un’altra recriminazione avanzata da Aristide è quella che i musicisti di scena, quelli
che accompagnano i pantomimi-danzatori battendo il tempo con i piedi, non solo
«sfasciano il palcoscenico» ma causano un fastidioso baccano. Contesta Libanio: cosa
dovremmo fare, tagliargli un pezzo di piede come suggerisce Aristide? In questo
passaggio, davvero divertente, l’ironia di Libanio si dispiega interamente secondo le
regole della buona retorica: volendo confutare le tesi del benpensante Aristide, che mal
sopporta il chiasso dei teatri, Libanio ne porta alle estreme conseguenze
l’atteggiamento censorio e lo ridicolizza come assurdo e grottesco:
95. La proposta di Aristide, che ha convinto la maggioranza e che molta gente ha fatto già sua - ma
coloro che si precipitano a lodare non sempre poi capiscono perché l’hanno fatto -, ricorda la requisitoria
di un tiranno piuttosto che una testimonianza convincente. Infatti, citando coloro che partecipano agli
spettacoli «con i piedi», Aristide afferma che una parte del loro piede, quella che sporge dal sandalo,
dovrebbe essere eliminata. In nome degli dèi, e per quale ragione? Semplicemente perché hai deciso
così? Dunque, mentre sei un avvocato ti trasformi in giudice e, evitando di dimostrare che cosa costoro
hanno commesso, emetti già la sentenza che, se condannati, dovranno subire? Non continuare così, tira
fuori lo straccio di una prova. Tu sei l’accusa, la pena la decide qualcun altro. Ma secondo me, incapace
di dire in che modo «coloro che fanno rumore» sono causa di degenerazione morale, in mancanza di
prove, egli già ha stabilito la pena. 96. Affermi: «Costoro con i piedi sfasciano il palcoscenico». Quindi
sei dispiaciuto per quattro assi di legno: è questa l’accusa? Non vai molto d’accordo con i suoni forti?
Quindi coloro che al fronte colpiscono gli scudi con le spade e che, prima della battaglia, sconvolgono
gli animi mettendo paura - è giusto che gli si taglino le braccia secondo la lunghezza delle loro spade? E
coloro che servono gli dèi con i cembali - e spesso, anche lì, c’è un ruolo per i piedi - e coloro che
propiziano gli dèi con i timpani - come meritano di essere trattati? Quanto gli si deve tagliare? 97. I
danzatori hanno bisogno di suoni forti, caro mio, percussioni capaci di tener testa quanto occorre al coro
intero e che aiutino il loro ritmo. Ma con i soli piedi non c’è abbastanza fragore e quindi, per produrne di
più, è necessaria una striscia di ferro che sporga dal sandalo. Per questa ragione, allora, priveresti i
danzatori dei loro piedi e ti ispiri all’antica barbarie che suggerisce il taglio del piede, proprio come
alcuni raccomandano il taglio delle mani o piuttosto, con lo stesso ragionamento, delle mani e delle
teste: insomma tagliare tutte le mani che portano sonagli, dato che cercano qualcosa di più che i suoni
prodotti solo dalle mani, e poi magari tagliare tutte le teste perché indossano un elmo con le piume? 98.
Continuerai poi dando un’accorciatina agli attori tragici segandoli alle ginocchia, poiché si arrampicano
sugli alti coturni e fanno in modo di alzarsi al di sopra degli altri. Allora non ti rimane che seppellire
vivo il trombettiere, dato che nessuna parte del suo corpo, e neanche il corpo tutt’intero, misura quanto
una tromba. E tralascio tutte quelle cose come l’arco, la freccia, il giavellotto, la lancia, il piccone,
l’aratro che farebbero mutilare coloro che li usano, se prevalesse la tua opinione. Insomma, se nelle
attività in cui gli uomini fanno uso di attrezzi si dovesse tagliare dal corpo un pezzo equivalente alla
lunghezza degli strumenti da loro usati, alcuni subirebbero la morte di Ippoloco66 ma altri, se non
65
Lib. Pro salt. 113 (Libanio 1908, 493).
Ippoloco, figlio del troiano Antimaco, fu ucciso da Menelao che gli tagliò il braccio libero dallo scudo
( Il. 11, 145).
66
ritardassero la propria punizione, diventerebbero uguali ai figli di Aloeo67: così arriveremo a infliggere
una pena perfino alle macchine che si portano sotto le mura assediate. Non vedi la strana piega che
prende la faccenda per questa tua semplice irritazione contro i sandali ferrati?»
Di tutti i risentimenti contro la danza - caratteristici di una visione tipicamente ostile
verso «le libertà» del corpo del danzatore - quest’ultima censura nei confronti del
«battere i piedi» sembra però più bizzarra delle altre. Erano i musicisti così pesanti
nella loro azione scenica da pestar forte sul palco fino a demolirlo? Sappiamo che
aiutandosi con uno speciale sandalo a doppia suola battente - quello strumento
chiamato dai greci kroúpeza e dai romani scabillum o scabellum - i musicisti
favorivano il danzatore nel tenere il ritmo. Esistono numerose testimonianze di questo
strumento, come il noto satiro degli Uffizi che danza battendo e aiutandosi con i
cembali. Ma in particolare un mosaico dell’Aventino del III sec. d.C.68, illustra bene
questa funzione in cui un musicista, suonando anche una tibia, scandisce il tempo con
un sandalo dalla doppia suola battente, mentre una danzatrice balla, aiutandosi a sua
volta con dei crotali. Dunque sappiamo di che si tratta. Ma proprio da questa
indicazione sul «battere i piedi», per l’esagerata reazione di fastidio che provoca,
possiamo intravedere una caratteristica tecnica della danza-pantomima romana: in dati
momenti, quando il cantore taceva, o forse tutto il tempo, nel pieno dello spettacolo, la
danza del pantomimo era un’azione che inseguiva il tempo offerto da un musicista che
batteva i piedi sistematicamente e rumorosamente tanto da sollevare le lamentele di
uno spettatore. Luciano sottolinea come fosse grave difetto di un pantomimo danzare
fuori tempo. Possiamo supporre una pantomima senza ritenere che anche i piedi del
danzatore, per inseguire il tempo-ritmo del musicista, a loro volta non battessero? E se
possiamo dire che «battere i piedi» sia il grado zero di quasi tutte le forme di danza, e
talvolta anche il grado zero di descriverle, è anche vero che il fatto in sé di «battere i
piedi» costituisce anche un dato tecnico. E dunque, conosciamo danze che «battono i
piedi» sistematicamente e fragorosamente?
La prima danza di questo tipo che viene in mente è senza dubbio il flamenco: si tratta
di una moderna danza spagnola, ma di derivazione orientale moresca e araba, nella
quale i ballerini battono i piedi muniti di scarpe chiuse e con i tacchi. Taconear è uno
dei verbi del flamenco. Un’altra danza in cui il danzatore ritma da solo il proprio tempo
con i piedi calzati è il tip-tap . Diffuso dall’Irlanda agli Stati Uniti, conosciuto in
Germania col nome di steptanz, il tip-tap per accentuare il battito faceva uso di zoccoli
di legno poi divenuti scarpe speciali munite di rinforzi di ferro: e sotto questa forma il
genere viene tramandato da quasi tutti i film musicali americani. Ma sappiamo che i
pantomimi romani non avevano scarpe: in genere avevano i piedi nudi (planipedes, per
l’appunto, senza scarpe) oppure portavano sandali assai leggeri che permettevano il
dispiego di tutta la loro agilità in movimenti ampi, saltelli, acrobazie. Lo stesso sandalo
rumoroso, accusato da Aristide e citato da Libanio, è un sandalo leggero a cui
l’appendice ferrata era stata probabilmente applicata: il testo di Libanio dice infatti
blaúte, letteralmente sandalo leggero, e non kroúpeza, la calzatura-strumento.
Ora sappiamo che le danze greche e romane erano per lo più eseguite a piedi nudi o
con calzature leggere e dunque anche quella della pantomima non doveva sottrarsi a
questa regola. Potrà sembrare strano, ma è difficile avere ragguagli su questo dettaglio
del piede nudo o calzato nella danza antica come nella pantomima: per fortuna esistono
67
Cioé sarebbero fermati all’inizio. I giganti Oto ed Efialte, figli di Poseidone e di Ifimedia, ma creduti
figli del gigante Aloeo, tentarono di porre il monte Ossa sopra l’Olimpo e il monte Pelio sull’Ossa ma
furono distrutti da Apollo prima di diventare adulti (Od. 11, 310).
68
Ora al Museo Pio Clementino, in Vaticano.
inequivocabili immagini sui vasi, negli affreschi e come di statuine di bronzo o di
terracotta. Non abbiamo invece nessuna difficoltà a reperire esempi di danze codificate
a piedi nudi, tutt’ora visibili, in altre culture antiche originarie: per esempio tutte le
danze classiche dell’India e quelle del Sud-Est asiatico, si fanno a piedi nudi e nei teatri
di Cina e Giappone dove il piede è calzato, l’attore-danzatore indossa pianelle leggere
o addirittura solo delle calze speciali (come i tabi del No e del Kabuki). Tra queste
danze, quelle che più usano battere sistematicamente i piedi per tenere il ritmo sono
quelle dell’India: il Kathakali, il Baratha Natyam, l’Odissi, il Katak sono danze in cui
la caratteristica del danzatore è proprio quella di seguire il ritmo dei musicisti che li
accompagnano, battendo i piedi e facendo risuonare una cavigliera di sonagli, mentre il
corpo, le braccia e le mani si dedicano ad una serie di figure. Esiste addirittura una
forma di danza del Sud dell’India chiamata chavittu natakam che letteralmente vuol
dire «danza del battere i piedi»69.
Non sembri strana questa escursione indiana: non si tratta di stabilire semplici
comparazioni, anche se tutte queste danze indiane avevano, e hanno ancora, come
accompagnamento esattamente lo stesso tipo di strumenti musicali squillanti dei
pantomimi romani: flauto, cembali e tamburi. Non si tratta di stabilire riscontri
stilistici, quanto di innescare quella che ho definito la «fantasia plausibile»70.
Indiscutibilmente non si può interpretare se non si conosce bene la filologia, l’arte di
rimettere insieme i frammenti attraverso le forme precedenti, le testimonianze
archeologiche e letterarie, la storia e il contesto. Ma nel caso di forme dinamiche come
quelle realizzate tramite tecniche del corpo, non si può neanche interpretare se non si
ha un’immaginazione, una «fantasia plausibile» che aiuti a visualizzare gli aspetti
concreti della pratica scenica osservata con altre pratiche simili sebbene distanti nel
tempo e nello spazio. Così il passo di Libanio, pur nella sua retorica da tardo impero,
arriva a sancire una realtà del teatro imprevista dallo stesso autore: il corpo del
pantomimo è uno strumento che non può essere tagliato fuori dalla sua arte. Per inibire
un attore non basta strappargli la maschera, il costume o gli accessori: ci vuole ben
altro. Occorre eliminargli i piedi:
117. E per quanto riguarda il movimento, quale anziano non si sentirebbe più vecchio o quale pigro non
vincerebbe la sua indole, rapito dai salti di un danzatore? E a proposito della velocità, è più ragionevole
paragonare i volteggi dei pantomimi a un pensiero, a un’ala o alle navi dei Feaci? Rammenta: è
impossibile osservare nei dettagli ogni azione dei pantomimi perché il loro corpo, troppo veloce, diventa
di continuo un’altra cosa. Ognuno di loro è quasi come Proteo, il dio egiziano che si trasforma sotto gli
occhi. Diresti che la bacchetta di Atena, che trasformò l’aspetto di Odisseo, faccia assumere ai
pantomimi ogni sembiante: vecchi, giovani, umili, potenti, tristi, allegri, servi, padroni... E per quanto
riguarda i loro piedi, ci si potrebbe perfino domandare se possano vincere il velocissimo Perseo. 118. Si
ammira di più la continuità e il numero dei loro volteggi, o l’improvvisa immobilità che segue e la figura
che prendono in questa posizione? Perché essi piroettano come se avessero ali ma finiscono immobili,
come incollati a terra: e con la posizione finale si presenta il quadro. E tanto grande è l’interesse che
hanno per il ritmo che un’altra gran prova della loro maestria è quella di fermarsi contemporaneamente
al canto. Il piacere che in questo modo offrono a intere città non causa proprio nessuna rovina71.
BIBLIOGRAFIA
69
È una forma di teatro-danza del Kerala del XVI sec. che sembra risalga all’ingresso delle comunità
cristiane nella regione e pertanto basato su storie anch’esse d’origine cristiana (Brandon 1993, 85).
70
Mutuando da Martin Bernal il quale afferma che nel formulare ipotesi non si deve ragionare e
giudicare in termini di prove ma in base ad una plausibilità competitiva : «tutto quello che si può sperare
di trovare è maggiore o minore plausibilità» e la maggiore plausibilità deve essere scelta per il fatto che
offre «un contesto più proficuo per la ricerca futura» (Bernal 1994, I, 4).
71
Lib. Pro salt. 117, 118 (Libanio 1908, 496-97).
- Albini (1997), U., Il mimo a Gaza tra il V e il VI sec. d.C.,Studi Italiani di Filologia Classica 15/1,
116-122.
- Anastasi (1981), R., Libanio e il mimo, in La poesia tardo antica: tra retorica, teologia e politica, Atti
del V Corso della Scuola Superiore di Archeologia e Civiltà Medievali, Erice (Trapani) 6-12 dicembre
1981, Centro di Studi Umanistici, Messina 1984, 235-58.
- Awasthi (1988), S., Arti marziali e rappresentazioni tradizionali. Il panorama asiatico, in Festival di
Chieri 1988, Torino, Rosemberg E Sellier.
- Barba (1997), E. - Savarese, N., L’arte segreta dell’attore. Un dizionario di antropologia teatrale,
Lecce, Argo.
- Beare (1986), W., I Romani a teatro, Bari, Laterza.
- Benz (2000), L., Mimos. II. Römisch. A. Geschichte. B. Charakter. C. Mimographie und
Lexikographie, in Der Neue Pauly .Enzyklopädie der Antike, Hubert Cancik - Helmuth Schneider edd.,
Verlag J.B. Metzler, Stuttgart - Weimar, VIII, 205-207.
- Bernal (1994), M., Atene Nera. Le radici afroasiatiche della Civiltà classica, Pratiche Editrice, Parma,
2 voll.
- Bieber (1961), M., The History of the Greek and Roman Theater, Princeton University Press, Princeton
(N.J.).
- Brandon (1993) ed., J.R., The Cambridge Guide to Asian Theatre,Cambridge University Press,
Cambridge.
- Daremberg-Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, Hachette, Paris.
- De Marinis (1993), M., Mimo e teatro nel Novecento, Usher, Firenze.
- Downey (1961), G., A History of Antioch in Syria from Seleuces to the Arab Conquest, Princeton
University Press, Princeton.
- Freis, C., Kathakali and Greek Drama (sito: Didaskalia dell’Università di Warwick).
- Garton (1972), C., Personal Aspects of the Roman Theatre, Hakkert, Toronto.
- Gentili (1977), B., Lo spettacolo nel mondo antico, Laterza, Bari.
- Graux (1877), Ch., Chorikios: Apologie des mimes,Revue de Philologie 1, 212-247.
- Jory (1981), E.J., The literary evidence for the beginnings of imperial pantomime,Bulletin of the
Institute of Classical Studies 28, 147-161.
- Jory (1996), E.J., The Drama of the Dance: Prolegomena to an Iconography of Imperial Pantomime,
in Roman Theater and Society. E. Togo Salmon Papers I, ed. by W.J. Slater, University of Michigan
Press, Ann Arbor (Mich.), 1-27.
- Kokolakis (1959), M., Pantomimus and the treatise Peri Orcheseos,Platon 10, 3-56.
- Lawler (1954), L.B., Phora, Schema, Deixis in the Greek Dance,TAPA 85, 148-158.
- Lawler (1964), L.B., The Dance in Ancient Greece,Wesleyan University Press, Middletown (Conn.).
- Leppin (1992), H., Histrionen, GMBH, Bonn.
- Libanio (1908), Libanii Opera. Orationes LI-LXIV, a cura di R. Foerster, Lipsiae, Teubner.
- Luciano (1877), Luciani Samosatensis Opera, a cura di C. Iacobitz, Lipsiae, Teubenr, vol. 2.
- Luciano (1992), La danza, a cura di S. Beta, Venezia, Marsilio.
- Martin ed. (1979), J., Libanius, Orationes Discours, Les Belles Lettres, Paris, 2 voll.
- Molloy (1996), M.E., Libanius and the Dancers, Olms - Weidmann, Hildesheim - Zürich - New York.
- Norman (1965), A.F., Libanius Autobiography, Or. I, Oxford University Press, Oxford.
- Petit (1866), L. Essai sur la vie et la correspondence du sophiste Libanius, A. Durand, Paris.
- Petit (1956), P., Libanius et la vie municipale à Antioche au Ivème siècle ap. J.C., XXX, Paris.
- Rotolo (1957), V., Il pantomimo. Studi e testi, Presso l’Accademia, Palermo.
- Savarese (1988), N., Apprendistato di un attore cinese alla fine del XIX secolo,Teatro e Storia 4, 146155.
- Savarese (1996), N., Parodossi dei teatri romani, in I teatri romani, a cura di N. Savarese, Il Mulino,
Bologna.
- Savarese (2000 5), N., Teatro e spettacolo tra Oriente e Occidente, Laterza, Roma.
- Savarese (2002), N., Il teatro eurasiano, Laterza, Roma.
- Schouler (1984), B., La tradition Hellenique chez Libanios, Atelier National Reproduction des Theses,
Université Lille III, Lille - Les Belles Lettres, Paris, 2 voll.
- Senelick (2000), L., The Changing Room. Sex, Drag and Theatre, Routledge, New York.
- Scrittori (1983), Scrittori della Storia Augusta, a cura di P. Soverini, UTET, Torino.
- Slater (1994), W.J., Pantomime Riots,Classical Antiquity 13/1, 120-144.
- Tantillo (2001), I., L’mperatore Giuliano, Roma-Bari, Laterza.
- Taviani (1990), F., Lettera su una scienza dei teatri,Teatro e Storia 9, 171-197.
-Teatri greci e romani. Alle origini del linguaggio rappresentato. Censimento analitico, a cura di P.
Ciancio Rossetto – G. Pisani Sartorio, Edizioni Seat, Roma 1994–96, 3 voll.
- Zarrilli (1993), P.B., a cura di, Asian Martial Arts in Actor Training, Center for South Asian Studies,
Madison (Wisc.).
- Zucchelli (1965), B., Le denominazioni latine dell’attore, Paideia, Brescia.
- Zucchelli (1995), B., Mimus halucinatur…: il teatro-spettacolo del II sec., in Storia letteratura e arte a
Roma nel secondo secolo dopo Cristo,Atti del Convegno - Mantova 8-10 ottobre, Olschki, Firenze, 295319.
- Wuest (1949), E., Pantomimus, Pauly-Wissowa, Realencyclopaedie XVIII, 3, 833-69.
SITOGRAFIA
perso.club-internet.fr/pemaloss/index.htlmLitarba (tutto su Libanio curato da Pierre-Louis Malosse).
Luigi Allegri
Teatro e spettacolo nel Medioevo
Bari, Laterza 1988, pp. 80-109
Capitolo secondo
I GIULLARI:
CONDIZIONI E MODI DELLO SPETTACOLO
Ormai l’accordo tra gli studiosi è praticamente unanime: l’unico filo di continuità, sul piano
della pratica e non della memoria del teatro, tra lo spettacolo romano e quello medievale, non è
costituito certo dal repertorio dei testi e dunque dalla letteratura teatrale, ma dall’attività degli attori.
Nessun dubbio dunque che l’attore medievale, nelle sue diverse determinazioni fino al giullare,
discenda in modo diretto e senza fratture dagli istrioni tardo-antichi, secondo una ricostruzione
storica che era già del vecchio Petit de Julleville, oltre un secolo fa:
L’interruzione del repertorio comico era assoluta: ma lo era anche nella derivazione degli attori?
Se la farsa quando rinasce non deve niente a Plauto, i giullari, questi più antichi attori dei
Medioevo, non erano gli eredi diretti degli istrioni e dei mimi romani? [...] Razza imperitura e, sotto
venti nomi diversi, sempre simile a se stessa, ha attraversato dieci secoli senza molto modificare né
i propri costumi né la propria fisionomia.1
Il quesito che ha animato il dibattito tra gli studiosi è stato invece un altro: questa dai mimi
romani è l’unica linea di discendenza riconoscibile nei giullari, oppure occorre individuarne un’altra
nella tradizione attorica delle culture barbare, quella degli scaldi islandesi e norvegesi e soprattutto
degli skops anglosassoni? Gautier, De Bartholomaeis e Faral, ad esempio, ritengono unica la
derivazione romana, tanto che quest’ultimo arriva ad ipotizzare una azione inversa, per cui
sarebbero gli attori di discendenza tardo-romana ad influire sugli skops, obbligandoli ad una
mutazione antropologica che porterà alla loro scomparsa: sarebbe accaduto cioè che gli attori
barbari, che erano soprattutto cantori epici con un ruolo sociale molto più alto e dignitoso dei loro
colleghi proto-giullareschi, per contrastare l’invadenza ed il crescente successo di questi ultimi, si
siano fatti giullari essi stessi, adottandone le tecniche basse e dunque degradandosi socialmente fino
a scomparire come categoria autonoma.2
Chambers o Menéndez Pidal, invece, e più recentemente Zumthor, danno credito alla doppia
discendenza, sia pur con argomentazioni differenti. Zumthor, in realtà, dandola come per scontata3;
Chambers deducendo da questa duplice paternità la doppia natura del giullare medievale che, in
quanto figlio del mimo romano, è turpe, socialmente degradato e portatore di tecniche basse, e in
quanto figlio dello skop anglosassone è invece cantore e poeta e dunque socialmente e
culturalmente più accreditabile4; e Menéndez Pidal affidandosi in certo modo al buon senso:
se il giullare ha, tra le sue altre attività, quella di cantare le gesta epiche della nobiltà barbara,
viaggiando di castello in castello, pare naturale che per questo aspetto derivi dai cantori barbari che
viaggiavano di corte in corte, cantando come autori o come semplici recitatori narrazioni eroiche,
sconosciute ai romani; è impossibile credere che la vita signorile del Medioevo, che contiene tanti
elementi di origine germanica, non debba per quanto riguarda i giullari nulla ai costumi degli
1
Petit de Julleville, 1889, p. 17.
Gautier, 1892, lI, p. 6; Faral, 1910, pp. 4-9 e 23; De Bartholomaeis, 1924, p. 22.
3
Zumthor, 1986, p. 4.
4
Chambers, 1903, I, pp. 65-69.
2
invasori, dato oltretutto che sappiamo che dal VI secolo al tempo di Carlomagno quei poeti e
cantori barbari percorrevano le corti dell’Europa occidentale convivendo coi mimi e con quelli che
già erano i nuovi giullari.5
Ed è questa, credo, l’ipotesi più probabile. Purché sia chiaro che, alla fine di quel processo di
omogeneizzazione culturale che ha portato alla riconoscibilità di una cultura medievale
riscontrabile con pochi scarti nelle società almeno dell’Europa occidentale, anche la mescolanza tra
le due tradizioni attoriche è ormai compiuta. Dunque, quando i giullari sono a pieno titolo tali,
dall’XI-XII secolo in poi, le distinzioni, salvo casi particolari, sono di gerarchia all’interno di questa
unica categoria, che è il prodotto finale del processo. Non mi sembra condivisibile insomma la tesi
secondo cui, semplicisticamente, il giullare colto che si risolverà nel trovatore discende in linea
diretta dal cantore barbaro mentre il giullare circense viene dal mimo romano, perché prima si è in
realtà compiuto un generale rimescolamento di pratiche attoriche e di ruoli sociali che ha ricondotto
in sé e dunque in qualche modo azzerato le due tradizioni precedenti.
Piuttosto, in quest’epoca, mi paiono da tenere in conto maggiore di quanto generalmente non si
faccia quelle influenze diverse, che Menéndez Pidal ha avuto modo di constatare nel contesto
culturale che più lo interessa, quello iberico, ma che sono operanti anche in altre zone d’Europa,
cioè quelle tartare, ebraiche e soprattutto musulmane6. Nelle corti spagnole del XIII secolo, ma
anche in quella siciliana, i rapporti reciproci tra attori cristiani e attori mori sono intensi: basti
pensare, ad esempio, che tra i giullari al servizio della corte di Castiglia, nel 1293, uno era ebreo, 12
erano cristiani e ben 13 erano musulmani7. Nel concreto, non siamo in grado di stabilire con
sicurezza il contributo di queste diverse tradizioni alla formazione del repertorio e del bagaglio di
tecniche del giullare cristiano, ma è probabile che l’attività principale degli attori musulmani sia
quella di musici, cantanti e soprattutto danzatori, sia che si tratti di uomini che, come sovente
accade, di donne.
Ma quello del rapporto tra peculiarità culturali regionali e possibilità di generalizzazione, per
quanto riguarda specificamente i giullari, è discorso da affrontare in modo non tangenziale. È
evidente anche da questi esempi che, soprattutto per le epoche meno remote per le quali possediamo
una maggiore documentazione, la figura del giullare si colora di caratteristiche particolari secondo
la zona e dunque il contesto politico e sociale in cui opera, e perciò le influenze che si esercitano su
di lui. Così appunto il giullare iberico può interagire più di ogni altro con quello musulmano o
ebreo, mentre ad esempio il giullare francese è l’esecutore primario delle canzoni di gesta. Ma
l’aspetto che non bisogna sottovalutare è quello della permeabilità delle culture locali, in un
processo di scambio reciproco di cui proprio i giullari sono forse l’elemento più attivo.
Da un lato, infatti, è proprio la relativa universalità delle tecniche di base dell’attività giullaresca
— la musica, la danza, i giochi — a rendere esportabili questi spettacoli anche al di fuori
dell’ambito culturale in cui sono nati. Dall’altro lato, poi, il nomadismo è caratteristica fondante
della giulleria, e i giullari infatti viaggiano molto, al seguito di qualche signore o attirati dalle
occasioni festive che possano servire da contesto alle loro esibizioni, come ad esempio le corti
bandite, e traversano così confini geografici, politici e culturali, esportando tecniche, temi, formule
letterarie e musicali. In tal modo, ad esempio, i giullari francesi portano le canzoni di gesta in
Spagna, specie lungo il cammino di Santiago, accompagnando i pellegrinaggi verso Santiago di
Compostela, e consentono in tal modo anche ai giullari spagnoli di assumere le stesse tecniche e gli
stessi temi, magari con l’introduzione di personaggi iberici nelle vicende cantate. Oppure esportano
le vicende di Orlando e dei paladini, e l’abilità di raccontarle, in Germania o in Italia, favorendo
anche da noi l’interesse e la passione per quei temi di cui resta traccia ad esempio nella decorazione
plastica della Cattedrale di Modena ma anche in alcuni documenti. Nel 1288 si registra ad esempio
5
Menéndez Pidal, 1957, p. 7.
Ivi, pp. 7-8 e 95-98. Per le danzatrici saracene alla corte siciliana, Meldolesi, 1973, pp. 41-42 e 50.
7
Menéndez Pidal, 1957, p. 97.
6
l’interdizione ai giullari francesi a far spettacolo nelle piazze di Bologna, forse come conseguenza
di quella condanna all’infamità ipso jure pronunciata qualche decennio prima dal giurista Odofredo
nei riguardi dei cantori di gesta professionisti che evidentemente a Bologna erano popolari. Ma
ancora più interessante, perché ci fornisce anche un quadro delle modalità approssimative con cui a
forza di tramutazioni e deformazioni successive arriva al popolo lo spettacolo di questi cantori di
gesta — giunti evidentemente in Italia al seguito dei pellegrini in viaggio verso Roma ma poi
adattatisi a cantare anche per i pubblici italiani —, è una epistola in latino di Lovato dei Lovati,
circa della fine del XIII secolo:
Passeggiavo a caso per la città ricca d’acque sorgive che prende nome dai tre ‘vici’ [Treviso],
ingannando il tempo col camminare senza fretta, quando scorgo su un palco in piazza un cantore
che declama le gesta di Francia e le imprese militari di Carlo. Pende il popolino intorno, intende le
orecchie, affascinato da quel suo Orfeo. Ascolto in silenzio. Egli con pronuncia straniera deforma
qua e là la canzone composta in lingua francese, tutta stravolgendola a capriccio senza curare filo di
narrazione né arte di composizione. E tuttavia piaceva al popolo. 8
Il nomadismo istituzionale è dunque una caratteristica fondante del giullare come categoria. Il
topos del giullare giramondo, alla continua ricerca di un nuovo pubblico o di un signore più
munifico, è presente in tutte le descrizioni, a partire dalle prime generazioni di giullari identificabili
con un nome — d’arte naturalmente —, come quel guascone del XII secolo che assume il nome
indicativo di Cercamon e che appunto ritroviamo attivo in Spagna. Ma il nomadismo del giullare —
beninteso al di fuori di quelle forme di stanzialità che, come vedremo, lo trasformeranno in
menestrello e in parte ne cambieranno natura e funzioni — non è che uno dei termini di una
costellazione solidale di valori, o forse meglio di disvalori, che caratterizzano il ruolo sociale degli
attori. Nomadismo, infatti, significa instabilità, e instabilità vuol dire festa9: il denominatore
comune di questa costellazione di termini è dunque lo spiazzamento, l’essere continuamente e
istituzionalmente fuori posto.
Intanto, come si è ampiamente sottolineato nel capitolo precedente, il giullare non ha ruolo
sociale: come persona, come soggetto produttivo dunque non esiste, non ha identità. L’unica sua
esistenza è su un piano altro rispetto a quello produttivo, ed è il territorio dello spettacolo e della
festa. Per questo, spesso, l’unica identità che gli è concessa e con la quale è conosciuto anche da
noi, è un’identità fittizia, un nome che non designa una persona ma un’attività, il nome d’arte. Certo
non si tratta di una regola fissa, perché a volte il giullare mantiene il proprio nome di battesimo,
magari a volte con l’aggiunta della sua qualifica, come ad esempio Boudec le Tabourer, Ricardo
Citharistae o Janyn le Citoler, ma è la diffusione del nome d’arte a dare il segno vero del rapporto
del giullare con la propria identità sociale. È un nome, questo, che non ricopre un essere concreto
ma un vuoto d’identità, che spiazza il soggetto dal territorio economico-sociale a quella dimensione
ludica che da questo territorio è fuori, e di cui è evidente testimonianza l’intenzione auto-ironica e
immediatamente connotante che il giullare gli assegna. Quando non lo identifica metonimicamente
col proprio strumento, come Citola o Cornamusa, il nome d’arte consegna infatti con chiarezza il
giullare all’universo metaforico di chi si designa non con un nome ma con una funzione, uno stato
d’animo, una situazione particolare. Dolcibene, Malanotte, Maldecorpo, Aenvistevoi, Clarinus,
Malapareillez, Pelez, Quatuorova, Passerellus, Sauvache, Simples d’amors, Cercamon, Marcabru,
Alegre, Saborejo, Pedro Agudo, Bon amis, Corazón, Maria Sotil, Graciosa, Preciosa, Reginaldo Le
8
Si vedano testo e traduzione in Roncaglia, 1965, pp. 736-37. Sui cantori di gesta a Bologna,
Muratori, Antiquitates Italicae Medii Aevi, lI, col. 844, e Levi, 1914, p. 6. Sulla diffusione dei
cantori di gesta in Italia, Farai, 1910, pp. 261-62.
9
Zumthor, 1986, p. 16.
Menteur, Perle in the eghe, Guillaume sans manière: ecco alcuni nomi di giullari, di epoche diverse,
citati quasi a caso tra quelli di cui resta traccia tra Italia, Francia, Spagna, Inghilterra 10
La dimensione metaforica del nome d’arte è tanto lampante che, come ci tramandano diverse
testimonianze tra cui un aneddoto molto citato, facendo scivolare questo nome sul piano dei
rapporti sociali, allo stesso modo che prendendo alla lettera una metafora, si ottengono effetti
grotteschi. È il caso degli scherzi giocati ai giullari da Guidoguerra e riportati da Boncompagno da
Signa:
Gli istrioni di tal sorta s’impongono nomi scherzosi, sia per acquistar notorietà con nomi fuor
dell’ordinario o per trarre dal proprio nome materia di scherno e per trar l’uditorio alle risa. E così
Guidoguerra, conte palatino di Toscana, con l’interpretazione di siffatti motti, beffò molti giullari.
Uno aveva in volgare tal nome che letteralmente significava Pica: e lo costrinse a salir su un albero
per volare. E così pure due eran venuti insieme da lui, l’uno che si chiamava Malanotte e l’altro
Maldecorpo. E perciò lasciò nudo sul tetto quel che si chiamava Malanotte e mentre nevicava e
soffiava all’incontro il vento di tramontana; fece poi distendere Maldecorpo ignudo fra due fuochi e
gli fece fregare il corpo con sugna di maiale fintantoché disse forte: sono liberato del tutto.
Similmente un giullare si chiamava Abbate: e perciò gli fece radere tutto il capo lasciandogli solo
una coroncina di capelli. 11
Dunque quest’uomo che spesso non ha un nome se non per metafora, che non ha un luogo fisso
di stazionamento, che non ha uno spazio deputato in cui compiere il proprio lavoro, che non ha un
posto né nel sistema economico e produttivo né di conseguenza in quello dei ruoli sociali e delle
gerarchie di valori, è costretto ad essere sempre fuori luogo, ad essere sempre altro rispetto al
contesto con cui entra in contatto. Non c’è posto, come s’è visto nel capitolo precedente, per il
giullare nel sistema simbolico della società e dunque non c’è un ruolo sociale e uno spazio reale in
cui sia possibile collocarlo: e per questo, nella vita quotidiana e concreta, il giullare è sempre ospite
di qualcuno, occupa sempre precariamente e temporaneamente uno spazio altrui, nel quale viene a
collocarsi geograficamente come uno straniero e socialmente come un diverso. 12
Diverso innanzi tutto per l’aspetto fisico, che deve immediatamente marcare, al solo sguardo,
l’estraneità del giullare ai parametri della quotidianità. Così, soprattutto in Francia, si rade la barba e
i capelli, e in generale prende a vestirsi in modo anomalo, molto vistoso, specie con quell’abito di
seta vergata, di due colori accostati nel senso dell’altezza, che ne diventa l’abbigliamento
caratterizzante. In questo modo il giullare compie un’operazione analoga a quella con la quale si
sceglie un nome d’arte, rifiutando cioè quell’identità sociale che l’abito da sempre assegna al
proprio portatore, e che del resto per il suo caso non è prevista. Così anche per questa via si
autoconsegna al territorio degli emarginati, assumendo un’identità vestimentaria fittizia che lo
colloca in un universo spiazzato e spiazzante in cui convive col classico rappresentante di chi è
senza identità, il matto, col quale spesso tende a confondersi. E questa diversità istituzionale, il
giullare la manterrà anche quando si troverà stabilmente al servizio di un signore, intruppato in una
squadra di addetti ai divertimenti per i quali è prevista una vera e propria divisa, che ne segni a un
tempo l’appartenenza alla categoria professionale e alla scuderia del suo padrone. 13
10
Chambers, 1903, 11, pp. 234-58; FaraI, 1910, p. 312; Menéndez Pidal, 1957, p. 4. Per un corposo
elenco di nomi e di specializzazioni, soprattutto musicali, desunti da un documento inglese degli
inizi dei XIV sec., si veda Bullock-Davies, 1978.
11
La traduzione qui utilizzata è quella che del brano dà Apollonio, 1981, p. 101. Si veda il testo
latino di Boncompagno, che è del 1218 circa, in Faral, 1910, p. 305.
12
Istrioni, giullari e stranieri sono messi sullo stesso piano e assoggettati alla medesima normativa
limitante ad esempio in uno statuto di Goslar del 1219: Le Goff, 1983, p. 345.
13
Menéndez Pidal, 1957, p. 5.
Ma diverso il giullare è anche in quanto portatore di tecniche e soprattutto di una modalità di
dispendio improduttivo del tempo e dell’azione che sono incompatibili con le strutture della
quotidianità e che possono essere coerenti solo con un luogo ed un tempo già a loro volta spiazzati
rispetto a quelli della quotidianità, cioè con la situazione festiva. Che ha poi, naturalmente, un
amplissimo spettro di possibilità concrete, dalla microfestività anche giornaliera del momento del
pranzo del signore, alla festa popolare, alla macrofestività delle grandi occasioni o ricorrenze
dinastiche. In tutti questi casi il giullare può portare la propria attività, dalla forma minima che lo
vede allietare col canto e con la musica un banchetto in un giorno qualsiasi, avendo per compenso
solo di sedersi a quella tavola, alle grandiose occasioni che lo vedono concorrere con centinaia o
migliaia di suoi colleghi ai grandi avvenimenti.
Sempre relegato in un altrove spaziale e sociale — e si pensi, come estremo di questo
meccanismo, addirittura all’altrove temporale in cui lo colloca Ugo di San Vittore — il giullare
patisce naturalmente la mancanza di luoghi reali e simbolici che gli siano propri, ma proprio per
questo ha il privilegio di poter percorrere trasversalmente i territori della società medievale, che per
gli altri soggetti, dotati invece di spazi e ruoli, sono rigidamente determinati. Così, come s’è detto, il
giullare attraversa confini geografici e politici, toccando paesi e culture lontane e irraggiungibili per
gli altri uomini di qualsiasi condizione; così attraversa confini sociali all’interno della stessa
comunità, facendo spettacolo indifferentemente per il popolo, per i borghesi ricchi, per i signori, per
i vescovi; così infine, e ciò che è per tanti versi più stupefacente in una società rigida come quella
medievale, egli stesso come soggetto sociale attraversa le barriere di classe, sia quando da chierico,
da borghese o addirittura da nobile si fa giullare e dunque emarginato, sia quando compie il tragitto
inverso divenendo attraverso donativi ricco possidente quando non feudatario. 14
Per queste ragioni il giullare, privo di luoghi istituzionali, diviene egli stesso un luogo
istituzionale, la sede in cui trovano posto una pratica e un meccanismo simbolico che fanno parte a
pieno titolo della cultura medievale, quelli del viaggio, dello spostamento. Più del pellegrino, che
spesso è tale solo contingentemente e non come categoria sociale, più del soldato che se pure si
sposta non ha nel viaggio l’elemento primario che lo definisca, il giullare è l’espressione simbolica
e il veicolo concreto della mobilità e dello spostamento come valore non secondario della cultura
medievale. Non stupirà, allora, rintracciare forme di istituzionalizzazione di questa funzione sociale
conquistata proprio viaggiando tra gli interstizi dei ruoli sociali altrui, da un lato con la
consuetudine, ampiamente documentata, di assegnare ai giullari compiti di ambasciatore, sia come
semplici latori di messaggi sia anche come incaricati di trattative 15. E dall’altro con la prassi delle
lettere di presentazione, che costituiscono appunto il trait d’union tra un luogo e l’altro dell’operare
del giullare. Per queste lettere esistono addirittura precisi formulari, di cui ci sono state tramandate
diverse redazioni, che costituiscono una testimonianza indiretta ma decisiva insieme del
riconoscimento, sia pure informale, della professionalità specifica degli attori, e del loro nomadismo
istituzionale. In alcuni casi si tratta di lettere di raccomandazione molto dettagliate, che specificano
con cura l’abilità o la specializzazione del singolo giullare, altre volte i formulari sono costruiti per
presentare un operatore appartenente a una categoria determinata (danzatore. suonatore d’arpa o di
viola, imitatore del canto degli uccelli o del verso degli animali, ecc.), altre volte infine sono del
tutto generici come questo, tratto dal trattato di Boncompagno:
14
Si vedano ad esempio i casi citati da Faral, 1910, p. 29.
La documentazione al riguardo è numerosa. Si vedano Milá y Fontanals, 1889, p. 263; Bonifacio,
1907, p. 96; Faral, 1910, p. 114; Menéndez Pidal, 1957, p. 56.
15
Il latore o la latrice della presente, giullaressa o giullare, il quale o la quale ha voluto intervenire
alla nostra corte o alle nostre nozze, raccomandiamo con particolare cura alla vostra cortesia,
pregando per riguardo al nostro affetto che lo o la vogliate ricompensare. 16
Del resto, nessun luogo e nessun contesto in cui potremo trovare i giullari dovrà stupirci, perché
essi sono davvero presenti ovunque la vita sociale si addensi e dunque presso ogni soggetto sociale
e vicino ad ogni nucleo di potere. Li troviamo, ad esempio, malgrado le condanne ufficiali della
Chiesa e della tradizione cristiana, in occasioni religiose e anche in spazi religiosi.
L’inconsuetamente ricca dotazione di documenti farfensi segnalataci da De Bartholomaeis 17 ci
attesta ad esempio che nell’Abbazia di Farfa, non lontano da Roma, già in epoche relativamente
antiche come i secoli XI e XII, giullari italiani, tra i primi di cui si abbia notizia, operano con
continuità in stretto contatto coi religiosi, coi quali allestiscono spettacoli come la celebre Cena
Cypriani, e dai quali ottengono anche donativi di terre. In seguito i giullari entreranno anche dentro
alle chiese, trasportando le loro abilità tecniche soprattutto di musici nelle feste liturgiche
spettacolarizzate e nel teatro religioso. E più in generale non è affatto infrequente, accostandosi alla
vita medievale nella sua quotidianità e fuori dai parametri ideologici, incontrare giullari che siedono
alla mensa di vescovi e abati, non diversamente che a quella dei signori laici, e che addirittura li
accompagnano nelle visite pastorali alle comunità di fedeli.
Per il fedele del resto, proprio come tale e non solo come uomo del popolo, la presenza del
giullare è una costante difficilmente prescindibile. Se lo trova infatti a dettare il passo con la musica
nelle processioni e, ancor più, a scandire le stazioni dei pellegrinaggi verso i santuari, ricreato dalla
sua musica e dalle canzoni di gesta o più spesso educato dal racconto edificante delle vite dei santi.
Se lo trova in quelle feste religiose in cui non è facile scindere la festività ritualizzata di tipo sacro
da quella profana di cui appunto il giullare è portatore. Se lo trova, a volte, accanto al letto in cui
giace malato, come medicina per sollevare l’animo, o addirittura vicino al catafalco a cantare
durante la veglia funebre 18.
Proprio a causa di situazioni come queste è facile capire come l’uomo del popolo non possa
nella sostanza recepire le condanne ufficiali che la Chiesa continua ad emanare, e come dunque
accetti, presumibilmente con gioia, la presenza dei giullari in tutte le innumerevoli occasioni in cui
ne viene toccato. Cosa che avviene principalmente o quando lo spettacolo è offerto da un qualche
potere costituito — signore, vescovo, municipalità —, oppure nella situazione del mercato e della
fiera, contenitore naturale, in quanto denso grumo di socialità, dell’attività giullaresca. Le forme più
diffuse in queste situazioni popolari sono naturalmente quelle di tipo basso, circense, ma, in Francia
soprattutto ma anche in Italia o in Spagna 19, non mancano altri generi, come le canzoni di gesta. La
piazza del mercato è tanto il luogo privilegiato dell’incontro tra popolo e giullari che uscire al
mercato è espressione tipica per indicare uno spettacolo rivolto al popolo e ai borghesi, così come
andar per corte o simili significa naturalmente rivolgersi ai signori.
L’altro grande momento di primaria rilevanza nella vita dell’uomo medievale, oltre a quelli che
scandiscono la vita religiosa nei luoghi sacri e la vita sociale nella piazza del mercato, è la guerra,
momento così drammatico e poco festivo che si fatica ad intravedervi la presenza del giullare.
Eppure è assodato da non pochi esempi che varie specie di giullari, dai suonatori ai cantori di gesta,
accompagnano i soldati nelle campagne militari. Spesso con finalità ricreative durante le pause dei
combattimenti, con modalità dunque non dissimili da quelle ancora utilizzate nelle guerre moderne,
ma a volte anche con scopi per così dire operativi. Ci è stato tramandato ad esempio di una banda di
16
Il testo latino è in Faral, 1910, p. 305. Altri di questi formulari, tratti da manoscritti della Bibl. de
l’Arsenal, sono pubblicati da Faral a p. 122. Diverse testimonianze sul fenomeno sono riportate da
Menéndez Pidal, 1957, pp. 86-87.
17
De Bartholomaeis, 1928, pp. 37-47.
18
Si vedano Faral, 1910, pp. 97 e 293; Menéndez Pidal, 1957, pp. 75-77.
19
Per quanto riguarda l’Italia si veda la documentazione citata alla nota 8; per la Francia, Faral,
1910, p. 59; per la Spagna, Menéndez Pidal, 1957, pp. 255-58.
saccheggiatori borgognoni dell’XI secolo che, allo scopo di intimidire e di scoraggiare eventuali
resistenze, si fa precedere da un giullare che canta le gloriose azioni degli avi accompagnandosi con
uno strumento 20. E soprattutto ci è stato consegnato, da numerose fonti, il personaggio di
Tagliaferro, che partecipa alla battaglia di Hastings del 1066 dalla parte dei normanni di Guglielmo
il Conquistatore.
Quella di Tagliaferro è una figura controversa, su cui molto si sono soffermati gli studiosi,
perché le fonti al riguardo non sono concordi. Potrebbe trattarsi di un guerriero che si presta a fare
l’istrione per disorientare il nemico, così come potrebbe essere un professionista che canta le
canzoni di gesta per fortificare i suoi in vista del combattimento. Delle dieci cronache che
raccontano la battaglia, tra il 1070 e l’inizio del XIII secolo, sette fanno menzione di questo giullare
che, marciando davanti all’armata, dà col suo canto il segnale della battaglia; tre di questi testi lo
individuano come Tagliaferro e due specificano che il canto è la Chanson de Roland 21 Forse non è
un caso comunque che la versione forse meno eroica e più grottesca, tesa a sottolineare l’aspetto
istrionesco più di quello guerresco di Tagliaferro, sia di uno scrittore della parte degli sconfitti,
l’inglese Enrico di Huntingdon, quasi a giustificare con lo spaesamento provocato da qualcosa fuori
posto, come appunto un giullare in una battaglia, gli iniziali successi di Tagliaferro:
Un tale dell’appropriato nome di Tagliaferro, poco prima che i guerrieri si scontrassero,
giocando ad agitare le spade di fronte agli Angli, mentre tutti lo guardavano stupiti, uccise un
vessillifero degli Angli, poi ugualmente una seconda volta, e una terza. Alla fine egli stesso fu
ucciso. 22
Anche a me piace credere a questa immagine, forse non vera, di un giullare che muore
collocando le proprie abilità tecniche e la propria capacità di stupire con lo spettacolo ancora una
volta in un contesto improprio, ostentando insomma la funzione di spiazzamento della propria
attività e dimostrando con ciò la fecondità potenziale di questo suo essere continuamente altro, o
altrove.
Questo istituzionale essere fuori ruolo e fuori luogo si attenua ma non si perde del tutto quando
il giullare si stanzializza, ponendosi stabilmente al servizio di qualche signore o anche, come spesso
accade, di una municipalità. Questo aspetto non scompare, da un lato, anche banalmente, perché il
giullare di corte non cessa per questo di viaggiare, come messaggero ma anche proprio come
soggetto per lo spettacolo, inviato come dono dal suo signore a qualche suo pari. Ma dall’altro lato,
soprattutto, perché l’essere spiazzato è per il giullare in primo luogo essere comunque altro rispetto
a qualsiasi luogo, è porsi come bolla di un vuoto sociale che — già lo si diceva — deve comunque
risolversi sul piano ludico, che al sociale è al massimo giustapponibile ma non integrabile. E la sola
integrazione possibile avverrà quando anche all’attività ludica professionale saranno riconosciute,
come vedremo, una funzione sociale e la liceità di una contropartita economica non occasionale,
cioè un salario. Allora il giullare, come stipendiato, avrà anch’esso un luogo specifico di residenza e
di azione, delegando la sua differenziazione dagli altri servitori del signore solo alle sue abilità
tecniche, caratterizzanti e per certi versi esclusive, e in grado di renderlo comunque ancora un
personaggio anomalo e particolare della corte.
Anche quando il giullare si insedia in qualche corte, comunque, o mantiene a grandi linee queste
caratteristiche di professionista dello spettacolo, e allora non muta di molto la propria immagine e il
proprio repertorio, o tende a divenire, come il trovatore, poeta e intellettuale, abbandonando il piano
20
Menéndez Pidal, 1957, p. 264.
Zumthor, 1986, pp. 17-18.
22
Enrico di Huntingdon, Historiae Anglorum, VI, 30 (Rerum britan. Scriptores). Il testo latino è
riportato, assieme ad altri brani di autori che citano l’episodio, da Faral, 1910, pp. 275-76. Il punto
sulle ipotesi di credibilità della figura di Tagliaferro così come ci è stata consegnata dalle
stratificazioni successive è fatto anche in Oldoni, 1978, pp. 30-31.
21
ludico. Non bisognerà dunque confondere, almeno per quanto ce lo consente la labilità di confini tra
le varie figure, l’ospitalità offerta dalle varie corti d’Europa ai trovatori, che anche quando eseguono
essi stessi le loro composizioni tendono comunque a porsi primariamente come letterati e come tali
sono accolti dai signori, con l’assunzione in servizio di giullari esecutori, specie musici e cantori,
destinati alle necessità spettacolari ordinarie della corte.
Esempi del primo tipo li troviamo anche in Italia. Non solo in quella corte di Federico II che
produrrà con la scuola siciliana uno dei primi momenti di letterarietà romanza in Italia, ma anche in
corti minori dell’Italia settentrionale come quelle dei Monferrato, dei Malaspina, degli Este, dei
Saluzzo, dei Da Romano, dei Savoia, dei Del Carretto, che, tra XII e XIII secolo, ospitano e si
scambiano trovatori provenzali e trovatori italiani, da Raimbaut de Vaqueiras e Aimeric de
Peguilhan a Lanfranco Cigala e Sordello 23. Ma è fatto questo, pur importantissimo nell’ambito
della storia delle letterature, che è ormai marginale rispetto al discorso sulla teatralità. Più ci deve
interessare invece il caso dei giullari di servizio, che è fenomeno assai diffuso ed è causa di un
mutamento sociale e professionale importante della figura dell’attore. Dal XIII e soprattutto nel
XIV e XV secolo non c’è corte che non abbia giullari fissi in numero più o meno cospicuo, con
compiti di intrattenimento quotidiano e che spesso si trovano in una situazione di notevole
familiarità, data dalla consuetudine, col signore. Particolarmente conosciuti, anche per il favore con
cui il sovrano guarda al mondo giullaresco, sono ad esempio i giullari della corte di Alfonso X di
Castiglia, nel XIII secolo, da quel Citola, identificato col suo strumento musicale, di cui lo stesso re
si burla in un componimento perché tenta di riscuotere due volte il salario, a quella giullaressa o
soldadera, Maria Pérez la Balteria, la cui popolarità fu grandissima 24.
Ma queste assunzioni stabili e dunque istituzionalizzate non possono non portare un mutamento
su1 piano dell’immagine sociale del giullare. Non dimentichiamo che sino a San Tommaso e a San
Bonaventura alla professione del giullare manca un riconoscimento di liceità morale, e che anche in
seguito la sua accettazione sociale è sempre più una prassi che contrasta con le enunciazioni
teoriche ed anche legislative che non una legittimazione sancita da qualche norma. Anche il potere
civile, infatti, fa a gara con quello religioso nel prendere le distanze dagli attori con ordinanze e
leggi che ne marcano continuamente la condizione degradata. Nell’Italia del XIII secolo, ad
esempio, Federico Il stabilisce che non vada punito chi offende i giullari maldicenti, negli statuti di
Ivrea del 1237 gli attori sono accomunati alle prostitute, e negli statuti di Parma si decreta che i
giullari non devono pagare tasse, il che, se pure si risolve in un vantaggio economico, è comunque
da considerarsi un segno di discredito sociale 25. Anche se poi le municipalità stesse, in Italia e
fuori, non si fanno scrupolo di assoldare giullari per occasioni particolari o addirittura di assumerne
di stabili 26.
Questa situazione di contraddittorietà manifesta dunque la necessità di essere superata, con
forme di legittimazione anche istituzionale di quella professione attorica che è ormai patrimonio
stabile e, nei fatti almeno, anche socialmente apprezzato, di tutte le corti, ossia nei centri di potere
politico e di decisionalità legislativa. E questo avviene anche con atti formali, ad esempio nelle corti
spagnole della prima metà del XIV secolo, a iniziare dalle Leges Palatinae del re di Maiorca nel
1337:
Nelle case dei principi, come tramanda l’antichità, sono permessi mimi ossia giullari, in quanto
il loro lavoro porta letizia, che i principi devono sommamente desiderare e con onestà coltivare, per
scacciare tristezza e ira e mostrarsi più gradevoli a tutti. Per la qual ragione vogliamo e ordiniamo
23
Si vedano Bertoni, 1967, pp. 3-35, e Roncaglia, 1982, pp. 105-22.
Menéndez Pidal, 1957, pp. 167-72.
25
Bonifacio, 1907, pp. 20-23. I documenti dell’epoca di Federico 11 sono pubblicati in Meldolesi,
1973.
26
Gautier, 1892, 11, pp. 57-58; Chambers, 1903, I, p. 51; Levi, 1914, pp. 12-18; Menéndez Pidal,
1957, pp. 59-62; Zumthor, 1986, p. 15.
24
che nella nostra corte vi debbano essere cinque giullari, dei quali due siano suonatori di tromba e
uno suonatore di timpani. 27
Qualche anno più tardi una legislazione simile, tradotta dal latino in catalano quasi parola per
parola, è adottata dal re di Aragona, con la sola differenza che i giullari ammessi sono quattro, tutti
suonatori di trombe e timpani. Ma il fatto che da documenti del 1352 sappiamo che in quella stessa
corte sono in servizio altre tipologie di giullari, come cantanti e suonatori di cornamusa28, ci
conferma nell’ipotesi che quelle leggi valgano soprattutto come affermazione del principio
giuridico della liceità della presenza dei giullari a corte, e non come prescrizione delle modalità
concrete, che possono cambiare nel tempo, con cui questa presenza si deve manifestare.
Come si vede, comunque, il giullare di corte è essenzialmente un musico. Non stupirà dunque
che il nuovo nome con cui cominciano a venire chiamati appunto i giullari al servizio stabile di un
signore, menestrello o simili a seconda delle diverse lingue, ancora oggi mantenga valenze
semantiche quasi esclusivamente musicali. La denominazione menestrello ha particolare fortuna in
ambito francese, dove inizia ad essere utilizzata in senso proprio, ossia per designare i giullari di
corte, fin dal XII secolo, e già nel XIII secolo è usata in senso lato, per designare tutti i giullari. Ed è
con questa accezione allargata che il termine entra anche in altre lingue e in altre culture: in Spagna
o in Italia, ma soprattutto in Inghilterra, dove ministrel è appunto termine generale per indicare i
giullari.
Il meccanismo di questa estensione di senso non è difficile da comprendere. È chiaro che
quando il giullare è assunto stabilmente a corte arriva ad una promozione sociale decisiva, ottiene
un riconoscimento della propria professionalità dal soggetto sociale più alto che possa fornirglielo,
acquisisce anche, sotto la protezione del signore, una sicurezza giuridica ed economica prima
sconosciuta. In tal modo tra il menestrello e il giullare che mantiene le vecchie caratteristiche di
instabilità sociale e di nomadismo si crea una gerarchia evidente a tutto vantaggio del primo, che
trova una rispondenza proprio nella differenza di denominazione. Naturalmente, se il nome
menestrello diventa distintivo di una condizione sociale più alta, la finalità di tutti i giullari sarà
quella di divenire menestrelli, se non di fatto almeno di nome. Così poco alla volta si produce uno
slittamento semantico, con la tendenza a lasciare il termine giullare sempre più ai rappresentanti più
degradati e professionalmente meno preparati della categoria. Nel XV secolo, infatti, il percorso è
totalmente compiuto, al punto che la strada di Parigi che dalla fine del XIII secolo si chiamava Rue
aux Jongleurs, due secoli dopo si chiama Rue des Ménestriers 29. Col risultato tuttavia di vanificare
ogni possibilità discriminatoria del nuovo termine e dunque di trasferire su di esso, quando non gli
corrisponda la condizione sociale che ne aveva determinato l’uso, tutte le connotazioni negative
prima associate al nome giullare.
Del resto, la categoria dei giullari, specie quella dei giullari nomadi, proprio per il vuoto di
identità sociale e la condizione di reale emarginazione esistenziale che la denominazione serve a
coprire, è per tutto il Medioevo un enorme calderone, un contenitore in cui spesso vengono a
confluire, per una sorta di contagio sociale, molti generi di soggetti ugualmente sradicati. Un caso
tipico è quello della confusione, che è ideologicamente a priori ma anche nelle pieghe della realtà
concreta, tra la professione di giullaressa e quella di prostituta. Consideriamo che il fenomeno della
diffusione e del successo delle giullaresse è tutt’altro che marginale, specie a partire dal XIII secolo
e particolarmente nelle situazioni spettacolari di corte: nell’ambito gallego-portoghese cui il
Cancioneiro da Ajuda si riferisce, ad esempio, su sedici miniature, ben dodici rappresentano anche
la giullaressa, soprattutto in veste di cantante, a fianco del giullare che suona 30. Ebbene questa
figura, che non di rado è la moglie del giullare che decide di seguirlo nei suoi viaggi per il mondo, è
27
Se ne veda il testo latino in Menéndez Pidal, 1957, p. 199.
Menéndez Pidal, 1957, pp. 200-2.
29
Faral, 1910, p. 106.
30
Menéndez Pidal, 1957, pp. 31-36. Sull’argomento si veda anche Faral, 1910, p. 63.
28
spesso, specie nelle sue determinazioni meno professionali come la soldadera, confusa con la
prostituta. Certo giocano qui diversi fattori, dal tradizionale pregiudizio anche del mondo classico
verso le donne attrici alla condizione già degradata e ambigua che le giullaresse hanno ricevuto in
eredità dalle mime tardo-romane, all’ostilità ancor più virulenta della cultura cristiana, che in un
attore donna non può che vedere il risultato di due principi negativi che si moltiplicano a vicenda.
Ma è certo che la presenza costante di donne, a torto o a ragione accusate di esercitare anche la
prostituzione, costituisce un ulteriore strumento di degradazione sociale della professione attorica. E
comunque, anche quando la figura della giullaressa subisce un processo analogo a quello del
giullare, con l’accettazione sociale e professionale in seno alle corti, il suo ruolo, salvo rari casi, è
comunque sempre subalterno, esecutivo, con le funzioni primarie di danzatrice e cantante.
Altro caso esemplare è quello dei goliardi, i chierici vaganti che, abbandonati gli studi o gli
ambienti religiosi, prendono a girare il mondo, conducendo una vita da sradicati, da emarginati e
molte volte anche da esecutori di spettacolo, come i giullari. Ma quantunque ai giullari spesso siano
sovrapposti, soprattutto nelle elencazioni dei soggetti sociali da condannare, i goliardi restano
tuttavia altra cosa, sia per la provenienza colta che li porta a scrivere componimenti raffinati come i
Carmina burana, sia perché essi non sono primariamente professionisti dello spettacolo, anche se a
volte possono mettere le loro abilità e il loro sapere al servizio di quei loro compagni di strada e di
taverna che sono i giullari. È l’autorità ecclesiastica, soprattutto, che tende a sovrapporre le due
categorie, perché naturalmente quello dei goliardi o addirittura dei chierici che si fanno giullari, è
problema costante per la Chiesa, la cui preoccupazione primaria è di tagliare ogni legame, in modo
che questi soggetti siano identificati senza ambiguità come estranei all’ambiente ecclesiastico, e
diversi da quel che erano. Questa linea di condotta è stabile per secoli, a partire dalle prescrizioni di
Gautier de Sens, del X secolo:
Stabiliamo che ai chierici ribaldi, soprattutto quelli che dal popolo sono chiamati della famiglia
di Golia, sia ingiunto da parte di vescovi, arcidiaconi, ministri e decani, di tagliare i capelli oppure
di raderli di modo che in essi non rimanga la tonsura clericale. 31
E questa preoccupazione la ritroviamo identica, quasi quattro secoli dopo, in una decretale di
Bonifacio VIII del 1301, che stabilisce che i chierici che si fanno giullari, goliardi o buffoni, se
esercitano questa professione per almeno un anno, ipso jure decadano da ogni privilegio clericale 32.
Naturalmente sarebbe una forzatura eccessiva vedere in certe operazioni compiute dai giullari a
partire dal XIV secolo, come l’associarsi in corporazioni e confraternite 33, dei meccanismi di difesa
della propria identità professionale, minacciata dalla confusione corrente con soggetti sociali
contigui. Certo è che le corporazioni, inaugurate a Parigi nel XIV secolo e poi nei due secoli
successivi diffuse anche nelle città francesi di provincia e in Inghilterra, costituiscono un tentativo
di riconoscersi e di farsi riconoscere come categoria, e una rivendicazione di quel ruolo sociale che
al giullare singolo viene negato. Ma sul piano della penetrazione nel tessuto sociale, della
integrazione quindi con le altre componenti della società, soprattutto con quella dei borghesi che
non può non venire individuata come alleato naturale, sono di certo più importanti le confraternite,
come quella famosa di Arras, nelle quali il giullare si trova fianco a fianco col borghese e con esso
intraprende imprese sociali, culturali, spettacolari.
Come si vede anche dall’approdo finale di questo discorso, sinora si è trattato delle condizioni e
del contesto in cui si esplica l’attività del giullare, in un’ottica in sostanza di sociologia dello
31
Gautier de Sens, Statuta, 13, P.L., 132, col. 720.
Se ne veda il testo in Faral, 1910, p. 327. In generale sui fenomeno dei goliardi, si vedano ancora
Faral a p. 43 e Menéndez Pidal, 197, pp. 28-31, in entrambi i casi con abbondante citazione di
documenti, soprattutto di condanne ecclesiastiche.
33
Se ne veda una trattazione ampia in Faral, 1910, pp. 129-42, e anche in Chambers, 1903, II, pp.
258-62.
32
spettacolo. È tempo ora di provare a descrivere e a comprendere quel che è più difficile ma anche
più importante da ricostruire, ossia le modalità e gli strumenti della teatralità giullaresca. Pagato il
debito d’uso al riconoscimento della difficoltà istituzionale di conoscere retrospettivamente un
fenomeno per definizione effimero come la performance spettacolare, mi pare di poter individuare
in due serie di documenti i cardini essenziali per una più approssimata ricostruzione: le fonti
iconografiche da un lato — decorazione plastica dei monumenti e soprattutto miniature — e le
classificazioni delle tipologie dei giullari dall’altro. Anche se occorre ricordare come, in entrambi i
casi, si tratti di fonti in parte sospette, spesso viziate da pregiudizi ideologici o da tesi precostituite
da dimostrare.
Per quanto riguarda le immagini, ad esempio, specie quelle di committenza ecclesiastica, è
visibile ad esempio il riflesso della concezione negativa dei giullari. Intanto, in generale, il giullare
raffigurato è quasi sempre un musico, essendo molto più rare, e rintracciabili prevalentemente nelle
epoche più antiche, le immagini del giullare circense, che compare sporadicamente sotto forma di
acrobata, di giocoliere o di lanciatore di coltelli. E il musico, in possesso di un’abilità tecnica più
specializzata, è da sempre superiore all’acrobata. Ma anche all’interno della categoria dei musici
affiorano precise differenziazioni gerarchiche 34. Dapprincipio il musico è usato spesso come figura
tipica, come segno per indicare il male e soprattutto il demoniaco: raramente ad esempio nelle
raffigurazioni del Giudizio Universale mancano le figure diaboliche che suonano qualche
strumento, prevalentemente a fiato e a percussione.
È solo dal XIV secolo che la musica comincia ad essere anche un attributo del mondo divino,
con la rappresentazione di angeli che suonano, ma soprattutto strumenti a corde come l’arpa o la
viola. Ed è una caratteristica, questa, che testimonia più dell’attenzione a un modello culturale
contemporaneo e alle sue determinazioni ideologiche che del rispetto delle Sacre Scritture, le quali
propongono con frequenza gli angeli che suonano le trombe. Nell’iconografia è invece proprio da
questa contrapposizione, tra fiati e soprattutto percussioni da un lato e corde e archi dall’altro, che
passa una linea di discriminazione che è inizialmente ecclesiastica ma diviene anche generale, tra
musica negativa e musica positiva. Non è solo una questione di qualità del suono — anche se la
rumorosità ad esempio dei tamburi mal si concilierebbe con la natura celeste degli angeli —, ed è
invece soprattutto una questione di specializzazione. Gli strumenti a corda e ad arco prevedono uno
studio anche teorico della musica che per gli altri non è necessario e comunque comportano un
grado maggiore di competenza e di abilità tecnica: sarà per questo, allora, che nelle raffigurazioni
positive e non demonizzanti del suonatore, sarà sempre particolarmente visibile la chiave per gli
accordi. Del resto, come vedremo nei prossimi capitoli, proprio la mancanza di musica o la cattiva
musica è una delle discriminanti che ghettizzano i diavoli nel teatro religioso.
Dalla documentazione iconografica, poi, possiamo ricavare altre informazioni o conferme
particolari, come ad esempio l’esibizione in coppia di giullari cristiani e musulmani, il ruolo
tutt’altro che secondario delle giullaresse, in veste soprattutto di danzatrici e di cantanti, oppure il
rapporto di subalternità anche comportamentale e vestimentaria tra giullare e trovatore, il quale
ultimo spesso sovrintende da seduto alle performances degli attori. 35
Ma è l’altra fonte primaria, quella delle classificazioni e delle descrizioni, che ci permette di
entrare con maggiore completezza dentro alle forme della teatralità giullaresca e ci fa incontrare una
multiformità di prestazioni difficilmente immaginabile. Con un ordine che non è correttamente
cronologico, ma che è ad estuario, in quanto procede da descrizioni generali a descrizioni sempre
34
Settis Frugoni, 1978, pp. 118-20, Allegata a questo saggio si trova anche una ricca
documentazione iconografica, almeno fino al XII-XIII secolo. Sull’iconografia del giullare nei
manoscritti si veda anche Leclercq, 1973, e nella decorazione degli edifici in Francia e Italia nel XII
secolo, Di Giovanni, 1975. Un corredo di immagini esteso e interessante è poi anche in Menéndez
Pidal, 1957.
35
Menéndez Pidal, 1957, pp. 34-35, che pubblica anche una miniatura a questo proposito
significativa del Cancioneiro da Ajuda.
più particolareggiate, mi servirò qui di quattro documenti, tra cui due che già abbiamo incontrato: il
brano del Penitenziale di Tommaso di Cobham che gerarchizza i giullari in base alla ammissibilità
morale; la Supplica di Guiraut Riquier; il Libro de Buen Amor dell’Arcipreste de Rita, Juan Ruiz; il
romanzo provenzale Flamenca.
Il testo di Tommaso di Cobham, della fine del XIII secolo, citatissimo in quanto, oltre a
classificare per generi gerarchizzati gli attori, è documento importante per testimoniare
l’accettazione di certi tipi di professionalità da parte della cultura cristiana, è molto preciso nel
disegnare i confini delle categorie quanto invece superficiale nella descrizione concreta. Di
rilevante interesse, comunque, è il collocare ai due lati estremi della scala di valori, secondo uno
schema che si va sempre più riconoscendo come generale, il mimo e il musico:
Vi sono tre generi di istrioni. Alcuni trasformano e trasfigurano il proprio corpo sia con turpi
salti o gesticolazioni sia turpemente denudandosi, sia ancora indossando orribili maschere, e tutti
questi sono condannabili se non abbandonano il loro mestiere. Vi sono poi altri che non lavorano e
vivono in maniera criminosa, sono senza domicilio e seguono le corti dei signori, e con spirito
calunniatore sparlano degli assenti per piacere agli altri. Anche questi sono da condannarsi, poiché
l’Apostolo proibisce di mangiare insieme ad essi, e sono detti buffoni erranti, poiché a nulla sono
utili se non alla crapula e alla maldicenza. Vi è poi un terzo genere di istrioni, dotato di strumenti
musicali per dilettare gli uomini, e anche questi sono di due specie. Alcuni infatti frequentano le
taverne e le compagnie disoneste, e lì cantano diversi canti per muovere gli uomini alla lascivia, e
questi sono condannabili come gli altri. Ma vi sono alcuni, che si chiamano giullari, che cantano le
canzoni di gesta e le vite dei santi, e portano sollievo agli uomini sia quando sono malati sia quando
sono in difficoltà, e non fanno tutte quelle turpitudini che invece fanno i saltatori e le saltatrici e gli
altri che si servono di immagini disoneste e fanno apparire come dei fantasmi per magia o in altro
modo. Così, se non fanno queste cose ma cantano coi propri strumenti le canzoni di gesta ed altre
cose utili per ricreare gli uomini, come abbiamo detto, questi ultimi si possono tollerare. 36
Come si vede, questo brano è coerente col quadro concettuale e storico che siamo andati
componendo: c’è il disprezzo per i buffoni di tipo circense, che si affidano solo alla corporeità, c’è
il rifiuto del giullare nomade e meno professionalizzato, c’è il privilegio accordato al musico,
purché non sia musico da taverna, ma quello che canta le canzoni di gesta e le vite dei santi. Se si
considera che solo per quest’ultimo Tommaso di Cobham ritiene legittima la professione,
ammettendo che gli si possa dare assistenza e compenso, non è difficile individuare in questa unica
figura legittimata quella che effettivamente si va affermando come categoria più rispettata, quella
dei giullari di corte, dei menestrelli.
Ed è la stessa direzione in cui va, in quello stesso torno d’anni e con una consapevolezza ancora
maggiore perché è una voce che viene dall’interno stesso della giulleria, la Supplica di Guiraut
Riquier, o meglio ancora la seconda parte, quella che si finge essere la Declaratio di risposta del re.
Anche qui la classificazione lascia all’estremo basso il giullare non specializzato, che si propone di
chiamare buffone, mentre al vertice è messo non il musico o il cantore di gesta bensì il letterato
senza più alcun rapporto con l’attività spettacolare, quale appunto Guiraut si sente. In sostanza si
propone una tripartizione di condizioni — che nel contesto del discorso ci sono anche
sommariamente descritte —, con quella generale e più numerosa dei giullari a costituire il variegato
corpo intermedio, e quella dei trovatori di corte, dalla corte pagati solo per comporre, chiamati a
staccarsi inventandosi una professione diversa. L’esempio per la classificazione è preso dalle
denominazioni che usano in Spagna:
[tutto ciò] è ordinato molto bene in Spagna, e non vogliamo che venga meno, ma che si continui
a dire come si dice, poiché le specialità di ciascuno sono ben distinte da nomi speciali: si chiamano
36
Se ne veda il testo latino in Chambers, 1903, II, pp. 262-63.
‘joglars’ tutti quelli che suonano strumenti, mentre gli imitatori sono detti ‘remendadors’, e i
trovatori sono chiamati in tutte le corti ‘segriers’; si dicono infine ‘cazuros’ per loro umiliazione
quegli uomini ciechi e sordi, dal punto di vista di una decorosa condotta, che cantano senza garbo e
rappresentano maldestramente per vie e per piazze il loro basso repertorio, e si uniscono a gentaglia,
vivendo in modo disonorevole. 37
Questa è la situazione nei casi migliori, come appunto in Spagna, scrive Guiraut, ma meglio
sarebbe se si facesse ancora maggiore chiarezza, individuando tre categorie e stabilendo per
ciascuna compiti e ruoli. La più bassa deve essere quella dei buffoni nomadi e non specializzati:
Diciamo quindi e fondatamente affermiamo che ogni indegno, che vive bassamente, sia o no
sapiente, non debba presentarsi in alcuna corte di pregio; così quelli che fanno saltare scimmie o
caproni o cani, o che fanno i loro giochetti sciocchi, come quello dei burattini, oppure imitano il
canto degli uccelli o suonano strumenti e cantano per pochi soldi in bassi ambienti, non devono
esser compresi nell’ambito della giulleria; e, come in Italia, si chiamino ‘buffoni’ quelli che, pur
frequentando le corti, si fingono pazzi, e non si vergognano di alcuna abiezione, mentre, al
contrario, non apprezzano ciò che è piacevole ed ha valore. 38
La categoria successiva, che già trova una legittimazione, e per la quale si propone di mantenere
la denominazione tradizionale, è quella dei giullari di corte, quelli che già in Francia e il secolo
dopo anche in Spagna si chiamano menestrelli:
E quelli che sanno vivere tra i potenti con cortesia e con decorose capacità, suonando strumenti
o raccontando ‘novas’ di altri autori, o cantando ‘vers’ e canzoni altrui, ben fatte e piacevoli ad
ascoltarsi, possono a buon diritto portare quel titolo di ‘giullari’. Egualmente, chi lo preferisca, può
designare ognuno di questi per sé; ma poiché tale è ormai l’uso corrente, siano chiamati pure
giullari, in quanto a ragione devono stare in corte e non avere preoccupazioni economiche, poiché
di tali persone c’è gran bisogno nelle corti, in quanto vi portano molti generi di intrattenimento che
ricreano piacevolmente lo spirito. 39
Si sarà notata l’insistenza di Guiraut, oltre che sulle abilità professionali, sulla decenza del
comportamento, con una decisa presa di distanza dall’immagine morale e sociale degradata del
giullare vagante, che viene abbandonato al suo destino di emarginazione e che anzi viene dipinto in
modo non meno fosco di certe condanne ecclesiastiche, pur di salvare per contrapposizione le
uniche due figure che a Guiraut interessano, quella del giullare di corte, che è l’esecutore
indispensabile delle composizioni di un trovatore che non voglia più essere anche uomo di
spettacolo, e il trovatore stesso, che appunto non deve far altro che comporre e che può addirittura
sfociare in quel dottore in poesia che lo trasforma definitivamente in intellettuale quasi accademico:
[i trovatori] sono coloro che conoscono il modo di far cobbole e danze doppie, sirventesi di
valore, albe e ‘partimens’, e comporre versi e musica, i quali non si occupano mai d’altro nelle
corti, ma dicono o trasmettono il proprio sapere ai valenti. Questi è più che giusto chiamare
37
Bertolucci-Pizzorusso, 1966, pp. 111 (trad.) e 103 (testo), vv. 162-183. Occorre tuttavia
sottolineare che sul termine segrier e sulla sua interpretazione c’è stata a lungo polemica tra i
filologi, alcuni dei quali, traducendo in maniera differente questo brano ed appoggiandosi ad altre
testimonianze, hanno inteso il segrier come una figura intermedia tra quella del giullare vagabondo
e quella del trovatore: tra questi anche Menéndez Pidal, 1957, pp. 16-18. Si veda comunque
l’esposizione del problema, con la difesa della tesi che, qui e altrove, segrier o segrel non designano
figure diverse dal trovatore, nell’introduzione di Bertolucci-Pizzorusso, 1966.
38
Ivi, pp. 111 e 104, vv. 198-221.
39
.Ivi, pp. 111-12 e 104-5, vv. 222-245.
trovatori, e sian detti ‘dottori in poesia’ quei valenti che fanno ‘vers’ e canzoni, ed altre valide
composizioni profittevoli e piacevoli per i begli insegnamenti che contengono; così la loro
condizione [oppure: merito] sarà ben chiarita [oppure: resa illustre]. 40
Ma accanto a queste classificazioni gerarchizzanti, che hanno una finalità appunto più nelle
partizioni che disegnano che nelle descrizioni che accessoriamente forniscono, ci sono poi quelle
enumerazioni di attività senza giudizio di valore che costituiscono la primaria fonte di conoscenze
degli strumenti e delle modalità di spettacolo. In un brano famoso del Libro de Buen Amor del
133041, Juan Ruiz, religioso e letterato molto vicino all’universo giullaresco per il quale dichiara di
aver scritto diversi componimenti, descrive una sorta di corteo giullaresco in cui ognuno è
identificato tramite lo strumento che suona e ci dà così modo di conoscere in un sol colpo oltre una
ventina di strumenti utilizzati in quell’epoca. Gli strumenti che si trovano in numero maggiore sono
quelli a corda, dalla viyuela de peñola alla viyuela dë arco, dalla citola alla harpa, dalla rota al rabé
(sorta di violino primitivo), dalla cinfónia (accompagnandosi con la quale si cantano le canzoni di
gesta) alla guitarra nelle sue due versioni mora e latina, dal salterio (di origine orientale) ai similari
medio canón e canón entero (con ben 78 corde), dall’alaút alla baldosa, con una varietà di nomi e di
oggetti da cui riesce molto difficile districarsi, distinguendo l’uno dall’altro ed assegnando a
ciascuno la propria funzione. Tra gli strumenti a fiato, che sono meno numerosi, troviamo
l’albogón, grande flauto a canne parallele, la flauta, la trompa, l’añafil di origine mora e l’odrezillo
di origine francese. Solo quattro gli strumenti a percussione, l’atabor, il taborete, l’atabal e il
panderete.
Ma anche questa enumerazione di strumenti e dunque di strumentisti è incompleta in quanto
prende in considerazione solo una categoria di giullari, quella dei musici, la quale tuttavia, pur se è
ormai diventata la categoria più rappresentativa, è ben lungi dall’esaurire la molteplicità delle
specializzazioni giullaresche. Sotto questo profilo, il documento più interessante e più completo è
un’opera di fantasia, il romanzo anonimo Flamenca, della metà del XIII secolo, che in una
fittissima pagina descrittiva ci fornisce un affresco impressionante di un dopo-banchetto in cui
cinquecento giullari offrono, contemporaneamente, il proprio spettacolo ai signori convenuti. Si
tratta di una pagina che nella sua concitata ellitticità può lasciare nell’ombra molte allusioni a
specifiche pratiche attoriche, soprattutto quelle che riguardano i racconti, ma che mi piace lasciare
così, nella sua forma di affastellamento paratattico, per chiudere con questo elenco che sembra non
finire mai un discorso sulle tipologie delle pratiche giullaresche che, comunque, non si riuscirebbe a
definire compiutamente:
Ed ecco avanzare i giullari. Ciascuno vuole farsi ascoltare. Avreste potuto udire le corde degli
strumenti modulate su tutti i toni. Chi conosce una nuova sonata sulla viola, una canzone, un
discordo o un ‘lai’ si mette in mostra più che può. L’uno suona sulla viola il ‘lai’ del Caprifoglio,
l’altro quello di Tintagel; l’uno canta quello del Fino Amante, l’altro quello che compose Yvain;
l’uno trae accordi dall’arpa, l’altro dalla viola; l’uno modula il flauto, l’altro il piffero; l’uno suona
la giga, l’altro la rota. L’uno recita i versi, l’altro lo accompagna con la musica; l’uno suona la
cornamusa, l’altro la zampogna; l’uno pizzica la mandola e l’altro accorda il salterio e il
monocordo. L’uno fa ballare le marionette, l’altro si esibisce coi coltelli; l’uno cammina carponi,
l’altro fa capriole; l’uno danza tenendo in mano la propria coppa, l’altro passa attraverso un cerchio,
un altro spicca salti. Tutti sono abilissimi. Chi vuole ascoltare racconti di re, marchesi e conti, può
udirne a sazietà; nessun orecchio se ne sta in ozio; infatti l’uno narra la storia di Priamo e l’altro di
Piramo; l’uno di Elena la bella, come Paride l’amò e la rapi; l’uno di Ulisse, l’altro di Ettore e di
Achille; c’è chi racconta di Enea e Didone che per lui fu dolente e infelice; o di Lavinia che dalla
40
Ivi, pp. 113 e 108, vv. 356-375
Ruiz, 1973, pp. 473-77, vv. 1225-1234. Per una analisi del brano, oltre alle note del curatore
dell’edizione citata, si veda Menéndez Pidal, 1957, pp. 47-51, 202-14 e passim.
41
sentinella della torre più alta fece lanciare un messaggio attaccato ad una freccia; alcuno favoleggia
di Polinice, di Tideo e d’Eteocle; altri di come Apollonio tenne Tiro e Sidone; c’è chi racconta del
re Alessandro, di Ero e di Leandro; chi di Cadmo, che fu esiliato e fondò Tebe; di Giasone e del
drago insonne; l’uno esalta il vigore di Alcide, l’altro ricorda come Fulide si diede morte violenta
per amore di Demofonte. L’uno racconta come il bel Narciso annegò, specchiandosi nella fonte;
l’altro come Plutone rapì ad Orfeo la bella moglie; l’uno ricorda la storia di Golia, ucciso da David
con tre pietre, l’altro il sonno di Sansone allorché Dalila gli tagliò i capelli; c’è chi narra di
Maccabeo, che combatté per il Signore; chi di Giulio Cesare che, solo, traversò il mare e non invocò
l’aiuto di Nostro Signore perché non aveva timore alcuno; chi rievoca della Tavola Rotonda, ove
non si presenta alcuno cui il re non dia responso per quanto sa, e dove mai vengon meno valore e
pregio; chi di Gauvain e del leone, che fu compagno del cavaliere che liberò Lunete; chi della
fanciulla bretone che imprigionò Lancelot perché questi ne rifiutò l’amore; chi di Perceval, che
giunse a corte a cavallo; chi d’Erec e d’Enide, d’Ugonet e Pende; di Governal, che a cagione di
Tristano soffrì tante pene; di Fenice, cui la nutrice diede morte apparente; del ‘Bello Sconosciuto’ e
dello scudo vermiglio che Myras trovò accanto alla posteria; di Guiflet, di Calobrenan; chi racconta
come Deliez tenne rinchiuso in prigione Keu il senescalco, che aveva sparlato di lui; chi narra di
Mordret; chi riferisce la storia del conte d’Ivet che fu cacciato dai Ventres e accolto dal Re
Pescatore; chi si rifà alla buona stella di Merlino; chi espone come gli Assassini uccidano, per
suggestione del Vecchio della Montagna; chi racconta come Carlo Magno resse l’Alemagna prima
di dividerla; chi le vicende di Clodoveo e di Pipino; l’uno ricorda come Lucifero fu per il suo
orgoglio escluso dalla gloria dei cieli; altri narrano le storie del giovinetto di Nanteuil e di Olivieri
di Verdun; l’uno recita il ‘vers’ di Marcabru, un altro racconta come Dedalo riuscì a volare e come
Icaro annegò per la sua imprudenza. Ognuno dice quanto sa di meglio. La sala risuona per lo
strepito dei suonatori di viola e per il vociare dei narratori. 42
Come si vede, in questo che può considerarsi un esempio adeguato di corte bandita, il catalogo
è veramente ampio e multiforme, anche se, c’è da giurano, nient’affatto completo. Così ci sono gli
acrobati e i giocolieri, i musici di vario tipo e i cantori, e questi ultimi sono indicati con
un’ampiezza di repertorio che non troveremo in altre fonti: dalle canzoni di gesta sul ciclo di
Carlomagno al ciclo arturiano, dagli episodi biblici ad un numero sorprendente di racconti desunti
dalla cultura classica, specie greca. Certamente, trattandosi di un romanzo e non di una cronaca, è
legittimo il sospetto di trovarsi di fronte a una sorta di catalogo più che alla descrizione di una
situazione verosimile, anche per il fatto di vedere qui riuniti, senza gerarchia alcuna, tutti i tipi di
giullari, da quelli circensi ai cantori di gesta, in un’epoca in cui invece gerarchie cominciano a darsi.
Ma la situazione qui raffigurata, pur costituendo certamente anche un catalogo astratto, è in realtà
credibile, poiché si tratta di una di quelle corti bandite destinate a far corona ad avvenimenti
speciali, come in questo caso un grande matrimonio, in cui i giullari accorrono da ogni parte
sapendo che c’è spazio e possibilità di spettacolo per tutti, proprio perché il senso primo dell’evento
non sta nel contenuto degli spettacoli che presenta ma proprio nel numero e nella varietà. Una corte
bandita, insomma, tanto più si qualifica come evento festivo indimenticabile quanti più giullari — o
uomini di corte come appunto in Italia sono anche chiamati 43 — riesce ad attirare e a ricompensare.
Al di fuori di queste occasioni, o anche di quelle feste di giullari che a volte diventano grandiosi
raduni come quello del 1313 a Parigi descritto nella Chronique de Geoffroy44 spesso ogni
42
La traduzione utilizzata è quella dell’edizione italiana Il romanzo di Flamenca, 1971, alla quale si
rimanda anche per le note esplicative — peraltro non copiose — e per il testo originale. In generale
sulle presenze di suonatori e di danzatori nei banchetti, si vedano Salmen, 1983, e Busch-Salmen,
1983.
43
Si veda Muratori, 1739, col. 842, e in generale Bonifacio, 1907.
44
La chronique métrique attribuée à Geoffroy de Paris, a cura di A. Diverres, Paris 1967, vv. 47035098.
specializzazione di repertorio si ritaglia anche un proprio pubblico preferenziale. Alcuni specialisti,
ad esempio, godono di un privilegio che si traduce in accettazione sociale e dignificazione culturale:
soprattutto alcuni generi di giullari di bocca, come vengono chiamati, ossia i cantori delle vite dei
santi da un lato, e i cantori di gesta o in genere di repertori alti come i romanzi d’avventura, i lais e i
romanzi del ciclo bretone, dall’altro. Differenti sono tuttavia le motivazioni sociali di questa
dignificazione. Nel secondo caso essa risiede nel pubblico, cortese e raffinato, nel primo invece
nella committenza, che è la struttura ecclesiale. Il destinatario naturale di questi racconti edificanti,
infatti, è chiaramente il popolo, tanto che abbiamo segni non equivocabili che in casi di doppia
destinazione degli spettacoli giullareschi, è al popolo che sono riservate le vite dei santi e al clero le
canzoni di gesta 45. Fenomeno peraltro non sorprendente se si considera che la forma narrativa,
quella stessa cui i giullari abituano la gente ad esempio recitando i fabliaux, è spesso individuata
dalla Chiesa come forma molto più idonea dell’enunciazione dottrinale a far breccia nella coscienza
dei semplici 46.
Se cantando le vite dei santi o sfruttando le proprie abilità musicali il giullare perfora le spesse
mura della chiesa, aggirando pratiche di secolare ostracismo, se divertendolo coi giochi o
raccontandogli storie si rende presente in ogni istante della vita del popolo, se facendosi interprete
dei valori della nuova cultura cortese e cavalleresca si insedia nelle corti, come strumento
indispensabile perché i signori si vedano rappresentati come vorrebbero e dovrebbero essere, è poi
come induttore di danza e di festa che entra in contatto con tutti gli strati sociali.
Il giullare è sempre, lungo tutto il Medioevo e in ogni contesto, legato alla danza. Sia in quanto
portatore di musica che alla danza è strumento indispensabile, sia in quanto egli stesso danzatore
professionista padrone della tecnica dei diversi balli, sia proprio come elemento scatenante della
danza e della festa. Non è dunque solo un fatto tecnico, come quello ad esempio descritto in due
versi del Roman des sept Sages, della metà del XII secolo:
Mentre i giullari suonano
i borghesi ballano. 47
È soprattutto una questione di altro tipo, più generale, per cui è nella danza, è non nella danza
virtuosistica del danzatore professionista ma in quella collettiva che si dà nelle situazioni festive,
che si può vedere il luogo più preciso per l’individuazione del ruolo antropologico della giulleria,
prima almeno che i giullari divengano assennati servitori di un signore. È nella danza, indotta e
guidata ed eseguita assieme agli altri, che le valenze della corporeità come strumento per
comunicare e per essere, della festività come mezzo per uscir fuori dalla quotidianità, di una azione
che lega insieme occasione contingente48 e pura gratuità non riducibile ad alcuna economia, di un
fare che è occupazione abusiva e straniata di uno spazio che nel quotidiano contiene altre valenze, è
qui che il giullare trova l’unico vero luogo che gli sia proprio nei meccanismi della società.
Per queste e per altre ragioni consimili, l’universo antropologico del giullare e dunque il modo
con cui organizza i propri strumenti espressivi e con cui si rapporta al pubblico è popolare, nel
senso in cui si intendeva questa nozione, pur fra molte cautele, nei capitoli precedenti, o almeno
risponde a delle modalità che sono quelle tipiche della cultura folklorica. Dal punto di vista della
45
Si veda Faral, 1910, pp. 45-46.
Gurevič, 1986, pp. 80 e sgg., insiste sulle differenze strutturali tra i messaggi indirizzati dalla
Chiesa ai dotti e quelli rivolti al popolo, con una accentuazione appunto della dimensione narrativa
in quest’ultimo caso.
47
Il testo originale è riportato da Faral, 1910, p. 285.
48
È Zumthor, nel contributo inviato al V° Colloque International de la Société Internationale pour
l’étude da Théâtre Médiéval (S.I.T.M.), svoltosi a Perpignan dal 7 al 12 luglio 1986, a p. 7 del
dattiloscritto, a insistere sull’importanza dell’occasione per definire il senso delle performances dei
giullari.
46
delineazione di una figura sociale, di un personaggio, è appunto con queste caratteristiche che il
giullare entra tra i protagonisti della novellistica, soprattutto toscana, tra XIII e XIV secolo, dal
Novellino, al Trecentonovelle al Decamerone. Si pensi ai vari Dolcibene, Gonnella, Ribi, Pietro
Guercio, Agnolo Moronti o Popolo d’Ancona raffigurati nel Trecentonovelle di Sacchetti, o ai
Martellino, Stecchi e Marchese dipinti come «uomini li quali, le corti de’ signori visitando, di
contraffarsi e con nuovi atti contraffacendo qualunque altro uomo, li veditori sollazzavano»
(Decameron, II, 1). Si tratta, appunto di un personaggio che corrisponde spesso ai canoni del
popolare di Bachtin, le cui caratteristiche costanti sono l’irriverenza, il rovesciare di segno le
situazioni, il ricorso continuo al grottesco, l’ostentazione della corporeità e delle sue funzioni più
basse. Dal punto di vista, invece, dei meccanismi dello spettacolo, questa dimensione popolare si
traduce, ad esempio, in una estrema convenzionalità (nel senso evidentemente di non
verosimiglianza) dei segni che il giullare utilizza e dei processi che innesca, che è figlia della
povertà di mezzi ma anche madre di un rapporto molto più stretto e più complice col pubblico;
oppure nella costruzione del proprio prodotto con una tecnica di assemblaggio di frammenti che
cura molto poco l’unitarietà e la coerenza dell’opera a tutto tondo, lasciando in vista le fessure
semantiche 49, come abbiamo visto ad esempio nel caso dei cantori di gesta a Treviso; oppure
ancora nel far riferimento ad un universo culturale comune al proprio pubblico, nell’appoggiarsi più
sul già conosciuto che sulla novità. 50
È questa la ragione dei rifacimenti innumerevoli di storie che invece restano prevalentemente le
stesse, con una gara anzi per accreditare la propria versione come la migliore51, oppure anche dei
meccanismi interni con cui si determinano le stesse opere scritte dei giullari. Quando, ad esempio,
in epoche ormai tarde, nel XIV secolo, i giullari, proprio in quanto tali e dunque separati dall’uomo
di lettere, accedono anch’essi alla scrittura, lo fanno con meccanismi che indicano la particolare
destinazione, popolare appunto, degli spettacoli di cui quegli scritti sono il libretto: si veda ad
esempio il caso dello Zaffarino studiato da Ezio Levi 52, che produce drammatizzazioni con rimandi
dall’una all’altra, presupponendo un rapporto col proprio pubblico che è di costanza, di complicità,
di ripetizione di temi conosciuti. È, naturalmente, l’esatto opposto da cui parte il trovatore, che fa
della novità del proprio dire il perno della sua qualità e che anzi utilizza il trobar clus, il poetare
difficile che istituzionalizza la distanza di saber tra il poeta e chi lo ascolta, come strumento per
differenziarsi dal giullare e dal suo universo culturale troppo poco staccato da quello del pubblico.
Da un certo momento, dunque, dal fiorire almeno della cultura cortese, il giullare restringe il
proprio raggio d’azione, è costretto a ritagliarsi il proprio pubblico in quella porzione di società il
cui mondo culturale resta sostanzialmente immutato. Ma fintanto che la società medievale si
mantiene sufficientemente instabile e produce interstizi discrepanti negli equilibri dei suoi diversi
centri di potere, anche l’instabilità istituzionale del giullare riesce a trovare luoghi e momenti
generali di ascolto e di azione. Quando la società si stabilizza, poi, e i poteri si definiscono meglio e
tendono a riordinare tutti i disequilibri, al giullare come portatore dei valori antropologici della festa
e della trasgressione non resta che marginalizzarsi ad operatore popolare, o trasformarsi in
menestrello stanziale e stipendiato oppure avviare quei processi di inserimento nelle strutture
drammaturgiche che si vanno determinando, quelle del teatro comico o del teatro religioso, e
trasformarsi in attore in senso stretto. In quest’ultimo caso, che per la storia del teatro è
naturalmente il più rilevante, sarà finalmente interprete, joueur de personnage o player of
Interludes, lascerà il titolo di giullare solo ai buffoni da fiera, e diventerà in senso pieno operatore di
49
Mukařovský, 1973, p. 410.
Mi si consenta di rinviare, per una trattazione più estesa di questi temi relativi alla teatralità
popolare, a Allegri, 1978, pp. 55-99.
51
Si veda quanto riferisce Faral, 1910, p. 125, a proposito dei cantori di gesta che ricorrono appunto
a questi espedienti.
52
Levi, 1915, p. 57.
50
teatro, intrattenendo col proprio pubblico non più rapporti di coinvolgimento ma di alterità
spettacolare.
F. Taviani, M. Schino
Il segreto della Commedia dell’Arte
Firenze, La Casa Usher 1982, pp. 309-29.
La produzione di teatro
SOMMARIO: L’evanescente concetto di improvvisazione – Teatro scritto e teatro non scritto – Le azioni e la dicitura –
La concezione classica della drammaturgia alla base della Commedia dell’Arte.
Un solo elemento attraversa sempre apparentemente uguale i disparati fenomeni e i diversi momenti
di teatro raccolti nell’idea di Commedia dell’Arte: l’improvvisazione. Sembra essere questo il
nocciolo reale di quell’immagine ideale di teatro emanata — soprattutto nell’emigrazione — dalle
multiformi attività dei comici italiani. I loro disparati teatri sarebbero, cioè, riconducibili ad
un’unica varietà, ad una specificità che li apparenta, poiché il tema dell’improvvisazione, dalla metà
del Cinquecento alla fine del Settecento, offrirebbe una continuità tale da giustificare che, a dispetto
di ogni altra considerazione, si parli di un teatro unitario. di uno stile, forma o genere preciso. La
tecnica dell’improvvisare, dagli italiani — soli fra tutti — posseduta, sviluppata, trasmessa di
generazione in generazione, costituirebbe il segreto della Commedia dell’Arte, sia esso un semplice
segreto di fabbricazione o un più sostanziale segno di saggezza teatrale. Nel 1700, quando i comici
italiani erano già stati cacciati da Parigi, Evaristo Gherardi presentando il loro repertorio di
commedie scriveva così:
Non dovete aspettarvi di trovare in questa raccolta tutte intere le commedie [...] Il teatro degli italiani
non può essere stampato, perché sono attori che non imparano testi a memoria e basta loro, per
rappresentare una commedia, d’averne letto il soggetto un attimo prima di entrare in scena.
La più grande bellezza delle loro storie sceniche, per ciò, è inseparabile dall’azione, perché il
successo delle loro commedie dipende in tutto e per tutto dagli attori che le rendono più o meno
piacevoli a seconda che abbiano più o meno abilità e intelligenza o a seconda della situazione in cui
si trovano a recitare. E questa necessita di recitare da un momento all’altro, senza preparazione, che
fa sì che sia tanto difficile sostituire un attore italiano quand’egli viene a mancare. Tutti possono
imparare a memoria un testo e poi recitarlo; ma occorre ben altro per essere un buon attore della
Comédie Italienne.
Chi dice “buon attore della Comédie Italienne” dice un uomo che ha una sua personalità, che recita
più con la propria immaginazione che con la memoria, che compone quel che dice nel momento
stesso in cui lo recita, che sa assecondare colui con il quale si trova sul palcoscenico, che sa, cioè,
sposare cosi bene le proprie parole e le proprie azioni alle parole e alle azioni del compagno da
inserirsi subito nella linea d’azione dell’altro e muoversi così come questa gli richiede, tanto da far
credere a tutti che sia una cosa preparata.
L’intento di Evaristo Gherardi non era, però, quello di spiegare ai lettori quali fossero i
procedimenti degli attori italiani, era piuttosto il desiderio di affermare che solo in loro l’arte
scenica trovava compimento. Affermava, infatti:
Un attore che recita semplicemente a memoria non entra in scena altro che per dir giù la sua parte il
più presto possibile così come l’ha imparata, ed è troppo occupato per prendersi cura dei movimenti
e dei gesti del compagno. Egli va diritto per la sua strada con la sfrenata impazienza di liberarsi della
sua parte come di un peso da gettar via per riposarsi. Di questi attori si può dire che sono come
scolari che vengono a ripetere, tremando, la lezione imparata con cura. O meglio: sono simili all’eco,
che mai parlerebbe se un altro non avesse parlato prima. (Gherardi, 1700, Avertissement)
Più che essere un documento sulla tecnica dell’improvvisazione, la pagina del Gherardi documenta
la volontà di celebrare i comici italiani in un documento in cui la loro fama poteva affidarsi soltanto
al ricordo, alle parole scritte o alle rievocazioni dei pittori. Si può pensare, infatti, che quel che
Gherardi scrive sia altrettanto lontano dalla realtà di quanto lo fossero i quadri e le stampe di Gillot
o Watteau che pretendevano di rappresentare la Comédie Italienne.
L’effetto che il Gherardi ottiene, quell’idealizzazione dell’improvvisazione, cioè, che più tardi,
sposandosi con la mentalità romantica, produrrà l’idea più comune e sbagliata della Commedia
dell’Arte come teatro della spontaneità e della libera fantasia creatrice, deriva da un accostamento
strampalato, che a dispetto d’ogni logica contrappone l’attore che improvvisa non a quello che non
improvvisa, ma semplicemente al cattivo attore. Il trucco è talmente smaccato che rischia d’esser
controproducente, tanto che il Gherardi, prima di chiudere il discorso, si affretta a smorzare l’enfasi
ricordando come vi siano eccellenti attori anche fra quelli che recitano a memoria, ma affermando
che in questo caso essi sono eccellenti proprio perché riescono a mascherare l’arte con l’arte, così
come i pittori fan sembrare naturale l’artificio.
Due dei diversi temi che si alternano nelle testimonianze sull’improvvisazione dei comici italiani, i
due temi più appariscenti, sono ben esemplificati dalla pagina del Gherardi: da una parte lo stretto
collegamento fra idealizzazione dell’improvvisazione e difesa della Commedia dell’Arte; dall’altra
la tendenza ad identificare recitazione naturale e recita improvvisata.
Mario Apollonio (1930, p. 188) avvisa, a proposito delle discussioni intorno ai limiti
dell’improvvisazione dei comici dell’arte, che «sarà bene notare che fra i contemporanei della
Commedia dell’Arte chi le è favorevole ammette la recitazione improvvisa, chi le si oppone parla di
repertorio e di zibaldoni». Il che è vero almeno nel senso che la magnificazione
dell’improvvisazione, come metodo compositivo proprio del modo italiano di far teatro, ritorna ogni
volta in cui siano in pericolo la presenza o gli usi delle compagnie italiane. È questo il contesto, per
esempio, in cui Carlo Gozzi, sul finire del XVIII secolo, alla fine dell’ultima grande battaglia sui
comici dell’Arte — la battaglia che meno servì alla loro vita materiale e più alla loro sopravvivenza
ideale — parla ancora una volta dell’improvvisazione come tecnica della recitazione naturale (cfr.
Gozzi, 1797, parte II, cap. I). La tendenza ad identificare recitazione naturale e recita improvvisata
deriva dalla contrapposizione fra attori italiani e attori francesi; è questa contrapposizione a essere
concretamente sperimentata dagli spettatori, che poi immaginano di individuare la causa
nell’elemento più evidente — o più appariscente e noto — degli italiani. Così Charles De Brosses,
in una delle sue Lettres de l’Italie (cfr. Duchartre, 1955, p. 39), dopo aver rilevato come il sistema
di recitare all’improvviso renda più incerto lo stile, afferma che esso dà però agli attori un’aria
naturale, per cui vanno e vengono sulla scena e parlano fra di loro come se fossero sulla via o nella
propria casa. Ma la connessione improvvisazione-naturalezza avviene, nello sguardo dello
spettatore De Brosses, perché egli — dice — confronta mentalmente gli italiani ai francesi.
Possiamo cioè vedere, nel concreto riflesso condizionato di uno spettatore, l’origine — in senso
logico, non cronologico — della retorica e inconsistente contrapposizione tracciata dal Gherardi. È
bene insistere su questo fatto: è per il confronto con i francesi, non per l’improvvisazione, che gli
italiani appaiono naturali. Ed è perché appaiono naturali, che l’improvvisazione viene identificata
come portatrice di naturalezza. L’idea base, in altre parole, è quella che contrappone stile italiano a
stile francese, una contrapposizione che istituisce un modo di guardare il teatro che Watteau aveva
fissato nei due quadri contrapposti L’Amour au Théâtre Italien e L‘Amour au Théâtre Français e
nelle stampe da essi derivate, e che — naturalmente — colora il modo in cui si guarda
l’improvvisazione scenica, i suoi caratteri, i suoi effetti, la sua giustificazione.
Si direbbe, però, che più ci si allontana dall’ambiente francese e dall’esigenza di difendere la
Commedia dell’Arte, più l’improvvisazione trascolora.
Torniamo, allora, a Luigi Riccoboni, che scrive in Francia per i francesi, ma incarna l’atteggiamento
degli intellettuali italiani verso il teatro. Ne L’Histoire du Théâtre Italien scrive:
L’improvvisazione permette una variazione nel recitare, di modo che, anche se si vede più volte lo
stesso canovaccio, si può vedere ogni sera una diversa rappresentazione. L’attore che recita
all’improvviso recita in maniera più vivace e più naturale di quello che recita una parte imparata a
memoria: è più facile sentire e quindi si dice meglio quel che si è composto da sé, che non quel che
si prende dagli altri con l’aiuto della memoria. Ma questi vantaggi della commedia recitata
all’improvviso sono pagati da molti inconvenienti: essa richiede attori ingegnosi e più o meno
ugualmente bravi, perché lo svantaggio dell’improvvisazione consiste nel fatto che la recitazione del
miglior attore dipende assolutamente da colui con cui dialoga: se si trova con un attore che non sa
cogliere con precisione il momento della replica, e che l’interrompe a sproposito, il suo discorso
langue e la vivacità dei suoi pensieri viene soffocata. (Riccoboni, 1728, pp. 61-62)
Apparentemente, l’impianto del discorso del Riccoboni è simile a quello del Gherardi, anche se con
più attenzione al concreto e maggior ricchezza di dettagli. Ma questi dettagli spostano il discorso
dalla generale valutazione dell’improvvisazione per l’arte dell’attore, ad una sua più circostanziata
valutazione sul piano della drammaturgia e della veste letteraria della commedia. Tutti gli elementi
del brano si muovono con sicurezza in questa direzione: la possibilità di operare variazioni sullo
stesso canovaccio; il vantaggio, per l’attore, di trovar da sé le proprie battute; la difficoltà
d’alternarsi bene nel dialogo quando le battute non siano fissate e non si sappia, quindi, quando il
compagno ha finito di parlare. Nella stessa direzione, infine, Riccoboni spinge il discorso quando
esamina gli aspetti più negativi dell’uso di recitare all’improvviso:
Per facilitare gli attori mediocri a recitare la commedia all’improvviso è stato necessario ricorrere ai
monologhi e a quei luoghi comuni che gli italiani chiamano robbe generiche di cui gli attori si
servono a seconda delle necessità e delle situazioni sceniche. Questo modo di dialogare non vale
nulla, perché spesso accade che si piazzano delle belle massime così mal a proposito che esse non
quadrano con ciò che l’interlocutore ha appena detto e sono del tutto fuori tema. (Riccoboni, 1728, p.
63)
A differenza di ciò che capiscono alcuni moderni, Riccoboni non dice che il ricorso alle robbe
generiche è dannoso perché rompe l’improvvisazione, ma perché è un uso letterariamente
inadeguato di luoghi comuni al posto di testi appropriati ed adattati all’individualità della
situazione. Benché le parole del Riccoboni siano spesso simili a quelle del Gherardi, egli si trova in
una zona del tutto diversa e si occupa dei pregi e dei difetti dell’improvvisazione non per il gioco
scenico degli attori, ma per la composizione della commedia, per la sua scrittura in azione.
Essenziale non è più il fatto che il testo sia improvvisato dall’attore, ma che sia composto da lui.
L’improvvisazione, cioè, viene a significare una personalizzazione del testo, più che una
composizione all’improvviso. È questo l’aspetto che Riccoboni discute per i francesi: la
drammaturgia dell’attore italiano, il quale parla in scena con parole che egli stesso ha composto, che
vengono dalla sua immaginazione e che non ha preso dal di fuori, da un poeta. (cfr. Riccoboni,
1728, p. 63)
Ma negli stessi anni, e forse negli stessi mesi, Riccoboni scrive dell’improvvisazione anche in
italiano e per gli italiani:
Non vi fu mai chi più di me avesse in odio la stravagante usanza di recitar comedie a l’improvviso e
chi forse più di me si sia servito di questo comodo. Per un comico diligente, morigerato e non affatto
ignorante, confesso che l’invenzione non è pericolosa servendogli anzi di stimolo per ben parlare e
per erudirsi. Ma io l’ho sempre abborrita poiché per esperienza ho conosciuto che al comico
ignorante e scostumato (che pur troppo alle volte se ne trovano) l’uso di recitare a l’improvviso gli
serve di facilità per studiar solamente come inserire ne’ suoi discorsi qualche oscenità. (Riccoboni,
Scenari inediti, p. 30)
In questo caso, l’improvvisazione è solo — come Riccoboni (Scenari inediti, p. 11) ha scritto
qualche pagina prima — un «uso inveterato» o un «comodo» che marchia, facilitandolo, il lavoro
teatrale delle compagnie, lo rende più veloce, ma anche più aperto agli arbitri e alle prepotenze
sceniche dell’uno e dell’altro attore.
Cominciamo così lentamente a vedere che il filo dell’improvvisazione, che sembra percorrere tutti i
teatri delle compagnie italiane dal XVI al XVIII secolo e in realtà composto di due fili che spesso
sono fra loro intrecciati, ma che possono anche correre separati: l’uno è costituito dalla
drammaturgia d’ogni singolo attore della commedia; l’altro dall’uso di rappresentare commedie con
poca o punta premeditazione, come per sorpresa o su due piedi.
Si tratta di due cose diverse, che possono essere di fatto unite, ma che non lo sono di diritto, e
possono, quindi, non aver nulla a che vedere l’una con l’altra.
Nelle testimonianze dei contemporanei, per il peso della pratica, le due cose si mischiano, ma se si
osserva bene, ci si accorge che è possibile una commedia premeditata, che però è prodotta dal
comporsi dei diversi interventi drammaturgici dei diversi attori attorno allo scheletro del
canovaccio, mentre d’altra parte è possibile una commedia all’improvviso in cui, però, non c’è
l’intervento della personale drammaturgia degli attori. Il primo caso è quello forse più diffuso nella
Commedia dell’Arte, in cui commedie molte volte recitate e ben concertate risultano dagli apporti
dei loro singoli attori e necessitano una nuova concertazione quando cambia un attore. Il secondo è
quello di commedie stese in ogni loro parte, che però gli attori non imparano a memoria — per
necessità o pigrizia — e che in qualche modo ricostruiscono all’improvviso, in poco tempo.
supplendo con l’invenzione al non saputo o — come si diceva nel gergo teatrale — andando a
suggeritore.
Accenna a questa seconda possibilità una testimonianza della metà del Seicento:
Orsù, diciamo che il virtuoso recitare in scena è una bella grazia, anzi è un compendio di molte
grazie, le quali molti mercenari e moderni comici scuoprono improvvisamente nel moderno teatro.
Non hanno tutte le rappresentazioni stese di parola in parola; o se pur le hanno, essi non le mandano
alla memoria nel modo de’ recitanti fanciulli o de’ verbali auditori, ma, apprendendole bene prima in
sostanza, come per brevi capi e punti ristretti, recitando poi improvvisamente, o quasi
improvvisamente, così addestrandosi ad un modo di recitar libero, naturale e grazioso. (Ottonelli, V,
capo IV, punto VIII)
L’accenno ai «recitanti fanciulli» è forse lo spunto concreto da cui il Gherardi, nel brano citato
all’inizio del capitolo, svilupperà la similitudine fra attore che impara a memoria il testo e scolaro
che ripete tremando la lezione. La testimonianza del gesuita Ottonelli, forse la persona più attenta ai
teatri degli attori fra quante se ne interessarono fra Cinque e Settecento, persona straordinariamente
attenta perché non interessata al teatro per il teatro, ma perché spinta da preoccupazioni morali,
civili, religiose, da simpatie e indignazioni che nascevano fuori dal teatro e al teatro tornavano con
tutta la forza, l’interesse e la fascinazione di una vera vocazione anti-teatrale, la testimonianza
dell’Ottonelli, dunque, passa velocemente dall’uno all’altro dei due poli fra cui oscillano le
testimonianze sull’«uso inveterato», il «comodo» di recitare all’improvviso: la coscienza del
pressappochismo e lo stupore per il virtuosismo. Come la tradizione aneddotica dei comici
dimostra, fino alle soglie del nostro secolo, pressappochismo comico e virtuosismo d’attore sono
l’uno l’altra faccia dell’altro, basta cambiare il punto di vista perché l’uno diventi l’altro e
viceversa. Uno degli schemi più ricorrenti dell’aneddotica teatrale è quello che mostra la bravura di
un attore attraverso il modo in cui ripara ad un errore, ad una trascuratezza o ad una mancanza di
preparazione sua o di un compagno. Le bravure dell’improvvisazione, in questo caso, non sono
altro che il rimedio alle lacune della professione. Ma in questo caso esse non hanno o non
dovrebbero aver nulla a che vedere con ciò che e stata chiamata Commedia all’improvviso. Eppure
il problema dell’improvvisazione nella Commedia dell’Arte è così confuso e poco chiaro che si
fanno confusioni anche fra teatro improvviso e aneddotica del rimedio improvvisato.
È il caso di Carlo Gozzi, che racconta — nelle Memorie inutili — quel che gli capitò un giorno a
Zara, mentre per diletto recitava una farsa improvvisata al teatro di corte, interpretando il
personaggio di Luce, moglie «mal maritata di Pantalone vizioso, rotto e fallito».
A causa del ritardo dell’attore che doveva interpretare Pantalone, Gozzi improvvisò — racconta —
una serie di azioni ed un lungo monologo in cui fece la satira del malcostume di una donna ch’era
tra il pubblico e a causa della quale aveva avuto da soffrire, ottenendo, così, un grande successo
(Gozzi, 1797, parte I, cap. XIII). Aneddoti di questo tipo percorsero le conversazioni, le cronache e
le memorie dei comici, e ancora le percorrono. La morale della favola, al di là del carattere
divertente della storia, è che un buon attore deve saper far fronte all’imprevisto e riempire gli
eventuali buchi della rappresentazione. Ma Gozzi formula così questa conclusione: «Che un buon
Comico all’improvviso non si deve sbigottire e non deve mancare di ciarle», attribuisce, cioè, al
comico all’improvviso una dote che invece dev’esser propria d’ogni comico. La confusione fra
improvvisazione come pratica scenica peculiare delle compagnie italiane e quel tipo di
improvvisazione o capacità di comporre per necessità su due piedi — che caratterizza, invece,
qualsiasi professionista — mostra quanto siano fragili — se osservate da vicino — le testimonianze
sul carattere improvviso della Commedia Italiana che invece, viste dall’alto e prese tutte quante
insieme e all’ingrosso, sembrano individuare con sicurezza un genere di teatro preciso e
circoscrivibile.
C’è, poi, un’altra confusione: quella fra improvvisazione come modo di produzione del teatro e
improvvisazione come dimostrazione ed esercitazione accademica. Questa confusione è facilitata
dal fatto che alcune delle più dettagliate testimonianze sul recitare all’improvviso sono di dilettanti
accademici; dal desiderio dei comici di nobilitare il proprio lavoro; da un generico riconoscimento
di una predisposizione italiana all’improvvisazione visibile sia nel teatro prodotto dalle compagnie
italiane che nel fenomeno tipicamente italiano dei verseggiatori all’improvviso; e infine da alcuni
casi obiettivi di riutilizzazione teatrale di tecniche accademiche di improvvisazione. Persino il
Perrucci, per il quale la recitazione all’improvviso individua un genere preciso di teatro, tende poi a
sovrapporla all’esercitazione e ai giochi accademici basati sull’improvvisazione. (cfr. Perrucci
1699, qui come Ill. Lett., VI, 13)
Ancor più sintomatico il fatto che nelle pagine di Scipione Maffei — colui che con l’alleanza del
Riccoboni condusse la campagna contro la pratica del teatro improvviso, per la formazione di un
repertorio classico nazionale — il tema dell’improvvisazione inneschi il passaggio dalla denuncia
della pigrizia e del pressappochismo dei comici all’ammirazione del loro virtuosismo, fino a
rivendicare agli italiani il genio dell’improvvisazione in generale, mischiando commedia
all’improvviso e poeti estemporanei.
Il Maffei sta parlando dell’uso del verso nelle tragedie e nelle commedie e deprecandone
l’abbandono:
Or benché non poche commedie si venissero poi anche in prosa rappresentando, si ritenne però
insieme l’uso del verso per tutto il secolo decimosesto; ma nel susseguente gustando i comici nel
parlar comune e sciolto il piacere della libertà, per non restar legati a parole e per poter in tal modo
recitare senza applicazione, cotal pigrizia gli fece a poco a poco abbandonare il verso del tutto, tanto
più che l’uso della moderna commedia li costrinse a riempire le compagnie di persone incapaci di
ben proferirlo. Si aggiunse, per invaghirli della prosa, la mirabil facilità loro, affatto incognita ai
comici d’altre nazioni antiche e moderne, di parlare in tal forma ottimamente a soggetto, cioè
all’improvviso. Egli è noto che scene abbiam moltissime volte udito in tal guisa, senza precedente
concerto alcuno, tanto graziose, tanto ben girate e con tal vivezza di facezie e con tal naturalezza di
sentimenti e con tal prontezza di risoluzioni che non sarebbe possibil mai di scriverle meglio al
tavolino. La qual dote cominciò in alcuni di costoro fin nel primo formarsi delle compagnie, poiché
Adriano Valerini, famoso comico veronese e autor di rime e dell’Afrodite tragedia, in un’orazione
che pubblicò il 1570 nella morte d’una donna di tal professione, racconta come l’Accademia de
gl’lntronati di Siena avea giudicato riuscir costei «meglio assai parlando d’improvviso, che i più
costumati autori scrivendo pensatamente» [cfr. Valerini 1570, qui come Ill. Lett. II, 8]. Gli stranieri
che ciò non credono, procurino d’udire i nostri odierni poeti estemporanei, ed abbian per certo che da
poi crederanno de gl’italiani in materia d’ingegno e di talento ogni cosa. Sia lecito il farsi qualche
volta giustizia da sé. (Maffei, 1723, pp. IX-X)
L’andamento del discorso del Maffei può apparire inconseguente: non solo, infatti, egli opera una
digressione dal suo argomento — l’uso del verso nei testi teatrali — ma attraverso minuscoli
slittamenti dell’attenzione passa da un atteggiamento negativo nei confronti degli attori che con i
loro usi contribuiscono ad allontanare il verso dal teatro, ad una chiacchierata in lode dei comici che
recitano all’improvviso. Pochi anni prima del Maffei, il suo amico Ludovico Antonio Muratori
aveva affrontato lo stesso argomento nel 6° capitolo del 3° libro Della perfetta poesia italiana
(pubblicato a Modena nel 1706 e in seconda edizione nel 1724), procedendo in linea retta dalla
considerazione dei pregi del verso nella poesia drammatica alla necessità di buoni attori che
sappiano recitar in versi, e da qui alla condanna di quegli istrioni moderni, «uomini per ordinario
ignoranti», i quali non fanno altro che recitare «quel solo che loro piace» e vanno in scena
servendosi «del solo soggetto, come lo chiamano, cioè della sola ossatura delle commedie, che
poscia all’improvviso è da loro rivestita con le parole». Un discorso talmente rettilineo che il
Muratori concludeva esortando i principi e i governanti delle città a proibire le commedie
all’improvviso ed altre «scipitezze» del genere. Il discorso del Maffei, invece, pur partendo dalle
stesse premesse e svolgendosi alla luce degli stessi principi, è come se si lasciasse a poco a poco
dirottare da una simpatia per la Commedia dell’Arte che si insinuava fra le crepe della sua pur
severa presa di posizione culturale.
Accade cioè al Maffei quel che accade, nello stesso anno 1723, a Pier Jacopo Martello nella lettera
a Giovan Battista Recanati sull’insuccesso della Scolastica dell’Ariosto messa in scena dal
Riccoboni (Ill. Lett. VI, 16): nell’un caso come nell’altro sembra quasi che il discorso scritto si lasci
andare, come nel parlar rilassato può avvenire, a concludere il contrario di ciò per cui era partito.
Ma si tratta soltanto di un’impressione dovuta alla nostra ottica. Per il Maffei, come per il Martello
o per il Riccoboni, non c’è contraddizione fra un giudizio negativo in nome delle virtù dell’Arte e
della Poesia e la curiosità divertita e un po’ campanilistica, sul piano dell’aneddoto, per il
virtuosismo degli attori di mestiere. Il teatro di cui loro parlano è il teatro come «per sua natura
dovrebbe essere», e non ha nulla a che vedere con ciò che in palcoscenico fanno i comici. Ciò non
toglie che quei comici siano bravi e divertenti nel loro genere, anche se abusivi.
È, insomma, l’atteggiamento di autorità e condiscendenza, di commiserazione e tenerezza che
l’intellettuale ha verso una miseria ingegnosa.
Così, mentre nella cultura francese — o parigina — i teatri delle compagnie italiane venivano
proiettati nell’irrealtà di un genere teatrale ideale, che presto coinciderà con l’idea stessa di fiaba
scenica e di grottesco che vivifica l’immaginazione degli uomini di teatro europei; nella cultura
italiana i teatri dell’Arte venivano proiettati nell’irrealtà dell’aneddotica che continuerà a lungo a
suscitare la divertita curiosità di coloro stessi che persevereranno a bollare il fenomeno come
sintomo di decadenza artistica e culturale. Questa distinzione dura fin quasi ai giorni nostri: mentre
gli uomini di teatro e gli studiosi europei rischiano di farsi un’idea completamente immaginaria
della Commedia dell’Arte; gli studiosi italiani, più legati al particolare e apparentemente più attenti
ai fatti, rischiano di perdere continuamente il rispetto per l’argomento del loro studio, e lasciano che
le loro pagine siano percorse dal riso di superiorità di chi si illude d’esser meno futile dei capricci
che scava dal passato. (cfr. nota 36 [qui omessa])
Sia per l’uno che per l’altro atteggiamento, l’improvvisazione di cui tutti parlano per affermarne o
per negarne la presenza nella Commedia dell’Arte, o per limitarne l’estensione, ma sempre come di
cosa che si sa cosa sia, diventa a ben guardare un concetto evanescente in cui si mischiano il
giudizio su un modo naturale di recitare, la definizione di uno stile italiano di recitazione
contrapposto al francese, la drammaturgia degli attori, l’esercitazione e la dimostrazione
accademica, il gioco prestigioso della composizione estemporanea, il rimedio improvvisato e la
ripetizione imprecisa, andando a suggeritore, di un testo mal appreso. A tutto questo deve
aggiungersi ciò che è forse fondamentale per l’improvvisazione scenica: la capacità di improvvisare
usando il pubblico come interlocutore, sorprendendo le sue attese e giocando con le sue reazioni (su
questo cfr. Apollonio 1968, p. 164 e Ill. Lett. VI, 16). Proprio perché si tratta di un elemento
fondamentale, però, riguarda tutto il teatro comico, e non ha nessun titolo per caratterizzare in
particolare la Commedia dell’Arte.
Ma la causa principale della difficoltà ad orientarsi, quando si parla dell’improvvisazione della
Commedia dell’Arte, non sta nel suo ridursi a concetto evanescente. La difficoltà diventa, anzi,
tanto maggiore quanto più si cerca di analizzare con precisione il problema, perché
l’improvvisazione — teatrale o no — si trascina dietro quasi per necessità una serie d’altri problemi
che non si identificano con essa, ma che vi aderiscono così strettamente da ricoprirla quasi del tutto.
Attraverso l’esame delle tecniche dell’improvvisazione e dei problemi pratici e teorici che esse
comportano, infatti, emergono con particolare chiarezza — quasi per l’accelerazione cui sono
sottoposti per il fatto di svolgersi allo scoperto — i problemi riguardanti le tecniche di
composizione. E evidente che una cosa è la composizione scenica e altra cosa l’improvvisazione,
ma altrettanto evidente è che a volte i principi dell’improvvisazione altro non sono che principi di
composizione così ben posseduti da poter essere applicati velocemente e quasi per istinto, così
come — reciprocamente — a volte alcuni problemi per la composizione emergono chiari quando si
immagina che la loro concatenazione logica riproduca una catena cronologica di fatti, come se
elementi implicati logicamente l’uno dall’altro comparissero storicamente uno dopo l’altro nel
corso del lavoro teatrale. Così, per esempio, Maurice Sand (Ill. Lett. 1, 1) crede che ciò che emerge
in una seduta di improvvisazione teatrale rispecchi nelle sue diverse fasi lo sviluppo storico del
teatro dell’Arte; e altri credono che elementi che derivano la loro necessità l’uno dall’altro,
caratterizzino altrettante fasi storiche. Secondo questo modo di guardare, che identifica modello
logico e sviluppo storico, il fatto che la drammaturgia degli attori determini l’esistenza degli
zibaldoni o «robbe generiche» fa credere che nella storia dell’improvvisazione dei comici si siano
succedute fasi ed epoche diverse caratterizzate prima da una vera e propria creazione
drammaturgica, e poi dalla decadenza con l’uso di pezzi precostituiti e generici. Il primo
responsabile di questo equivoco fu probabilmente Francesco Saverio Quadrio che nella seconda
parte del terzo volume Della storia e della ragione d’ogni poesia (Milano 1744, p. 223) dice che il
«provvedersi di certi squarci imparati a memoria, quasi di luoghi topici, onde valersi non pur nei
soliloqui […] ma ancor nei dialoghi» fu dovuto alla decadenza degli attori dopo il 1680. È stata una
lettura approssimativa del Riccoboni (1728, p. 63) a spingere il Quadrio a questa strana
affermazione, contraddetta sia dalle notizie documentate che dal buon senso. È, invece, una lettura
troppo fiduciosa del Quadrio a perpetuare l’equivoco: quando il suo modo meccanico di concepire il
divenire storico viene accettato e riletto con occhi moderni (cfr. ad es. Tessari, 1969, pp. 80 e 225)
esso determina l’abbaglio secondo cui ad una fase dell’improvvisazione come naturalezza e talento
naturale succederebbe un momento di riflusso in cui l’improvvisazione non sarebbe più nient’altro
che una tecnica compositiva. Ma la contrapposizione fra un’inesistente improvvisazione «vera e
propria», naturale e antiletteraria, e un’improvvisazione come composizione e montaggio di pezzi
precostituiti e variazione attorno ad essi è una contrapposizione anacronistica.
Forse la più interessante analisi dell’improvvisazione della Comédie Italienne e quella di JeanAugustin-Julien Desboulmiers, uno scrittore parigino di racconti e romanzi piccanti, specializzato
nell’aneddotica indiscreta, morto quarantenne nel 1771. Nel 1769, Desboulmiers pubblica 7
volumetti di Histoire anedoctique et raisonnée du Théâtre Italien, nel primo dei quali affronta, fra
l’altro, il tema dell’improvvisazione:
Un attore riempie la sua immaginazione di tutte le idee dell’autore e cerca le differenti vie per
condurre il dialogo a coincidere con tutti i punti dell’azione. Un altro, che deve aver parte anche lui
alla stessa scena, la studia anch’egli fra sé, e naturalmente immagina di costruirne il dialogo in
tutt’altra maniera. Ed ora ecco i due attori in scena, pieni ciascuno del proprio carattere e della
propria situazione. Tutti e due tendono allo stesso punto dell’azione, ma obbligati a rispondersi
sensatamente e legati, per necessità, agli stessi argomenti, sono forzati ad abbandonare a poco a poco
la via che avevano premeditato, per adeguarsi a quella che l’altro vuol seguire. È questo che dà alla
scena un carattere di naturalezza e verità tale che anche il miglior scrittore può raggiungerlo solo
raramente. Nasce qualcosa di più di quel che può nascere da un testo scritto, qualcosa che nasce
come per un lampo e nell’istante stesso della rappresentazione. (Desboulmiers, 1769, I, p. 33)
La descrizione che Desboulmiers fa dell’improvvisazione è particolarmente acuta, lascia da parte
tutti i luoghi comuni e si ferma su di un aspetto centrale ed in genere ignorato: come l’effetto di
naturalezza e di verità nasca dal conflitto fra due opere di creazione non coincidenti, da una
tensione che crea energia o dalla sfasatura fra le due ottiche diverse dei due attori, che tendendo per
vie diverse allo stesso punto, creano la profondità del campo drammatico. È evidente, però, che più
che un discorso sull’improvvisazione, Desboulmiers fa un discorso sulla composizione, e cioè su
come la commedia possa essere tessuta tendendo ed intrecciando i fili delle diverse drammaturgie
dei diversi attori. Egli, infatti, continua così:
D’altra parte, quando si rappresenta la stessa commedia, gli attori hanno gran cura di ricordarsi tutti i
particolari che han fatto buon effetto il primo giorno e non mancano di rimetterli allo stesso posto, il
che non impedisce di far sbocciare nuovi fiori improvvisati che si aggiungono ai primi nella memoria
degli attori. La commedia resta in repertorio, cento attori differenti si succedono gli uni agli altri nel
rappresentare lo stesso canovaccio e vi introducono sempre qualcosa di nuovo. Alla fine, le scene
sono così piene che si rimane colpiti dalla quantità di particolari e di trovate teatrali che contengono.
Per recitare perfettamente occorre solo essere ben istruiti della tradizione teatrale. Così,
l’improvvisazione è, in fondo, una questione di memoria. (Ibidem)
L’improvvisazione, insomma, non è l’improvvisazione; e la rappresentazione premeditata si
distingue dall’altra, detta «all’improvviso», perché meno «a memoria», perché si rifà solo ad un testo
fisso, e non ad una tradizione fissata in tutti i suoi particolari. I paradossi cui ci conduce JeanAugustin-Julien Desboulmiers son meno paradossali di quanto sembra. Nel momento in cui il
discorso si fa più preciso e non si aggira più intorno ad un concetto evanescente, esso va oltre
l’improvvisazione e mostra come abbia veramente consistenza, piuttosto, il problema della
composizione delle commedie alla maniera dei comici. È di questo che in realtà parlano studiosi
contemporanei come Mic ed Apollonio nelle pagine che formalmente dedicano, invece,
all’improvvisazione. E da questo punto di vista diventa futile, diventa la traccia di una vecchia
confusione e l’eco di quel concetto vuoto di cui s’è parlato, la discussione, tanto annosa quanto
imprecisa, sui limiti dell’improvvisazione in rapporto all’uso dei pezzi precostituiti. Così come
diventa inutile o per lo meno non essenziale tentare di «salvare» l’esistenza dell’improvvisazione
della Commedia dell’Arte spostandola idealmente, dall’improvvisazione dei materiali
all’improvvisazione del loro montaggio.
Tutto questo può essere vero, e certamente in molti casi lo fu. Ma quel che è più importante rilevare
è che il tema dell’improvvisazione dei comici dell’Arte, con tutte le implicazioni e le associazioni
che esso trascina con sé, è il riflesso di un altro problema e ne è, insieme, lo schermo.
Scrive il Nicoll:
La virtù dell’improvvisazione fa degli attori altrettanti autori. La misura dell’improvvisazione
certamente variò a date diverse, in diverse compagnie e da un attore all’altro; ma dal principio alla
fine essa fu il fattore che determinò la particolare qualità dello stile italiano, distinguendolo da altri
metodi teatrali.
E aggiunge:
Di recente sono stati fatti alcuni tentativi di negare questa virtù, che però rimane tale. (Nicoll, 1963,
pp. 27-28)
Di fronte a frasi come questa, siamo ora in grado di diffidare.
Il luogo comune di un genere teatrale che si distingue dagli altri perché in possesso del segreto
dell’improvvisazione si è dimostrato costruito di pezzi eterocliti, che non stanno insieme. Sappiamo
che non è l’improvvisazione l’essenziale, ma ciò che essa cela, cioè la drammaturgia degli attori. Il
Mic lo dice con queste parole:
Sembra improbabile che un teatro che portava in scena soggetti estremamente complicati, con un
numero rilevante di personaggi, potesse basarsi sulla pura improvvisazione [...] Il carattere essenziale
della Commedia dell’Arte, comunque non consisteva nell’improvvisazione [...] ciò che la
caratterizzava era piuttosto il fatto che uno spettacolo dell’Arte non era sottomesso alla volontà d’un
unico aurore. (Mic, 1927, p. 125)
Il Mic prosegue ripetendo ciò che diceva Riccoboni, in uno dei brani citati nel corso di questo
capitolo, e cioè che per gli attori sarebbe più facile «sentire» ciò che hanno loro stessi composto,
piuttosto che ciò che è stato scritto da altri e da loro imparato a memoria. Ma noi non lo seguiremo
su questa strada. Ci domandiamo, invece, cosa significhi, storicamente, la produzione di uno
spettacolo non sottoposto alla volontà di un unico autore. Per comprenderlo dobbiamo risalire
indietro nel tempo, alla metà del Cinquecento, negli anni in cui s’era svolto il Concilio di Trento e
se ne applicavano le riforme; e in cui nasceva, ad opera delle compagnie italiane, il «teatro moderno
in quanto teatro» (cfr. Ill. Lett. IV, 8).
* * *
La data simbolica per l’origine della Commedia dell’Arte, il 1545, anno a cui risale il primo
contratto a noi noto della formazione d’una compagnia (Ill. Lett. IV, 3), è anche la data d’inizio del
Concilio di Trento. I rapporti fra i comici di professione e gli uomini che rappresentavano
l’ideologia morale e religiosa sancita dal Concilio non furono facili, anche se furono infinitamente
più facili e morbidi di quelli che intercorsero fra i professionisti del teatro e i religiosi delle
confessioni non romane. Se da quei rapporti e da quegli scontri non derivarono atti di intolleranza
definitiva, derivarono, però, pagine e pagine polemiche e predicatorie, editti, lettere, pareri, che
sono, sì, la testimonianza di un’attenzione fatta di minacce e di irritazione, ma che trasmettono più
notizie sull’ambiente del teatro di quante ne abbiano trasmesse tutti assieme i teatri e i loro
spettatori di quegli anni (cfr. Ill. Lett. V; Taviani 1969 e 1971).
C’è, fra queste notizie, anche una delle prime testimonianze sull’improvvisazione degli attori
italiani, e proviene da un Cardinale.
Gabriele Paleotti, creato cardinale il 12 marzo 1564, alla chiusura del Concilio di Trento,
Arcivescovo di Bologna dal 1566, aveva lavorato a lungo alla Curia di Roma, dove s’era fatto una
particolare esperienza in materia di libri proibiti. Come Arcivescovo sapeva quindi servirsi bene
degli strumenti che il Concilio metteva in mano alle autorità ecclesiastiche per regolare la
trasmissione della cultura, dando loro il potere di permettere o proibire le nuove pubblicazioni e le
rappresentazioni teatrali pubbliche che — secondo un’opinione rigorosa — dovevano regolarsi per
analogia con la stampa. Ma nel caso delle commedie fatte dai comici di professione, sosteneva il
Paleotti, esse andavano proibite in blocco: ciò che il Cardinale innanzi tutto notava era che di quelle
commedie mancava il libro. Erano bensì vere commedie, e non zannate, non erano pure e semplici
rappresentazioni carnevalesche e buffonesche, ma erano commedie senza un libro di riferimento.
Nel 1578, il Paleotti comunicava così il suo parere alla Curia di Roma:
Non basta il dire che prima si rivedano queste commedie e si levi il cattivo, perché in pratica non
riesce, perché sempre vi aggiungono parole o motti che non sono scritti, anzi non mettono essi in
iscritto se non il sommario o l’argomento, e il resto fanno tutto all’improvviso (in Taviani, 1969, p.
39).
Un aspetto interessante di questa testimonianza e il modo in cui passa da una generica osservazione
degli usi dei comici («sempre vi aggiungono parole o motti che non sono scritti»), ad uno sguardo
più ravvicinato che individua una precisa organizzazione nella produzione degli spettacoli («non
mettono per iscritto se non il sommario...» ecc.), quasi la frase rispecchiasse, con la ripresa di
quell’anzi, le esperienze sempre più precise fatte dal Cardinale nell’esercizio delle sue funzioni. Già
una decina di anni prima (cfr. Taviani, 1969, p. 38), la Curia bolognese s’era occupata delle
commedie portate in giro dalle compagnie professionistiche: ciò che agli occhi dei giudici della
pubblica moralità era emerso sempre più chiaramente era che il pericolo consisteva in qualcosa che
precedeva il contenuto delle commedie, e si annidava nel fatto stesso per cui esse avvenivano in
assenza di un testo scritto: è solo il testo scritto che permette il controllo prima che lo spettacolo
avvenga. Lo spettacolo senza un libro che lo preceda elude, per definizione, i decreti di controllo
dei libri: è controllabile non in quanto pubblicabile, ma solo in quanto già pubblico. Ma il Cardinale
sa bene — a differenza di molti frettolosi moderni — che dallo spettacolo non è assente un testo, un
testo che può essere in tutto simile ai testi scritti. Ciò che è assente è solo la scrittura che renda
presente (e controllabile) il testo anche senza lo spettacolo.
L’improvvisazione, cioè, non si oppone alla premeditazione, come la parola sembrerebbe indicare;
si oppone, in questo caso, alla scrittura.
La cosa di cui parla il Paleotti, ci porta così a scoprire un altro significato possibile della qualifica di
«improvvisato» data al teatro dei professionisti, il significato più concreto e ristretto di «teatro non
scritto».
Quando torniamo a sentire ancora oggi quel vero e proprio ritornello secondo cui la Commedia
dell’Arte si baserebbe sul rifiuto del testo letterario, non possiamo non meravigliarci di quanto forte
sia l’illusione ottica che fa confondere testo letterario con testo scritto.
Un’illusione ottica pari a quella di chi considera la lingua solo dal punto di vista della lingua scritta,
e che nasce dalla deformazione del letterato e del lettore che nella loro esperienza identificano
composizione e scrittura, conoscenza e lettura, e sono quindi portati a giudicare non composto quel
che non è scritto, e non esistente quel che non è leggibile. Tranne casi estremi, è difficile che esista,
nella nostra civiltà, un poema o un romanzo non scritto. Persino una raccolta di poesie, per lo meno
in ambiente colto, se c’è vuoi dire che è scritta. Ma con il teatro è diverso, e la pratica dei comici
dell’Arte dovrebbe dimostrarlo: in quel caso era quasi normale che esistessero commedie — con il
loro bravo testo letterario — ma non scritte. Dove stava, allora, il testo, ci si domanderà, se non
stava per iscritto? Esso compariva all’improvviso nello spettacolo, non prima. Compariva
all’improvviso non era improvvisato. Il problema dell’improvviso è innanzi tutto un problema del
lettore e del Cardinale Paleotti, che non hanno nulla da leggere. Non degli attori che non avrebbero
nulla di composto prima dello spettacolo.
Ciò che il teatro delle compagnie professionistiche rifiuta — o ciò di cui più semplicemente fa a
meno — non è il primato e la centralità del testo, ma il primato e la centralità del libro.
Se non si vede in tutta la sua complessità questo problema concreto, si devia verso la semplicistica
astrazione di un teatro che — rifiutando il testo drammatico — viene da noi immaginato come un
teatro che privilegia il gesto sulla parola, un teatro della fisicità o della teatralità pura. Sono
equivoci che corrono sul filo delle associazioni arbitrarie di parole: popolano le storie del teatro di
luoghi comuni, di fantasmi privi d’ogni radice storica, e si nutrono della cattiva lettura dei
documenti.
Lo scritto in cui meglio sono rappresentati gli atteggiamenti dei comici professionisti italiani nei
confronti del testo teatrale è il primo dei due prologhi de Il finto marito di Flaminio Scala.
Siamo nel 1618, Flaminio Scala, che ha composto molti scenari di commedie ed è stato accanto ai
più grandi comici del suo tempo, che ha diretto compagnie, ora ha settant’anni, e immagina che un
forestiero giunga nel teatro dove sta per recitarsi una sua commedia scritta — eccezionalmente —
per intero. Scala immagina il disprezzo del forestiero letterato, immagina di non essergli neppure
noto, lui che non è autore vero di libri e che «a’ suoi dì ha fatto mille suggetti» senza scrivere
commedie, e si lascia difendere da un comico. Un professionista del teatro non scritto e un
osservatore del teatro scritto si affrontano, così, su una scena ancora vuota:
Comico
Forestiero
Comico
Forestiero
Comico
Forestiero
— Ma non mi negherete già, che dove lo Scala ha portato i suoi suggetti, sempre
hanno dato gusto e son piaciuti.
— È vero, ma perché? Perché egli ha cercato fargli apparire con le azzioni; e le
buone compagnie di comici son quelle che, ben recitando, nobilitano i suggetti; ma
quella composizione, poich’è solamente scritta sopra un foglio, s’ella non ha in sé
l’arte del bene scrivere che l’accompagni, resta fredda e cade.
— Dunque questa, ora recitata, piacerà, perché hanno fatto scelta de’ personaggi.
— Sta bene; ma essendo imparata a mente, se il disteso non è vago proprio e di
buona lingua, non daranno in nulla.
— Cotesto è vero quando con un bello e nobile encomio si vuol celebrare chi che
sia, o pure narrare un fatto seguìto, ma nella commedia basta che vi sia buona
imitazione et il verisimile, e che la locuzione non sia scabrosa o barbara; anzi la
familiare, senza tanta arte, è la più propria, perché la commedia rappresenta azioni
comuni, e non di uomini di alta qualità; onde l’esquisitezza gli è impropria.
— Ben dite nel troppo; ma per imitare più parti et introdurre ciascuna a parlar
propriamente bisogna saperne assai, perché non si può dilettare con la variazione o
del bergamasco o del veneziano o del bolognese, ma bisogna con la proprietà delle
parole, ancorché non si muti linguaggio, ben imitare; et a questo ci vuol del buono.
Sì che torno a ridire che non spero molto di questa, perché ognuno val ne l’arte sua.
(Scala, 1618, p. CX).
La discussione, come si vede, non riguarda la capacità dei comici a fare un buon teatro — il
forestiero è anche lui d’accordo che il loro teatro funziona — ma la loro capacità di scrivere una
commedia, fissando e traducendo completamente in parole gli effetti delle azioni sceniche. Il
professionista del teatro non scritto sostiene che lo Scala, nel momento in cui vuole, può anche
scrivere una commedia, perché il livello della dicitura, della locuzione, non e il più importante, e la
lingua, purché sia famigliare e corretta, non deve essere particolarmente curata. L’osservatore del
teatro scritto, al contrario, sostiene che tutta la sostanza della commedia scritta si esprime appunto
nella superficie della sua dicitura o locuzione, e che quindi Scala è destinato al fallimento, perché in
questo caso pratica un’arte non sua. E indicativo l’esempio che porta: in una commedia occorre
caratterizzare anche verbalmente i diversi personaggi. Ma mentre gli attori in scena possono
caratterizzarli all’ingrosso, dando direttamente ad ognuno lingue o dialetti diversi, come fanno i
comici di professione che fanno parlare un personaggio in bergamasco, un altro in veneziano e un
altro ancora in bolognese, quando la commedia è scritta le diverse caratterizzazioni linguistiche dei
personaggi debbono essere realizzate attraverso gli strumenti offerti da una sola lingua, debbono
essere, cioè, più raffinate e richiedono la specializzazione di un letterato. Il comico risponde:
Comico
— L’arte vera del ben far commedie credo io che sia di chi ben le rappresenta,
perché se l’esperienza è maestra delle cose, ella può insegnare, a chi ha spirito di
formare o meglio rappresentare i soggetti recitabili, il ben distenderli ancora, quando
però quel tale non sia nato in Voltolina o dove si lascia l’io per il mi.
Ancora una volta, cioè, ribadisce che per scriver bene teatro non occorre nessuna particolare
specializzazione letteraria, ma la conoscenza dell’uso corretto della lingua e nulla più.
Il tema in discussione fra il comico e il letterato è, in fondo, molto limitato: non riguarda il teatro
all’improvviso, non l’arte del recitare e neppure — come si vedrà — il conflitto gesto-parola.
Non è nient’altro che la discussione su quel che serve per scrivere (ancora una volta: scrivere, non
rappresentare) una buona commedia. Attraverso il dialogo fra il comico e il forestiero — e ancor
più attraverso il dialogo a distanza con i suoi moderni interlocutori, gli studiosi della Commedia
dell’Arte — Flaminio Scala mostra quanto siano celate e profonde le conseguenze
dell’identificazione fra testo drammatico e scrittura del testo drammatico; come esse si travestano
in semplici contrapposizioni di poetica e come nascondano la complessità del concreto lavoro
teatrale.
Il primo prologo del Finto marito, infatti, è stato recentemente messo in luce, citato, analizzato più
volte come uno dei documenti migliori della così detta poetica della Commedia dell’Arte (cfr.
Jannaco, 1960; Marotti, 1976, pp. XLVIII-L; Tessari, 1969, pp. 69-78 e 1981, pp. 50-54), ma le
analisi rischiano continuamente di inciampare sulla parola azione» usata dallo Scala e di cadere
nella sfera d’attrazione delle discussioni teatrali dei nostri anni, ritrovando nelle pagine dello Scala
una poetica del gesto o della mimesi cinetica o del diretto rapporto fra gesto dell’attore e reazione
fisica dello spettatore, o — più in generale — una teoria del teatro come arte libera dal legame con
la letteratura. Ma, in realtà, le parole dello Scala riguardano un livello del teatro molto diverso e
molto più raffinato.
Dice Flaminio Scala che «le commedie nell’azzioni consistono propriamente e in sustanzia», perché
«alle azzioni son più simili l’azzioni che le narrazioni » (Scala, 1618, p. CXIII). Poi, per convincere
il suo interlocutore, introduce l’esempio del gesto che è più efficace della parola. Ma notiamo,
intanto, che per lui «gesto» e «azzione» sono due cose ben distinte, e che usa il «gesto» come
esempio per spiegare la forza dell’«azzione»:
Per tale cagione adunque l’orazione o locuzione ancora, e le parole sole, poca arte avranno in questo
dell’imitazione, perché ogni minimo gesto a tempo et affettuoso farà più effetto che tutta la filosofia
di Aristotile, o quanta retorica suppone Demostene e Cicerone. E che sia vero che gl’affetti si
muovono più agevolmente da’ gesti che dalle parole, ciascuno che ha intelletto et anco gli animali
bruti sempre faran più caso e moverannosi più a chi alza il bastone che a chi alza la voce. (Scala,
1618, p. CXIII).
Poco più avanti aggiunge:
E considerisi ciò ne gl’amanti, che più da una lacrimuzza, da uno sguardo, da un bacio, per non dir di
più, e da simili cosarelle vengono dal subbietto amato tirati e mossi, che dalla persuasiva di qual si
voglia gran filosofo morale, che con ben ordinata scrittura, perfetti concetti, ottima locuzione et
esquisite parole e migliori ragioni esorti alla virtù, persuadendo a lasciar da canto la sensualità.
(Scala, 1618, p. CXIV).
Ora è chiaro che qui Flaminio Scala contrappone il gesto alla parola non per contrapporre un teatro
basato sul gesto «gestuale») ad un teatro basato sul testo — come la pubblicistica teatrale dei nostri
anni si è abituata a contrapporre — ma per rafforzare con una similitudine lampante il suo
argomento secondo cui ciò che è importante in una commedia non è la coltre della dicitura ma la
sostanza costituita dalla serie dei fatti. I due termini, «dicitura» e «serie dei fatti», sono una
traduzione moderna e meno aperta ad equivoci di ciò che Scala intende con «azzioni» e
«locuzione». Derivano dal Manzoni, nell’Introduzione a I promessi sposi: «Perché non si potrebbe,
pensai, prender la serie de’ fatti da questo manoscritto, e rifarne la dicitura?». È lecito immaginare
simili parola in bocca ad un comico: perché non si potrebbe fissare l’ossatura delle commedie e
lasciare che la loro epidermide cambi e ondeggi, abbandonandone la responsabilità agli attori? Un
progetto del genere non ha nulla a che vedere con il progetto d’un teatro del gesto. È, piuttosto, un
progetto che vede l’attore come traduttore — alla lettera — d’una commedia letterariamente
composta. Per comprendere come questo possa avvenire, e che cosa significhi il fatto che avvenga,
occorre ritornare alle parole dello Scala e alla deformazione con cui noi oggi siamo tentati di
leggerle. Ci troviamo in uno di quei casi, infatti, in cui per comprendere un fenomeno del passato,
più che impossessarci delle sue categorie, dobbiamo liberarci delle nostre.
Per la nostra mentalità, il livello verbale — la dicitura — di un’opera coincide con il suo livello
sostanziale. Ci troviamo quindi in difficoltà e quasi bloccati quando si tratta di distinguere le
«parole» dalle «azioni» di un dramma.
Parlare di un teatro basato sulle azioni finisce per noi fatalmente con il confondersi con il parlare di
un teatro eminentemente visivo, dove prevale l’espressione fisica e mimica dell’attore, dove si nega
o si svaluta l’importanza della parola e del testo drammatico. La confusione è aumentata dal fatto
che quasi sempre, quando uomini di teatro moderni hanno rivendicato la necessità di basare lo
spettacolo sull’espressione fisica dell’attore, sugli aspetti mimici e visivi del teatro e non sui suoi
aspetti letterari, hanno fatto riferimento alla Commedia dell’Arte.
Ma l’azione di cui parla Flaminio Scala quando si dice che su di essa si basa essenzialmente il teatro
non coincide con l’agire in scena dell’attore. Tanto meno coincide con la sua gestualità.
L’esistenza di un problema dell’azione come problema drammatico che non e pertinente a quello
della gestualità dell’attore o dell’aspetto visivo e cinetico del teatro noi la riconosciamo facilmente
quando pensiamo al cinema e alla sua composizione drammatica.
Nessuno vedrebbe alcun riferimento all’espressione fisica dell’attore, all’idea di uno spettacolo
gestuale, se leggesse che il cinema «nell’azzioni consiste propriamente e in sustanzia», e che per
scrivere un film basta saperne concepire e comporre la serie dei fatti e poi stendere i dialoghi nella
normale lingua famigliare, senza preoccuparsi, addirittura, se gli attori li cambieranno, poi, nel
momento della realizzazione, o se li adatteranno a sé o ne ripeteranno con parole proprie la
sostanza.
Il film, insomma, non e uno spettacolo per cui abbia senso dire che il gesto prevale sulla parola o
che l’elemento visivo in movimento prevale sul racconto. Ha un testo alla base, ma e molto raro che
qualcuno ne giudichi la qualità giudicando il valore letterario dei suoi dialoghi, Il valore strumentale
dei dialoghi, della parola, è qualcosa che viene riconosciuto proprio in rapporto alla composizione
drammatica, non in opposizione ad essa.
Sono simili le constatazioni di Flaminio Scala nel primo prologo al Finto marito: il tessuto
letterario dei dialoghi non è importante in una rappresentazione teatrale e neppure nella scrittura
d’una commedia. Egli non sostiene né un teatro basato sulla fisicità del gesto, né i1 suo contrario —
un teatro basato sulla mediazione della parola: queste distinzioni gli sono estranee. Le azioni di cui
parla non hanno nulla di paragonabile con le azioni che compongono una partitura gestuale in un
teatro moderno: sono, invece, racconto, rappresentazione, messinscena di un intreccio, anche se le
parole che gli attori debbono dire non sono particolarmente importanti. Ma non sono importanti non
perché possano essere eliminate, ma perché possono essere non particolarmente curate dal punto di
vista letterario.
Dovrebbe apparire ormai chiaro che è un errore interpretare le dichiarazioni dello Scala come se
fossero in favore di un teatro basato più sugli elementi visivi e mimici, più sul virtuosismo degli
attori e sulla loro dote d’improvvisare senza testo, che non sulla tecnica di composizione del testo
drammatico. Dovrebbe risultar chiaro, anzi, che è vero il contrario.
Quando parla del teatro come di un’imitazione delle azioni attraverso le azioni, lo Scala intende
sottolineare proprio l’importanza della composizione drammatica contro una concezione che invece
rischia di lasciare in secondo piano il dramma — l’azione — per mettere in rilievo l’eleganza
dell’eloquio, la preziosità del livello verbale. Ciò che a noi sembra paradossale, e cioè che
l’elemento letterario di una commedia venga considerato come un suo materiale, un suo ingrediente
non più importante dell’ambientazione scenografica, è invece opinione comune allo Scala, ai suoi
colleghi, ai suoi contemporanei (cfr. Francesco Andreini nella premessa a Scala, 1611, p. 13, e
Seragnoli, 1980, pp. 174-180).
Per noi, il livello verbale di un dramma è ciò in cui si esprime la sua azione. Per Flaminio Scala e
per molti del suo tempo era esattamente il contrario: ciò che rischiava di nascondere l’azione.
Una preoccupazione, questa, tipicamente classica: «Qualcuno — racconta Plutarco nel suo opuscolo
Dell’udire — domandò a Melanto cosa ne pensasse della tragedia del poeta Dionisio. Melanto
rispose: “Non sono riuscito a vederla, tanto era coperta dal velo delle parole”». Nel momento stesso
in cui Flaminio Scala spiega perché egli — autore di scenari — sia in grado di scrivere per disteso
una commedia, spiega anche perché normalmente di commedie non ne abbia scritte e perché i
comici professionisti potessero recitare un teatro non scritto: perché, appunto, le parole della
commedia altro non sono che un velo che copre l’essenziale, il montaggio delle azioni o secondo la
formula aristotelica — la «composizione dei casi».
Se ne deduce, contro tutte le previsioni, che la visione drammaturgica dello Scala è rigorosamente
classica, e che se essa sembra irregolare, lo sembra solo perché si distingue dalla posizione
classicista che vigeva presso i letterati del suo tempo e che lascia tracce ancora presso il nostro
modo di pensare il problema della drammaturgia.
Ma prima di procedere in questa direzione, conviene voltarci indietro per considerare il cammino
percorso: i luoghi comuni sull’improvvisazione degli attori italiani sembravano celare o un
multiforme intreccio d’usi e abusi comici, o la particolare pratica di produzione di teatro che
affidava agli attori la composizione della commedia. L’antinomia commedia
improvvisata/commedia premeditata, cioè, velava l’antinomia più concreta fra commedia composta
e commedia eseguita. Seguendo questa traccia, e vedendo come la produzione dei comici si
manifestava nei primi decenni di vita delle compagnie, siamo giunti a un’antinomia ancora più
concreta: teatro scritto/teatro non scritto. Quest’ultimo, però, non poteva esser confuso con un teatro
anti-letterario, gestuale, mimico, ma — al contrario — si mostrava come un teatro che svalutava la
stesura della dicitura in nome della composizione dei casi, delle azioni, e che quindi in nessun modo
poteva esser visto come un teatro senza testo letterario, anche se questo testo era prodotto in
maniera tale da comparire solo nello spettacolo. Si possono dedurre da tutto questo ancora due
corollari che riguardano l’improvvisazione.
Innanzi tutto, siamo ora in grado di circoscrivere il livello in cui è possibile vedere all’opera, in
maniera continua e sistematica, l’improvvisazione: il livello estremamente superficiale della
dicitura, cioè della traduzione operata dall’attore, con parole sue, della serie dei fatti e degli
argomenti fissati.
In secondo luogo, risulta ora evidente almeno una ragione per cui è stata l’improvvisazione a
colpire tanto l’immaginazione degli osservatori della Commedia dell’Arte e dei suoi studiosi. Essi
restavano e restano colpiti proprio dall’elemento più superficiale (l’improvvisazione nella
traduzione della coltre della dicitura) a causa dei propri interessi particolari: come il Cardinale che a
causa delle sue funzioni è soprattutto interessato al fatto di non poter leggere le commedie, anche
per lo studioso moderno la non trascrizione dei testi delle compagnie professionistiche diventa il
fatto più importante perché è per lui il più importante: quello che gli impedisce di conoscere a
distanza di secoli le commedie dei professionisti. Se gli attori, infatti, possono tramandarsi le
commedie attraverso la composizione dei casi e la serie degli argomenti trasmessi oralmente o
velocemente appuntati, tali da poter essere poi tradotti nelle parole dello spettacolo; per i lettori le
commedie si trasmettono solo attraverso i dialoghi distesi. Nel primo caso la composizione dei casi
trasmette le parole dei dialoghi sotto forma di «soggetti» che gli attori possono tradurre. Nel
secondo, sono i dialoghi a trasmettere la composizione dei casi attraverso azioni che i lettori
possono immaginare.
Ritorniamo, così, all’ipotesi che si faceva poco fa: la differenza delle compagnie italiane — cioè
della Commedia dell’Arte — dai teatri circonvicini e dall’idea di teatro vigente nell’alta cultura del
secolo XVI e XVII non deriverebbe dal loro distaccarsi dalla tradizione del teatro letterario, ma dal
combinare in maniera diversa gli elementi di quella tradizione.
È legittimo sostenere, infatti, che il teatro ideato dalle compagnie professionistiche italiane, il teatro
all’improvviso, fu, per eccellenza, un teatro classico, e che proprio per questo apparve subito così
diverso dal teatro «di imitazione classica», cioè dal teatro classicista.
Il primo continuava ad utilizzare i processi compositivi classici. Il secondo si ispirava ai risultati.
Il primo era classico perché tutto concentrato sull’azione, sul dramma, da cui tutti gli altri elementi
venivano dedotti.
Il secondo era classicista perché si concentrava sulle reliquie del teatro antico, sui testi
sopravvissuti, e deduceva l’importanza della dicitura non dalla sua essenzialità, ma dalla sua
permanenza.
L’idea classicista vede il teatro come qualcosa che deve discendere dal libro, perché ha i libri
davanti e risale al teatro antico attraverso i libri. Teoricamente, distingue fra «composizione dei
casi» e materiale verbale, ma praticamente trova, nei testi che legge, che l’uno è l’altro. La moderna
ideologia teatrale, cioè, si costruisce ipostatizzando le regole della sua trasmissione, e diventa
incommensurabile con l’idea di teatro dei comici, che si costruiva su altre regole di trasmissione,
quelle per cui, fra composizione dei casi e materiale verbale della commedia, poteva essere
trasmesso l’uno e l’altro o soltanto l’uno.
Quello delle compagnie italiane apparirà presto come una forma bizzarra o mostruosa di teatro, una
varietà folcloristica o eretica, nata non si sa dove né come. Ed in realtà si distingueva davvero dai
teatri che contemporaneamente nascevano in diversi paesi d’Europa. Ma si distingueva perché,
mentre le compagnie professionistiche degli altri paesi si legavano alle composizioni drammatiche
degli scrittori, e quindi ad una drammaturgia che privilegiava lo scritto, gli italiani si legarono al
processo di produzione della letteratura drammatica e lo adattarono, fuori dalla pratica della
scrittura, ad altre pratiche professionali di produzione di teatro. Se il teatro degli italiani, infatti,
appare così diverso dal teatro degli scrittori, è perché gli italiani usano gli stessi metodi degli
scrittori per ottener altri risultati. Il che vuoi dire che l’indipendenza dalla volontà di un unico
autore, che risultava celarsi dietro i luoghi comuni sull’improvvisazione, cela a sua volta più
complesse strategie di rapporti dove i confini fra la produzione di teatro e la politica dei teatri si
fanno labili.
OPERE CITATE IN FORMA ABBREVIATA
Apollonio 1930
Mario Apollonio, Storia della Commedia dell’Arte, Roma-Milano, Augustea, 1930 (reidiz. fotomeccanica: Firenze,
Sansoni, 1982).
Apollonio 1968
Mario Apollonio, Prelezioni sulla Commedia dell’Arte, in AA.VV., Contruti dellIstituto di Filologia Moderna – Serie
Storia del Teatro, vol. I, Milano, Vita e Pensiero, 1968, pp. 144-190.
Desboulmiers 1769
Jean Auguste Jullien dit Desboulmiers, Histoire Anedoctique du Théâtre Italien depuis son rétablissement en France
jusqu’à l’année 1769, Paris, Lacombe, 1769, 7 voll.
Duchartre 1955
Pierre-Louis Duchartre, La Commedia dell’Arte et ses enfants, éd. d’Art et Industrie, 1955, (è la versiona ampliata di
un’opera già apparsa nel 1925).
Gherardi 1700
Le Théâtre Italien de Gherardi ou Recueil général de toutes les Comédies et Scènes Françoises jouées par les
Comédiens Italiens du Roi pendant tout le temps qu’ils ont été au service, Paris, Cusson et Witte, 1700, 6 voll. (ed.
definitiva che fa seguito a quelle parziali, pubblicate a Parigi nel 1694, 1695, 1697 e 1698. L’edizione del 1700 è stata
ripubblicata ad Amsterdam nel 1701, 1707 e 1721 e a Parigi nel 1717, 1738 e 1741. Un’antologia del Recueil del
Gherardi è stata pubblicata da Marcello Spaziani nel 1966 (vedi). È da questa raccolta che vengono tratte le citazioni.
Gozzi 1797
Carlo Gozzi, Memorie inutili della vita di Carlo Gozzi scritte da lui medesimo e pubblicate per umiltà, Venezia, Palese,
1797. (Ed. moderna: Bari, Laterza, 1910, a cura di Giuseppe Prezzolini, 2 voll., collana «Scrittori d’Italia». È da questa
che citiamo).
Jannaco 1960
Carlo Jannaco, Stesura e tendenza letteraria della commedia improvvisa in due prologhi di Flaminio Scala, in «Studi
Secenteschi», I, 1960, pp. 195-207.
Maffei 1723
[Scipione Maffei], Istoria del teatro e difesa di esso, in Teatro italiano, o sia scelte di tragedie per uso della scena,
tomo I, Verona, Vallarsi, 1723, pp. I-XVIV.
Marotti 1976
Studio critico e raccolta di documenti sugli inizi della Commedia dell’Arte a cura di Ferruccio Marotti per il volume
Flaminio Scala, Il Teatro delle Favole Rappresentative, 2 tomi, Milano, Il Polifilo, 1976.
Mic 1927
Constant Mic (Konstantin Miklashevskij), La Commedia dell’Arte, ou le théâtre des comédiens Italien des XVI, XVII et
XVIII siècle, Paris, Schiffrin, aux Editions de la Pléiade, 1927 (traduzione italiana in versione ridotta di Carla Solivetti,
Padova, Marsilio, 1981).
Nicoll 1963
Allardyce Nicoll, The World of Arlequin. A critical Study of the Commedia dell’Arte, Cambridge, University Press,
1963. (Trad. italian, Il mondo di Arlecchino, Milano, Bompiani, 1965. Nuova edizione a cura di Davico Bonino: ivi,
1980. È questa l’edizione da cui sono tratte le citazioni).
Ottonelli V
Giovan Domenico Ottonelli, Della Christiana Moderatione del Theatro. Libro detto l’Istanza, Firenze, Bonardi, 1652.
(Un’ampia antologia dell’opera dell’Ottonelli si trova in Taviani 1969, pp. 320-526).
Perrucci 1699
Andrea Perrucci, Dell’arte rappresentativa premeditata e all’improvviso. Parti due. Giovevole non solo a chi si diletta
di rappresentare, ma a’ predicatori, oratori, accademici e curosi, Napoli, Mutio, 1699.
Riccoboni 1728
Luigi Riccoboni, Histoire du Théâtre Italien depuis la decadence de la Comédie Latine, avec un catalogue des
Tragedies et Comédies imprimées depuis l’an 1500 jusqu’à l’an 1600 et une dissertation sur la tragedie moderne,
Paris, Delormel, 1728. (Rist, anastatica: Bologna, Forni, 1969).
Riccoboni, Scenari inediti
Luigi Riccoboni, Discorso della Commedia all’improvviso e scenari inediti, a cura di Irene Mamczarz, Milano, Il
Polifilo, 1973. (Pubblica un manoscritto inedito di Luigi Riccoboni conservato alla Biblioteca Nazionale di Parigi [...]).
Sand 1862
Maurice Sand, Masques et bouffons. Comédie Italienne, textes et dessins par Maurice Sand, gravures par A. Manceau,
préface par Georges Sand Paris, Lévy, 1862.
Scala 1611
Flaminio Scala, Il teatro delle Favole Rappresentative, overo la ricreazione comica, boscareccia e tragica, divisa in
cinquanta giornate, Venezia, Pulciani, 1611 (ed. moderna a cura di Ferruccio Marotti, Milano, Il Polifilo, 1976, 2 voll..
È questa l’edizione da cui citiamo).
Scala 1618
Flaminio Scala, Il finto marito, Venezia, Baba, 1619 [ma 1618]. (I due prologhi al Finto marito sono pubblicati in
Marotti 1976, pp. CIX-CXVIII).
Seragnoli 1980
Daniele Seragnoli, Il teatro a Siena nel Cinquecento. “Progetto” e “modello” drammaturgico nell’Accademia degli
Intronati, Roma, Bulzoni, 1980.
Spaziani 1966
Il “Théâtre Italien” di Gherardi, otto commedie di Fatouville, Regnard e Dufresny presentate da Marcello Spaziani,
Roma, ed. dell’Ateneo, 1966.
Taviani 1969
Ferdinando Taviani, La Commedia dell’Arte e la società barocca: la fascinazione del teatro, Roma, Bulzoni, 1969.
Taviani 1971
Ferdinando Taviani, Studio introduttivo a N. Barbieri, La Supplica, Milano, Il Polifilo, 1971.
Tessari 1969
Roberto Tessari, Commedia dell’Arte. La maschera e l’ombra, Milano, Mursia, 1981.
Valerini 1570
Adriano Valerini, Oratione in morte della divina Signora Vincenza Armani, comica eccellentissima, Verona, [1570].
Mirella Schino
Profilo del teatro italiano. Dal XV al XX secolo
Roma, Carocci 1995, pp. 109-117
Attori
Col nuovo grande attore, Luigi Vestri, la conquista dell’arte scenica avviene ancora una volta, come per il Morrocchesi,
di forza [...]. Il suo colloquio col pubblico diventava la materia stessa della sua arte, quasi una musica, una sostanza
plastica, ch’egli andava modulando per suggerire un’immagine. Da buon attore, partendo dalla sua fisicità (ed aveva,
non solo nel corpo, qualcosa di grave, di inizialmente avviluppato: quel suo volto largo, di guance cascanti, ma di fronte
fantasiosa sui potenti archi ciliari, si concentrava ora nella bocca, così diversa da ritratto a ritratto, ora negli occhi strabi,
e di lì, dalla bocca e dagli occhi, si sperdeva), piegava il corpo e il volto a promuovere quel trasporto, quel rapimento
che lo rendevano signore della scena, anzi del coro; e di lì muoveva a un’immagine fantastica che toglieva consistenza e
realtà a tutto, alle parole del testo come all’occasione fittizia della rappresentazione, al proprio esser uomo di carne ed
ossa come alla molteplice realtà degli uomini adunati ad ascoltarlo. Si dirà che questo giuoco di realtà sovrapposte è
d’ogni grande attore: ma appunto l’idea che noi abbiamo oggi del grande attore ebbe in Italia una prima e grandissima
personificazione in Luigi Vestri 1.
Così Mario Apollonio ha analizzato il peso attorico di Luigi Vestri, uno dei capostipiti del
fenomeno — detto “del grande attore” — che nel corso dell’Ottocento e più o meno fino al
fascismo dominerà completamente il teatro italiano.
Mario Apollonio, uno dei fondatori degli studi teatrali italiani, uno dei primi a interessarsi alla
specificità dello spettacolo rispetto al problema dei testi, è stato anche uno dei pochi che del
fenomeno del grande attore hanno tentato di rendere il peso, analizzando la concretezza dei mezzi e
l’oscurità di certi effetti sul pubblico.
La visibilità e la concretezza dei metodi d’arte e di battaglia con il pubblico del grande attore
hanno fatto sì che spesso se ne preservassero descrizioni fisiche in dettaglio, minuziose e fresche.
Ritorniamo un attimo su Vestri, ad esempio, per ascoltare la descrizione che ne fece, negli ultimi
anni dell’Ottocento, uno dei primi grandi raccoglitori di notizie sugli attori italiani, Luigi Rasi:
A vederlo, pareva che la natura lo avesse creato non ad altro che al genere comico: era pingue nella persona, aveva il
ventre sporgente innanzi: alto, però, quanto si conveniva, non notavi nelle sue membra alcuna increscevole
sproporzione. Piacevole fisionomia; negli occhi, nelle labbra e nella fronte, potenza di esprimere le più interne
commozioni dell’animo, senza stento nella severità o nella tenerezza, senza sconcezze nel ridicolo; sì che più volte, non
proferendo parola, non movendo mano, seppe con un sol sguardo scuotere la moltitudine attonita, atterrirla o rallegrarla
secondo che dimandassero le trattate passioni 2.
Il grande attore della tradizione ottocentesca è l’attore creatore, autore dello spettacolo non meno
dello scrittore. È un fenomeno non solo italiano, ma diffuso in tutta l’Europa occidentale, in Russia,
negli Stati Uniti, fiorito dai primi anni dell’Ottocento (in Italia, un po’ in ritardo, verso la metà del
secolo), fino all’inizio del Novecento e all’avvento della regia. Malgrado la sua importanza
coreutica e culturale, il teatro dell’attore-creatore è oggi spesso dimenticato, come se avesse poca
parte nella storia del teatro. La fama dei grandi attori è spesso ricordata con diffidenza, quasi fosse
una fama usurpata, nata da un’infatuazione episodica e superficiale da parte degli spettatori, e dallo
strapotere dell’attore e dalla mancanza di quella unificazione dello spettacolo (il “regista”) in grado
di gareggiare con l’attore, restituendolo a più giuste dimensioni.
Il teatro del grande attore ottocentesco non è però teatro di abusi e di mancanze. È un’arte
diversa, complessa, che in Italia era stata protagonista dello spettacolo anche in altri momenti storici
(nel Cinque e nel Seicento, con la Commedia dell’Arte), che in altri periodi era sembrata quasi
1
Mario Apollonio, Storia del teatro italiano [1938-50], Sansoni, Firenze 1981, pp. 58-9.
Luigi Rasi, I cornici italiani. Biografia, Bibliografia, Iconografia, Fratelli Bocca (e poi Francesco Lumachi), Firenze
1897-1905, sv.
2
nascondersi, e che nell’Ottocento trovò le condizioni opportune per svilupparsi con particolare forza
e prepotenza, condizioni che erano quelle, pratiche e organizzative, fornite dalla struttura che si è
chiamata “per compagnie”. Il grande attore, in Italia, fu un fenomeno anche numericamente
imponente, completamente inserito, quasi previsto dal contesto teatrale, mentre all’estero assunse
più l’aspetto di una serie di eccezioni, necessariamente in attrito con le istituzioni esistenti
(l’esempio migliore è il contrasto con la Comédie Française da cui si sviluppò il caso Sarah
Bernhardt).
Questo cosiddetto “grande attore” in Italia s’era formato e, potremmo dire, era stato partorito, dalla lotta per la
sopravvivenza. Nella prima metà dell’Ottocento, le condizioni dell’attore drammatico in Italia erano tra le più misere
d’Europa. Coinvolto nel fallimento delle grandi compagnie stabili dell’età napoleonica, soverchiato dalla concorrenza
del melodramma e del balletto, privo d’un repertorio nazionale decente, ostacolato dalle censure, l’attore italiano a metà
del secolo è costretto a compiere una serie di scelte che condizioneranno la nostra vita teatrale per quasi un secolo. Le
scelte sono: abbandono degli schemi letterari e culturalistici adottati e promossi dalla Compagnia Reale Sarda; apertura
al repertorio straniero, meno costoso perché non si pagavano diritti, e più sicuro; accantonamento dell’idea di Stabile;
riorganizzazione del nomadismo e della compagnia basata sui ruoli, ripresa delle tournées all’estero 3.
La prima generazione dei “grandi attori” italiani è quella di Gustavo Modena (1803-1861) e di
Carlotta Marchionni (1796-1861) (quasi il carattere di precursori ebbero figure di qualche anno
precedenti, quella di Antonio Morrocchesi (1768-1838), primo grande interprete alfieriano, o di
Luigi Vestri (1781-1841), il più grande attore della sua epoca). Le altre generazioni si succedettero
a intervalli regolari: Adelaide Ristori (1822-1906), Antonio Petito (1822-1876), Tommaso Salvini
(1829-1915), Ernesto Rossi (1827-1896) erano di quasi trent’anni più giovani. Altri trent’anni ci
vollero per il formarsi della terza generazione, il cui vertice è rappresentato da Eleonora Duse
(1858-1924), da Ermete Zacconi (1857-1948) e da Ermete Novelli (1851 -1919), e fra i dialettali
Eduardo Scarpetta (1853-1925). Poi quella di Ruggero Ruggeri (1871-1953), di Angelo Musco
(1872-1937), di Emma (1875- 1965) e Irma Gramatica (1870-1962). Gli ultimi esponenti, ormai alla
fine del teatro di tradizione, furono Maria Melato (1885-1950), Gilberto Govi (1885 -1966), Ettore
Petrolini (1886-1936), Raffaele Viviani (1888-1950), Memo Benassi (1891-1957). Ognuna di
queste generazioni cercava di differenziarsi dalla precedente nello stile recitativo e nelle scelte di
repertorio: doveva quindi attendere che i vecchi fossero realmente fuori gioco per poter cominciare
ad affermarsi. Segno della potenza dell’abitudine a teatro, ma segno, soprattutto, della forza dei
protagonisti, superiore a quella della moda.
Nonostante la presenza dei precursori, e nonostante la genialità delle personalità successive, fu
la prima generazione a porre le fondamenta per la tradizione italiana dell’attore.
Dell’arte ereditata questi innovatori accentuarono soprattutto il “gioco di scena” illustrativo: riempirono emotivamente
lo spazio, facendo “parlare il corpo” per contrapposizioni plastiche e ritmiche (gesto/voce, occhi/capelli,
passo/controgesto, ecc.), e inventarono memorabili soluzioni a sorpresa (tipici i passaggi dalle composizioni armoniche
alle insensatezze prossemiche). Ma il grande attore fu soprattutto un risolutore. Primo: con l’arte del movimento si
appropriò degli spazi scenici concepiti per il melodramma, che avevano costituito un fattore di inferiorità per i
precursori. Secondo: professando il primato del personaggio e l’interpretazione come “incarnazione”, il grande attore
tolse legittimità alla fedeltà accademica al testo. Terzo: articolando il personaggio “incarnato” per momenti di
enigmatica riconoscibilità e procedendo per soluzioni empiriche “logicoanalitiche”, stimolò il pubblico —
tradizionalmente distratto — a un atteggiamento partecipativo, di autoproiezione. Quarto: esibendosi nell’atto di
sciogliere dei nodi interpretativi “insolubili”, mostrandosi capace di superare certe resistenze fisiche e agendo da
inimitabile, egli arrivò a creare un culto durevole della propria persona e a prevalere così sulle incertezze della fortuna
scenica 4.
Benché le differenze generazionali fossero importanti, si può tuttavia parlare dell’arte del grande
attore come di un “discorso ininterrotto”, condizionato molto più dalle necessità di sviluppare e
3
Alessandro d’Amico, L’attore italiano tra Otto e Novecento, in Petrolini. La maschera e la storia, a cura di Franca
Angelini, Laterza, Bari 1984, pp. 26-7.
4
Claudio Meldolesi, Fondamenti del teatro italiano. La generazione dei registi, Sansoni, Firenze 1984.
variare le linee interpretative da una generazione all’altra di attori, che da stretti legami con le
poetiche di cui si facevano portavoce i testi teatrali 5.
I grandi attori rappresentarono anche il vertice decisionale ed economico del teatro: erano infatti
il richiamo più potente per il pubblico (di gran lunga più potente di quello di qualsiasi autore) in un
teatro che viveva di incassi; esercitavano un’influenza determinante nell’organizzazione e nella
scelta dei testi all’interno di ogni compagnia; svolgevano un’importante funzione pedagogica —
fatta di esempi e di consigli — nei confronti delle nuove leve; avevano nelle loro mani quasi tutto il
potere economico.
Questo loro peso nel teatro fece sì che si moltiplicassero le biografie, i libri di memorie (da cui
bisogna distinguere le monografie: gli esempi migliori sono probabilmente quella di Luigi Bonazzi,
Gustavo Modena e l’arte sua, Perugia 1863; e La Duse, di Luigi Rasi, Firenze 1901). Nascono
anche opere complessive, come la raccolta di Luigi Rasi, I comici italiani, [...], come pure [...] di
quelle che sono forse le due testimonianze successive più interessanti, l’opera di Silvio d’Amico e
quella di Mario Apollonio. Questo filone di studi ha continuato a svilupparsi anche dopo la
sparizione del fenomeno, sia come tentativo di un riordinamento complessivo6 sia come
ricostruzione dell’arte di un particolare attore 7. Dal 1979, inoltre, la rivista del Museo dell’attore di
Genova, “Teatro Archivio”, pubblica studi e materiali sull’attore. Più rari e più frammentari sono i
tentativi di studiare specificamente le tecniche di recitazione 8.
I comici stessi molto frequentemente, e con molta competenza, hanno scritto di sé. Si tratta non solo
di libri di memorie, ma anche di studi artistici in cui affrontano con serietà e acume i problemi
connessi alle loro o altrui interpretazioni, vere e proprie discussioni critiche (Giovanni Emanuel, ad
esempio, scrive un opuscolo sulle interpretazioni shakespeariane sue e di altri grandi attori 9). Un
documento unico rimane l’opera di Edward Tuckerman Mason10, in cui viene minutamente
ricostruita l’interpretazione del grande attore Tommaso Salvini. Il fatto stesso che un libro del
genere sia stato possibile mostra come la drammaturgia dell’attore fosse una vera composizione,
elaborata con gli anni, che rimaneva intatta nelle diverse messinscene, quali che fossero gli altri
interpreti. La drammaturgia dell’attore ottocentesco può appoggiarsi a ciò che Meldolesi 11 ha
chiamato la “sfasatura”, cioè una forma di attualizzazione politica (per Modena) o psicologica (per
la Ristori) del testo. Essa può anche basarsi su di un’opera di composizione autonoma dell’attore,
che aggiunge al testo altre ricerche secondo una vera e propria opera di drammaturgia (Luigi
Bonazzi, nel suo Gustavo Modena e l’arte sua, Perugia 1865, ricorda ad esempio come Modena si
servisse, per l’interpretazione del Saul, più dell’Antico Testamento che del testo di Alfieri; e
Adelaide Ristori nei suoi Ricordi e studi artistici, Torino 1887, parla di un lungo lavoro sui quadri e
sui libri di storia — e non certo solo sul testo di Schiller, ma anzi perfino in contrapposizione ad
5
Cfr. in particolare D’Amico, L’attore italiano tra Otto e Novecento, cit.
Cfr. in particolare Vito Pandolfi, Antologia del grande attore, Laterza, Bari 1954, e Giovanni Calendoli, L’attore.
Storia di un’arte, Edizioni dell’Ateneo, Roma 1959. Cfr., inoltre, per un panorama complessivo non solo italiano,
Claudio Meldolesi, Ferdinando Taviani, Teatro e spettacolo nel primo Ottocento, Laterza, Roma-Bari 1991; e Roberto
Alonge, Teatro e spettacolo nel secondo Ottocento, Laterza, Roma-Bari 1988.
7
Cfr. Claudio Meldolesi, Profilo di Gustavo Modena. Teatro e rivoluzione democratica, Bulzoni, Roma 1971; Cesare
Molinari, L’attrice divina. Eleonora Duse nel teatro italiano fra i due secoli, Bulzoni, Roma 1985; Mirella Schino, Il
teatro di Eleonora Duse, Il Mulino, Bologna 1992.
8
Ferdinando Taviani, Alcuni suggerimenti per lo studio della poesia degli attori nell’Ottocento, in “Quaderni di teatro”,
21-22, agosto-novembre 1983; e Cesare Molinari, Teorie della recitazione: gli attori sull’attore. Da Rossi a Zacconi, in
AA.VV., Teatro dell’Italia Unita, Il Saggiatore, Milano 1980; di nuovo Schino, Il teatro di Eleonora Duse, cit.
9
Giovanni Emanuel, Rossi o Salvini, Bologna 1880, pubblicato con lo pseudonimo John Weelman di Terranova. Cfr.,
inoltre, Adelaide Ristori, Ricordi e studi artistici, Torino 1887; Ernesto Rossi, Studi drammatici e lettere
autobiografiche, Firenze 1885, e Quarant’anni di vita artistica, Firenze 1887-89; Tommaso Salvini, Ricordi; aneddoti
ed impressioni, Milano 1895; Ermete Zacconi, Ricordi e battaglie, Milano 1946. Cfr. anche i trattati di recitazione di
due attori dai particolari interessi pedagogici, Alemanno Morelli, Note sull’arte drammatica rappresentativa, Milano
1862; e Luigi Rasi, L’arte del comico, Milano 1890.
10
Edward Tuckerman Mason, The Othello of Tommaso Salvini, New York-London 1890.
11
Meldolesi, Gustavo Modena cit.
6
esso — da cui era scaturita la sua realizzazione della Maria Stuarda). La drammaturgia dell’attore
implica una forma di personalizzazione della parte, trasformata in materiale per una creazione
coerente e artisticamente personalizzata (sono elementi, questi, che ritornano tutti, amplificati,
anche nel grande filone degli attori dialettali). L’autonomia creativa dell’attore è spesso anche
autonomia ideologica o personale.
Spesso gli attori furono legati ai movimenti risorgimentali. La biografia certo più significativa è
quella di Gustavo Modena, il quale aprì la serie dei grandi attori italiani. Il suo esempio fu
fondamentale, la sua influenza determinante. Certamente i suoi successori non seguirono i suoi
insegnamenti, ma senza di lui sarebbe mancato loro l’esempio da cui differenziarsi, il primo nucleo
di una tradizione da arricchire 12. Modena fece scuola, anche in senso stretto: nel 1843, senza tener
conto di possibilità più immediatamente vantaggiose (più tardi rifiuterà anche un’offerta della più
grande attrice dei suoi tempi, Adelaide Ristori) organizzò una compagnia di giovani, formata da
elementi scelti, esperienza che ripeté nel 1847 (alcuni di questi giovani, Tommaso Salvini, Fanny
Sadowsky, Ernesto Rossi, divennero poi altrettanti capiscuola e attori famosi). Anche questa
propensione alla pedagogia, soprattutto nei confronti dei futuri attori, fu un tratto fondamentale
della tradizione italiana.
Gustavo Modena fu anche un esempio, raro in Italia, di attore colto e impegnato politicamente
(mazziniano e combattente, rimase molti anni in esilio, lontano dall’Italia). Tuttavia i drammi in cui
più frequentemente si propose al pubblico (Luigi XI, di Delavigne; Bianca Cappello e Spazzacamini
della Valle d’Aosta, di Sabbatini; La calunnia, di Scribe, e perfino i “concerti” in cui recitava brani
della Divina Commedia) non sono a prima vista le scelte che ci si aspetterebbe da questa cultura e
da questo impegno. Si può dire (malgrado l’eccezione rimarchevole del Saul e Filippo di Alfieri e
del Maometto di Voltaire) che non entrò a far parte del suo repertorio nulla di quello che un uomo
colto interessato al teatro avrebbe considerato l’antologia della letteratura drammatica più degna e
rappresentativa per l’Italia. Non entrarono a far parte del repertorio di Modena neppure testi politici,
o da lui notoriamente amati (ad esempio si cimentò una sola volta in Shakespeare, nell’Otello).
Essendo certamente da escludersi, nel suo caso, motivazioni commerciali, Modena diventa forse il
miglior esempio di come il grande attore fosse cosciente (ed agisse di conseguenza) di una profonda
spaccatura tra i propri gusti personali, di lettore, e magari di spettatore, e le proprie esigenze di
attore.
L’attività politica di Modena ebbe un’influenza certamente importante, ma più mediata, sulle sue
scelte artistiche. L’abitudine a un secondo interesse, più pressante ancora del teatro, favorì
probabilmente il suo rifiuto di ogni ricezione passiva dei suggerimenti che gli fornivano la
tradizione o il testo. Cominciò a svilupparsi in questo modo, come un atteggiamento mentale di
rifiuto, uno dei fulcri dell’arte del grande attore: l’imprevedibilità, l’autonomia, la mancanza di
docilità anche in scena13. Modena creò una recitazione basata su di una composizione quasi
musicale di toni e di frammenti, del tutto indipendente (e anzi perfino contraddittoria) rispetto al
testo (questa sarà una linea fondamentale per il grande attore: Eleonora Duse la sviluppò fino ai suoi
limiti estremi, sfasando il ritmo anche della singola frase, e sfruttando soprattutto pause “alogiche”
e silenzi). Fondò, per l’attore, un tipo di atteggiamento forte e non consenziente, fatto di autonomia
dalla tradizione, dal pubblico, dai gusti e dalle tendenze correnti, che sarà poi tipico dei più
interessanti tra i grandi attori.
Usò il suo notevole e riconosciuto talento per la scrittura per prendere le distanze dalle abitudini
teatrali correnti: mentre gli attori scrivevano abitualmente memorie, o trattati di recitazione, o brevi
scritti di tono ameno, Modena si limitò testardamente alle lettere e ad articoli d’intervento.
L’attore dell’Ottocento era innanzitutto indipendente. In senso stretto non lo si potrebbe neppure
definire un interprete. Sulla sua recitazione influiva più l’insieme delle parti (il modo in cui diversi
12
Claudio Meldolesi, Modena rivisto, in “Quaderni di teatro”, 21-22, agosto-novembre 1983, numero monografico: La
poesia dell’attore ottocentesco.
13
Ibid.
personaggi, immaginati da autori diversi, entravano in reciproca relazione all’interno del repertorio)
che non i singoli testi. Le scelte in base alle quali veniva composto un repertorio non erano scelte di
gusto letterario, ma non erano né casuali né dettate da vanità o da ragioni di opportunità.
Rispondevano sì alle esigenze commerciali, ma anche a quelle professionali dell’attore.
Esercitandosi con continuità nell’ambito di uno stesso “ruolo”, in un repertorio ben assortito, egli
acquistava l’esperienza per “creare” la sua parte mediante accostamenti inaspettati di toni forti e
morbidi, mediante richiami e associazioni, mediante caratterizzazioni diverse e impreviste anche
dall’autore. Lo spettacolo, l’attrattiva per il pubblico, nasceva proprio dall’intreccio di queste
diverse drammaturgie parallele.
Ma questa mancata sottomissione a ciò che spesso è considerato il materiale nobile del teatro, il
testo letterario, spesso fa sì che si parli in termini negativi, con incomprensione, del mestiere
dell’attore. Un modo di guardare al teatro dell’Ottocento che si è trasmesso fino ai nostri giorni e
per cui l’attore creatore è spesso confuso con il “mattatore”. Nell’affermare l’esigenza critica dello
spettacolo come opera d’arte unitaria (e cioè il moderno concetto di regia) si è parlato con fastidio
crescente dei “vizi” del palcoscenico italiano, senza rendersi conto di come arte e vizi fossero le due
facce di uno stesso fenomeno: l’autonomia creativa dell’attore che implica una produzione e una
organizzazione teatrale diversa, ma non per questo inferiore, nel gusto e nel modo di produzione, a
quella che passerà nel Novecento.
A questo difficile e non di rado distruttivo passaggio sono dedicati gli studi di Gigi Livio
raccolti in La scena italiana 14, che abbracciano un arco di tempo che va da Gustavo Modena a
Petrolini; e il volume di Roberto Alonge 15, che significativamente, dopo il capitolo dedicato al
“grande attore”, intitola un capitolo al passaggio Dall’industria dello spettacolo allo spettacolo
dell’industria per significare «l’avvento della regia».
14
15
Gigi Livio, La scena italiana. Materiali per lo spettacolo dell’Otto e Novecento, Mursia, Torino 1989.
Alonge, Teatro e spettacolo nel secondo Ottocento, cit.
Silvio d’Amico
Maschere. Note su l’interpretazione scenica, Mondadori, Milano 1921, pp.
53, 60-70.
Shylock
(Novelli)
Shakespeare veramente non ha scritto Shylock; ha scritto Il mercante di Venezia. La constatazione è
ovvia; ma sembra di solito dimenticata da coloro che hanno studiato quest’opera. Quasi tutti infatti
paion rivolgere di preferenza i loro sguardi sull’ebreo; il quale ne è sì il carattere più appariscente; ma
non il principale. Persino Heine, in «Donne e fanciulle di Shakespeare», dovendo intrattenersi intorno
alla figura di Porzia, finisce col non aggiungere più che poche parole a quelle della Jameson, e si
dilunga poi ad osservare i tratti di Shylock.
Eppure, che l’opera non s’intitoli a lui, sarebbe cosa da tener presente anche a chi volesse limitarsi
ad esamirare il solo carattere dell’usuraio. Che questo non sta a sé, ma naturalmente si rivela attraverso
le vicende del poema; dal cui svolgimento trae luci e ombre. Ora il poema si origina e si svolge non
dalla storia di Shylock; ma dalla storia di Antonio, il mercante: la quale costituisce il nodo donde si
svolgono le due azioni parallele, quella dell’usuraio e quella di Porzia.
[...] L’ebreo, sebbene sia da annoverare fra le più caratteristiche creazioni di Shakespeare, non è
certo il "protagonista" del poema, nel senso classico della parola. Questo procede così aperto e vario,
che non si serra mai intorno a una figura centrale, neanche alla stessa Porzia: si allarga anzi sempre più
per le file de’ molteplici episodii, i quali sono tuttavia germinati, con spontanea logica, da
un’architettura interiore esile ma salda. Il suo intreccio fiorisce con dovizia shakespeariana, ma
metodicamente, in scene, in quadri, in persone; e dalla tranquilla armonia di tutta questa fioritura risulta
la perfezione quasi latina del poema.
***
Vogliamo ora immaginare che sia possibile ad una nostra Compagnia drammatica, e segnatamente
alla Compagnia del più tipico fra i nostri "mattatori", intendere, comporre e rendere questa poesia agile
e intensa, in tutti i suoi elementi? Potrà esser mai la florida signora Giannini, che è la prima attrice e
quindi è Porzia, a dirci: «Il mio piccolo corpo è stanco di questo gran mondo»? E dove troveremo
nella Compagnia Novelli una creatura come Gessica, la bella ebrea; un caratteristico buffone
shakespeariano, come Lancillotto gobbo; un buono e saggio Antonio; un principe di Marocco?
Nella Compagnia italiana del "mattatore", di regola non c’è che lui: ergo, nel Mercante di Venezia
non apparirà che Shylock. Poco importa si tratti di Shakespeare: il suo poema sarà considerato, come
tutti i lavori teatrali grandi e piccoli di questo grande mondo, niente più che un canevaccio da trarne un
carattere, uno straordinario carattere, ad uso del nostro maggior comico.
Dunque si adotterà una riduzione, intitolata Shylock senz’altro: la quale offrirà a Novelli il modo di
impadronirsi della figura del vecchio ebreo e di trasportarla in primo piano, respingendo il più possibile
nell’ombra tutte le altre. Si otterrà di conseguenza una specie di monologo affidato a lui, sopra uno
sfondo di controfigure non aventi altro còmpito che quello di fornirgli il pretesto per parlare.
Questo sfondo è stato distribuito in quattro atti anziché in cinque. Un povero criterio di realismo,
ereditato dalla commedia francese di cinquant’anni fa, ha soppresso l’originale procedimento
shakespeariano, che è per cambiamenti di scena a vista. La scena è dunque fissa in ciascun atto: con
disastrose conseguenze.
Nel primo, siamo per una strada di Venezia. Sono state condensate in questo atto le scene di Antonio
co’ suoi amici, quella in cui egli stipula il patto con Shylock, e — di colpo — quella del rapimento di
Gessica. Poi se ne è aggiunta ancor una, di invenzione del riduttore (o dell’attore?), che l’ha tratta da un
breve dialogo fra Salarino e Salanio nella scena VIII del second’atto; il che riprova il modo con cui s’è
considerato il poema; schema da porre in azione «a soggetto». In questa scena Shylock ritorna, e scopre
il rapimento della figlia. Le sue imprecazioni sono coperte nientemeno che con un coro di fischi, dei
monelli venuti in coro a dargli la baia.1
Al secondo atto, Shylock riappare nella via, sempre urlato dai ragazzi: è affranto dalle inutili
ricerche per scoprire sua figlia e il rapitore. Segue il dialogo con l’ebreo Tubal, che gli dà, alternate, le
notizie dei disastri commerciali del suo debitore, e quelle della prodiga vita di sua figlia. Quindi giunge
la novella del fallimento di Antonio: e trionfa, contro le implorazioni de’ suoi amici, la ferocia
dell’usuraio che lo fa imprigionare.
Come s’è visto, in questi due primi atti è interamente soppressa — oltre le scene di Lancilotto Gobbo
con suo padre e con Gessica, e altre secondarie — la storia di Porzia, di cui si fa appena cenno, senza
ch’ella appaia. Ma quanto al riduttore è sembrato essenziale di quella storia, invece d’essere intrecciato,
a grado a grado, con le scene della storia di Antonio e di Shylock (che n’è in dipendenza), è stato
condensato goffamente nel terz’atto. Qui s’aprono all’improvviso le sale di Porzia dove si ritrovan
Gessica e Lorenzo, e si succedono a tamburo battente le scene col principe di Marocco, col principe di
Aragona e con Bassanio. La gioia di Porzia e del suo sposo sono sconvolte dall’annunzio che Antonio è
fallito. Ma Porzia forma il suo piano per salvarlo.
E siamo all’atto quarto: che consiste, quasi integralmente, nella I scena del quart’atto di
Shakespeare. Ma, uscito definitivamente Shylock, è soppressa la fine dell’atto; ed è soppresso per
intero l’atto quinto: logica conseguenza dell’aver proiettato tutto il dramma sulla figura dell’ebreo,
elevandolo a protagonista d’un intrigo alla Scribe.
***
Non resta, dunque, a considerare altro che l’ebreo.
Diciamo subito che Ermete Novelli, quanto mostra di aver rinunziato a intendere il poema,
altrettanto è entrato nello spirito del carattere shakespeariano.2
S’è già avuto occasione di notare altrove che Novelli non esce mai da un suo eterno tipo di vecchio
tra burbero e benefico. E che, come accentuandone le qualità bonarie ci dà i «promiscui» della vecchia
scena specialmente francese, così, accentuandone, le qualità rudi sino alla ferocia, giunge a Nerone, a
Luigi XI, a Shylock.
Ma, se di Nerone, egli ha ben reso l’istrionismo tragicomico, e se di Luigi XI intuito a preferenza
certe grosse note di bigottismo pauroso e crudele, è dubbio che nell’una e nell’altra figura abbia
1
Si racconta che in una capitale europea, dove Novelli aveva rappresentato di questa roba, venne Irving e dette il Mercante di
Venezia. Qualche critico teatrale scattò irritato, e chiese conto all'attore inglese di aver amputato dal dramma la scena dei ragazzi
sibilanti «così bene interpretata dal celebre Novelli». Irving dovette scrivere una lettera ai giornali, per far notare che la scena era
stata, non già soppressa da lui, ma inventata o aggiunta dal celebre Novelli.
2
E. BOUTET, nelle Cronache Drammatiche, art. I°, vol.3, fasc. 31, pag. 96, racconta: « Per istudiare il tipo israelitico di Shylock,
egli passava giorni interi in una botteguccia veneziana; ma l'ebreo della botteguccia gli forniva alcune linee del volto; la persona
non era completa. E allora, a Trieste, Ermete Novelli ha speso quattrini su quattrini, comperando tutti i giorni dagli ebrei polacchi
cedro del Libano, da farne una catasta. Nemmeno là trovava tutte le forme esteriori del suo carattere; erano mezze tinte e tinte
preziose, nulla più. Ma a Ferrara trovò la faccia, il gesto e l'atteggiamento che gli servivano. In un caffeuccio untuoso frequentava
un mercante. Tutti i giorni Novelli andava a sorbire un atroce caffè in quel tenebrore; ma conversava col suo mercante e ne
sorprendeva le più piccole sfumature dell'atteggiamento e della fisionomia. Una volta si fece scappare il nome Shylock, il
mercante non tornò più; però aveva posata quanto era necessario."
conservato quel tanto di regale ch’esse pur debbono avere.
Shylock invece lo intende tutto; non soltanto nella sua ferocia; ma nella sua miseria, nella sua
abbiezione, nel suo sudiciume, nella sua avarizia, nella sua grettezza, nella sua ostinazione, nella sua
disperazione, nella sua viltà; e anche nella pietà umana che ispira. Truccatura, abbigliamento,
atteggiamenti, parlata, tutto è perfetto in Novelli quando incarna Shylock. La mobilità della sua
maschera facciale non è forse sfruttata da lui in modo più vario e potente che in questa interpretazione.
Le occhiate di lui si fanno, volta a volta, cupide, sprezzanti, dubbiose, sospettose, sommesse,vili,
astute, aspre, selvagge. Quelle sue due rughe che gli corron dalle nari sin oltre gli angoli della bocca,
nella sua smorfia più abituale, sa incavarle profonde e dure sino a dare un pauroso senso di terror
giudaico. E riesce a incurvar l’alta statura sino a far della sua persona una povera e abbietta cosa
strisciante, si rannicchia sugli scalini della sua casa o del tribunale come un mucchio di stracci,
s’abbatte in terra gemendo e imprecando come squassato e infranto nell’intimo dell’esser suo. Anche
quel suo rabbioso strisciar sull’erre conferisce a tutto il suo linguaggio un che di rauca volontà nemica,
vendicativa; le parole: — Ebreo! Cristiani! — pronunciate a quel modo, riescono un gorgoglìo d’ira
costretta e impotente. In verità, Shylock è davanti a noi.
***
Tutto questo prova che Novelli ha miracolosamente intuito e studiato. Non però che ce lo tenda con
la dovuta fedeltà ai segni in cui Shakespeare lo fissò. Per la riduzione del poema ch’egli ha adottato, e
per gli stessi mezzi di cui si serve, ciò gli riesce impossibile.
E anzitutto: Novelli, al solito, non recita scrupolosamente la sua parte, secondo il testo
shakespeariano.
V’hanno sì certi tratti, dove il poeta incise a colpi profondi questo suo tremendo carattere, ai quali
l’attore dà uno straordinario rilievo. Cito quelli in cui Shylock replica alla prima domanda di Antonio:
Voi mi avete chiamato innocente, malfattore, cane; avete sputato sul mio mantello da ebreo... Ora che sembra abbiate
bisogno ch’io vi soccorra, venite a dirmi: — Shylock, vorremmo denaro... — Denaro chiedete? E che potrei rispondervi io?
Non dovrei dirvi: — Forse che un cane ha del danaro? È mai possibile che un cane presti tremila ducati? — Ovvero dovrei
salutarvi profondamente, e nell’attitudine di uno schiavo dirvi con voce bassa e timida: — Mio bel signore, voi sputaste su
me mercoledì scorso; voi un altro giorno m’avete preso a calci; altra volta mi chiamaste cane; in riconoscenza di queste
cortesie vi presterò tutto il denaro che vi occorre...?
E l’altro brano famoso:
E tutto questo perchè? Perché io sono un ebreo. Ma un ebreo non ha occhi? Un ebreo non ha mani, organi, dimensioni,
sensi, affezioni, passioni? Non è nutrito dagli stessi cibi, non rimane ferito dalle stesse armi, non va soggetto alle stesse
infermità, non è risanato dagli stessi rimedi, non è riscaldato e assiderato dalla stessa estate e dallo stesso inverno, come un
cristiano? Se ci pungete, non mandiamo sangue noi? Se ci solleticate, non ridiamo? Se ci avvelenate, non moriamo? E se ci
oltraggiate, non dobbiamo vendicarci?
Novelli è meraviglioso dicitore di questi ultimi due tratti. E un rilievo anche più forte dà alla scena
in cui Tubal gli porta, insieme, le notizie della prodigalità della figliola fuggita, e quelle della rovina di
Antonio; il contrasto di battuta in battuta, dove si alternano metodicamente l’avvilimento e l’aspra,
compiacenza, è anzi esagerato sino allo schematismo.
Tuttavia il nucleo della parte Novelli se lo rifà a suo modo. Non dimentichiamo ch’egli è l’autentico
«commediante dell’arte». Pur avendo inteso il tipo, Novelli non sa ridarlo in una paziente e diligente
esecuzione del testo e si contenta d’averne assimilato lo spirito (ed è già molto); poi lo ricostruisce
come gli va.
E anche qui par che si affidi, almeno in parte, alle «trovate» più o meno immediate, e alla così detta
improvvisazione. V’hanno infatti scene intere di questa sua interpretazione ch’egli rende quasi senza
parole, coli borbottii, con brontolii, con muggiti e con ruggiti sordi. Altre, scene, come abbiam detto, le
aggiunge. Ad altre infine toglie dei brani: le due volte ch’io l’ho udito, a distanza di anni, non gli ho
inteso dire uno dei primi tratti della sua parte, là dove si parla delle ricchezze con cui Antonio dovrebbe
garantire il suo debito:
Ma le navi non son che tavole, i marinai non son che uomini: ci son topi di terra e topi di mare, ladri di terra e ladri di
mare, vo’ dire pirati; più, c’è il pericolo delle onde, dei venti e degli scogli...
Né, l’ultima volta almeno, ho udito da lui un altro tratto, di carattere così nettamente
shakespeariano, che nel testo è al principio del quart’atto:
Mi chiederete perché mi piaccia di più prendere una libbra che tremila ducati... Non risponderò a questo, se non
dicendovi è un mio capriccio: vi basta? Se un topo mi rode la casa, e io per avvelenarlo voglio spendere diecimila ducati,
che ci trovate a ridire? Vi par questa una buona risposta? Ci son certuni che non possono vedere un porchetto di latte con la
gola aperta; altri che s’atterriscono alla vista d’un gatto; altri che al suono nasale di una cornamusa non possono ritenere
l’orina; tanto la nostra sensibilità, padrona assoluta de’nostri affetti, li assoggetta all’impero delle sue simpatie e delle sue
ripugnanze! Ora se volete una risposta, eccovela: a quel modo che non si può spiegare con nessun argomento sensato
l’avversione di certuni per un maiale che sbadiglia, di altri per un gatto, animale utile e inoffensivo, di altri pel suono della
cornamusa; a quel modo che tutti cedono a una forza invincibile, la quale li costringe a dispiacere agli altri perché essi
stessi sono offesi; a quello stesso modo non posso e non voglio dare altri motivi della mia inflessibilità nel procedere
contro Antonio a scapito della mia borsa, che un odio radicato da un’assoluta avversione. Ho risposto a tono?
Il perché di questi tagli non si riesce poi a intender bene. O Novelli, secondo l’abitudine che gli si
attribuisce, anche qui rimpasta e in parte improvvisa sera per sera, più o meno a caso, saltando o
aggiungendo come gli capita: il che con Shakespeare è inconcepibile; oppure non sente quei brani,
come succede talvolta agli esecutori, e li sopprime; il che è sacrilego.
Ma intanto la conseguenza di tutto ciò è che il carattere di Shylock, pur evidente, resta in certo
senso "immobile": laddove Shakespeare, che non è Eschilo, non ne ha fatto una statua parlante, ma lo
ha ben posto in azione, ce lo ha dato drammaticamente.
Vediamo il testo originale. Quando Shylock appare la prima volta, non è che un avido e sospettoso
usuraio. Rimastica cupo le sue parole, che usa ripetere: «Tremila ducati... bene — Per tre mesi... bene.
— Antonio farà cauzione... bene. — No, no, no, no...» . Non impreca, né, molto meno, urla. Borbotta
sordo. L’idea della vendetta su Antonio è risvegliata man mano in lui, insieme con l’odio, dai ricordi
del disprezzo e dello scherno subìti. Concepisce l’atroce piano; ma dissimula il suo intento; che, come
abbian già notato, fa stipulare il patto «piacevolmente», «per celia».
Oh padre Abramo, che son mai questi Cristiani! La malvagità dei loro atti insegna ad essi a sospettare delle intenzioni
altrui. Ditemi di grazia, s’egli non pagasse al termine stabilito, che ci guadagnerei io esigendo l’adempimento dell’impegno?
Una libbra di carne di uomo non vale una libbra di carne di montone, di bue o di capra. Quel ch’io fo, lo fo per offerta di
amicizia...
Poi il rapimento di Gessica dà il tracollo al suo odio. Shylock non è il Barabba di Marlowe: se la
sua ferocia ci appare ancora inaudita, Shakespeare l’ha pur giustificata il più umanamente possibile
con le circostanze in cui la fa prorompere. Vendicarsi di Antonio, per lui è vendicarsi di tutti i cristiani,
compreso il rapitore di sua figlia. Soltanto così si intende la selvaggia rabbia della sua vittoria, soltanto
così è possibile ch’egli arrivi ad affilare il coltello. La sentenza di Porzia lo ripiomba nell’avvilimento.
Shylock è distrutto. Un cencio.
Ora queste spiegazioni e gradazioni psicologiche, questo progressivo svelarsi del suo carattere di
scena in scena, questo ascendere di Shylock sino al culmine della sua ira e questo suo riprecipitare,
nella sconfitta, Novelli non ce lo dà. Per lo meno non ce lo dà con la nitidezza posta da Shakespeare.
Dalla prima battuta all’ultima, egli è su per giù sempre uguale e se stesso. Nel prim’atto è già così iena
come nel quarto; stipula il patto con la stessa palese voluttà di sangue con cui poi ne chiederà
l’esecuzione; si rannicchia miserabile sugli scalini della sua casa, mentre detta le condizioni al
debitore, allo stesso modo che sugli scalini del tribunale, quando aspetta il responso del Doge che lo
schiaccerà.
Perciò dicevamo che Novelli non rende la dinamica del personaggio, e che nelle sue mani il
dramma diviene un monologo. L’interesse materiale dell’intrigo potrà forse attrarre, anche così com’è,
lo spettatore; ma interesse psicologico, dopo la scena di presentazione, in fondo non ce n’è più,
Shylock s’è già dato intero sin dalle prime battute. E l’immobilità del carattere fa sì ch’esso resti
inesplicato: quindi, che appaia esagerato. Enorme errore.
D’altra parte l’aver soppresso o svisato o impallidito tutto lo sfondo da cui la figura di Shylock
viene in luce, ne diminuisce irresponsabilmente il risalto. Di fatto Porzia, ridotta a quel modo, non
esiste più. Non c’è più tutto quel quadro luminoso, pregno di spirito della Rinascenza e di splendor
veneziano, tutto quel prodigio di sontuosità che circonda e corona la fulgida erede, tutta la sua grazia e
tutta la sua lietezza, di contro alla fosca abbiezione del vecchio. Non c’è più quel contrasto, che
incantava Heine, fra il vago parlare di Porzia, pieno di festose immagini mitologiche, e il brutto e tetro
discorrer del giudeo, irto di rozze citazioni bibliche, facezie livide e di metafore ripugnanti. Non c’è più
quel contrapporsi dell’inno d’amore intonato dai cuori in sussulto, prima intenti allo studio degli
amorosi enigmi e poi beati dall’intima armonia che intendono all’unisono con quella dell’ampia notte
stellata — di fronte alla volontà malefica, al singhiozzo soffocato, all’ira ristretta, all’obliqua
imprecazione di Shylock.
Lo stesso è da notare per l’insufficienza di Gessica, che, nell’interpretazione ridotta e sbiadita
d’un’attrice inetta, quasi scompare; e per l’assenza pressoché assoluta di Lancillotto Gobbo. Al rilievo
della figura dell’ebreo mancano ancora questi altri due contrasti che il poeta gli aveva posto intorno,
come una cornice immediata: la soavità di sua figlia, così amorosa e tenera creatura che non par suo
sangue («C’è più differenza fra la sua carne e la tua che fra il carbone e l’avorio» gli dice Salarino al 3°
atto); e la buffoneria del servo; che dovrebbe prorompere e schioccar grassa accanto alla cupa grettezza
del padrone.
Shylock non vive isolato. Distrutto il poema, attenuate le figure circostanti, anche gran parte degli
elementi che compongono la sua stessa persona si dissolve e si disperde.
È doloroso riconoscere che questo avvenga nell’incarnazione fattane da Ermete Novelli; la quale pure
passa, per molti riguardi a ragione, come una delle più potenti del nostro teatro contemporaneo.
1916