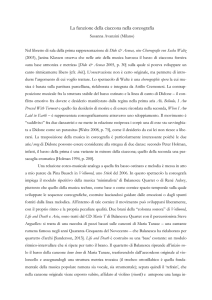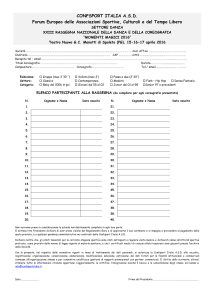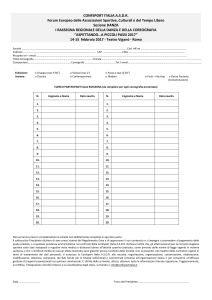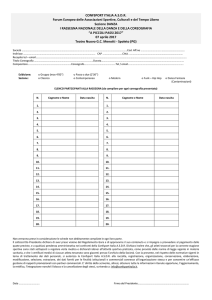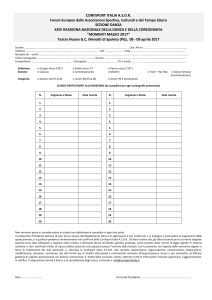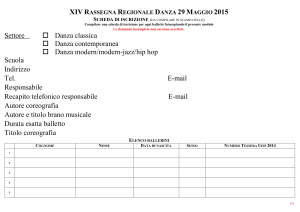coreografia Sasha Waltz
musica Tristan Honsinger Quintett
Jean-Marc Zelwer (Le tourment de Vassilissa la Belle)
danza
Davide Camplani, Maria Marta Colusi,
Edivaldo Ernesto, Mamajeang Kim,
Florencia Lamarca
scene Barbara Steppe
disegno luci Tomski Binsert, André Pronk
la pièce è stata creata da e con i danzatori
Nasser Martin-Gousset,
Ákos Hargitay/ Thomas Lehmen,
Charlotte Zerbey, Takako Suzuki, Sasha Waltz
tecnico luci Martin Hauk
tecnico suono Lutz Nerger
sartoria Emily Abel
preparatore Takako Suzuki
assistente alla regia Steffen Döring
tour manager Karsten Liske
SASHA WALTZ A FERRARA
co-produzione Sasha Waltz & Guests,
Grand Theatre Groningen, NL
con il gentile supporto di Senatsverwaltung für Kulturelle
Angelegenheiten/ Berlin, Fond Darstellende Künste e.V.,
Initiative Neue Musik Berlin e.V.
PRIMA ASSOLUTA BERLINO 1993
PRIMA ITALIANA FERRARA1996
Sasha Waltz & Guests
si avvale del sostegno di Hauptstadtkulturfonds
Travelogue I – Twenty to Eight
7 marzo 1996
prima nazionale
Allee der Kosmonauten
12 marzo 1998
prima nazionale
Zweiland
13 marzo 1998
prima nazionale
Impromptus
4 dicembre 2004
prima nazionale
spettacolo presentato in collaborazione con
durata dello spettacolo: 70’ senza intervallo
Dido & Aeneas
16, 17 giugno 2006
prima nazionale
nobody
2, 3 novembre 2007
prima nazionale
TRAVELOGUE: SURREALISMO E VERITÀ.
IL VIAGGIO DI SASHA WALTZ
NELL’UNIVERSO DOMESTICO
di Marinella Guatterini
Con il debutto, nel 1996, di Sasha Waltz il Teatro Comunale di Ferrara approfondiva il suo
originale “progetto Germania” e lo rendeva,
se possibile, ancor più eclatante. In quell’occasione, infatti, si incaricava di lanciare un’artista
ancora totalmente sconosciuta in Italia, tenendo a battesimo Travelogue I ‑ Twenty to Eight, lo
spettacolo che l’aveva rivelata in Europa e in
America. Sasha Waltz era stata scoperta dalla
critica tedesca e internazionale, e il suo lavoro
mostrava senza ombra di dubbio una maestria
compositiva (e sarebbe stato poco: molti creatori tedeschi possedevano questa qualità)
che andava di pari passo con un’innovazione
linguistica tale da far scattare, in chi, come noi,
aveva seguito negli anni le vicende della danza contemporanea, un campanello d’allarme.
All’epoca non sapevamo ancora dire se il suo
suono avrebbe avuto la potenza d’urto e soprattutto la durata del tintinnio che avevamo
udito molti anni prima, nel 1980, in occasione
del debutto italiano di Pina Bausch con Café
Müller al Teatro Due di Parma, né se la Waltz
sarebbe stata in grado di equiparare l’insondabile genialità della regina del Tanztheater
di Wuppertal, ora purtroppo scomparsa, e
anzitempo. Ma di una cosa eravamo certi: che
grazie a una manciata di spettacoli quella giovane tedesca schietta e volitiva, nata nel 1963
a Karlsruhe, aveva già spostato di centottanta
gradi la prospettiva di lettura del Tanztheater
indicandone nuove modalità e disvelando un
respiro poetico in grado di tradurre gli umori
delle giovani generazioni, in specie in quella
delicata sfera dei rapporti interpersonali e di
coppia di cui la Bausch ci aveva restituito un
suo spaccato d’epoca, segnato dalle disillusioni, dalle angosce e dalla frustrazione di una
Germania ancora cocentemente ferita dall’or-
rore dell’Olocausto.
Inoltre: nel 1996 il segno di Sasha Waltz ci era
apparso più “allegro” e al tempo stesso meno
universale di quello dei campioni e delle campionesse del Tanztheater anni Ottanta. Sebbene l’umorismo (spesso nero) dei suoi primi
pezzi e la vorace sensualità della sua danza, si
schiantassero volentieri, come avremo modo
di constatare questa sera, contro l’alienazione,
l’horror vacui e il solipsismo, l’alito della sua coreografia, sgorgante da una gestualità ancora
inedita, era fresco; vi serpeggiava la speranza
costruttiva di chi non è ancora del tutto provato dal faticoso mestiere di vivere, né intendeva
abbandonarsi a quella Sehnsucht così tipicamente tedesca, che affiora persino dalle rovine
dei “paesaggi Bausch”. La poetica della Waltz,
a metà anni Novanta, si sviluppava invece in un
qui e ora del tutto contiguo a una generazione
– quella dei giovani nati negli anni Sessanta – e
cavalcava la loro voglia di riscatto, recupero e
fantasia. Del resto Sasha Waltz aveva alle spalle
una formazione e una storia personale ideologicamente positive.
La nostra ospite, come gran parte dei coreografi quasi cinquantenni o già approdati al
mezzo secolo d’età, non ha seguito un iter di
studi regolari: la “regolarità” nella costruzione
di un coreografo era, già all’inizio degli anni Novanta, quasi del tutto in estinzione… Occorreva, invece, accumulare esperienze diverse e la
Waltz, rifuggendo le Scuole dei grandi maestri
del contemporaneo come, a esempio, Merce
Cunningham, aveva gettato il suo corpo e il suo
cuore nell’avventura sperimentale dei Postmoderni ancora radicali (come Pooh Kaye),
convinti della necessità di una danza semplice,
naturale, lontana dagli intellettualismi: un’arte
“di contatto”. E si vedrà quanta Contact Dance
in cui i partner di una coppia rivelano la loro
personalità “pelle a pelle” (una modalità nata
soprattutto dalla sperimentazione del postmoderno Steve Paxton) emerge dai movimenti
inventivi di Travelogue I ‑ Twenty to Eight.
Con rinnovata fiducia nelle potenzialità dell’arte interdisciplinare, Waltz aveva inaugurato,
proprio a New York, le sue prime collaborazioni creative con pittori, musicisti, generici artisti
visivi, performer e naturalmente ballerini. Al
ritorno in Germania, nel 1988, la sua biografia
si infittiva di scambi, di suggestioni letterarie,
poetiche e cinematografiche tradotte in teatrodanza grazie a uno scambio diretto con gli
interpreti: ballerini ma anche co-autori.
La serie delle improvvisazioni intitolate
Showing (I, II, III, IV e V), che inaugurava la residenza della Waltz al centro artistico Bethanien
di Berlino (1993), manteneva l’immediatezza
degli eventi performativi. La danza nasceva da
improvvisazioni di artisti in parte coinvolti nella
successiva trilogia Travelogue, come il raffinato
compositore e violoncellista Tristan Honsinger, a capo di un suo sestetto, e i versatili danzatori Takako Suzuki e Nasser Martin‑Gousset.
Era singolare, e tuttavia esemplificativo di una
tendenza ancora attualissima, il fatto che l’artista non avesse creato una sua compagnia fissa,
ma preferito la formula dell’invito a “guests”,
cioè a ospiti di volta in volta anche diversi, scelti
in base alla necessità di un dialogo dal quale
scaturissero, auspicabilmente, danza e coreografia diverse. Waltz firmava le idee, i progetti,
l’impostazione narrativa: il resto nasceva dal
dialogo, e si sa quanto muti il nostro modo di
comunicare se mutano i nostri interlocutori...
Anche l’espandersi dei ruoli – da coreografa
a regista –, era una novità dell’epoca, ora assodata: sempre più spesso ci imbattiamo in
metteur en danse che collaborano con registi,
e in coreografi che diventano anche registi: il
caso esemplare di Alain Platel (l’autore di Out of
context - For Pina atteso anche al Comunale di
Ferrara) indica come la danza abbia perso la sua
centralità “tecnica” a favore di una coreografia
tanto onnicomprensiva da definirsi regia tout
court. Ma indica anche che dalla seconda metà
degli anni Novanta la danza contemporanea
ha vissuto una ennesima rivoluzione di cui ancora in parte risente l’influsso. Lo spettatore se
ne avvedrà proprio immergendosi nella visione del primo Travelogue.
Il titolo innanzitutto – una crasi di travel (viag-
gio) e dialogue (dialogo) – indica l’idea di un
viaggio che Waltz e compagni compiranno
nell’universo, pensate quanto fantastico, della
vita domestica. Una cucina (Travelogue I), una
stanza da bagno, retro di un equivoco bar (Travelogue II), una camera sovrastante una strada
(Travelogue III). Gli ambienti non sono supposti,
e neppure trasfigurati: gli oggetti che li ingombrano e servono alle azioni sono del tutto reali
e… banali. Ma le luci che li investono (di Thomas Binsert e André Pronk, collaboratori ricorrenti nei primi progetti della Waltz, come la scenografa, Barbara Steppe), emanano un sapore
esagerato, artificiale. L’artificio, lo chiarirà anche la danza dello spettacolo di stasera, nasce
da una potente suggestione cinematografica.
I cinque protagonisti della prima tappa di Travelogue, creata nel 1993, sono del tutto simili
a noi (“ogni uomo è un danzatore”: torna qui
a risuonare il più nobile motto labaniano) ma
spesso giocano un ruolo (eine Rolle spielen, interpretare una parte, o to play a role: in tedesco
come in inglese il verbo “interpretare” significa
anche “giocare”) caricato di enfasi filmiche. Ep-
pure parlano, rispondono al telefono, tentano
di mangiare anche se l’egoismo umano – quanti sentimenti spiccioli si riflettono nella piccola
cucina! – porta qualcuno a impossessarsi della
pagnotta e gli altri ad accontentarsi delle briciole...
Il sopruso non è, però, fonte di conflitti esasperati: nella cucina si vivono solo microdrammi
che si perdono in un parossismo surreale. C’è
spazio per la fantasia di ciascuno, per un sogno
d’amore che diventa palpabile scena dei sensi (e di parti del corpo) accarezzati sulle note
di un tango milonga, restituito solo con gli
arti inferiori, e contro lo spigolo di un tavolo.
E c’è tempo per una gimkana liberatoria tra le
bottiglie vuote… Attrazione, repulsione, sensualità, aggressività ma anche tenerezza sono
i colori delle danze di coppia e di un delicato
assolo “bonbon” che rivela pudore. Il viaggio
non è grandioso ma minimale: il linguaggio è
pero una geniale sintesi di gestualità mimicoacrobatica, di danza di sala, e di musical, con
ripetizioni battenti che potrebbero essere ricondotte all’influenza di certa danza fiammin-
ga (Anne Teresa De Keersmaecker), lasciata
però alle spalle nell’urgenza espressiva che
assegna all’ossessione ripetitiva una valenza di
scatto musicale, di ritmo orgasmico crescente
e decrescente, ma non si interrompe mai, come
nell’eruzione vulcanica e rumoristica del finale.
Spiace, ieri come oggi, non poter assistere anche alle altre tappe di Travelogue (le due pièce
restanti, a loro volta, fanno serata a sé, e non
sono mai approdate in Italia) perché l’insieme
del viaggio rivela come Waltz si sia mossa, nella
prima tappa, sul terreno della commedia, nella
seconda del genere noir (è una pièce con delitto) e nella terza in quell’ambito di fiction semifiabesca e infantile che include i Walt Disney e
Mary Poppins.
La diversità d’umore, di paesaggio e d’espressione di questa sorprendente trilogia comportò, negli anni Novanta, una diversa riflessione
sul teatrodanza. Il genere stava infatti progressivamente perdendo lo specifico di denuncia
sociale, tipico degli anni Ottanta, per adattarsi
a obbiettivi più ecelettici. Ma non aveva ancora trovato coreografi di spicco. L’incontestabile
genialità compositiva dei tre Travelogue sarebbe stata per Sasha Waltz una prova certa dei
suoi futuri primati. Ma già Travelogue I, con i
suoi calibratissimi e speciali interpreti, era un
primo, importante biglietto da visita.
Al termine dello spettacolo è possibile percepire un vago senso di sospensione: non abbiamo assistito, tuttavia, a una pièce non finita,
bensì a un’eclatante messa in scena di tempi
inconsistenti più che drammatici, e di talune
comiche, più che laceranti, nevrosi. Restano
i bisogni primari: mangiare, amare, dormire,
ma come soddisfarli nella cucina, metafora di
turbamenti giovanili, microconflitti generazionali e delicatissimi orrori umani? Ecco il quesito
che arrovellava e ancora arrovella Travelogue
I - Twenty to Eight.
Una breve postilla
In questo scritto, ricamato una seconda volta
da un calco pre-esistente, mancano almeno
due considerazioni importanti. La prima riguarda la fama conquistata da Sasha Waltz grazie a
una serie di produzioni che hanno confermato
il suo valore artistico. Pensiamo a una sua seconda trilogia, meno legata a elementi narrativi, e concentrata sul tema del corpo nell’era
tecnologica, composta da Körper, S, e noBody
else (2000-2002). Una tappa che, tra l’altro, ha
visto la coreografa e la sua mobile compagnia,
la Sasha Waltz & Guest, trasferiti alla Schaubühne am Lehniner Platz, per un progetto di
co-direzione artistica dell’importante teatro
berlinese conclusosi nel 2005, proprio l’anno
di nascita di Dido & Aeneas.
Precedente all’allestimento dell’opera di
Henry Purcell, tra l’altro ospitata solo al Teatro Comunale di Ferrara, con grande risalto e
merito, un’immersione nella musica di Franz
Schubert per Impromptus (2004), coreografia
(pure ospitata nel teatro estense) di gracidante
malinconia, in cui la Waltz rinunciava all’andamento frantumato in azioni coreo-gestuali del
suo precedente teatrodanza per ricercare una
sinfonica unità compositiva, poi ulteriormente
messa a punto nella lunga gestazione – oltre
un anno di lavoro – di Dido & Aeneas. L’opera
debuttò alla Staatsoper Unter den Linden di
Berlino grazie alla collaborazione con Attilio
Cremonesi, esperto di musica barocca, qui direttore dell’Akademie für Alte Musik e del Vocalconsort di Berlino ma anche ricostruttore e
compositore ex-novo delle musiche perdute di
Purcell. Sapientemente integrati nell’opera dodici ballerini e cinquantun strumentisti, coristi
e cantanti solisti. Il successo internazionale indusse la coreografa a proseguire il suo dialogo
con la musica cantata in Medea (2007), nuova
edizione dell’opera Medeamaterial del compositore francese Pascal Dusapins, su testo di
Heiner Müller che debuttò al Grand Théâtre del
Lussemburgo mentre il suo Roméo et Juliette,
su musica di Hector Berlioz fu una creazione
destinata al Balletto dell’Opéra di Parigi. Al
debutto, nell’ottobre 2007, danzatori, coristi e
cantanti furono diretti sul podio dal russo Valery Giergiev. Da quella data in poi il lavoro della
Waltz si è concentrato su eventi site-specific,
tra cui l’inaugurazione del Maxi, Museo di arte
contemporanea di Roma, installazioni e agili
improvvisazioni. Ma ha anche incluso il recupero delle sue coreografie anni Novanta.
Ed eccoci giunti alla seconda considerazione di
questa postilla. È in atto, da qualche tempo e in
ambito internazionale, una considerevole tendenza a recuperare le più significative o riuscite
coreografie del passato. Tale propensione – nel
programma coreutico del Teatro Comunale di
Ferrara ne è un esempio anche il Rosas danst
Rosas, pièce del 1983 di Anne Teresa De Keersmaeker – investe soprattutto i maggiori creatori odierni di danza contemporanea (e non
solo loro: pensiamo agli Early Works recuperati
dalla settantenne Trisha Brown), probabilmente spinti a misurarsi con il valore della memoria,
tante volte esaltato in rassegne, e fomentato
da critici ed esperti. Non si tratta, crediamo,
di colmare i vuoti dovuti a taluni momenti di
stanchezza creativa o esistenziale, di cui peraltro anche gli artisti più sensibili e titolati possono essere preda. O del semplice passaggio
di consegne a eventuali danzatori allievi di
centri e scuole dirette dagli artisti in questione.
Ma forse di una ragionata strategia: del riconoscimento di un atto dovuto alla storia della
danza in sé, alla sua tradizione e soprattutto a
un pubblico sempre cangiante e nuovo. Non
possedere un repertorio, estasiante utopia,
professata con ostinato rigore da molti artisti
odierni, preclude alle giovani generazioni il
piacere di assistere a taluni evergreen del contemporaneo, ma nega anche all’artista quello
sguardo allo specchio necessario per trovare o
ritrovare se stesso pur in rotte sempre cangianti e da scoprire.