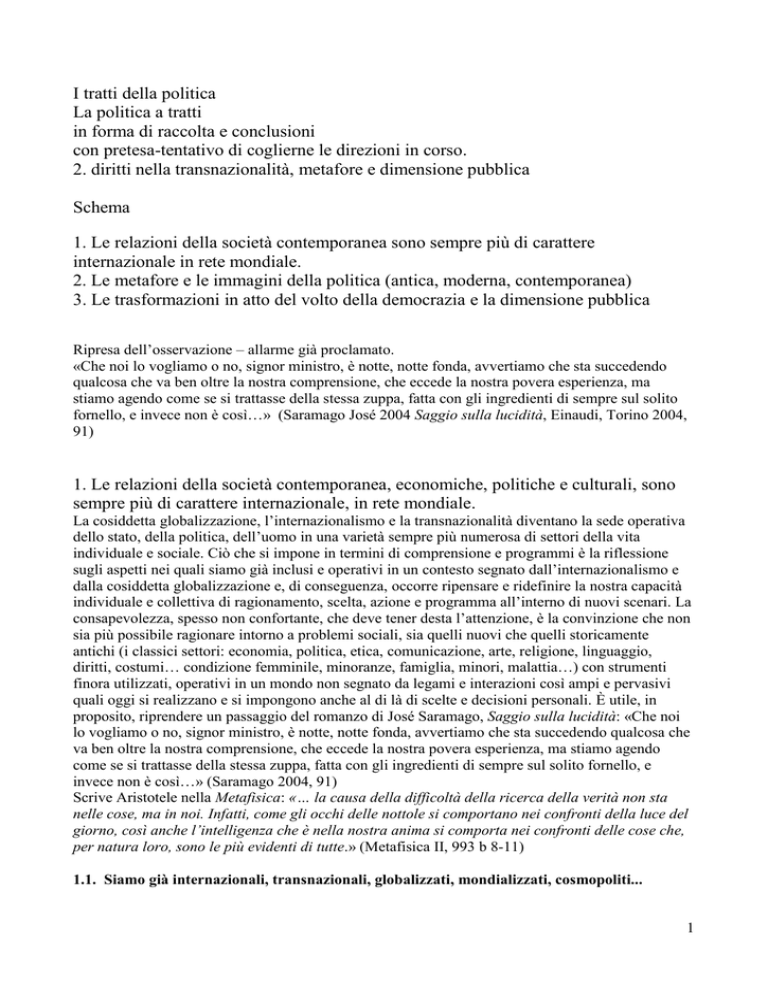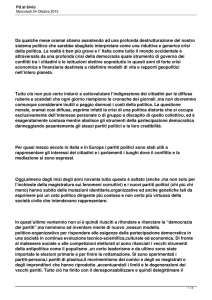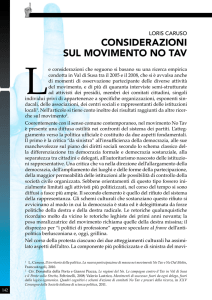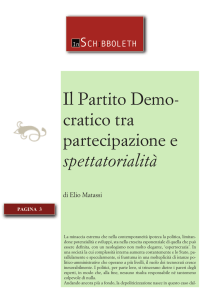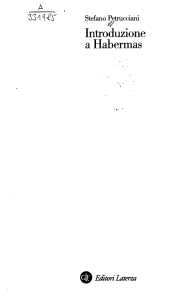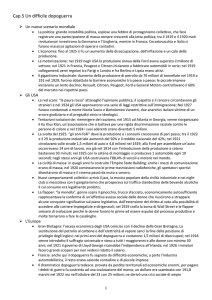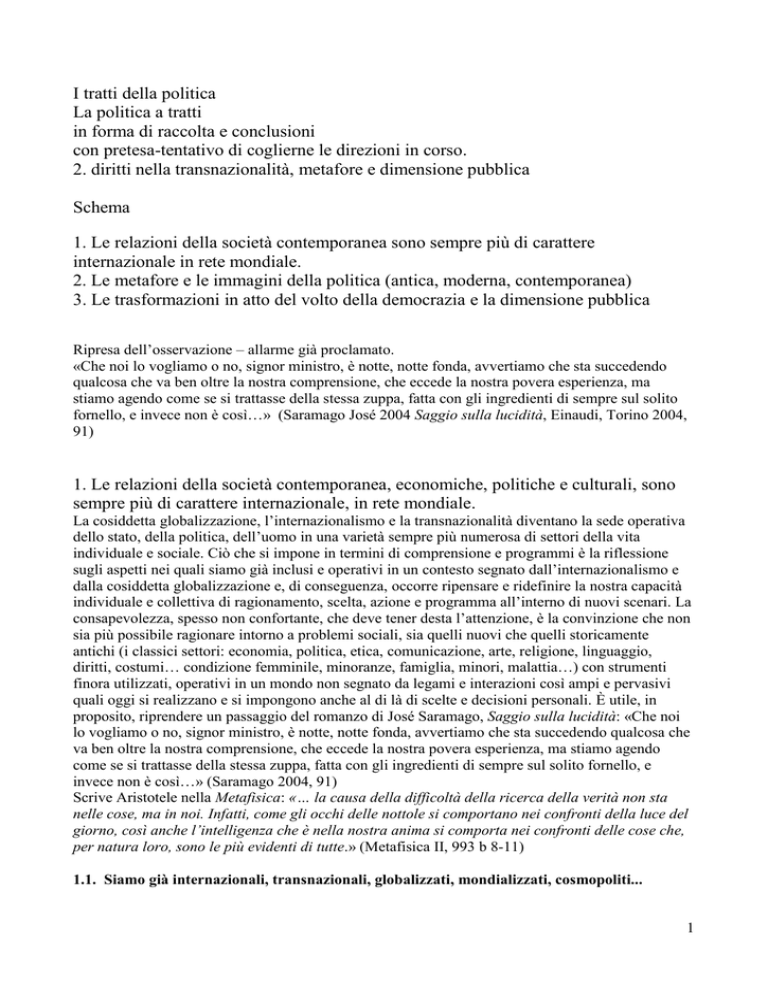
I tratti della politica
La politica a tratti
in forma di raccolta e conclusioni
con pretesa-tentativo di coglierne le direzioni in corso.
2. diritti nella transnazionalità, metafore e dimensione pubblica
Schema
1. Le relazioni della società contemporanea sono sempre più di carattere
internazionale in rete mondiale.
2. Le metafore e le immagini della politica (antica, moderna, contemporanea)
3. Le trasformazioni in atto del volto della democrazia e la dimensione pubblica
Ripresa dell’osservazione – allarme già proclamato.
«Che noi lo vogliamo o no, signor ministro, è notte, notte fonda, avvertiamo che sta succedendo
qualcosa che va ben oltre la nostra comprensione, che eccede la nostra povera esperienza, ma
stiamo agendo come se si trattasse della stessa zuppa, fatta con gli ingredienti di sempre sul solito
fornello, e invece non è così…» (Saramago José 2004 Saggio sulla lucidità, Einaudi, Torino 2004,
91)
1. Le relazioni della società contemporanea, economiche, politiche e culturali, sono
sempre più di carattere internazionale, in rete mondiale.
La cosiddetta globalizzazione, l’internazionalismo e la transnazionalità diventano la sede operativa
dello stato, della politica, dell’uomo in una varietà sempre più numerosa di settori della vita
individuale e sociale. Ciò che si impone in termini di comprensione e programmi è la riflessione
sugli aspetti nei quali siamo già inclusi e operativi in un contesto segnato dall’internazionalismo e
dalla cosiddetta globalizzazione e, di conseguenza, occorre ripensare e ridefinire la nostra capacità
individuale e collettiva di ragionamento, scelta, azione e programma all’interno di nuovi scenari. La
consapevolezza, spesso non confortante, che deve tener desta l’attenzione, è la convinzione che non
sia più possibile ragionare intorno a problemi sociali, sia quelli nuovi che quelli storicamente
antichi (i classici settori: economia, politica, etica, comunicazione, arte, religione, linguaggio,
diritti, costumi… condizione femminile, minoranze, famiglia, minori, malattia…) con strumenti
finora utilizzati, operativi in un mondo non segnato da legami e interazioni così ampi e pervasivi
quali oggi si realizzano e si impongono anche al di là di scelte e decisioni personali. È utile, in
proposito, riprendere un passaggio del romanzo di José Saramago, Saggio sulla lucidità: «Che noi
lo vogliamo o no, signor ministro, è notte, notte fonda, avvertiamo che sta succedendo qualcosa che
va ben oltre la nostra comprensione, che eccede la nostra povera esperienza, ma stiamo agendo
come se si trattasse della stessa zuppa, fatta con gli ingredienti di sempre sul solito fornello, e
invece non è così…» (Saramago 2004, 91)
Scrive Aristotele nella Metafisica: «… la causa della difficoltà della ricerca della verità non sta
nelle cose, ma in noi. Infatti, come gli occhi delle nottole si comportano nei confronti della luce del
giorno, così anche l’intelligenza che è nella nostra anima si comporta nei confronti delle cose che,
per natura loro, sono le più evidenti di tutte.» (Metafisica II, 993 b 8-11)
1.1. Siamo già internazionali, transnazionali, globalizzati, mondializzati, cosmopoliti...
1
Si tratta di aspetti messi in evidenza con ricchezza di dati e di teorie da tutti gli studi sociali
economici e politici sulla società contemporanea. Variano i concetti forniti per fissare i legami che
attualmente definiscono le relazioni di carattere mondiale, sono diversamente documentati su basi
storiche geopolitiche, economiche e sociali gli scenari empiricamente ricostruiti, non sempre
coincidono le valutazioni dei livelli di opportunità nuove e di rischio collegato che segnano i flussi
mondiali che intrecciano e ridefiniscono le gestioni territoriali un tempo considerate autonome e
sovrane, ma viene confermata da tutti la consapevolezza di vivere in società che non possono più
prescindere, per capire e agire, al di fuori di legami di estensione globale. Si possono qui
richiamare, scandendoli per ambiti di studio e di tesi, alcuni degli studi della contemporaneità
considerati classici; le loro tesi sono un passaggio obbligato.
1.1.1. Bauman Zygmunt 2000 Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari 2002
La natura “liquida” della società contemporanea, la dialettica tra corpi solidi e corpi fluidi che pone
in situazione precaria qualsiasi ordine costituito (quindi solo momentaneamente costituito)
«Detto in parole povere, tutte queste caratteristiche stanno a significare che i liquidi, a differenza
dei corpi solidi, non mantengono di norma una forma propria. I fluidi, per così dire, non fissano lo
spazio e non legano il tempo. Laddove i corpi solidi hanno dimensioni spaziali ben definite ma
neutralizzano l’impatto — e dunque riducono il significato — del tempo (resistono con efficacia al
suo scorrere o lo rendono irrilevante), i fluidi non conservano mai a lungo la propria forma e sono
sempre pronti (e inclini) a cambiarla; cosicché ciò che conta per essi è il flusso temporale più che lo
spazio che si trovano a occupare e che in pratica occupano solo «per un momento». In un certo
senso, i corpi solidi annullano il tempo, laddove, al contrario, il tempo è per i liquidi l’elemento più
importante. Nella descrizione dei corpi solidi, il tempo è un elemento che si può tranquillamente
ignorare; fare altrettanto con i fluidi sarebbe, viceversa, un grave errore. Le descrizioni dei fluidi
sono tutte delle istantanee sul cui retro occorre sempre apporre la data. […] Sono questi i motivi
per considerare la «fluidità» o la «liquidità» come metafore pertinenti allorché intendiamo
comprendere la natura dell’attuale e per molti aspetti nuova fase nella storia della modernità. […]
Queste e simili obiezioni appaiono del tutto giustificate, e ancor più lo saranno quando
rammentiamo che la famosa espressione «fondere i corpi solidi», allorché fu coniata, un secolo e
mezzo fa, dagli autori del Manifesto del Partito comunista, si riferiva al trattamento che
l’esuberante e baldanzoso spirito moderno riservava a una società considerata troppo stagnante per i
propri gusti ed eccessivamente refrattaria al cambiamento e alla manipolazione per le proprie
ambizioni, imbolsita com’era nelle sue consuetudini. […] La «fusione dei corpi solidi», la
caratteristica permanente della modernità, ha dunque acquisito un nuovo significato, e soprattutto è
stata reindirizzata verso un nuovo obiettivo; e una delle principali conseguenze di tale
reindirizzamento è stata la distruzione delle forze capaci di far mantenere nell’agenda politica la
questione dell’ordine e del sistema. I corpi solidi per i quali oggi — nell’epoca della modernità
liquida — è scoccata l’ora di finire nel crogiolo ed essere liquefatti sono i legami che trasformano le
scelte individuali in progetti e azioni collettive: i modelli di comunicazione e coordinamento tra
politiche di vita condotte individualmente da un lato e le azioni politiche delle collettività umane
dall’altro. […] Quella oggi in atto è, per così dire, una ridistribuzione e riallocazione dei «poteri di
fusione» della modernità. Tale fenomeno interessò inizialmente le istituzioni esistenti, le cornici
normative che circoscrivevano i campi delle possibili scelte operative, come immobili ereditari con
la loro inoppugnabile ascrizione per legge. […] In realtà, il modello rotto venne prontamente
sostituito da un altro; la gente venne liberata dalle vecchie gabbie solo per essere redarguita e
censurata qualora mancasse di risistemarsi, con strenui, incessanti e perenni sforzi, nelle nicchie
prefabbricate del nuovo ordine: le classi, le cornici che inglobarono (in modo altrettanto ferreo dei
defunti estates) la totalità delle condizioni e prospettive di vita e stabilirono la gamma
realisticamente possibile di progetti e strategie di vita. Il compito che gli individui liberi dovettero
assolvere consistette nell’impiegare la nuova libertà acquisita per trovare la nicchia appropriata e
sistemarvisi in modo confortevole: seguendo alla lettera le regole e le norme di condotta identificate
come corrette e appropriate per quella ubicazione. […] Significa però che stiamo attualmente
2
passando dall’epoca dei «gruppi di riferimento» preassegnati a quella del «raffronto universale» in
cui la destinazione dei singoli sforzi di autocostruzione è endemicamente e incurabilmente
sottodeterminata, non è data in anticipo e tende a subire numerosi e profondi cambiamenti prima
che tali sforzi raggiungano il loro unico fine reale: la fine della vita dell’individuo.
Oggigiorno modelli e configurazioni non sono più «dati», e tanto meno «assiomatici»; ce ne sono
semplicemente troppi, in contrasto tra loro e in contraddizione dei rispettivi comandamenti,
cosicché ciascuno di essi è stato spogliato di buona parte dei propri poteri di coercizione. Hanno
inoltre mutato natura e sono stati riclassificati di conseguenza: come voci nell’inventario dei
compiti individuali. […] Oggi tali modelli sono malleabili in una misura mai sperimentata o
finanche immaginata dalle generazioni passate, ma al pari di tutti i fluidi non conservano mai a
lungo la propria forma. È molto più facile plasmarli che mantenerne la foggia. […] Sarebbe incauto
negare, o finanche minimizzare, il profondo mutamento che l’avvento della modernità fluida ha
introdotto nella condizione umana. La lontananza e l’irraggiungibilità della struttura sistemica,
associata allo stato fluido, non strutturato, dello scenario prossimo e immediato della politica della
vita, cambiano radicalmente tale condizione e impongono un ripensamento delle vecchie nozioni
che ne caratterizzavano la descrizione. Come tanti zombie, tali nozioni sono oggi al contempo
morte, ma ancora viventi. La questione pratica è se la loro resurrezione, sebbene in una nuova
forma o incarnazione, sia possibile o meno, e — qualora non lo sia — come ordinarne una dignitosa
ed efficace sepoltura. […] Ho scelto di analizzare cinque delle nozioni di fondo intorno alle quali le
esplicazioni ortodosse della condizione umana tendono a ruotare: emancipazione, individualità,
tempo/spazio, lavoro e comunità.» (Zygmunt Bauman 2000 Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari
2002 pp. V-XIV)
1.1.2. L’internazionalismo della finanza, dei capitali, delle tecnologie, delle merci, della
manodopera e gli effetti sociali in termini di libertà e uguaglianza.
In apertura e allarme, un rischio: «… non avendo i cittadini di questo paese la salutare abitudine di
esigere il regolare rispetto dei diritti che la costituzione concedeva loro, era logico, anzi, era
naturale che non fossero arrivati a rendersi conto che glieli avevano sospesi.» (Saramago José 2004
Saggio sulla lucidità, Einaudi, Torino 2004, 49)
1.1.2.1. Castells Manuel, 1996, 2000 L’Età dell’informazione: economia, società, cultura,
Università Bocconi Editore 2002, UBE Paperback, Milano 2008.
L’obiettivo e il progetto: «…proporre alcuni elementi per una teoria esplorativa e comparativa
(cross-cultural) dell’economia e della società nell’età dell’informazione, in quanto si riferisce
specificamente alla nascita di una nuova struttura sociale. L’ampio raggio della mia analisi è
dovuto alla pervasività dell’oggetto di tale analisi (l’informazionalismo) in tutti i domini sociali e le
espressioni culturali. […] …non condivido una visione della società tradizionale, costituita da
livelli sovrapposti, con la tecnologia e l’economia alle fondamenta, il potere all’ammezzato e la
cultura all’attico. Tuttavia, per maggiore chiarezza, sono costretto a una presentazione sistematica e
alquanto lineare delle tematiche che, pur collegandosi reciprocamente, non possono integrare
pienamente tutti gli elementi finché questi non saranno esaminati a fondo attraverso il viaggio
intellettuale che il lettore è invitato a intraprendere. Questo primo volume riguarda
fondamentalmente la logica di ciò che io definisco la Rete, mentre il secondo (Il potere
dell’identità) analizza la struttura dell’io e l’interazione tra la Rete e l’io nella crisi delle due
istituzioni centrali della società: la famiglia patriarcale e lo stato-nazione. Il terzo volume (Nuovo
millennio) tenta di fornire un’interpretazione delle trasformazioni storiche dell’ultima parte del XX
secolo, come risultato della dinamica dei processi studiati nei primi due volumi. […]
Questo approccio origina dalla convinzione che siamo entrati in un mondo realmente multiculturale
e interdipendente, che può essere compreso, e cambiato, solo da una prospettiva plurale che faccia
convergere identità culturale, networking globale e politica multidimensionale.» (Castells Manuel
1996 La nascita della società in rete, UBE Paperback, Milano 2008, 27-28)
3
1.1.2.2. Stiglitz E. Joseph 2012 Il prezzo della diseguaglianza. Come la società divisa di oggi
minaccia il nostro futuro, Einaudi, Torino 2013 [Joseph E. Stiglitz è premio Nobel 2001 per
l’Economia]
Dobbiamo essere internazionali, transnazionali, globalizzati, mondializzati, cosmopoliti...
L’internazionalismo più che un dato di fatto comporta una passaggio continuo dall’essere al dover
essere; è un progetto, una prospettiva, un impegno, un futuro che attende di essere avvertito e
gestito. In sé l’internazionalismo (e assimilati o assimilabili come globalizzazione…) conserva una
certa neutralità o per lo meno una ambivalenza. «Il problema tuttavia non è se la globalizzazione sia
buona o cattiva, ma che i governi la stanno gestendo molto male, per lo più a beneficio di interessi
particolari. L’interconnessione tra i popoli, i paesi e le economie del pianeta è uno sviluppo che può
essere usato in modo efficace tanto per promuovere la prosperità quanto per diffondere avidità e
sofferenza. Lo stesso vale per l’economia di mercato: il potere dei mercati è enorme, ma essi non
hanno alcuna caratteristica morale intrinseca. Dobbiamo decidere noi come gestirli. Nei loro
momenti migliori, i mercati hanno avuto un ruolo cruciale, per gli straordinari aumenti di
produttività e la crescita del tenore di vita degli ultimi due secoli, incrementi di gran lunga superiori
a quelli dei precedenti duemila anni. Ma anche i governi hanno avuto un ruolo importante in questi
avanzamenti, un fatto che i sostenitori del libero mercato solitamente mancano di riconoscere.
D’altra parte, i mercati possono lavorare altrettanto bene a favore della concentrazione di ricchezza,
possono trasferire i costi ambientali sulla società e abusare di lavoratori e consumatori. Per tutte
queste ragioni è chiaro che i mercati vanno domati e temperati, se si vuole essere sicuri che lavorino
a beneficio della maggioranza dei cittadini. E occorre ripetere tali interventi più volte, per garantire
la continuità dei risultati.» (Stiglitz 2012, XIII-XIV)
[1] il disagio recente ma strutturale dell’economia avanzata «Negli Stati Uniti, tuttavia, le proteste
spinsero ben presto lo sguardo oltre Wall Street, fino a concentrarsi sulle più marcate iniquità della
società americana. Il loro slogan divenne «il 99 per cento». I manifestanti che lo scelsero
riprendevano il titolo di un articolo che avevo scritto per la rivista «Vanity Fair», Dell'1 per cento,
per l’1 per cento, dall’1 per cento, e che descriveva l’enorme crescita della disuguaglianza negli
Stati Uniti e un sistema politico che sembrava dar voce in misura sproporzionata a quanti si
trovavano in cima alla scala sociale.
Tre temi rimbalzavano in giro per il mondo: che i mercati non funzionavano come avrebbero
dovuto, perché non erano evidentemente efficienti né stabili; che il sistema politico non aveva
corretto i fallimenti del mercato; e che il sistema economico e quello politico erano
fondamentalmente iniqui. Concentrandosi sull’eccessiva disuguaglianza che oggi segna gli Stati
Uniti e alcuni altri paesi industrialmente avanzati, questo libro spiega come i tre temi siano
intimamente legati fra loro: la disuguaglianza è causa, nonché conseguenza, del fallimento del
sistema politico e contribuisce all’instabilità del nostro sistema economico, il quale a sua volta
contribuisce ad aumentare la disuguaglianza, in un circolo vizioso che è come una spirale
discendente in cui siamo caduti e da cui potremo riemergere soltanto attraverso le politiche
concertate che mi accingo a descrivere.
Prima di focalizzare l’attenzione sulla disuguaglianza, vorrei dunque dipingere un quadro del
contesto descrivendo i più evidenti fallimenti del nostro sistema economico.» (Stiglitz 2012, XI)
[2] contrariamente a slogan che si definiscono liberisti, la diseguaglianza non è un fattore di stimolo
e impulso dell’economia (o comunque un fattore inevitabile e teoricamente costituente) ma un
ostacolo alla crescita, visto il legame che questa ha con l’intera coesione sociale. «Di fatto, stiamo
pagando cara la nostra crescente e smisurata disuguaglianza: non soltanto con una crescita più lenta
e un Pil inferiore, ma anche con una maggiore instabilità. Per non dire degli altri costi della
disuguaglianza: una democrazia indebolita, un ridotto senso di equità e giustizia oltre che, come ho
suggerito, una messa in crisi del nostro senso di identità.» (Stiglitz 2012, XXV) « Uno dei lati più
oscuri dell’economia di mercato venuti alla luce è stata l’ampia e crescente disuguaglianza che ha
sfilacciato fino all’orlo il tessuto sociale dell’America e la sostenibilità economica del paese: i ricchi
stavano diventando più ricchi, mentre gli altri affrontavano difficoltà che apparivano in contrasto
4
con il sogno americano. […] Vari paesi nel mondo offrono esempi spaventosi di ciò che accade a
una società quando raggiunge il livello di disuguaglianza verso il quale ci stiamo dirigendo. Non si
tratta di una bella immagine: sono paesi in cui i ricchi vivono in comunità recintate, assediate da
masse di lavoratori a basso reddito; sono sistemi politici instabili, dove il populismo promette alla
gente una vita migliore soltanto per disilluderla. La cosa più grave, forse, è proprio la mancanza di
speranza. In questi paesi i poveri sanno che le loro prospettive di uscire dalla povertà, per non
parlare di arrivare in alto, sono scarsissime. Non è qualcosa a cui dovremmo aspirare.» (Stiglitz
2012, 4,6) « In realtà accade l’opposto: come abbiamo osservato, nel periodo in cui la
disuguaglianza aumentava, la crescita è stata più lenta e la dimensione della fetta distribuita alla
maggioranza degli americani è andata diminuendo. […] Vedremo più avanti che, mentre la teoria
dell’effetto a cascata non funziona, un’economia al contrario (tricke-up) potrebbe farlo: tutti, anche
coloro che stanno in alto, potrebbero beneficiarne se dessimo di più a chi sta in fondo o a metà della
scala sociale.» (Stiglitz 2012, 10-11) «… disuguaglianza che caratterizza le società disfunzionali»
(Stiglitz 2012, 29) E in sintesi globale: «Stiamo pagando un prezzo elevato per quest’ampia e
crescente disuguaglianza e dal momento che, se non facciamo qualcosa, la disuguaglianza
probabilmente continuerà a crescere, è facile che anche il prezzo da pagare aumenti. Chi sta in
mezzo, e soprattutto chi sta in basso, ci rimetterà di più, ma anche il paese nel suo insieme — la
nostra società, la nostra democrazia — pagherà moltissimo.
Le società caratterizzate da una diffusa disuguaglianza non funzionano in modo efficiente e le loro
economie non sono né stabili né sostenibili nel lungo periodo. Quando infatti un gruppo di interesse
ha troppo potere, riesce a fare in modo che la politica operi a suo vantaggio, più che a beneficio
dell’intera società.» (Stiglitz 2012, 143)
Puntare sulla crescita senza affrontare il problema delle diseguaglianze ha l’effetto di incrementarle
(un effetto etico) e di indebolire di conseguenza il mercato (un effetto economico); è allora utile
(anche utilitaristico; cfr. Amartya Sen) coniugare etica ed economia. Più in generale, manchiamo di
una antropologia economica e di una filosofia sociale (cfr. John R. Searle).
[3] la situazione di disuguaglianza ha sempre una specificità storica (non è compreso se non viene
specificato); nel passaggio di crisi economica di fine ‘900 si caratterizzata per due aspetti:
[3.1.] ha subito una forte polarizzazione: «L’America ha sempre pensato a se stessa come a un
paese della classe media. Nessuno vuole vedersi come un privilegiato e nessuno vuole annoverare la
propria famiglia tra i poveri. Ma negli ultimi anni la classe media si è svuotata… La polarizzazione
della forza lavoro ha fatto sì che oggi, mentre più denaro va a chi sta in alto, più persone stiano
scivolando verso il basso.» (Stiglitz 2012,12-13)
[3.2.] è la crisi della classe media: «… lo svuotamento della classe media e l’aumento della
povertà» (Stiglitz 2012, 65) « È opinione ampiamente condivisa che la classe media sia l’ossatura
della nostra democrazia. […] … la polarizzazione del nostro mercato del lavoro ha svuotato la
classe media, che mentre si assottiglia sta perdendo ogni illusione rispetto a un procedere politico
che evidentemente non fa i suoi interessi.» (Stiglitz 2012, 216)
Un tratto proprio della società contemporanea a sviluppo economico avanzato, considerata dal
punto di vista dello stile di vita e di consumo, è caratterizzata dalla forte riduzione quasi scomparsa
del proletariato (della classe operaia o in generale, sociologicamente e politicamente, delle classi) e
dal formarsi tendenziale di una universale classe media (una infinita e indistinta "middle class");
resta sullo sfondo una società degli esclusi che ha peraltro il cinico effetto sociale di trasmettere alla
classe media la sensazione di “avercela fatta”. A parte una ristretta élite al vertice, e coloro che "non
hanno retto il gioco" e sono finiti così ai margini della società, la struttura sociale appare
caratterizzata da una grande middle class, alla quale sembrano approdare insieme, ormai, ceti medi
e operai, resi più simili da capacità di spese in crescita, relativamente più uniformate e stabili,
dunque da livelli e stili di consumo proprio di paesi considerati a sviluppo medio alto. Area sociale
vasta, non gruppo, non classe… appare più come una classe di consumo che come classe
produttiva; si tratta della "società dei due terzi" (o dei quattro quinti): una maggioranza sociale
sostanzialmente compatta e soddisfatta di sé che non si preoccupa delle condizioni di vita del terzo
5
restante, confinato in condizioni di insignificanza politica, di subalternità o esclusione culturale e di
acuto disagio sociale; o se ne occupa solo in quanto avverte il pericolo e vive l’insopportabile paura
di entrare a farvi parte piombando in fondo, ai margini o all’esterno del sociale, fuori da uno stile di
vita faticosamente costruito e finora fruito. È questa “classe” ad essere maggiormente colpita dalle
diseguaglianze emergenti dalla recessione economica di fine ‘900 e spaventata dal rischio
dell’esclusione sociale. Vista la sua consistenza numerica e rilevanza sociale è la crisi e la paura di
un sistema di società quale era prodotto dalla precedente crescita produttiva; va in scena la
condanna all’espulsione dal sistema di chi è disoccupato (il vasto mondo di chi entra nella
precarietà, negli ammortizzatori sociali, che presto si scoprono non infiniti, o altro: precari,
cassintegrati, esodati, pensioni ridotte, assistiti da enti caritativi...), verso un tenore di vita in
declino, un destino di povertà e di esclusione sociale [il concetto sociale di povertà, cfr. Amarthya
Sen]. «I poveri, in America, vivevano sull’orlo del precipizio anche prima della crisi, ma con la
Grande recessione questo è diventato sempre più vero anche per la classe media.» (Stiglitz 2012,
14)
Ed è soprattutto la fine di fiducia in un sistema cui si pensava con orgoglio storico di poter
appartenere: «La fiducia nell’equità di fondo dell’America, nel fatto che viviamo in una terra di pari
opportunità, contribuisce a unirci. Questo, per lo meno, è il mito americano, potente e durevole. Ma
sempre di più è soltanto un mito. […] Il declino delle opportunità è andato di pari passo con la
nostra crescita di disuguaglianza. Di fatto, si tratta di un modello osservato in vari paesi: le nazioni
che presentano una disuguaglianza superiore offrono sistematicamente opportunità meno paritarie.
[…] È a livello dei primi e ultimi gradini della scala sociale che gli Stati Uniti dànno i risultati
peggiori: chi sta in fondo ha buone possibilità di rimanervi, chi sta in cima pure, e questo molto più
che in altri paesi.» (Stiglitz 2012, 24-25)
E la novità sta anche nella rapidità della trasformazione: «Si diceva un tempo della disuguaglianza
che tentare di coglierne le variazioni era come osservare l’erba che cresce, nel senso che in entrambi
i casi è difficile accorgersi dei cambiamenti nel corso di un breve intervallo di tempo. Ma oggi
questo non è più vero.» (Stiglitz 2012, 53-54)
[4] tra le cause gestionali che possono essere indicate come dinamiche di crisi economica vi è la
concezione liberistica (falsamente liberistica come già Adam Smith denunciava) dell’economia
come sistema dotato di autonomia di regolamentazione e garantito da automatismi interni di
correzione: «l’inesorabile funzionamento dell’economia di mercato» (Stiglitz 2012, 425);
presupposto che porta a sostenere la necessaria esclusione di controlli esterni, sociali o politici,
definiti come attacchi alla libertà e attacco al massimo profitto che le libertà in economia sono in
grado di garantire per “mano invisibile”. La «convinzione che i mercati fossero sempre efficienti.»
(Stiglitz 2012, 150) Presupposto che legittima l’esclusione di regole (in nome della libertà di
iniziativa e della efficacia della creatività) e che fa chiudere gli occhi sulle condizioni di monopolio,
di privilegio, di protezione politica e di costi sociali che di fatto sorregge e garantisce l’autonomia
rivendicata ed esibita. Presupposti che si autoalimentano in quanto vengono trasformati in mantra
dell’economia, veri e propri miti posti in sentenze, valide in quanto ripetute, trasformate in leggi
indubitabili, capaci di produrre cecità e irresponsabile superficialità di fronte ai crolli economici e
sociali delle ricorrenti crisi; addirittura confermate dai fallimenti che quelle sentenze avallano e
giustificano. Ne consegue che l’autonomia dell’economia di fatto è diventata la priorità
dell’economia, così come storicamente strutturata (cioè con la prevalenza di settori garanti del
massimo profitto a breve, come il settore bancario-finanziario) sul sociale e sul politico. (Sul tema
dei “miti”, sentenze, luoghi comuni e tragici paradossi delle presunte teorie economiche: Stiglitz
2012, 357-367) «A coloro i quali, nell’infuriare della Grande depressione, sostenevano che alla fine
le forze del mercato avrebbero vinto e riportato l’economia al pieno impiego, Keynes rispondeva
che sì, nel lungo periodo i mercati potrebbero funzionare, ma che nel lungo periodo saremo tutti
morti.» (Stiglitz, 2012, 427)
[5] la globalizzazione dell’economia e i suoi veloci ritmi hanno visto impreparate o assenti la
politica e la società ad esaminare i processi in atto, esercitare i controlli. L’economia globale ha
6
tratto enormi vantaggio da questa assenza (nella circolazione libera di capitali all’insegna della
evasione fiscale e della speculazione finanziaria) e ora chiede e fruisce di protezione politica (ad alti
costi sociali) per risolvere i disastri provocati, adducendo le ragioni del rigore come condizione di
salvezza non di un sistema economico ma dell’economia tout cour.
[6] in questo quadro il risveglio politico nella forma dell’indignazione (gli indignados) e della
controproposta. [cfr. Castells Manuel 2012 Reti di indignazione e speranza. Movimenti sociali
nell’era di Internet, EGEA, Università Bocconi editore, Milano.]
E la consapevolezza, in un’ipotesi di bilancio e sintesi: «Per la maggior parte delle persone, la fonte
di reddito più importante è il salario. Le politiche macroeconomiche e monetarie che portano a un
aumento della disoccupazione — e a salari inferiori per i cittadini — sono oggi una delle principali
fonti di disuguaglianza nella nostra società. Nell’ultimo quarto di secolo le politiche e le istituzioni
macroeconomiche e finanziarie non sono riuscite a creare stabilità; non sono riuscite a creare
crescita sostenibile e, cosa più importante di tutte, non sono riuscite a creare crescita a vantaggio
della maggior parte dei cittadini della nostra società.
Alla luce di questi drammatici fallimenti, ci si sarebbe potuti aspettare una ricerca di modelli
macroeconomici e monetari alternativi. Ma proprio come le banche — per le quali nessun sistema è
a prova di accidente, dunque loro sono rimaste vittima di un cataclisma che si verifica una volta
ogni secolo e la nostra recessione attuale non è motivo sufficiente per cambiare un sistema che
funziona — sono riuscite a resistere con successo a un ritorno alla regolamentazione (o reregulation), molti di quanti nutrivano le convinzioni macroeconomiche sbagliate che hanno portato
a politiche monetarie difettose sono rimasti su posizioni irriducibili. Si sono mostrati riluttanti a
modificare le loro opinioni. La teoria era giusta, sostengono: ci sono stati soltanto alcuni errori di
attuazione.
La verità è che i modelli macroeconomici non prestavano sufficiente attenzione alla disuguaglianza
e alle conseguenze delle politiche distributive. Le politiche basate su questi modelli difettosi hanno
contribuito a creare la crisi e al tempo stesso si sono dimostrate inefficaci al momento di gestirla.
Non è escluso che stiano contribuendo a far sì che, nel momento in cui l’economia si riprenderà,
sarà senza occupazione. Ma la cosa per noi più importante è che le politiche macroeconomiche
hanno contribuito all’elevato livello di disuguaglianza a cui stiamo assistendo in America e altrove.
Anche se i difensori di tali politiche potrebbero sostenere che siano le migliori per tutti, non è così.
Non esiste un’unica miglior politica.» (Stiglitz 2012, 413- 414)
«In questo libro ho sottolineato come a contare non sia soltanto la crescita, ma il tipo di crescita (o,
come a volte si dice, la qualità della crescita). Una crescita nonostante la quale la maggior parte
delle persone se la passasse male, dove la qualità dell’ambiente ne risentisse, dove la gente vivesse
nell’ansia e con un senso di alienazione, non è il genere di crescita che dovremmo perseguire. La
buona notizia è che talvolta possiamo plasmare le forze del mercato per il meglio e ricavarne entrate
che possono essere usate per promuovere la crescita e rinforzare il benessere della collettività.»
(Stiglitz 2012, 447)
[un’appendice a margine della crescita e della decrescita: tendenza e controtendenza.
a. la tendenza « Le nostre società tendono per propria natura ad accentuare lo sviluppo della
produzione attraverso l'aumento dei consumi.» (Violante Luciano 2013 Politica e menzogna,
Einaudi, Torino, 100)
b. la controtendenza: l’ipotesi che esista un tetto, un limite; come per ogni fenomeno evolutivo
esiste un punto massimo altre il quale non è possibile un incremento, forse come accade alla
velocità della luce, velocità limite che struttura la realtà nota. La crisi è dunque un aver raggiunto, in
alcuni processi, quel tetto e non resta che la possibilità o di conservarlo, ad alti costi, o di tornare sul
sistema per sanare le discontinuità enormi che stanno sotto quei picchi di crescita e li mantengono
nel loro stare al limite. Il punto massimo del profitto (finanziario o di pochi) si regge su scompensi
economici ed esclusioni sociali (nelle società locali tra le aree del mondo), le diseguaglianze sono
all’origine di quello che viene chiamata crisi (Stiglitz), non è contro la logica dello sviluppo
immaginare una ipotesi di arresto nella volontà di incremento dei beni (Rawls). Questa ipotesi del
7
tetto, limite, cielo-tetto presentata in forma di romanzo (all’interno di un romanzo): « Si chiama
Hector Grant e vive con la sua ragazza Josephine che fa anche lei la giornalista e si occupa di
società e cultura. Una sera invitano Fil a cena e parlano di Economia tutto il tempo. Hector gli
racconta di una ricerca che stanno facendo al giornale, sul benessere delle famiglie dal dopoguerra
in poi, su quale livello abbiano raggiunto le varie generazioni, più o meno dal 1960 al 2010. Lui ha
accesso all'UK Data Archive, una marea di dati, più di settecentomila famiglie. Se vuole, può
passargli il file. Il giorno che Fil li ha sotto gli occhi, quei preziosi dati, non ci può credere. Guarda i
grafici, estasiato. Osserva il procedere ora zigzagante ora lineare del percorso di ogni generazione.
È esattamente come aveva pensato, i numeri gli danno ragione. Le ultime due generazioni sono
cresciute meno, anzi, adesso non crescono affatto, perché. .. sono partite altissime! Semplice, si
vede dalla linea. L’ultima generazione, la sua, la generazione detta dei precari, i cosiddetti giovani
senzafuturo, non può muoversi non solo per la crisi, ma perché parte dal livello massimo raggiunto
dalle generazioni precedenti. E certo che non si muove: per muoversi davvero dovrebbe forare il
cielo.
Bisogna mettere un cielo-tetto alla crescita. Non si può continuare così, a dismisura. Chiaro. È come
per i pesci: i tonni devono smettere di mangiare troppe acciughe, se no finiscono. Sono costretti ad
accontentarsi. Gli Stati uguale. Ogni Stato deve imparare a dire: bene, io sono partito di qui e arrivo
fin qui, grazie, mi basta, gli altri arrivino dove possono arrivare, essendo partiti da dove son partiti.
Certo che se partono da più in basso fanno più strada. Se io parto dall’arrivo, sono già arrivato, e
quindi di strada non ne faccio neanche mezzo metro. Ovvio. Per una persona come per uno Stato.
Che poi, a ben vedere, gli Stati sono abbastanza uguali alle persone. Se uno è già arrivato, dove
deve ancora andare? Magari si ferma un po’. Magari gli viene quella voglia di smettere di correre…
Arrivare, il segreto sta tutto nel significato etimologico di questo verbo: se uno ha già toccato la
riva, ovvio che poi sta fermo. Sono gli altri che navigano ancora a vele spiegate.
È una verità così evidente… Fil se li vede come in una gara di corsa campestre, gli Stati Arrivati,
chiamiamoli così. Compresa la vecchia Europa. Belli seduti in cerchio ai bordi della pista, lì dove
comincia il prato, esausti, sudati, ognuno con la pettorina numerata un po' sgualcita; sotto lo
striscione del traguardo, all’ombra, dopo la gara, a strimpellare una canzone, bersi un’aranciata,
sbocconcellarsi un panino, o anche appisolarsi, se quello è in quel momento il loro massimo
piacere, aspettando con fiducia che gli altri Stati del mondo a poco a poco arrivino, e si siedano
anche loro lì al fresco, in modo che alla fine tutti diventino Stati Arrivati e si crei un colossale
ammucchio, una specie di globale Déjeuner sul l’herbe collettivo, planetario.
È una visione un po’ semplice, certo, per un economista. Anche piuttosto... immaginifica,
d’accordo. Surrealista, astratta. Fil se ne rende conto, non è così ingenuo. Ma vorrebbe davvero che
la crisi dei Paesi ricchi non fosse considerata una tragedia. È solo un arrivo, secondo lui. Certo non
gli sfugge che essere arrivati ponga qualche non piccolo problema: l’arresto della crescita in un
Paese, comunque lo si voglia chiamare (decrescita, arrivo, stagnazione o picnic sull’erba), è un
guaio. E non perché si smetta di arricchirsi, ma perché se la torta non cresce più, la gente comincia a
strapparsi di mano le ultime fette rimaste. Invidia sociale, odio di classe, violenza. Il problema sta
tutto lì, Fil lo vede con chiarezza: far vivere tutti bene, nonostante una crescita zero. È una sfida
nuova: non solo far crescere i Paesi emergenti, ma far sopravvivere i Paesi già emersi, non farli
sprofondare. Forse si può cercare di farli avanzare in qualche altro modo, o far sì che accettino di
non avanzare più, continuando però a stare bene a galla. Non c’entra la decrescita. L’idea è di
prevedere uno «stato sereno di non avanzamento»: come continuare a essere degli Stati Arrivati,
insomma, come far proseguire quella condizione di arrivo, renderla in un certo senso perpetua…
Perpetuare l’Arrivo, ecco. Un fermo immagine fisso sull’atleta che taglia il filo del traguardo, che
non torna indietro e nemmeno si mette in un angolo, a riposare.
Sopravvivere alla propria ricchezza. Rimanere abbastanza ricchi senza più smaniare e sgomitare,
anzi, aspettando gli altri, magari aiutandoli. Si tratta d’inventare una nuova vita, niente meno!
Prevedere un altro tipo di progresso, in questa era di post-progresso. Forse, non porselo nemmeno,
il problema di un progresso. A tutto questo arriva Filippo Cantirami, sul finire di quel 2011: all’idea
8
di un tetto, all’immagine rilassante e utopicamente equa di un «cielo economico» che abiti
stabilmente sopra di noi e ci faccia un po' da tetto, protezione e limite allo stesso tempo, sotto il
quale provare a vivere, e a progredire, in modo nuovo.
Che poi a questo pensiero arrivi leggendo nuovi economisti o i classici che nessuno legge più, o
guardando pascolare pecore, o pensando ai tonni e alle acciughe, o consultando i dati dell’archivio
britannico, importa poco. Ci arriva, e proprio nel momento in cui Jeremy sta per finire il dottorato a
Stanford al posto suo, e tutti pensano che lui sia lì, e invece lui se ne sta sui prati intorno a Oxford,
dove nessuno sa chi è e che cosa fa, e studia, e pensa, e prende placidamente appunti per quella sua
nuova teoria economica, che di lì a qualche anno sarà nota come Ceiling Theory.» (Mastrocola
Paola 2013 Non so niente di te, Einaudi, Torino 2013, 291- 293)
Per il tema un indiscusso classico contemporaneo: Ivan Illich. Il testo: Illich Ivan 1973 La
convivialità, red!, 2005. Dalla quarta di copertina. «LA CONVIVIALITÀ Una proposta libertaria
per una politica dei limiti allo sviluppo. In questo libro Illich sostiene che lo strumento industriale
ha oggi superato in molti casi quella soglia critica oltre la quale diviene controproduttivo; si
allontana cioè da quegli scopi per cui era stato progettato e genera impotenza. Per esempio, la
diffusione dei mezzi di trasporto riduce la velocita degli spostamenti; l’iperproduttività produce
crisi economiche. L’alternativa a questo stato delle cose e rappresentata da quella che Illich chiama
«società conviviale». Lo strumento conviviale permette un controllo personale e diretto, genera
efficienza senza ridurre l’autonomia, non crea rapporti di dipendenza ed estende il raggio d'azione
individuale.»
«La società, una volta raggiunto lo stadio avanzato della produzione di massa, produce la propria
distruzione. La natura viene snaturata. Sradicato, castrato nella sua creatività, l’uomo è rinserrato
nella propria capsula individuale. La collettività è governata dal gioco combinato di una
polarizzazione estrema e di una specializzazione a oltranza. L’affannosa ricerca di modelli e
prodotti sempre nuovi, cancro del tessuto sociale, accelera a tal punto il mutamento da escludere
ogni ricorso ai precedenti come guida per l’azione. Il monopolio del modo di produzione industriale
riduce gli uomini a materia prima lavorata dagli strumenti. E tutto questo in misura non più
tollerabile. Poco importa che si tratti di un monopolio privato o pubblico: la degradazione della
natura, la distruzione dei legami sociali, la disintegrazione dell’uomo non potranno mai servire a
uno scopo sociale. […] Siamo talmente deformati dalle abitudini industriali che non osiamo più
scrutare il campo del possibile, e l’idea di rinunciare alla produzione di massa di tutti gli articoli e
servizi è per noi come un ritorno alle catene del passato o al mito del buon selvaggio. Ma se
vogliamo ampliare il nostro angolo di visuale, adeguandolo alle dimensioni della realtà, dobbiamo
ammettere che non esiste un unico modo di utilizzare le scoperte scientifiche, ma per lo meno due,
tra loro antinomici. C’è un uso della scoperta che conduce alla specializzazione dei compiti, alla
istituzionalizzazione dei valori, alla centralizzazione del potere: l’uomo diviene l’accessorio della
megamacchina, un ingranaggio della burocrazia. Ma c’è un secondo modo di mettere a frutto
l’invenzione, che accresce il potere e il sapere di ognuno, consentendo a ognuno di esercitare la
propria creatività senza per questo negare lo stesso spazio d’iniziativa e di produttività agli altri.
[…] Chiamo società conviviale una società in cui lo strumento moderno sia utilizzabile dalla
persona integrata con la collettività, e non riservato a un corpo di specialisti che lo tiene sotto il
proprio controllo. Conviviale è la società in cui prevale la possibilità per ciascuno di usare lo
strumento per realizzare le proprie intenzioni.» (Illich 1973 La convivialità, 13, 14-15)
Osserva operativamente Umberto Galimberti: « Ma là dove l’efficienza rappresenta di per sé una
ragione sufficiente per l’agire umano, l’inefficienza diventa uno dei modi per sabotare la tirannia
dell’efficienza, una sorta di “etica” adottata per protestare contro lo smarrimento di senso e di fini
(causa finale), contro lo sfruttamento illimitato delle risorse naturali (causa materiale), contro
l’abolizione dell’etica e dell’estetica in ogni processo di produzione e consumo (causa formale).
Pensare esclusivamente in termini di “costi e benefici” secondo il principio che prescrive di ottenere
il massimo dando il minimo “non è giusto,” scrive Hillman, “non è etico, è antisociale, è abusivo,
forse è il male”. […] Tutti i numeri in ascesa, che ogni forma di potere ostenta con spirito
9
ottimistico, nascondono quell’aspetto oscuro che manda segnali di declino, quando non di pericolo,
fino a quel limite che è l’estinzione. A questo punto “la crescita assume una coloritura cancerosa”,
come accade al nostro organismo quando le cellule si moltiplicano oltremisura. È allora che la
crescita, questo ideale ottocentesco così radicato nel nostro inconscio, acquista un significato
sinistro, “vuoi che a crescere sia il debito pubblico, oppure la popolazione, i disoccupati, le
dimensioni della città, l’inquinamento dell’aria, l’aliquota di imposta, il costo della vita, il tasso di
colesterolo, e persino i numeri quando saliamo sulla bilancia del nostro bagno”. Oltre un certo
livello, “crescere” è dunque sintomo di problemi, quando non addirittura di declino. La psicologia
evolutiva, che per Hillman “proviene dagli armadi vittoriani del darwinismo sociale, non si accorge
quanto sia cambiato il valore dell’idea di sviluppo …» (Galimberti Umberto 2009 I miti del nostro
tempo, Feltrinelli, Milano, 116-118]
1.1.2.3. Beck Ulrich, La società cosmopolita, il Mulino, Bologna 2003
2. Le metafore della politica (antica, moderna, contemporanea)
Si sa che non tutto si presta come metafora adatta (l’aquila è un exemplum assai più adatto della
gallina per designare la sfera delle cariche e delle funzioni del potere) e il contesto debitamente
costruito gioca una parte centrale. «Nella maggior parte delle cariche cittadine si avvicendano chi
comanda e chi è comandato (infatti si ritiene che tutti i cittadini siano uguali per natura e che non ci
sia alcuna differenza), ma tuttavia quando alcuni comandano e altri obbediscono, si cerca di
introdurre una differenza e nella figura esteriore e nel linguaggio e nei titoli di onore, come diceva
Amasi parlando del catino per i piedi.» (Aristotele, Politica 1259b4-9) Narra Erodoto (II, 172) che
il re egiziano Amasi aveva difficoltà a farsi apprezzare dai sudditi, perché era di umili origini. Egli
allora prese un bacile d’oro, che lui stesso e i suoi convitati usavano per lavarsi i piedi, lo fece a
pezzi e ne ricavò la statua di una divinità, che fu onorata da tutti. Allora disse ai sudditi che quella
statua era stata un bacile nel quale un tempo si era urinato e vomitato e ci si era lavati i piedi;
eppure ora quello stesso materiale era venerato. La stessa cosa era accaduta a lui, che era stato un
popolano; ma ora, come re, doveva essere onorato.
2.1. Il ruolo della metafora/immagine nella concettualizzazione e nella programmazione, e il
ruolo del mito come sede operativa prima della metafora
«Noi apprendiamo soprattutto dalle metafore» Aristotele, Retorica, 1410b15.
«Per proseguire veloci conservando la precisione, niente è più essenziale di un mito.» (Latour
Bruno 1999 Politiche della natura. Per una democrazia delle scienze, Raffaello Cortina editore,
Milano 2000, p.2)
«… ogni metafora «agisce direttamente sui sensi e soprattutto su quello della vista, che è il più
acuto [...]; le metafore che si riferiscono alla vista sono molto più efficaci perché pongono al
cospetto dell’animo ciò che non potremmo né distinguere né vedere». La metafora, se
particolarmente forte, finisce per trasformarsi in un dispositivo di autorità e diventare una sorta di
dogma a cui tutti fanno fede.» (Aime Marco 2013 Cultura, Bollati Boringhieri, Torino, 75)
«Una metafora, possiamo tradurre così la domanda iniziale, genera realtà, non svanisce nel grande
mare dell’espediente letterario, si costituisce come strumento, ma anche come nuovo oggetto, come
tema, come questione. Se però un metafora crea un orizzonte di senso che prima non c’era, se oltre
a cercare soluzioni genera nuove domande, ciò significa che può organizzarsi in tradizione, che si
rende disponibile ai vari autori e dunque in un certo senso produce una questione che non è più
eludibile. Al di là del significato puntuale che essa assume nel singolo autore, che è il momento di
partenza dell’analisi e che ne rivela in pieno le potenzialità, essa va vista nel flusso storico in cui è
immersa e che contribuisce a determinare e connotare.» (Briguglia Gianluca 2006 Il corpo vivente
dello Stato, Bruno Mondadori, Milano p. 9)
10
2.1.1. … e ricorda in contesto psicanalitico: «L’azione morfogena dell’immagine […] La ripresa
della funzione costitutiva del narcisismo nell’analisi freudiana dell’Io come formazione
immaginaria orienta il primo ritorno di Lacan a Freud. La meditazione sul narcisismo costituisce
infatti il nerbo della sua teorizzazione del registro dell'Immaginario. Al centro è l’incidenza
dell’immagine nella costituzione del soggetto, è quello che egli denomina come l’azione
“morfogena dell’immagine”. Si tratta, in altri termini, di ripensare tutta la problematica freudiana
dell’identificazione come un “nuovo oggetto psichico”, di mostrare come l’azione identificatoria
dell’immagine operi una vera e propria plasmazione del soggetto. Per Freud, infatti,
l’identificazione non indica né l’effetto di un semplice condizionamento esterno, né un rapporto di
imitazione in esteriorità del soggetto nei confronti di un’immagine situata come ideale. Secondo
Lacan la grande novità del concetto freudiano di identificazione consiste nel suo configurarsi come
il luogo di una inedita causalità psichica inconscia. L’inconscio appare come potenza causale
dell’identificazione, strutturato come una serie di identificazioni. Per questa ragione l’azione
morfogena dell’Imago viene eletta da Lacan alla dignità dell’oggetto specifico della teoria
psicoanalitica in quanto tale, così come Galileo ha potuto fondare scientificamente la fisica sul
“punto materiale inerte”. (Recalcati Massimo 2012 Jacques Lacan. Volume I Desiderio, godimento
e soggettivazione, Raffello Cortina editore, Milano. 13)
2.1.2. … in generale, dal punto di vista storico, nelle relazioni politiche l’immagine svolge oggi il
ruolo che un tempo era dell’ideologia. Semplifica, orienta, chiarisce, fa appello alle emozioni,
convince o intellettivamente o emotivamente (demagogicamente); ha la stessa ambivalenza della
retorica. È in opera, anche nell’immagine, la doppia deformazione possibile dei termini e la doppia
astuzia: la complicazione (la solennità, il fasto, la ridondanza, strumenti inutili e retorici allo scopo
di nascondere, disorientare e quindi pilotare politicamente), la semplificazione (sbrigativa,
populista, a nascondere la complessità di un problema in un luogo comune condiviso e spiccio).
2.1.3. … in generale, dal punto di vista trascendentale, relativo al ruolo della immaginazione nel
processo conoscitivo: «L’oggetto fenomenico non viene più immediatamente costituito con le
categorie dell’intuizione e dell’intelletto, bensì attraverso un’operazione trascendentale
riconoscibile nella sfera della sensibilità stessa: con la creazione di simboli ordinati
sistematicamente, conferenti oggettività alle impressioni sensoriali. L’intelletto non può compiere
da solo la sintesi dei fenomeni; ci vogliono i simboli per far sì che, nel dato, traspaia la traccia di un
non-dato. Al soggetto conoscente il dato di fatto intramondano è presente solo nella misura in cui
trae da se stesso forme capaci di rappresentare una realtà inaccessibile all’intuizione sensibile. È in
quanto rappresentata che la realtà diventa fenomeno. La rappresentazione è la funzione
fondamentale della coscienza trascendentale; e la sua opera non è decifrabile che indirettamente, in
base alle relazioni grammaticali delle forme simboliche. La filosofia delle forme simboliche, nella
quale si risolve la critica della ragion pura, intende tutto ciò nel senso di una analisi logica del
linguaggio impostata in maniera trascendentale. […] Per mezzo dei mondi immaginari, che si
articolano nelle forme simboliche, «noi scorgiamo e in essi possediamo ciò che chiamiamo la
realtà» (E. Cassirer, Filosofia delle forme simboliche, Firenze, 1961, vol I, p.48).[…] Benché i
simboli, in quanto segni fisici, entrino a far parte della sfera del sensibile, essi non vanno equiparati
ai fenomeni empirici coi quali hanno che fare le scienze della natura. Essi sono piuttosto la
condizione trascendentale affinché possa manifestarsi a dei soggetti un mondo in generale.»
(Habermas Jürgen 1967 Logica delle scienze sociali, il Mulino, Bologna 1970, 11-14)
2.2. metafore in politica: per la politica, per i politici
2.2.1. per i politici: «L’ascesa al potere e la conferma nel ruolo dipendono anche dalla costruzione
dell'immagine. È l'elaborazione di un personaggio. È una narrazione che a un certo punto si
condensa intorno a un nucleo e si fa messaggio. Pensiamo alla campagna elettorale nei Paesi dove
la scelta del leader avviene democraticamente.» E quando uno sguardo, una posa, un dettaglio
ripresi e ripetuti in fotografia (o altro) rivelano aspetti inquietanti o agghiaccianti là dove si voleva
trasmettere sicurezza e familiarità: « È lo squarcio nel velo dipinto. È la rivincita dell' occhio
11
meccanico guidato da quello umano. La fotografia racconta l’inespresso, la rappresentazione
smaschera la volontà. Anche se il soggetto non guarda. Nel gennaio 1998 ero a Cuba e seguivo
l'incontro tra il Papa e Fidel Castro. Fu pubblicata una foto che mi sembrò più forte di ogni altra: i
due, di spalle, camminavano in un corridoio scuro, verso una luce al fondo, sorreggendosi. Scrissi
che era l' immagine di due poteri condannati a durare fino alla morte, del sostegno reciproco che si
davano per perpetuare un dominio. In conseguenza di quelle parole mi fu negato un successivo visto
d’ingresso a Cuba: persona non grata. Lo stesso non accadde per il fotografo. Il potere, spesso, è
così: non si accorge di che cosa lo mette veramente a nudo. Si dedica alla costruzione del proprio
mito riproponendo collaudate tecniche di persuasione, propaga per immagini valori non più
condivisi. Finisce per smarrirsi in un gioco di specchi riflessi frantumati da uno sguardo colmo di
disincanto. E nessuno che abbia colto l’insegnamento più raffinato dell’Islam: il profeta non
appare.» (Gabriele Romagnoli, Volti del potere, la Repubblica 3.07.2011)
2.2.1.1. … per gli effetti di massa, Gustave Le Bon, in Psicologia delle folle, scrive: «Le folle si
lasciano impressionare soprattutto dalle immagini. Qualora non siano disponibili potranno essere
suscitate con un sapiente impiego di parole e formule... queste infatti provocano nell' animo delle
moltitudini le più formidabili tempeste. … il potere di una parola non dipende dal suo significato
ma dall'immagine che suscita. I termini dal significato più confuso possiedono a volte il più grande
potere».
«Governare è far credere» Niccolò Machiavelli, Il Principe
2.2.2. per la politica: gli antichi miti, come miti archetipi (archetipici)
«il potere dei miti sulle idee» «Il valore del pensiero archetipico non consiste nel dare una sicura
identificazione ai problemi. Il suo scopo è piuttosto quello di aprire la mente alla riflessione
psicologica sulle posizioni e i progetti della mente. E anche se pensiamo che i miti sono ormai da
lungo tempo dimenticati, e che gli Dei e le Dee sono morti, in realtà essi risorgono nelle passioni
dell’anima. L’ipotesi che il nostro temperamento sia tracciato sulle linee di una griglia mitica è
un’idea che merita maggiore spazio… » (Hillman James 1995 Forme del potere. Capire il potere
per usarlo in maniera intelligente, Garzanti, Milano 1996, 165, 82)
«… nella consapevolezza che molto di quel materiale mnestico che costituisce il corpo dell’iceberg
della cosiddetta «civiltà occidentale» torna ad acquistare una propria incandescenza. O, per usare un
termine più sobrio, una sua problematicità attiva. » (Revelli Marco 2012 I demoni del potere,
Laterza, Roma-Bari, XIII)
«Quanto più la storia contemporanea accelera i propri ritmi, emancipandosi dal passato e
rimuovendolo, tanto più questo, ad un tratto, sfonda la parete del presente per riapparirci in forma
spettrale — come un fantasma della violenza senza limiti da cui proveniamo e che, nonostante tutti i
salti di civiltà, non ci siamo mai del tutto lasciata alle spalle. Nel saggio di Revelli [I demoni del
potere, Laterza, 2012], essa assume il volto, minaccioso e sinistro, di due miti fondativi, quello
della Medusa, poi sconfitta da Perseo e quello delle Sirene, ingannato da Ulisse — forse mai
indagati con una pari capacità di coglierne gli echi attualissimi. Sia il volto accecante della Gorgone
sia il corpo ammaliante delle Sirene costituiscono una rappresentazione icastica dei demoni che non
soltanto bussano alla nostra porta, ma nascono dentro di noi, come l'ombra lunga che sottende la
nostra esperienza quotidiana.» (Esposito Roberto 2012 Civiltà barbarica. Perché l’Occidente non
controlla più il lato selvaggio del potere, la Repubblica, 05.10.2012)
2.3. in ipotesi: la sequenza storica delle metafore programmatiche nel campo del pensiero e
dei modelli politici, immagini mitiche.
2.3.1. volti antichi, classici e mitici: la Gorgone (Medusa) e le Sirene e i processi. In mappa:
I demoni
La difesa
Il processo
L’esito civile
Gorgone
Perseo – lo specchio
Il diritto e la polis
Nomos
Sirene
Ulisse – i vincoli
La narrazione comunicativa
Logos
«Entrambe situate sul confine tra uomo e animale, entrambe simboli di un potere che schiaccia gli
uomini sulla dimensione della cosa, la Medusa e le Sirene differiscono per lo strumento omicida che
12
usano — lo sguardo la prima e la voce le seconde. Se la Medusa pietrifica chi la guarda, proiettando
sul suo viso l’immobilità della propria maschera, le Sirene prosciugano la soggettività di chi le
ascolta, dissolvendola nel loro canto di morte. Eppure, in questa simmetria, già traspare una prima,
significativa, differenza. Piuttosto che la violenza bruta della Gorgone, le Sirene esercitano un
potere più sottile e seducente. Esse non pongono direttamente le mani insanguinate sulla vittima, ma
la attirano da lontano nel gorgo. Proprio per questo Ulisse può sfuggire alla loro presa con un
artificio tecnico, facendosi legare all’albero della nave senza perdere le note letali del loro canto.
Come già per la Medusa, Revelli ripercorre le grandi interpretazioni del mito — da Adorno e
Horkheimer, a Blanchot, a Kafka — cogliendone il nucleo di senso. Accettando, e vincendo, la
sfida con le sirene, Ulisse fa della loro presenza mitica un racconto, traversando la soglia epocale
che conduce dall’universo muto e barbarico del mito al mondo aperto e narrabile della storia.
In questa prospettiva l'autore introduce un parallelo tra l’origine del racconto e quella del diritto,
Del resto il processo di civilizzazione, coincidente con l’istituzione della polis, nasce nel doppio
segno del Logos e del Nomos, della Parola e della Legge.» (Esposito Roberto 2012 Civiltà
barbarica. Perché l’Occidente non controlla più il lato selvaggio del potere,la Repubblica,
05.10.2012)
2.3.1.1. La Gorgone. «Il volto di Medusa. Ovvero il potere e lo sguardo»
«Hans Kelsen, in un testo del 1926, a un certo punto lascia cadere un’espressione inattesa per chi lo
conosce soprattutto per il suo razionalismo giuridico rigorosissimo. Quasi gettando per un attimo lo
sguardo oltre il confine ben presidiato del suo normativismo assoluto, nella zona tellurica dei nudi
fatti, introduce un’espressione orrifica: «il volto di Gorgone del Potere».
Vorrei prendere lo spunto da questa particolarmente brutale metafora del potere, perché ci introduce
immediatamente in medias res. Val la pena di rileggere per intero la frase di Kelsen, il quale sta
parlando specificamente della differenza tra approccio giusnaturalistico e positivismo giuridico e,
nell’ambito di questo, della particolarità della sua «dottrina pura del diritto». Scrive appunto
Kelsen: «La questione che occupa il diritto naturale è l’eterno problema di che cosa si celi dietro il
diritto positivo. Ma chi cerca una risposta trova, temo, non la verità assoluta d’una metafisica o
l’assoluta giustizia di un diritto naturale. Chi solleva il velo e non chiude gli occhi incrocerà lo
sguardo fisso della testa di Gorgone del Potere».
La frase è diventata celebre. Ma pochi si sono posti a fondo la domanda: perché la Gorgone?
Perché, tra le tante possibili, proprio questa metafora mitologica, per rappresentare la dimensione
demoniaca che caratterizza il potere allo «stato naturale»? Il potere «nudo», senza veli, il «volto
demoniaco del potere», per dirla con Gerard Ritter?
Certo, è possibile che con essa Kelsen intendesse riferirsi, genericamente, al carattere selvaggio,
belluino, del potere ridotto alla dimensione della pura forza, spogliato dell’involucro «civile» del
consenso e della legge. Che il richiamo alla Gorgone implicasse un semplice riferimento al
«mostruoso». Ma in realtà il simbolismo della Gorgone va molto al di là di questo livello
superficiale. È più complesso. Per certi aspetti più inquietante, se interpretato più che come
metafora come «allegoria» del potere.» (Revelli Marco 2012 I demoni del potere, Laterza, RomaBari, 3-4)
Come se si vuole sollevare il velo dei fenomeni e della loro (umana e pietosa) composizione in
forme razionali per vedere cosa c’è oltre, non troviamo un’essenza metafisica, tanto meno un ordine
(a meno di dar realtà alle nostre costruzioni mentali e teoriche) ma un vuoto (un inconoscibile come
indica Kant con la nozione di noumeno [per l’opportunità è forse utile richiamare l’ambiguità di
quell’oltre che Kant prefigura o richiama: 1. fonte di smarrimento e denso di pericoli, quando ne
parla nella Critica della Ragion pura: «…un vasto oceano tempestoso, impero proprio
dell’apparenza dove nebbie grosse e ghiacci, prossimi a liquefarsi, danno a ogni istante l’illusione
di nuove terre, e, incessantemente ingannando con vane speranze il navigante errabondo in cerca
di nuove scoperte, lo traggono in avventure, alle quali egli non sa mai sottrarsi, e delle quali non
può mai venire a capo.» (Kant, Critica della ragion pura, 243); 2. luogo ed esperienza del sublime,
del sublime naturale, quando richiama quella situazione nella Critica del giudizio: «Lo stupore che
13
confina con lo spavento, il raccapriccio e il sacro orrore che prova lo spettatore alla vista di
montagne che si elevano fino al cielo, di profondi abissi in cui le acque si precipitano furiose, di
una profonda e ombrosa solitudine che ispira tristi meditazioni, etc., quando egli si senta al sicuro,
non costituiscono un timore effettivo; sono soltanto una prova ad abbandonarvisi con la nostra
immaginazione, per sentire il suo potere di collegare l’emozione suscitata da tali spettacoli con la
serenità dell’animo, e di essere superiore alla natura in noi stessi, e quindi anche a quella fuori di
noi, in quanto può avere influenza sul sentimento del nostro benessere.» (Kant, Critica del Giudizio
122)], o caos e dolore (come accade alla Volontà di vita presentata da Schopenhauer), o macerie
(come lo spettacolo che appare agli occhi dell’Angelus Novus di Benjamin), così «Chi solleva il
velo e non chiude gli occhi incrocerà lo sguardo fisso della testa di Gorgone del Potere». È qui
anche la fine (o l’assenza) della funzione del concetto di stato di natura formulato dal pensiero
politico moderno, sia giusnaturalistico che contrattualistico.
Mascheramento e pietrificazione, i due attributi della Gorgone-Medusa. «Dietro l’allegoria della
Gorgone, dunque, sta la constatazione di una connotazione originaria patologica del potere nella sua
forma elementare. Di una sua intrinseca minacciosità, pericolosità — diciamolo pure —
mostruosità. Il suo collocarsi sul confine del disumano; e la sua tendenziale vocazione a provocare
la disumanizzazione di chi vi entra in relazione, sia esso chi lo esercita o chi lo subisce; il titolare o
il destinatario di esso.» (Revelli 2012 I demoni del potere, 9)
2.3.1.1.1. Perseo e lo specchio. «Lo specchio di Perseo. Perseo è celebrato come fondatore di città
(«i micenei lo ricordarono come il loro Eroe fondatore»). Soprattutto come «uccisore di mostri».
Ma egli è anche l’uomo degli «artifici». L’Eroe che più di ogni altro ha utilizzato una
strumentazione, diciamo così, «tecnica» (o «magica», che in questo contesto è sinonimo) nelle
proprie imprese: calzari alati offerti da Hermes, la «cappa di Ades» che rendeva invisibili, la kibisis
magica in cui riporre la testa mozzata della Gorgone, oltre naturalmente al «lucido scudo di Atena».
Nell’immaginario degli antichi egli è colui che «doma» le potenze infere, la naturalità selvaggia
degli elementi e delle passioni, riaffermando una ragionevole idea di ordine della Polis (non per
nulla una delle ultime sue battaglie fu contro Dioniso e le sue milizie femminili, le Aliee). In Ovidio
egli è rappresentato addirittura nel gesto delicato del prendersi cura dei fragili resti della Gorgone,
del suo capo mozzo e mostruoso adagiato su un letto di foglie, perché la «ruvida sabbia» non abbia
a rovinarlo impedendone l’uso postumo. Nella rappresentazione moderna Perseo incarna in qualche
misura il ruolo, multiforme e cangiante, di ciò che «redime». Italo Calvino lo evoca nelle sue
Lezioni americane come espressione di leggerezza, capace di «redimere» l’esistenza dalla
«pesantezza, l’inerzia, l’opacità del mondo»: «L’unico eroe capace di tagliare la testa della Medusa
è Perseo, che vola coi sandali alati, Perseo che non rivolge il suo sguardo sul volto della Gorgone
ma solo sulla sua immagine riflessa nello scudo di bronzo. Perseo mi viene in soccorso anche in
questo momento, mentre mi sentivo già catturare dalla morsa di pietra». (Revelli 2012 I demoni del
potere, 16); e cita Georges Didi-Huberman: «Perseo affronta malgrado tutto la Gorgone, e questo
malgrado tutto – questa possibilità di fatto, a dispetto di una impossibilità di principio – si chiama
immagine: lo scudo, il riflesso non sono soltanto la sua protezione, ma anche l’arma l’astuzia, il
mezzo tecnico di cui egli dispone per decapitare il mostro». È esso, nel suo carattere di
«artificium», a spezzare l’opaca ineluttabilità del destino («l’impotente fatalità dell’inizio») per
introdurre e rendere possibile, come fattore di «redenzione», l’effetto liberatorio della risposta
etica: «ebbene, affronterò comunque la Medusa, guardandola altrimenti». ». (Revelli 2012 I demoni
del potere, 18)
2.3.1.1.2. Perseo e lo scudo del diritto. «Nel dispositivo giuridico-politico moderno, infatti,
incentrato sulla dialettica tra Contratto e Legge, tra Consenso e Norma, e sul passaggio complesso
ma tendenzialmente compiuto al «governo delle leggi», la dimensione originaria, naturale e
selvaggia, del Potere non viene del tutto cancellata, ma scivola, per così dire, «sullo sfondo»
(appare, appunto, come «riflessa») rispetto al «primo piano» occupato dalle «forme» e dagli
«apparati» che ne esercitano la gestione e il controllo. Il moderno racconto sull’«Ordine» subisce,
per così dire, un’apostrophé, uno «scarto laterale» spostando lo sguardo dall’ambito «disumano»
14
della violenza pura, primigenia e infera, come espressione di potere fine a se stesso, a quello della
costruzione tutta «umana» di un ordine consapevolmente voluto attraverso l’elaborazione delle
istituzioni ad esso preposte: della machina machinarum, appunto, che non rinuncia all’esercizio
della Gewalt (della Forza-Violenza) ma la retrocede allo status di «mezzo» rispetto ai propri fini
specificamente ed esplicitamente «umani» (l’extrema ratio al servizio e a garanzia della regola che
recita: pacta sunt servanda; la minacciata possibilità della sanzione in caso di violazione della
Norma). La incorpora al proprio «paradigma» in una posizione «strumentale», o, se si preferisce,
per proseguire il parallelo col discorso sull’impresa di Perseo, in forma di immagine riflessa, e, per
questa via, la «redime». Retrocedendola da fine-in-sé a «mezzo», strumento tecnico, assegnandole
un carattere «strumentale», la asserve e, insieme, la «umanizza» (la pone al servizio di una funzione
«umana»). La «umanizza asservendola», o la «asserve strumentalizzandola», esattamente come, nel
testo di Kracauer, la rappresentazione di Medusa riflessa sullo scudo, sottraendo la violenza
(orrifica) della Gorgone alla sua primordiale «purezza» (alla sua assenza di fini, al suo carattere
esclusivamente «espressivo») e ri-assegnandole un carattere di «mezzo», finiva per «umanizzarla»
(riportarla su un piede di parità rispetto all’uomo, renderle una natura paritariamente umana) e
insieme per asservirla ad uno scopo a sua volta «umano» (l’impresa dell’eroe, la capacità di
guardare e quindi di «capire» dello spettatore), redimendola. Non dimentichiamo che nel mito il
potere della testa della Gorgone non finisce con la morte di Medusa, ma continua a esercitare la
propria minacciosa funzione come arma, come «strumento», nelle mani dell’eroe (mostrando
quell’orribile reperto Perseo pietrificherà di volta in volta Atlante, poi Fineo, fratello di Cefeo che
voleva negargli Andromeda, poi Polidette che lo derideva e infine Preto… […] Nell’ordinamento
normativo razionalmente elaborato come condizione e forma dell’ordine, in sostanza, si
anniderebbe la «métis del riflesso» che permette, appunto, di «domare» la potenza infera della
violenza utilizzando la sua stessa immagine; di eliminare il terrore reale insito nella belluina
bellicosità dello «stato di natura» attraverso la minaccia del terrore potenziale utilizzato come
instrumentum juris. […] Cosicché mentre il diritto, per un verso, si pone come limite della forza,
per altro verso, e contemporaneamente, ne costituisce la giustificazione. Mentre la controlla, la
legittima. » (Revelli 2012 I demoni del potere, 19-21) Sotto protezione e per interposto artificio
dell’immagine, può sopportare vincere, sottomettere e gestire il volto della Gorgone,
trasformandone la testa mozzata in strumento politico di controllo e vittoria su molti nemici, così
solo attraverso il diritto (il velo del diritto, alla Kelsen) può sopportare e gestire il peso della
violenza, trasformandola in strumento politico di ordine. Resta l’ambivalenza insuperata (e
insormontabile?) del «ruolo esplicitamente «sovrano» dell’ordinamento giuridico internazionale,
assurto a potenziale principio di ordine» (cfr. Kelsen) e dei «sintomi di una crescente difficoltà del
dispositivo giuridico-politico a controllare la potenza distruttiva dei propri stessi mezzi coercitivi».
(Revelli 2012 I demoni del potere, 24)
2.3.1.2. Le Sirene. Il canto delle Sirene. (Ovvero: il potere e la voce, la parola, il canto).
«Nel repertorio primordiale dei «demoni del potere», tra le figure teriomorfe, subito dopo la
Gorgone vengono le Sirene. Esse fanno irruzione nell’universo culturale novecentesco quasi
contemporaneamente al richiamo kelseniano al «volto di Gorgone del potere», sempre in area
tedesca, introdotte da due autori da Kelsen assai lontani, apparentemente agli antipodi. Horkheimer
e Adorno le pongono al centro del capitolo introduttivo della loro Dialettica dell’Illuminismo, a
simboleggiare la fine della preistoria (l’esaurimento del Mito) e il passaggio al tempo della ragione
(al mondo del Logos). A segnare cioè il confine varcato nel trapasso all’«ordine patriarcale». […]
Questa è dunque la promessa irresistibile fatta a Odisseo: il racconto di «tutto ciò che i Greci e i
Troiani hanno sofferto intorno a Troia»; il canto delle vicende di un passato non ancora trapassato,
che d’altra parte egli conosce perfettamente per averle vissute direttamente da protagonista. La
trasposizione poetica (in forma appunto di «canto») di un passato noto di cui godere, in cui
riconoscersi e, nel contempo, arrestarsi. Dunque, morire.» (Revelli 2012 I demoni del potere, 25,29)
Che forza di attrazione può avere il sentirsi raccontare ciò che già si conosce per averlo vissuto di
persona? Si tratta di passare a un canto della narrazione che diventa memoria epica, trapasso nel
15
tempo delle generazioni e possibilità così di sfuggire alla morte, alla morte della dimenticanza; è
entrare nella gloria (kléos, gloria, fama).
«L’eroe — scrive Hartog [François Hartog 1996 Memoria di Ulisse. Racconti sulla frontiera
nell’antica Grecia, Einaudi, Torino 2002] — accetta di morire in combattimento, di oltrepassare le
porte dell’Ade e dell’oblio, pur di ottenere in cambio il kleos, pur di continuare a vivere nel canto
degli aedi e nella memoria sociale del gruppo». Ora il canto delle Sirene contiene, nel proprio
intimo, l’irresistibile promessa della rivelazione («precoce») del kleos. Ascoltandolo, «come se
ascoltasse un poeta cantarlo dopo la morte», all’eroe è offerto l’assoluto privilegio di accedere,
ancora vivente, al proprio kleos: di conoscere da vivo ciò che agli altri è permesso solo da morti. Si
tratta — lo sappiamo — di una promessa fallace: le Sirene non sono le Muse che «grazie al canto
degli aedi, conferiscono agli eroi morti una vita imperitura». Sono «muse di morte», l’unica eternità
che offrono è quella del nulla. Ascoltandole, l’eroe perderà kleos e nostos [il ritorno tra i suoi]. Le
sue ossa resteranno a imbiancare il prato solitario, senza nome, né storia, né gloria ricordata.»
(Revelli 2012 I demoni del potere, 32-33)
[Il canto delle Sirene, o il kleos in vita, per riscontrarlo come fatto politico, può essere messo in
relazione alla tendenza e dedizione dello Stato a costruire in vita, quando si è al governo, la propria
gloria, con celebrazioni e convegni. Ma è una gloria di morte, destinata a celebrare con menzogna
una storia che ancora non può essere raccontata e che cadrà nella dimenticanza con l’estinguersi di
quel governo, imploso nella sua narrazione, accaduto e finito nelle parole del suo autoracconto.]
2.3.1.2.1. L’astuzia di Ulisse (la sua metis) consiste nel non negarsi l’ascolto del canto e del suo
incanto resistendo con decisione passiva e attiva (farsi legare) ai suoi effetti mortiferi. L’effetto è
redentivo, da “katastrophé”. L’artificio di Ulisse provoca l’effetto di far uscire dal mito e far sorgere
il racconto: Ulisse non accade nel canto delle Sirene ma è Ulisse che racconta; non è il canto delle
Sirene a raccontare, fuori dal tempo, ma sono le Sirene ad essere raccontate nel tempo e nel viaggio
di Ulisse. «… il racconto può cessare di essere «mitico», di condannare l’identità all’immobilità di
un destino pietrificato e scritto una volta per tutte, per farsi (finalmente) «racconto storico»… È
però soprattutto Blanchot [Maurice Blanchot, Le chant des Sirènes, in Id., Le livre à venir,
Gallimard, Paris 2008] quello che per primo, esplicitamente, ricollega il mito delle Sirene, e
l’astuzia di Ulisse, con la nascita del racconto.» (Revelli 2012 I demoni del potere, 42)
2.3.1.2.2. La politica come “storytelling”. O l’ambivalenza del racconto nel racconto politico. In
termini più drammatici l’accadere delle storie nella comunicazione politica e la fine della storia
(della possibilità di una narrazione responsabile).
«A partire dagli anni Novanta, prima nel mondo delle imprese e poi in quello della politica, si è
assistito alla diffusione di un nuovo paradigma del marketing e della comunicazione definito
storytelling e sancito dal passaggio dalla brand image (immagine di marca) alla brand story (storia
di marca). Improvvisamente il focus si spostava dal marchio alle narrazioni collegate al marchio,
riscoprendo un metodo di consenso e di legittimazione antichissimo: «l’arte di raccontare storie è
nata quasi in contemporanea con la comparsa dell’uomo sulla terra e ha costituito un importante
strumento di condivisione dei valori sociali» [Salmon 2007]. Per Roland Barthes «il racconto è
presente in tutti i tempi, in tutti i luoghi, in tutte le società; il racconto comincia con la storia stessa
dell’umanità; non esiste, non è mai esistito in alcun luogo un popolo senza racconti» [1969, 7].
Nella politica, d’altro canto, le ideologie politiche sono state sempre trasmesse di generazione in
generazione, e dai leader ai cittadini, attraverso racconti [Westen 200]; trad. it. 2008, 139]. Come
mai improvvisamente lo storyrelling è divenuto un approccio dominante nel marketing? Per due
ordini di ragioni: da un lato un crescente successo nell’ambito delle scienze sociali, che ha fatto
parlare di «svolta narrativa» e di «revival dello storytelling» [Salmon 2007]; dall’altro la necessità
di trovare nuovi modi per catturare l’attenzione e conservare consumatori sempre più distratti e
infedeli. [se ne fa ampio ricorso anche nella pubblicità e a illustrare uno specifico prodotto: vedi il
mulino bianco e le illustrazioni dei suoi singoli prodotti… sono storie]
Lo storytelling ha la funzione di mobilitare le emozioni attraverso la pratica di racconti condivisi, la
capacità di coinvolgere il cittadino consumatore/elettore in una relazione durevole ed emozionale.
16
Vincent [2002] sottolinea come le campagne pubblicitarie diventino sequenze narrative, i
consumatori audience, i loghi vengano sostituiti da personaggi. Un approccio non solo adatto alle
campagne elettorali, ma che, secondo Cornog [2004], fa parte della storia delle elezioni
presidenziali statunitensi da George Washington ai giorni nostri. Sin dalle origini della Repubblica
americana i candidati hanno dovuto raccontare agli elettori delle storie convincenti sulla nazione,
sui suoi problemi e, soprattutto, su se stessi.» (Cacciotto Marco 2011 Marketing politico. Come
vincere le elezioni e governare, il Mulino, Bologna, 146)
«‘Volete sapere come raddoppiare le vendite e quadruplicare il profitto?’ chiede Doug Stevenson,
presidente delle Story Theater International, ‘Venderete molto di più utilizzando una success story,
che descrivendo le caratteristiche e i vantaggi del vostro prodotto o servizio. Una storia, e il
prodotto è venduto. La gente adora le storie’». Lo riferisce Christian Salmon, autore di un libro che
ha fatto, a modo suo, epoca [Christian Salmon, Une machine à fabriquer des histoires (Una
macchina inventa-storie, in il manifesto/Le monde diplomatique, novembre 2006), Christian
Salmon, Storytelling. La fabbrica delle storie, Fazi, Roma 2008]. E aggiunge: «Il successo dello
storytelling non è rimasto confinato alle sole direzioni d’impresa e al marketing, in dieci anni si è
imposto a tutte le istituzioni, tanto da apparire come il paradigma della rivoluzione culturale del
capitalismo, una nuova norma narrativa che alimenta e vitalizza i più diversi settori di attività».
[…]… quando Ronald Reagan fu eletto Presidente degli Stati Uniti e inaugurò, oggi lo sappiamo,
una nuova epoca. […] Era, in qualche misura, l’inizio dell’inarrestabile scivolamento della politica
verso il marketing, anzi, della tendenziale identificazione tra politica e marketing, mentre il
marketing a sua volta si spostava progressivamente dal prodotto al marchio, al logo, e, infine, alla
story. […] Con lui compariranno, nel cuore del potere, gli spin doctors, gli specialisti nel «far
girare» il racconto, nel girarlo e ribaltarlo a favore del committente, che poi con Bill Clinton
occuperanno stabilmente la Casa Bianca per evolvere infine negli story doctors di George W. Bush,
quando la story assumerà sempre più un carattere noir. E la narrative assorbirà, quasi senza residui,
la politica, diventando la forma più evidente dell’esercizio del Potere. […] … quello che si
materializza nell’ipermoderno storytelling non è il racconto redivivo, il «racconto salvato», è il
racconto postumo. È il racconto dopo la morte del racconto… […] Lo storytelling percorre il
cammino in senso inverso: incolla sulla realtà racconti artificiali, blocca scambi, satura lo spazio
simbolico di sceneggiati e di stories. Non racconta l’esperienza del passato, ma disegna i
comportamenti, orienta i flussi di emozioni, sincronizza la loro circolazione».
Lontana anni luce dai «percorsi del riconoscimento» di cui parlava Paul Ricoeur a proposito del
récit, questa inedita «arte di raccontare storie» nasce con il fine esplicito di conformare i
comportamenti collettivi all’immagine del mondo di chi controlla i flussi comunicativi. Di far
precipitare i pezzi scomposti delle vite in frantumi dentro il calco predefinito di un’identità virtuale
ricostruita altrove. In questo senso essa appare figlia di una doppia morte: morte della forma
narrativa e, insieme, morte del soggetto narrato; estinzione del «racconto tradizionale», come si è
visto, ma anche del protagonista «storico» di quel racconto. […] non sembra ricondurci puramente e
semplicemente alla figura teriomorfa delle Sirene. Alla leggerezza del loro volo. Né alla consistenza
soft del loro annientamento mnestico, pur avendo, questa nuova narrativa tecnicizzata, lo stesso
potenziale di fascinazione del loro canto: la medesima capacità di abbattere le barriere protettive del
sé, di cancellare le capacità di ascolto critico... Se un profilo emerge dietro quel canto postumo, esso
sembrerebbe piuttosto quello di Medusa. La sua dura immobilità di maschera. La ferocia distruttiva
delle cose che si ammantano di parole ma mantengono la loro inerte petrosità, la propria distanza
abissale dall’umano. È la propria capacità di pietrificare. Il racconto che occupa la scena del mondo
«dopo la fine del racconto», è, se vogliamo condurre fino in fondo l’allegoria, il canto della
Gorgone fattosi, per una paradossale metamorfosi, Nomos della Terra.» (Revelli 2012 I demoni del
potere, 63-72 passim)
Insomma, ritorna la Gorgone, la mediazione del diritto non ha funzionato; quella violenza che era
stata scongiurata ma non annullata, solo assorbita politicamente e affidata alle forme del diritto,
sembra prendere il sopravvento e realizzarsi nella forma di uno stato in cui il potere totale è
17
diventato un diritto nella forma della persuasione narrata e della anarchia. Si capisce allora
l’insistenza di Kelsen nel dare al diritto, e al diritto nella sua formalità, un tratto originario, dietro al
quale non si può andare; non si può sollevare il velo del diritto, ne emergerebbe il volto della
Gorgone; ma allora non è accettabile il contratto sociale di Hobbes che non annulla la violenza ma
la consegna al Leviathan; il rischio è troppo alto perché quella violenza non torni rinnovata e magari
potenziata nelle forme giuridiche di un potere che non deve dar conto di sé; un potere le cui
narrazioni e la cui storytellig è costruzione senza passato, libera e arbitraria, della realtà
momentanea, senza vincoli e con un inesorabile e progressivo annullamento della democrazia.
[Appendice. Si apre qui il complesso tema della comunicazione politica, delle diverse forme
storiche della sua costruzione tecnica e degli effetti politici sulla tenuta della democrazia.
Per fare il punto sulla situazione alcuni riferimenti: Cacciotto Marco 2011 Marketing politico. Come
vincere le elezioni e governare, il Mulino, Bologna; Cosenza Giovanna 2012 Spotpolitik. Perché la
“casta” non sa comunicare, Laterza, Roma-Bari; Ricciardi Mario 2010 La comunicazione. Maestri
e paradigmi, Laterza, Roma Bari]
2.3.2. volto moderno (classico e mitico): il Leviatano
«La Modernità in politica, si può dire, nasce esattamente dalla rottura di questo rapporto con la
Morale. Dallo sganciamento dell’ambito del Politico dal campo di controllo e di interferenza delle
altre sfere; e dall’assunzione della dimensione tecnica (dell’adeguatezza dei mezzi ai fini) come
unico criterio di giudizio sull’azione politica. Nasce, dunque, con l’affermazione di quella che è
stata chiamata l’«autonomia della politica» (o «del Politico»): autonomia, appunto, del discorso del
Potere dall’ordinamento morale corrente. Emancipazione della sfera del potere dalla sfera della
Morale. […] Ma è soprattutto in Hobbes che il potere rivendica, anche nominalmente (e questa
volta positivamente [nel senso del diritto positivo]), il proprio rapporto genetico con la dimensione
del «mostruoso», senza ammettere limiti. Il Leviatano proviene dritto dritto dal Libro di Giobbe, il
testo seminale sulla questione del male; ha il nome terrifico dell’«antagonista di Dio» in terra e la
genesi tipica del «numinoso». Ma qui non è la sua qualifica di «antagonista» a contare, e neppure la
sua origine «sacra» (almeno dal punto di vista letterario); è la sua connotazione in termini di
Potenza. È l’affermazione che sta in quel versetto 41,24: Non est potestas super terram quae
comparetur, la quale ne spiega l’assunzione come pilastro di un nuovo paradigma «autosufficiente».
In cui il Politico si auto-fonda senza più mediazione con altre sfere valoriali.
Ancora una metafora teriologica, dunque. Ancora il riferimento a un mostro «numinoso» per dare
un corpo, una personificazione, al potere; ma ora neutralizzato, rispetto al potenziale di negatività
implicito, non più dall’Etica bensì dalla Tecnica. Leviathan perde il proprio carattere selvaggio,
ferino, infero, il proprio potenziale demoniaco, e può, per così dire, entrare «a servizio» degli
uomini, anziché annientarli ciecamente, perché parte di un meccanismo. Anzi: perché meccanismo
tout court. Machina machinarum, sottoposta al gioco di forze della fisica meccanica. Controllabile
dal sapere ingegneristico: fattore di potenza «naturale» utilizzabile esattamente come lo sarà, di lì a
poco, il vapore e l’energia elettrica. Natura selvaggia «messa al lavoro». Reificata. Medusa
sottoposta essa stessa al potere pietrificante del proprio sguardo.» (Revelli Marco 2012 I demoni del
potere, Laterza, Roma-Bari, 13, 14) Occorre ricordare la funzione del meccanicismo in Hobbes: si
tratta di una funzione logica, non solo di incidenza e definizione nel campo della fisica; quindi
determinante anche nella costruzione “meccanica” di un sistema politico di carattere assolutistico
ma dotato di autocontrollo per l’atto di origine e per la motivazione, il fine, del suo esistere. Nella
metafora assoluta presentata da Hobbes si fondono gli elementi del naturale-selvaggio, divinobiblico (Hobbes definisce lo Stato Dio terreno), tecnico-scientifico ai fini della autonomia del
politico.
2.3.2.1. «Contro la violenza indifferenziata di Kratos— il volto bestiale e demoniaco del potere —
le mura della città costituiscono una barriera protettiva che gli uomini si impegnano a non
infrangere. Naturalmente ciò non vuol dire che la violenza scompaia. Essa viene assunta e
incorporata dallo Stato, che si riserva di adoperarla solo contro coloro che dovessero contravvenire
18
al giuramento di ubbidienza al sovrano. L'immagine, non meno spaventosa, del Leviatano di
Hobbes — un mostro marino, di origine biblica, protetto da una corazza fatta di scaglie umane —
rappresenta questo passaggio dalla violenza scatenata alla violenza trattenuta e finalizzata al
controllo sociale. La costruzione di quel ius publicum europaeum che per almeno quattro secoli ha
garantito l’ordine all'interno degli organismi statali, ne costituisce l’esito insieme prezioso ed
ambivalente. Prezioso perché ha consentito uno sviluppo senza precedenti alla civiltà occidentale.
Ambivalente perché non solo è stato costruito al prezzo di infinite guerre che hanno rovesciato
all’esterno degli Stati la violenza dominata al loro interno, ma soprattutto perché, nel cuore del
Novecento, ha visto schizzare fuori dal suo fondale una violenza in camicia bruna più primitiva di
quella mitica. È allora che, insieme alle trama del diritto, ha rischiato di spezzarsi anche quella
della memoria storica, ripiegata su stessa in un incubo da cui è stato arduo risvegliarsi.» (Esposito
Roberto 2012 Civiltà barbarica. Perché l’Occidente non controlla più il lato selvaggio del potere,
la Repubblica, 05.10.2012)
2.3.2.2. La metafora del Leviatano conserva dunque aspetti inquietanti, incastonati nella
ambivalenza dell’atto di nascita dello Stato Assoluto. Uno stato che ha il monopolio della forza e
anche del diritto. Se è vero che il diritto costituisce il contesto di legittimazione dell’uso della forza
è altrettanto vero che nella gestione ed emanazione del diritto il Leviatano non conosce superiori a
sé; se è vero che la natura meccanica del potere politico (della macchina dello Stato) ne garantisce il
funzionamento meccanico, cioè secondo regole e forme stabilite, la macchina resta pur sempre un
prodotto umano, un risultato delle scienze poietiche. Una simile consapevolezza sta probabilmente
all’origine dell’urgenza di proclamare sedi o momenti “politici” posti alle spalle dello Stato stesso:
la natura come luogo dei diritti naturali, il contratto come atto di nascita dello Stato, la natura
meccanica importata nello Stato stesso, la natura e il vincolo logico del diritto. In questa linea, a
livello radicale e fondativo e nell’età contemporanea, si inserisce il progetto di Hans Kelsen di
definire le linee per una teoria del diritto puro; diritto positivo, per la ribadita autonomia del potere
politico, ma diritto puro, per l’urgenza di fondazione giuridica dello Stato secondo coordinate di
giustizia; ciò proprio nel momento storico in cui si stanno formando i totalitarismi del ‘900
(Lineamenti di dottrina pura del diritto 1934).
2.3.3. volti / immagini contemporanee: Guernica, Rete, Telemaco
«Mai come tra gli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso i demoni del potere sono tornati ad
affacciarsi, rendendo pietre, o polvere, decine di milioni di uomini. Che si sia trattato di una
parentesi, richiusa una prima volta alla fine della guerra calda e una seconda alla fine di quella
fredda, oppure dell'annuncio di qualcosa di ancora più devastante, resta per adesso incerto. Le
pagine drammatiche scritte da Pasolini sul mutamento antropologico in atto non solo nel nostro
Paese — come le immagini insostenibili di Salò-Sade — pongono forti dubbi sul nostro futuro. Ma
ancora più problematica si presenta la condizione di quel mondo globale che ha sfondato le mura
della politica moderna, aprendolo alla libera circolazione dei flussi demografici, tecnologici. Molti
hanno puntato sulle sue potenzialità emancipative, prima che qualcosa di arcaico come i conflitti
etnici e religiosi abbia prodotto uno sgradevole risveglio dalle prime illusioni.» (Esposito Roberto
2012 Civiltà barbarica. Perché l’Occidente non controlla più il lato selvaggio del potere, la
Repubblica, 05.10.2012)
«Che accadrà ora, nel punto storico in cui la solidità dei «luoghi» sembra vacillare e sciogliersi
sotto la spinta travolgente dei «flussi»; e quelle linee di confine che avevano delimitato lo spazio del
Logos e la signoria del Nomos farsi incerte e impermeabili? Avevamo tutti (o quasi) provato uno
straordinario senso di sollievo, e di liberazione, al tempo del «crollo dei muri»: di quelli fisici (e
politici), sotto la spinta delle rivoluzioni incruente di fine Novecento; e di quelli economici (e
finanziari), per effetto di quella grande «rivoluzione spaziale» che è la globalizzazione. Avremmo
dovuto sospettare che in quell’improvviso abbassamento delle mura della città, attraverso le brecce
aperte nelle barriere che avevano circondato fino ad allora le nostre «sfere vitali», qualcosa sarebbe
filtrato «dall’esterno» a decostruire la nostra domesticità faticosamente stabilizzata. E,
simmetricamente, che qualcosa sarebbe fuoriuscito (si sarebbe «liberato») di quanto tra quelle mura
19
era stato posto sotto custodia, a cominciare da quella potenza assoluta — quella potestas
superiorem non recognoscens, per dirla con i classici — che si chiama appunto «sovranità». E che
costituisce l’alfa e l’omega della costruzione dell’ordine interno della civitas.» (Revelli Marco 2012
I demoni del potere, Laterza, Roma-Bari, X- XI)
2.3.3.1. La barbarie della civiltà. Guernica di Pablo Picasso (1937), un condensato di immaginisimboli e un evento artistico politico per «una violenza più primitiva di quella mitica»; la barbarie
della civiltà, una barbarie raffinata, tecnicamente potente, senza controllo e senza limiti. «Nach
Auschwitz». «Dopo Auschwitz» - dice a più riprese Adorno, nulla può restare come prima, esente
dal contagio con l’orrore.» (Vercellone Federico 2008 Oltre la bellezza, il Mulino, Bologna, 132)
L’opera di Picasso è vissuta come un simbolo, immagine del potere e del suo possibile volto anche
molto tempo dopo la sua composizione e riceve conferma della sua forza dalla volontà esplicita di
un suo occultamento strategico in una prassi di comunicazione politica che investe prioritariamente
sul ruolo informativo e comunicativo dell’immagine. «La mattina del 5 febbraio 2003 nel Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite il segretario di Stato Colin Powell mostra prove che si sarebbero
rivelate false circa il possesso da parte dell’Iraq di armi di distruzione di massa. Poco prima della
riunione qualcuno aveva provveduto a coprire con un telo blu l’arazzo che riproduce Guernica
(l’opera di Picasso assurta a simbolo degli orrori della guerra), donato all’Onu da Nelson
Rockefeller nel 1987. L’arazzo si trovava alle spalle del segretario di Stato ed era destinato perciò a
essere ripreso dalle Tv di tutto il mondo durante il discorso di Powell. Si preferì oscurarlo nel
timore che la sua visione rendesse i presenti più sensibili ai rischi della guerra, pregiudicando così
l’esito dell’esposizione di Powell? È possibile, perché la menzogna politica ha bisogno di una
scenografia che non contraddica il suo messaggio.» (Violante Luciano 2013 Politica e menzogna,
Einaudi, Torino, p. 16-17)
2.3.3.1.1. Si tratta di una violenza sorda e spietata per la logica di normalità che la caratterizza; il
principio di questa logica è infatti il “mito dell’efficienza. «Il mito dell’efficienza, che molti
sembrano condividere applaudendo i leader politici che promettono di garantirla, fu sperimentato su
larga scala come macchina di potere nei lager nazisti, dove il problema era di “sistemare” in
ventiquattro ore i convogli dei deportati che quotidianamente arrivavano. […] la causa efficiente
che — messe in ombra le altre cause che Aristotele chiamava “finale”, “formale”, “materiale” —
diventa l’unica risposta alla domanda che chiede il perché di un determinato agire.» (Galimberti
Umberto 2009 I miti del nostro tempo, Feltrinelli, Milano, 115, 116)
2.3.3.2. Lo spazio senza limiti e senza gerarchie. La rete o la comunicazione universale nell’era
dell’accesso; l’orizzontalità senza inizio né fine, senza guidatore, senza un disegno preordinato, in
un futuro di pacifica anarchia garantita nel suo successo solo dalla tenuta del diritto, delle libertà,
del bene comune e dalla legge, in termini di diritto internazionale. Il riferimento visivo artistico va
all’opera di Manolo Valdes, Mappamundi; una mappa del mondo nella quale sullo sfondo
geografico della terra sul quale compaiono tutti i continenti dall’America al Giappone…ha
disegnato una rete costruita come le mappe guida per le reti metropolitane cittadine, immaginando
un coordinamento orizzontale continuo e rapido tra tutte le zone del mondo, rete sulla quale i
veicoli si muovono senza bisogno, ormai, di un guidatore, di una intelligenza motrice; e i
movimenti avvengono senza scontri.
2.3.3.2.1. è rivoluzione dei flussi sociali: «La rivoluzione della tecnologia dell’informazione e della
comunicazione e la trasformazione sociale che l’accompagna è secondo Castells una cesura epocale
nel modo di sviluppo delle società umane. L’esperienza del tempo viene alterata, lo spazio
riorientato e riorganizzato dalla logica dei flussi della società in rete, della società che comunica e
consuma mediante la Rete, in base a processi che diffondono istantaneamente simboli e conoscenze,
modificando in profondità le espressioni culturali e cambiando radicalmente le forme del potere
politico e della mobilitazione sociale.» Presentazione dell’opera: Castells Manuel 1996, 2000 La
nascita della società in rete, Università Bocconi Editore (2002) UBE Paperback, Milano 2008
2.3.3.2.2. è il mutamento antropologico; tratti di una nuova antropologia. «Un nuovo archetipo
umano ha fatto la sua apparizione. L’uomo nuovo del ventunesimo secolo è profondamente diverso
20
da coloro che l’hanno preceduto, nonni e genitori borghesi dell’era industriale: si trova a suo agio
trascorrendo parte della propria esistenza nei mondi virtuali del ciberspazio, ha familiarità con i
meccanismi dell’economia delle reti, è meno interessato ad accumulare cose di quanto lo sia a
vivere esperienze divertenti ed eccitanti, cambia maschera con rapidità per adattarsi a qualsiasi
nuova situazione (reale o simulata). […] generazione «proteiforme» […] Vivono in un mondo di
stimoli sonori che durano sette secondi, sono abituati all'accesso rapido alle informazioni, hanno
una soglia d’attenzione labile, sono più spontanei che riflessivi. Pensano a se stessi come a giocatori
più che a lavoratori e preferiscono essere considerati creativi piuttosto che industriosi. Sono
cresciuti in un mondo di occupazione just-in-time e sono abituati a incarichi temporanei. Anzi, le
loro vite, in generale, sono segnate da un grado di mobilità e di precarietà maggiore, sono meno
radicate di quelle dei loro genitori. Sono più «terapeutici» che ideologici e pensano più in termini di
immagini che di parole: sono meno abili nella composizione di frasi, ma superiori nell’elaborazione
di dati elettronici. Sono più emotivi che analitici. Ritengono che Disney World e Club Med siano
«veri», considerano i centri commerciali pubbliche piazze e non distinguono fra sovranità del
consumatore e democrazia. Trascorrono con personaggi di fantasia, nei film, nei programmi
televisivi e nel ciberspazio, tanto tempo quanto ne dedicano ai propri simili nella vita reale; anzi,
arrivano perfino a inserire tali personaggi nella conversazione e nell’interazione, rendendoli parte
della propria storia personale. Il loro mondo è più fluido, segnato da confini più sfumati. Sono
cresciuti a ipertesti, link fra siti Web e anelli di feedback, e hanno una percezione della realtà più
sistemica e partecipativa che lineare e obiettiva. Non si preoccupano della localizzazione geografica
delle persone a cui abitualmente mandano e-mail, delle quali conoscono solo l’indirizzo virtuale.
Pensano al mondo come a un palcoscenico e alla propria vita come a una serie di rappresentazioni
teatrali. Cambiano in continuazione, a ogni passaggio fondamentale della propria esistenza
sperimentando stili di vita sempre nuovi. Questi uomini e queste donne non sono interessati alla
storia, bensì ossessionati dalla moda e dallo stile. Provano tutto e amano l’innovazione. D’altra
parte, nel loro ambiente in rapido e costante mutamento, costumi, convenzioni e tradizioni sono
quasi inesistenti.» (Rifkin Jeremy 2000 L’era dell’accesso. La rivoluzione della new economy, A.
Mondadori 2000, 249-250)
2.3.3.2.3. è un mutamento di orizzonti e relazioni: le sovrapposizioni tra reale e virtuale. Prende
forma sociale, anche in un evidente gap generazionale, la progressiva inutilità e impossibilità di
distinguere il reale dal virtuale. La realtà virtuale che per le generazioni del secondo ‘900 si
presenta (se va bene) come mezzo, per le generazioni presenti è sede e contesto di vita e di relazioni
del tutto e sempre più intrecciata al cosiddetto mondo reale fino a condurre alla inefficacia e
inutilità di una distinzione tra reale e virtuale.
Sono trasformazioni che pongono al centro il problema dell’accesso: non l’appropriazione (come
nella tradizione dell’economia classica, da Locke a Marx) genera le relazioni sociali, economiche e
politiche, ma l’accesso alla reti (alla rete mondiale ora dominante: world wide web) e la gestione
delle condizioni che lo rendono possibile: «un mondo di reti, gatekeepers e connettività». L’accesso
sta diventando un potente strumento concettuale per riformulare una visione del mondo e
dell’economia, ed è destinato a diventare la metafora più efficace della nuova era: l’«era
dell’accesso».
2.3.3.3. Telemaco o il diritto alla domanda di senso, pur nella consapevolezza della assenza di
risposte; il complesso di Telemaco in sostituzione al complesso di Edipo e il costituirsi quotidiano
della simbolizzazione nella cura. «Telemaco è infatti il "giusto erede" di un genitore vulnerabile che
non si propone come un modello esemplare o universale, ma può rappresentare «una testimonianza
etica, singolare, irripetibile» sulla possibilità di stare al mondo con qualche passione, sulla capacità
di restituire fiducia nell’avvenire. E seppure la verità che trasmette si sia indebolita, non c'è nessuna
nostalgia per il pater familias, il tiranno che una volta assicurava l’ordine più repressivo,
«incarnazione normativa della potenza trascendente di Dio». L'icona un po' struggente di Telemaco,
che non trasgredisce la Legge ma anzi la invoca, che non si crogiola nel nichilismo ma chiede al
mondo adulto la restituzione di un senso alla vita, allontana dall’immaginario la figura di Edipo, del
21
figlio inconsapevole e colpevole. Su quel mito sofocleo, Freud ha costruito l’impianto della
psicoanalisi per dire l’interdizione paterna al desiderio della "Cosa" materna. Ma se i padri non
proibiscono l’incesto e anzi lo promuovono, annullando la differenza tra le generazioni, anche
Edipo “evapora”, diventa una figura incapace di descrivere l'impoverimento dei legami familiari e
sociali. Non basta più la sua colpa cieca per decifrare l'enigma delle identità giovanili, tanto meno
l’egocentrismo di Narciso, con quel suo specchio che si rivela suicidario. Serve uno sguardo
diverso sulla crisi profonda che attraversa l’Occidente e il rapporto tra le generazioni. Ci vogliono
occhi ben aperti, come quelli di Telemaco, il figlio di Ulisse e Penelope, di un uomo capace di
coltivare una dimensione etica della vita e di una donna che — a dispetto del corpo intaccato dagli
anni — può contare su una figura maschile non titanica, ma profondamente umanizzata. «Telemaco
si emancipa dalla violenza parricida di Edipo; egli cerca il padre non come un rivale con il quale
battersi, ma come un augurio, una speranza, come la possibilità di riportare la Legge sulla propria
terra», cosi scriveva Recalcati in un articolo di un paio di anni fa, uscito su queste pagine con il
titolo In nome del figlio.» (Sica Luciana, La scomparsa di Edipo. Se negli anni della crisi i figli
smettono di combattere il padre, la Repubblica 20.03.2013, p. 49 con riferimento all’opera di
Recalcati Massimo 2013 Il complesso di Telemaco. Genitori e figli dopo il tramonto del padre,
Feltrinelli, Milano)
2.3.3.3.1. Alla radice si colloca la funzione formante del padre come colui che «porta la parola».
La tesi è illustrata da Massimo Recalcati in presentazione dell’opera e del pensiero di Jaques Lacan:
«Il padre che porta la parola. Più precisamente, il compito del padre come colui che porta la parola è
innanzitutto quello di mantenere la vita associata al senso non perché la vita in se stessa abbia un
senso — alla radice della vita, ci dice Lacan, non troviamo altro che la sua congiuntura con la morte
—, ma perché la vita, prima ancora di essere riconosciuta dall’Altro, esige di essere riconosciuta,
cioè insiste a entrare nell'ordine del senso come ordine umano. Un padre è colui la cui risposta alla
domanda di riconoscimento del figlio sancisce innanzitutto il riconoscimento del carattere umano di
questa domanda e del suo diritto assoluto; è colui che riconosce alla vita il diritto di appartenere
all’ordine del senso, sebbene questo diritto non possa mai rendere la vita giustificata
ontologicamente nel suo essere, ovvero cancellare l’assenza di senso della sua origine, la sua
“congiuntura con la morte”.» (Recalcati Massimo 2012 Jacques Lacan. Volume I Desiderio,
godimento e soggettivazione, Raffello Cortina editore, Milano, 149, 150-151)
2.3.3.3.2. Ancora alla radice si colloca la funzione formante del padre come colui che porta (con
ricorrente ambivalenza) «la domanda di senso e il limite del senso».
«La risposta del padre non può salvare la vita dall’ustione del non-senso, non può proteggerla
dall’incontro con la scabrosità insensata e “senza legge ” del reale — non può rispondere a quella
“passione della giustificazione" che, secondo Lacan, accomuna tutte le nevrosi —, insomma non
può conferire all’esistenza alcun diritto di esistere. La funzione paterna si costituisce così come un
atto che mentre introduce la vita umana nella dialettica simbolica del riconoscimento e del senso
deve saper mostrare, nel medesimo tempo, tutti i limiti di quella dialettica, poiché l’azione del
grande Altro come risposta della parola alla domanda di senso di cui si nutre la vita umana non
salva questa vita dall’aleatorietà della contingenza, non la può sottrarre dall’incontro col reale come
limite del senso, come impossibile da simbolizzare.» (Recalcati Massimo 2012 Jacques Lacan.
Volume I Desiderio, godimento e soggettivazione, Raffello Cortina editore, Milano, 151-152)
Insomma: assumersi la responsabilità di stare in una domanda e in una risposta che sostengono la
ricerca e la costruzione del senso; (ricorda Heidegger: il domandare è la pietas del pensare).
3. Le trasformazioni in atto del volto della democrazia e la dimensione pubblica
Si prendono in considerazione due processi su cui converge con notevole frequenza l’attenzione
degli autori contemporanei che si dedicano alla definizione critica e propositiva di modelli politici:
il mutamento delle forme di partecipazione e azione politica da parte del sociale, il declino della
dimensione pubblica nelle relazioni sociali.
22
[1] Sul primo tema insistono, tra i tanti, gli studi (più volte richiamati) di Beck Ulrich 1986 La
società del rischio. Verso una seconda modernità, Carocci, Roma 2000, Beck Urlich 2002 Potere e
contropotere nell’età globale, Laterza Roma-Bari 2010; di Castells Manuel 2012 Reti di
indignazione e speranza. Movimenti sociali nell’era di Internet, EGEA, Università Bocconi editore,
Milano; Stiglitz E. Joseph 2012 Il prezzo della diseguaglianza. Come la società divisa di oggi
minaccia il nostro futuro, Einaudi, Torino 2013; di Sloterdijk Peter 2010 La mano che prende e la
mano che dà, Raffello Cortina editore, Milano 2012. Si prendono qui in considerazione in
particolare, come di fronte ad un recente bilancio critico, le tesi espresse da Revelli Marco 2013
Finale di partito, Einaudi, Torino e, come lascito e monito, le analisi e le ipotesi di Weil Simone
(1943) Senza Partito. Obbligo e diritto. Per una nuova pratica politica, Feltrinelli, Milano 2013,
con premessa di Marco Revelli.
[2] Sul secondo tema intervengono, in particolare, due ampi studi: l’opera di Habermas Jürgen
1962, 1990 Storia e critica dell’opinione pubblica, Laterza, Roma-Bari 2011 e l’opera di Sennett
Richard 1974, 1976 Il declino dell’uomo pubblico, Bruno Mondadori, Milano 2006. Divergono le
impostazioni dei due studi (Habermas si muove sul postulato di metodo secondo cui “la teoria
dell’agire comunicativo è intesa a mettere in luce un potenziale razionale insito nella prassi
comunicativa quotidiana”; Sennett ricostruisce le fasi e le dinamiche storiche che portano al
declino della dimensione pubblica), comune è la tesi della crisi della dimensione sociale civile e,
antropologicamente, del “declino dell’uomo pubblico”.
Come sempre, un’analisi critica sorretta da passione politica si traduce in indicazioni e proposte per
un recupero e una ricostruzione del vivere civile.
3.1. il mutamento delle forme di partecipazione e azione politica da parte del sociale; la crisi
del partito e le alternative in ipotesi.
Introduttivamente sono programmatiche le affermazioni di Urlich Beck: «Democratizzazione come
spodestamento della politica» (Beck 1986, 265) «…la modernizzazione politica toglie alla politica
il suo potere e i suoi confini e politicizza la società. Più precisamente, la modernizzazione politica
offre ai centri e ai campi d’azione della sub-politica che essa rende possibile e fa gradualmente
emergere l’opportunità di un controllo extraparlamentare affiancato o contrapposto alle altre istanze
di controllo. In questo modo si differenziano ambiti e mezzi più o meno chiaramente definiti della
politica cooperativa e alternativa parzialmente autonoma, basati su diritti conquistati e tutelati. […]
In altri termini: accanto al modello della democrazia specializzata acquistano realtà forme di una
nuova cultura politica, nelle quali centri eterogenei della sub-politica, in virtù di un esercizio
effettivo dei diritti costituzionali, influenzano il processo di formazione e di applicazione delle
decisioni politiche.» (Beck 1986, 269,270)
«Quando non ci si attende più che i contorni di una società alternativa emergano dai dibattiti
parlamentari o dalle decisioni dell’esecutivo, ma dalle applicazioni della microelettronica, dalla
tecnologia dei reattori nucleari e dalla genetica umana, cominciano a crollare le costruzioni che
hanno finora neutralizzato politicamente il processo di innovazione. Nello stesso tempo, l’agire
tecnico-economico nella sua costituzione continua ad essere protetto contro le esigenze
parlamentari di legittimazione. Perciò lo sviluppo tecnico-economico si situa tra le categorie della
politica e quella della non-politica. Esso diventa una terza entità, acquistando lo status precario e
ibrido di una sub-politica, nella quale l’ampiezza dei cambiamenti sociali provocati sta in rapporto
inversamente proporzionale alla loro legittimazione. […] … il sistema politico rischia di essere
esautorato mentre resta viva la sua costituzione democratica.» (Beck 1986, 259)
A quelle tesi sulle «… forme di azione politica non convenzionale» fa esplicito riferimento Marco
Revelli: «Con quella, cioè, che Ulrich Beck ha chiamato subpolitics (sub-politica) o «politica della
seconda modernità», intendendo con questo termine «quella politica che si colloca all’esterno e al di
là delle istituzioni rappresentative del sistema politico degli Stati» [Beck Urlich 1986 La società del
rischio. Verso una seconda modernità, Carocci, Roma 2000, p. 52]. E che con quel prefisso «sub»
— letteralmente riferito a un «abbassamento» del piano d’azione, e a un avvicinamento di esso al
23
terreno concreto delle relazioni vissute — allude, appunto, a una «configurazione della società dal
basso» [ivi, 53] e a «una auto-organizzazione della politica che tende a mobilitare [orizzontalmente]
tutti i settori della società» [idem].
Le caratteristiche tipiche di questo stile di comportamento collettivo sono contrassegnate — al
contrario di quanto accadeva con la composizione antropologica e sociale novecentesca — dalla
disseminazione, dalla riflessività (da una forte esigenza di autonomia) e dall’orizzontalità, con una
mobilitazione orientata — è ancora Inglehart [Inglehart R. 1990 Valori e cultura politica nella
società industriale avanzata, Liviana, Torino 1993] a ricordarcelo — «su specifici problemi», che
richiedono «una competenza relativamente alta» e si affermano con un’azione puntiforme,
strutturata su «gruppi ad hoc più che su stabili organizzazioni burocratiche» come appunto i
sindacati o i tradizionali apparati dei partiti.» (Revelli Marco 2013 Finale di partito, Einaudi,
Torino, 60).
3.1.1. Il disagio: «E ci troviamo oggi a viaggiare con mappe scadute e con coordinate mutevoli, in
uno scenario liquido, in cui i grandi contenitori di ieri — i partiti politici, le loro strutture
organizzative e le loro rappresentanze istituzionali, quelli che costituivano i punti di riferimento
fissi — sono divenuti d’un colpo elastici e permeabili. Tendono a rilasciare nell’ambiente il loro
contenuto fluido, attraversati da una patologica — e sempre incombente — «crisi di fiducia» (il
vero mal du siècle). Da un ritrarsi delle fedeltà e da un senso insidioso di diffidenza.
Condannati a costituire il fondamento pressoché unico della legittimazione politica, i partiti politici
non riescono più a trattenere stabilmente i propri «mandanti» — a garantirsene la delega, a
strutturarne con continuità l’appartenenza — trasferendo in misura preoccupante la propria crisi alle
stesse istituzioni che dovrebbero, appunto, legittimare. Finendo per smarrire — e tradire — il
proprio mandato.» (Revelli Marco 2013 Finale di partito, IX)
3.1.2. I motivi del disagio vengono da lontano: le ricorrenti e diffuse strategie “democratiche” per
una disattivazione dei cittadini nella politica (nella democrazia) o per un coinvolgimento che ha
l’intento e produce l’effetto di una disattivazione, annullamento di proposizioni, e di una
disponibilità totale del cittadino al disegno politico esistente, in cerca di una formale conferma
democratico-elettorale; 2. la residuale e sorprendente (non prevista ma mai del tutto sopita) ma poco
ascoltata capacità politica reattiva del sociale di fronte ai tentativi della sua disattivazione; il ruolo
dell’indignazione e del “movimentismo”; e si tratta di un’“ultima uscita”; così la definisce nel titolo
il capitolo/saggio di Sloterdijk Peter 2010 La mano che prende e la mano che dà, Raffello Cortina
editore, Milano 2012, dal potenziale imprevedibile.
«A noi, dunque, abitanti della seconda res publica amissa (della collettività sacrificata), ancora una
volta non resterebbe altro da fare che attendere i Cesari e le loro edizioni economiche, i populisti, in
quanto oggi il populismo fornisce la dimostrazione che il cesarismo funziona anche con le
comparse. […] Chi considera il panorama dei disordini politici in Europa, soprattutto nei focolai di
crisi in terra tedesca, dovrà presto tenere presente una cosa: se oggi non si riesce a disattivare del
tutto i cittadini, malgrado le numerose offerte di espertocrazia e di cultura del divertimento, è
perché non si è tenuto conto del loro orgoglio. Tutto a un tratto torna sul palcoscenico il citoyen
timotico, donna e uomo, il cittadino autocosciente, informato, disposto a condividere idee e
decisioni. Questo cittadino denuncia al tribunale della pubblica opinione la rappresentazione
malriuscita delle sue richieste e delle sue conoscenze nell’attuale sistema politico. Il cittadino è
tornato ed è ancora in grado di indignarsi perché, nonostante tutti i tentativi di appiattirlo a fascio
libidico, ha conservato il proprio senso di autoaffermazione e manifesta tale qualità portando la
propria dissidenza nei luoghi pubblici. […] Disattivare i cittadini mediante la rassegnazione è come
giocare col fuoco, perché può convertirsi in ogni momento nel suo contrario, ossia in aperta
indignazione o manifesta ira civile. Se solo l’ira finisse per trovare il tema contro il quale dirigersi,
non sarebbe più cosa facile deviarla.» (Sloterdijk 2010 La mano che prende e la mano che dà, 111122 passim)
3.1.3. Gli ambiti di una autonomia decisionale individuale e sociale. Con riferimento alla realtà
italiana e al referendum sull’acqua e sul nucleare e al netto sì per la abrogazione del nucleare e,
24
soprattutto, della privatizzazione dell’acqua, Revelli osserva. «Si tratta — inutile negarlo — di una
svolta epocale, perché segna con chiarezza la fine del monopolio del controllo della classe politica
sulla «sfera pubblica». O, se si preferisce, la separazione tra sfera pubblica e sfera politica — fino
a ieri strettamente identificate — stabilendo che la prima è in qualche misura più ampia della
seconda. Che non può essere occupata monopolisticamente dal ceto politico, ma che conserva
ambiti e spazi in cui l’ultima parola spetta direttamente al cittadino perché lì sono in gioco risorse,
strutture, entità — «beni comuni», insomma, intendendo con questo termine «ciò che appartiene
all’orizzonte dell’esistere insieme» […] E dalla sempre più esplicita separazione (e distanza) tra i
luoghi e le figure delle «rappresentanze istituzionali» e i luoghi e le istanze «della vita» (in molti
casi della «vita nuda» nel suo rapporto con l’ambiente, il territorio, i bisogni primari, le condizioni
essenziali dell’esistenza). Separazione di linguaggi, di atteggiamenti, di sensibilità, di priorità, ma
anche di stile di vita, di accesso a privilegi, di reddito, testimoniata da un’infinità d’indizi e
registrata anche in un buon numero di sondaggi.» (Revelli Marco 2013 Finale di partito, 21, 24)
Dunque si tratta, in questi casi, di ambiti non decidibili da alcun potere “rappresentativo” ma di
diretta competenza dei soggetti o del soggetto sociale se e quando quei settori vengono messi a
rischio di esistenza, di disponibilità, di diritti e di libertà: 1. L’ambito dei “beni comuni”, 2.
L’ambito della “nuda vita”.
3.1.4. Il contesto storico economico e produttivo più ampio e determinante per comprendere la
trasformazione in atto nelle forme della rappresentanza e della partecipazione politica.
Fase 1. «… nella affollata recherche sull’ascesa e caduta dei grandi contenitori politici
novecenteschi, a molti — potremmo dire a quasi tutti — è sfuggito il banale fatto che essi dovettero
la propria fortuna, nel corso del «secolo breve», alla pressoché perfetta identificazione con il
modello organizzativo vincente nel lungo ciclo aperto dalla seconda rivoluzione industriale. […]
Uno dei pochi ad aver colto la pressoché assoluta consonanza tra le forme organizzative della
produzione di massa standardizzata e dell’amministrazione burocratica, da una parte, e il modello
organizzativo delle grandi «macchine politiche» (il partito di massa o di «integrazione di massa»
novecentesco) dall’altra, è stato proprio Inglehart.» (Revelli Marco 2013 Finale di partito, 65,66)
Nella stessa direzione Antonio Gramsci (paragrafo 70 del quattordicesimo Quaderno dal carcere,
scritto tra 1932 e il 1935, dedicato alla struttura del partito politico «formato»; e con lui, ma del
tutto separatamente: Lev Trockij, in uno dei pochissimi suoi testi di critica a Lenin, analizzando il
modello di partito proposto da questi nel Che fare? (e plasmato sulla teoria di Karl Kautsky) traccia
un «perfetto parallelismo tra struttura di Fabbrica e struttura di Partito» (ivi 71). Il rapporto
strutturale tra relazioni produttive economiche e fisionomia delle rappresentanze politiche, il
«parallelismo tra struttura di Fabbrica e struttura di Partito», è indicato sempre da Inglehart:
«Nell’accomunare — nelle prime pagine de La società postmoderna — «la produzione di massa
della catena di montaggio e la produzione di massa della burocrazia», e nel considerarli entrambi
«strumenti organizzativi chiave della società industriale», sottolineava come essi avessero svolto
«un ruolo enorme, rendendo le fabbriche capaci di produrre milioni di unità e i governi di trattare
milioni di individui mediante routine standardizzate».» (Revelli Marco 2013 Finale di partito, 67)
«Il fatto è che quella perfetta sovrapposizione di piani tra «governo della fabbrica», «governo
dell’economia» e «governo delle masse», unificati, anzi identificati dalla medesima forma —
dall’identica «formula organizzativa» — era parte integrante ex origine della concezione
novecentesca della rivoluzione. O, più generalmente, dell’allora condivisa visione del processo di
trasformazione della società, inteso come mastodontica costruzione artificiale di un nuovo ordine
sociale, progettato secondo razionalità e mediante la stessa razionalità prodotto. […] la sociologia
dell’organizzazione ha chiamato questo paradigma «razionale» e vi ha aggiunto la qualifica di
«sistema chiuso»: perché dalla possibilità di «chiusura» del suo nucleo funzionale […] dipende la
sua efficienza. E la sua stessa sopravvivenza come strumento adeguato al perseguimento dello
scopo voluto. […] Le macchine organizzative novecentesche hanno tutte le stesse caratteristiche
(siano esse Fabbriche o Eserciti, Partiti o Chiese. . .): una tendenza intrinseca al gigantismo (a
incorporare masse ampie di uomini in modo stabile, sistemandoli in strutture solide e permanenti).
25
Una vocazione onnivora e centripeta, tesa ad attirare entro il proprio campo organizzativo quante
più funzioni possibile, per sottometterle alla «mano visibile» dei propri livelli gerarchici e
garantirsene l’assoluta prevedibilità di comportamento (a praticare la logica del make in
contrapposizione a quella del buy direbbero gli esperti di management). Dunque un primato
dell’«integrazione verticale», come si dice in gergo — rigida, «proprietaria» —, rispetto alle
connessioni «in rete», flessibili e mobili. Un altissimo livello di formalizzazione di tutti i ruoli e
delle funzioni, con scarsi margini di autonomia individuale, primato dei protocolli e delle
procedure, affidamento privilegiato alle routine. Ora, questo «paradigma» ha funzionato benissimo
per oltre un cinquantennio. Poi, di colpo, è imploso. Difficile dire quando con precisione, e perché.»
(Revelli Marco 2013 Finale di partito, 71-72, 74-75).
Fase 2. «… emergere di un nuovo «paradigma socio-produttivo» […] segnato non più dai grandi
processi di centralizzazione e di razionalizzazione ma dal decentramento e dalla delocalizzazione.
Dalle esternalizzazioni e dalle reti lunghe di fornitura e subfornitura.» (Revelli Marco 2013 Finale
di partito, 65-66) «Un primo segnale fu dato dai mercati (da quelli dei prodotti tipici dell’epoca
fordista, il mercato dell’auto, dei generi di consumo durevole) che si fecero a un tratto saturi, a
crescita lenta, o vicina allo zero, e insegnarono che il vecchio trucco di Detroit — abbassare il
prezzo delle proprie merci semplicemente accrescendone il volume e distribuendo i costi fissi su un
numero maggiore di unità — non andava più. Che bisognava inventare qualcosa di diverso per
competere in un mercato fattosi difficilissimo. Ma nello stesso periodo segnali di allarme venivano
anche sul versante delle amministrazioni pubbliche, con i bilanci sempre più in rosso nonostante le
alte tasse, e l’inefficienza oltre i limiti di guardia. Né si salvavano i partiti di massa, colpiti, come si
è visto, da una crisi di confidence senza precedenti. Si trattava, com’è evidente, di una crisi
«sistemica» (non certo di un cedimento settoriale): di quelle che richiedono un cambio di direzione.
O, appunto, un «salto di paradigma». Che infatti ci fu.» (Revelli Marco 2013 Finale di partito,76)
3.1.5. Le nuove attuali forme, restando nel parallelo fabbrica-partito.
3.1.5.1. Fabbrica: « Il primo pilastro a cedere fu il «gigantismo». … la crescita lineare degli apparati
non era più prolungabile… Esternalizzare, dunque, tutto l’esternalizzabile. Delocalizzare. E poi
smantellare tutti quegli apparati d’impresa che non intervenivano direttamente sul prodotto… fu
inventato il just in time… Quella «catalitica» è l’organizzazione «minima», per così dire. Che si
limita a decidere ma non a eseguire («che tiene il timone ma non rema»). In cui i funzionari —
come dice il termine chimico stesso — si limitano a far combinare tra loro (a «catalizzare»,
appunto) i fattori necessari alla soddisfazione dei bisogni pubblici, traendoli dall’«ambiente»,
indirizzandoli e mobilitandoli, ma non «incorporandoli». È anche un’«organizzazione comunitaria»,
che coinvolge nella propria azione i destinatari dei suoi servizi — gli utenti, i cittadini — anziché
confinarli in un ruolo passivo. Dunque che rinuncia a separare rigidamente gli «addetti ai lavori»
dagli «estranei». A isolare e sigillare il campo organizzativo rispetto all’ambiente, anzi, che convive
e si integra con il proprio ambiente, mescola interno ed esterno, produce sinergie e cooperazione. …
«arreso al disordine», perché consapevole dell’impossibilità di segregarlo al di fuori dei propri
«confini organizzativi» troppa complessità, troppe variabili da controllare, troppa soggettività da
sterilizzare, troppe individualità irriducibili a norma. E quindi rassegnato a convivere con esso: ad
attrezzarsi per gestire le inevitabili «contingenze esterne», per far fronte agli imprevisti non
riconducibili a protocolli o routine, per «navigare a vista», insomma, intercettando flussi anziché
strutturando spazi stabili e definiti, ricombinando set di risorse mutabili, cogliendo occasioni
istantanee. Non più la metafora del diamante, con le sue geometrie perfette e irrigidite in una
razionalità pietrificata — com’era stato per l’ideale organizzativo fordista —, ma quella del fumo,
con le sue spire mobili, il suo proteimorfismo, la magmaticità e la flessibilità di ciò che fluttua
nell’aria… «Paradigma naturale», verrà chiamato. A «sistema aperto», più simile all’organismo
che sa adattarsi al proprio ambiente istante per istante, e che mantiene aperti tutti i varchi, e porosi
tutti i confini tra ciò che è dentro e ciò che è fuori: esattamente l’opposto del precedente
«meccanismo», che non casualmente aveva incarnato la visione del mondo nel secolo della
meccanizzazione e della massificazione.» (Revelli Marco 2013 Finale di partito, 76-80 passim)
26
3.1.5.2. Partito. «Naturalmente tutto ciò non poteva non coinvolgere la «forma partito». Che ne fu,
infatti, frontalmente sfidata. … i tradizionali partiti di massa — anzi, di «integrazione di massa» —
europei, in particolare quelli provenienti dalla tradizione socialista e comunista, ne furono colpiti in
pieno. Erano un tipo di organizzazione per definizione «pesante», concepita e costruita non solo per
gestire i processi istituzionali della rappresentanza (per concorrere alle elezioni), ma anche — e
spesso soprattutto — per incorporare nelle proprie strutture (per «integrare», appunto) interi pezzi di
società, aree ampie del proprio elettorato, per orientarne e formarne valori e cultura, strutturarne
aspetti significativi della vita (il tempo libero, le letture, i gusti…), assicurandosene nel contempo la
prevedibilità dei comportamenti politici ed elettorali. … Esattamente come le grandi corporation
alle prese con mercati fattisi d’improvviso imprevedibili, anche i partiti di massa dovettero imparare
a «navigare a vista». A intercettare flussi di voti mutevoli. A interpretare aspettative e domande
inedite e imprevedibili, galleggiando, per così dire, su una massa «liquida», dai comportamenti
sempre meno «standardizzati», o riconducibili ai grandi aggregati sociali (operai, ceti rurali, classi
medie, ecc.), e sempre più individualizzati e personalizzati. Non più un «corpo elettorale» —
secondo la vecchia dizione — ma piuttosto un «mercato politico» (è da pochi decenni che questo
termine, in sé orribile, si è affermato anche tra i cultori della materia), con tutte le regole, tutti i
rischi e tutta l’imprevedibilità del mercato. Alcuni non ce l’hanno fatta, e sono implosi
scomparendo o quasi (è il caso dei partiti comunisti…) … Altri… il cosiddetto «partito pigliatutto»,
… Qualcuno … «si costruiscono volta a volta un’opportuna piattaforma elettorale popolare per
guadagnarsi elettori»… Qualche altro … riorganizzando le appartenenze su basi etnico-regionali…
Tutti, comunque, posti di fronte a un comune rischio di obsolescenza e di fragilità.» (Revelli Marco
2013 Finale di partito, 80-83 passim)
In ulteriore ipotesi, sempre in parallelo: «Una delle ragioni principali — forse la principale —
all’origine dell’implosione del modello fordista era stata la crescente insostenibilità dei cosiddetti
«costi organizzativi». … Ora, qualcosa di simile è accaduto anche ai partiti di massa, nel momento
in cui la sempre meno sicura fedeltà dei seguaci, la crescente fluidità ed evanescenza delle rispettive
«basi», ha reso incerto e sempre più esiguo il flusso di contributi e di risorse economiche (oltre che
di prestazione gratuita di attività volontarie) fino ad allora fornite dal corpo militante.» (Revelli
Marco 2013 Finale di partito, 84-85) Su questo versante: « L’anomalia italiana. È però l’Italia la
maglia nera in questa corsa alla rovescia alla dilatazione dei costi, attestata su un livello di spesa per
i partiti e per le loro attività paragonabile a quello americano. Con una differenza sostanziale,
tuttavia. E cioè che mentre negli Stati Uniti il crescente volume di «investimento» è concentrato in
massima parte sui «costi di transazione» — si spende molto in occasione delle tornate elettorali,
per «acquistare» sul mercato visibilità e immagine, mentre i «costi organizzativi» dei partiti sono
minimi —, in Italia «costi di transazione» e «costi organizzativi» sono cresciuti insieme,
parallelamente e di conserva, facendo letteralmente esplodere i bilanci delle diverse «imprese
politiche». Nessuno in realtà sa con precisione a quanto ammonti la «spesa politica» italiana, a
causa del peso consistente del «sommerso». Ma certamente essa si muove su dimensioni di molte
lunghezze superiori alla media europea… » (Revelli Marco 2013 Finale di partito, 90-91)
3.1.5.3. Più radicalmente, Simone Weil, già nel 1943, sull’onda della considerazione di come i
partiti del primo Novecento siano precipitati (per repressione, per debolezza, per esplicita
volontà…) nei totalitarismi che hanno distrutto nella guerra totale e totalitaria ogni forma di
democrazia politica, sostiene la tesi di una inesorabile e intrinseca tendenza degenerativa dei partiti
politici verso la demagogia e verso il totalitarismo. Il potere diventa in loro e attraverso di loro,
negazione progressiva delle libertà individuali e dell’umanità sociale.
«Su un versante, infatti, la struttura collettiva, il “partito”, appunto, occupa tutto lo spazio sociale
disponibile, si afferma come unico, esclusivo strumento per incidere sul reale, per "agire
pubblicamente", appunto, senza il quale — e al di fuori del quale — si è costretti all’impotenza, non
si può perseguire nessun obiettivo, né concepire alcun risultato raggiungibile. E per questo da
mezzo (da "strumento", appunto, costruito per perseguire un risultato) diventa esso stesso fine (fine
a se stesso"), condizione per il perseguimento di tutti i risultati e dunque preoccupazione principale
27
di ogni aderente, oggetto di cura e di attenzione esclusiva, la cui forza e dimensione viene prima di
tutto perché da queste tutto dipende.
Lo dice benissimo l’autrice: «Il fine primo, e in ultima analisi, l’unico fine di qualunque partito
politico è la sua propria crescita senza alcun limite». E aggiunge — con un repentino passaggio
dalla sociologia alla teologia —, che ci si trova nel campo di una forma di «idolatria, dato che
solamente Dio è legittimamente un fine in se stesso». Accade così al partito politico quello che
quotidianamente si osserva per l’intero sistema dei mezzi — il potere, il denaro, la tecnica —
trasformatisi, rapidamente, in fini dentro una logica di potenza che vede nella crescita quantitativa
la condizione del risultato e che sostituisce al valore del "bene" quello del "tanto". Così per la "tesi
maggiore". Sull’altro versante del sillogismo (quello della "tesi minore") accade che l’esistenza
stessa dell’organismo pubblico, la sua natura di “macchina” per produrre energie collettive
("passioni" dice Weil, per indicare il carburante principale con cui si produce mobilitazione e
dunque forza pubblicamente esercitabile), finisca per imporre la propria azione "disciplinante".
Cioè uniformante, imitatrice dell’autonomia intellettuale. Omologatrice, diremmo noi oggi. Accade
che la logica "di partito” richieda, necessariamente, il sacrificio di quell’essenziale funzione —
inevitabilmente individuale, di per sé sottratta a ogni disciplinamento esteriore — che è il pensiero.
La ricerca della verità. L’interrogazione sul "bene", che per sua natura è "universale", non può
essere spartito o immaginato per separazione e contrapposizione. Se vuole esistere come entità
collettiva, dunque, il partito non può, come scrive Simone Weil, non «esercitare una pressione
collettiva sul pensiero di ognuno degli esseri umani che ne fanno parte». Non può porre se stesso
come "oggetto di fede". In cui identificarsi, in una sorta di rito feticistico con cui al valore astratto
(ma generale, valido per l’intero genere umano) del bene si sostituisce l’immagine concreta (ma di
per sé vuota, e per sua natura "parziale") dello strumento che a quel bene dovrebbe servire.
L’involucro, chiamato a rappresentare (ma in realtà a sostituire) il contenuto.
Per questo — per effetto di questo gioco perverso dei due pezzi del sillogismo — il moderno partito
è contemporaneamente particolare e totalitario: obbliga a pensare per contrapposizione e pretende
il controllo assoluto sul pensiero dei propri aderenti. Opera per scissione verso l’esterno ed esercita
una pressione uniformante verso l’interno. Chiede, in nome della "disciplina" — che è la condizione
di esistenza del mezzo diventato fine — la rinuncia alla ricerca individuale. Pretende una delega
totale a un sé vuoto (perché preoccupato solo del proprio continuare a esistere e non del fine che
sarebbe chiamato a perseguire). Esso ricalca, alla luce della sociologia politica, un percorso non
dissimile da quello compiuto dalla Chiesa…» (Weil Simone (1943) Senza Partito. Obbligo e diritto.
Per una nuova pratica politica, Feltrinelli, Milano 2013, Premessa di Marco Revelli, 11-13).
(Simone Weil coglie la relazione tra un’alta diffusione di una religiosità, vissuta come appartenenza
fedele e ubbidiente ad una chiesa, e la degenerazione delle forme di rappresentanza politica in
strutture di controllo demagogico del sociale.)
Nelle parole e nello stile diretto di Simone Weil: «Ovunque, senza eccezione, tutte le cose
generalmente considerate come fini sono per natura, per definizione, per essenza e nel modo più
evidente unicamente dei mezzi. Si potrebbero citare tanti esempi quanti si vuole in tutti i campi.
Stato, potere, denaro, grandezza nazionale, produzione economica, diplomi universitari e via
discorrendo.
Solo il bene è un fine. Tutto ciò che appartiene al regno dei fatti rientra nell’ordine dei mezzi. Ma il
pensiero collettivo è incapace di elevarsi al di sopra del regno dei fatti. È un pensiero animale, non
ha nozione del bene se non in misura appena sufficiente per commettere l’errore di scambiare
questo o quel mezzo per un bene assoluto. La stessa cosa avviene per i partiti. ln linea di principio il
partito è uno strumento al servizio di una particolare concezione del bene pubblico. Questo è vero
anche per quelli che sono legati agli interessi di una categoria sociale, poiché si tratta sempre di una
certa concezione del bene pubblico in virtù della quale vi sarebbe coincidenza tra il bene di tutti e
quegli interessi. Ma questa concezione è estremamente vaga. Tutto ciò è vero senza eccezione e
quasi senza differenza di grado.» (Weil Simone (1943) Senza Partito. Obbligo e diritto. Per una
nuova pratica politica, Feltrinelli, Milano 2013, 24)
28
3.1.6. «Una democrazia «oltre» i partiti? … Ilvo Diamanti C’è democrazia senza i partiti?» «Poi,
nel passaggio dalla riflessione colta alle retoriche politiche prevalenti, quelle che erano domande e
individuazioni di rischi sono diventate perentorie certezze. La formula ha perso il punto
interrogativo per assumere l’esclamativo: «Non può esserci democrazia senza partiti!».» (Revelli
Marco 2013 Finale di partito, 101,102)
«In realtà non è così. Il nesso tra la democrazia e la «forma-partito» così come essa si è strutturata
nell’ultimo sessantennio non è affatto così esclusivo e indissolubile. La democrazia dei moderni si è
definita concettualmente e praticamente ben prima che comparisse all’orizzonte il «partito di
massa» e che esso divenisse il monopolista quasi esclusivo del processo di partecipazione e di
rappresentanza. Può sopravvivere alla fine di quel monopolio e di quella centralità, rinnovandosi nei
contenuti e nelle procedure. Né l’attuale crisi dei partiti nella loro espressione storica ci pone di
fronte alle alternative «terminali» e «assolute» che la retorica della «fine della democrazia»
sembrerebbe richiamare: il «partito politico» non scompare istantaneamente in ogni forma e in ogni
luogo. S’indebolisce, certo. Si modifica: può subire una metamorfosi selettiva, più profonda in
alcune realtà geopolitiche e sociali, meno in altre. Per molti aspetti l’ha già subita. È mutato nel
profondo, nei suoi stessi codici genetici.» (Revelli Marco 2013 Finale di partito, p.103)
3.1.6.1. Le trasformazioni: alcune, poste in particolare evidenza (come direzioni del rischio).
3.1.6.1.1. Dalla «democrazia dei partiti» alla «democrazia del pubblico» (Manin Bernard 1997
Principi del governo rappresentativo, il Mulino, Bologna 2010, in particolare dalle pp. 229-259;
nella sequenza storica: democrazia parlamentare, democrazia dei partiti, democrazia del pubblico).
«Nella «democrazia del pubblico», infatti, non si vota più in primo luogo il partito e il suo
programma — come avveniva, appunto, nella «democrazia di partito» ma si torna a votare
soprattutto la persona, come nel «parlamentarismo» delle origini. Con una differenza, tuttavia,
sostanziale: … qui è il prodotto di un processo artificiale di costruzione dell’immagine nella quale il
mezzo televisivo in particolare gioca un ruolo predominante. È una «personalità» fabbricata
secondo una procedura tecnica di elaborazione mediatica.» (Revelli Marco 2013 Finale di partito,
p. 108)
3.1.6.1.2. « La «democrazia istantanea». (Revelli Marco 2013 Finale di partito, p.114) L’irrompere
di proclami sulla democrazia diretta attraverso le comunicazioni in digitale (la rete, il web…) con
la tanto proclamata e dubbia ostensione di democrazia; in realtà:
1) «Al di fuori delle retoriche pan-tecnologiche, infatti, è evidente che il meccanismo della
decisione telematica tende a cancellare la fase necessariamente lenta, problematica, riflessiva, della
discussione per selezionare e promuovere invece i fattori emotivi, le sensazioni immediate, le
pulsioni istintive.»; 2) « E anche questo è un paradosso del nostro tempo: che a un’estensione
dell’acculturazione e della conoscenza finisca per corrispondere un contemporaneo restringimento
del tempo della discussione e della deliberazione argomentata, compresso fino alla dimensione
puntiforme del fatidico click. Col quale, indubbiamente, può essere soddisfatta l’esigenza di
interdizione e di controllo di questa nuova folla solitaria desiderosa di rompere l’isolamento e di
irrompere «in remoto» nella sfera istituzionale riducendo le distanze tra luoghi della vita e luoghi
della decisione. Ma difficilmente può essere restaurata la virtù della proposizione deliberativa
mediante l’approfondita disamina dei problemi nell’arena reale parlamentare — come avveniva per
l’esercizio del «potere legislativo» prima che la partitizzazione della vita pubblica ne segmentasse
lo spazio e il campo — se non per settori limitati di pubblico capaci di accedere a sofisticate forme
di software…»; 3) «rimane precario il tentativo dei protagonisti emergenti della «politica digitale»
di emanciparsi dalla ferrea legge di Michels e dal destino oligarchico che incombe su di loro…»
(Revelli Marco 2013 Finale di partito, p.120,121)
3.1.6.1.3. La comparsa della contro-democrazia in termini di sospetto e di sfiducia. « Controdemocrazia. Ovvero «la démocratie de la défiance». (Pierre Rosanvallon, “uno scienziato politico”)
«…la crisi di fiducia. È il nucleo essenziale della «contro-democrazia», che non è la negazione
della democrazia — non significa «antidemocrazia» — ma una forma diversa di democrazia. E non
può essere ricondotta a semplice «antipolitica», ma costituisce una modalità diversa della politica.
29
La natura che essa assume quando il «popolo», finita l’illusione di poter esercitare il potere
direttamente o tramite i propri rappresentanti, ripiega sull'esigenza — talvolta rancorosa — di
controllarlo. […] La contro-democrazia, dunque, è in primo luogo una forma di «democrazia di
sorveglianza» […] riprendendo la celebre distinzione di Isaiah Berlin tra «libertà positiva» e
«libertà negativa» […] una «democrazia dell’interdizione» […] ma anche una «democrazia
dell’imputazione».» (Revelli Marco 2013 Finale di partito, p. 122-124) Ma si fa largo anche una
patologia della sorveglianza nelle forme di un populismo indignato ma rancoroso, semplificatore e
falsamente inteso come corpo unico e organico, che all’unisono si muove in battaglia
indistintamente contro corruzione, oligarchia, privilegio, casta, estraneo, straniero… noi contro loro
(anche a questi aspetti rimandano le osservazioni di Rosanvallon e di Revelli, come di Elias Canetti,
Ernesto Laclau, Slavoy Žižek). «Sono, queste folle solitarie post-moderne, «masse mute, disilluse,
sconcertate e disgustate, con problemi a cui i populismi non forniscono un linguaggio, ma attraverso
i quali essi sanno attizzare la collera, facendola grondare in modo sempre più sordo sul selciato
delle città e nelle cabine elettorali». In esse, nella torsione populistica che le avvinghia, si
intrecciano drammaticamente «la manifestazione parossistica dello smarrimento contemporaneo e
l’espressione tragica dell’incapacità di superarlo». [citazioni da P. Rosanvallon 2006
Controdemocrazia. La politica nell’era della sfiducia, Castelvecchi, Roma 2012] (Revelli Marco
2013 Finale di partito, p. 126-127) Si potrebbe dire, in formula, che si assiste alla continua e
rabbiosa (ri)costruzione di una contrapposizione tra un “noi” e un “loro”; “noi-loro” in cui
l’opposizione violentemente rivendicata e continuamente cangiante diventa il mezzo per esercitare
il potere, quello stesso potere che si vuole criticare, assaltare, abbattere.
3.1.6.2. L’alternativa, la direzione verso un recente e necessario incontro. Il bivio è populismo vs
cittadinanza attiva, che può essere il volto dei movimenti e della loro relazione con i partiti
rinnovati nella forma e nella funzione di catalizzatori; a impedire che, per mancato incontro tra i
due, i partiti restino macchine di potere e di governo esterno, i movimenti restino nuclei protestatari
alla base incapaci di incidere o in attesa di poter accedere al ruolo di partiti e lì morire reiterando
quell’oppressione (o distanza dal sociale, separatezza) contro la quale erano sorti.
I “nuovi” luoghi del politico: «Nella formazione, appunto, di un «pubblico» esigente e partecipante
alla sua base. Nelle reti orizzontali di mobilitazione e d’intervento, nelle molteplici forme di «presa
di parola», di tutela delle precondizioni essenziali della vita biologica e sociale (nell’affermazione e
difesa dei «beni comuni»). Nei circuiti di riaffermazione di cittadinanza attiva dal basso. Nelle
stesse forme sperimentali di «democrazia locale », in territori delimitati ma densi, perché in essi è
ben visibile l’implicazione tra azione collettiva e vita.
Come in una sorta di gigantesco gioco di vasi comunicanti la sovranità verticale che si era
concentrata in alto può rifluire in basso, nella «massa positiva» di micro-comunità interrelate che
costituiscono quella che Ulrich Beck ha denominato la «sub-politica», non per sminuirne il valore
ma per sottolinearne il carattere «basilare». Il suo muovere alla base della piramide, forte del fatto
che le società sono capaci di meglio coordinarsi orizzontalmente, di auto-organizzarsi e di ricorrere
in misura enormemente minore che nel passato a (ingombranti) «autorità tutelari». […] innescando
un’interlocuzione dinamica tra le forme di auto-organizzazione della società — alimentate dai new
media — e le forme sempre più leggere della rappresentanza. […] ai partiti «che raccolgono voti »
si relazionano — non necessariamente si contrappongono — i movimenti «che mobilitano
potenziali elettori e cercano di modificare i termini della raccolta dei voti». Con gli uni — i
movimenti — finalmente in veste di cause (anziché di partner «incompiuti», in attesa di essere
sollevati all’altezza del «primato della politica»). E gli altri — i partiti — considerati per quello che
sono (o sono diventati): macchine. Strumenti leggeri, effimeri, «testimoni secondari» rispetto ai
soggetti e ai luoghi «della vita» in cui si sperimentino e pratichino forme diverse di relazione e di
socialità. [cfr. M. Walzer, Partiti e movimenti, diversi mestieri, in «Reset», 20 luglio 2012]»
(Revelli Marco 2013 Finale di partito, p. 127-128, 136-137)
3.2. il declino della dimensione pubblica nelle relazioni sociali.
30
Due studi principali di riferimento:
Sennett Richard 1974 1976 Il declino dell’uomo pubblico, Bruno Mondadori, Milano 1982
Habermas Jürgen 1962, 1990 Storia e critica dell’opinione pubblica, Laterza, Roma-Bari 2011
In ottimismo. Come “provocazione” di apertura una società nell’orizzonte di un’etica del dono o
visione generale di un vivere civile ispirata all’etica del dono (rimanda alla posizioni di Marcel
Mauss [e alla rivista di Scienze sociali che in acronimo riprende il suo nome: la rivista del MAUSS
(Movimento Anti-Utilitarista nelle Scienze Sociali – Mouvement AntiUtilitariste dans les Sciences
Sociales)] e di Alain Caillé, in particolare l’opera: A. Caillé, Théorie anti-utilitariste de l’action, La
découverte, 2009, comparsa in Italia con il titolo Critica dell’uomo economico. Per une teoria antiutilitarista dell’azione, Il Melangolo, Genova), richiamata attraverso una riflessione dal già citato
testo di Peter Sloterdijk: «Avevo parlato dell’importanza della generosità per la democrazia con lo
scopo di indicare il cammino verso una collettività nuovamente capace di empatia. […] … garantire
l’idea del bene comune non più unicamente attraverso la redistribuzione coatta, ma basandola su
un’etica del dare dal fondamento più ampio possibile ... […] Vorrei chiarire ancora una volta la mia
tesi foriera di conflitti, secondo la quale in una società democratica le tasse andrebbero trasformate
da riscossioni forzose in donazioni a favore della collettività, versate dai cittadini in maniera
volontaria: dapprima soltanto in piccola percentuale, in seguito in proporzioni progressivamente
crescenti. Personalmente ritengo che solo una trasformazione del genere potrebbe rianimare una
società irrigiditasi in routine che riflettono riluttanza e malumore nei confronti dello Stato e
introdurre nuova linfa — sotto forma di responsabilità collettiva — nei sistemi funzionali, ormai
autoreferenziali. […]… il motivo di una psicopolitica della generosità, onnipresente nei libri da me
pubblicati nell’ultimo decennio, sia collocato fin dall’inizio nell’orizzonte di un’etica del dono. […]
La donazione a vantaggio del bene comune potrebbe dunque trasformarsi, nel tempo, in un habitus
psicopolitico consolidato, impregnando le popolazioni democratiche come una seconda natura e
operando una conversione globale delle collettività nel senso dell’empatia e della solidarietà
materializzata.» (Sloterdijk Peter 2010 La mano che prende e la mano che dà, Raffello Cortina
editore, Milano 2012, p.11-16, 51)
In pessimismo, il problema dell’assenza della dimensione pubblica nelle attuali società.
L’argomento, la tesi e la situazione presentata da Sennett Richard 1974, 1976 Il declino dell’uomo
pubblico, Bruno Mondadori, Milano 1982 sono contenuti nella frase in esergo, citazione classica
che esprime con efficacia l’idea dominante dell’analisi di Sennett. «Ognuno di questi uomini,
chiuso in se stesso, si comporta come se fosse estraneo al destino di tutti gli altri. I figli e gli amici
costituiscono per lui l’insieme del genere umano. Quanto al resto dei suoi simili, capita che si
confonda con loro, ma non li vede; li sfiora, ma non li sente. Non esiste che in se stesso e per se
stesso. E se ancora la famiglia ha un qualche significato per lui, è la società a non averne più
alcuno.» Ch.-A.C. de Tocqueville 1835 La democrazia in America.
L’introduzione di Habermas al proprio studio parte da un analogo allarme, storicamente ricollocato:
«… da circa un secolo, le sue [della «sfera pubblica»] basi sociali stanno per la verità nuovamente
disfacendosi; la tendenza alla disgregazione della dimensione pubblica è inequivocabile: mentre la
sua sfera si estende sempre più vistosamente, la sua funzione si va sempre più depotenziando.»
(Habermas 1962, 1990 Storia e critica dell’opinione pubblica, 6)
3.2.1. Una breve definizione e l’origine storica della dimensione pubblica, o della sfera pubblica
politica (che Sennett analizza in un ampio arco storico, ragionando in particolare sull’Ancien
Régime e sulla sua crisi nel corso del XIX secolo, Habermas ricostruendo le dinamiche, le forme e i
luoghi della nascita della sfera pubblica borghese fondata sulla affermazione del diritto privato e di
stampo liberale fino a coglierne il mutare della logica di fronte al sorgere del contemporaneo Stato
sociale e dei mezzi di gestione del consenso attraverso i mass-media: «concepita in un primo
momento come la sfera dei privati riuniti come pubblico; costoro rivendicano subito contro lo stesso
potere pubblico la regolamentazione della sfera pubblica da parte dell'autorità, per concordare con
questa le regole generali del commercio nella sfera privatizzata in linea di principio, ma
31
pubblicamente rilevante, dello scambio di merci e del lavoro sociale. […] La sfera pubblica
borghese si sviluppa nel campo di tensione fra Stato e società, ma in modo tale da rimanere essa
stessa parte dell’ambito privato.» Habermas 1962, 1990 Storia e critica dell’opinione pubblica, 33,
163; e gli studi si pongono in parallelo con le ricerche di Foucault. In esame e sotto prospettive
storiche diverse tre autori e tre paesi europei: Sennett , area inglese; Habermas, Germania; Foucault,
Francia).
In forma di preliminarmente occorre richiamare la doppia ipotesi di origine della “pubblicità”, come
res publica, espressa da Searle R. John, 2010 Creare il mondo sociale. La struttura della civiltà
umana, Raffaello Cortina editore, Milano 2010 (Making the Social World: The Structure of Human
Civilization): associamento o costitutività ? [esposta in apertura a conclusione 1.]
3.2.1.1. «Una res publica rappresenta in genere i legami associativi e di reciproco impegno che
esistono tra individui non uniti da vincoli di sangue o di amicizia: è il legame che unisce una folla,
un “popolo”, uno Stato.» (Sennett 1976 Il declino dell’uomo pubblico, 3-4) Il riferimento “mitico”
e originario va al mondo della Grecia antica, ricostruito dal classicismo (dall’immaginario
classicistico) come un universo che tiene congiunti ethos e polis.
«…la «sfera pubblica politica», come compendio di quelle condizioni di comunicazione nelle quali
può effettuarsi una formazione discorsiva dell'opinione e della volontà di un pubblico di cittadini
dello Stato, è appropriata come concetto fondamentale di una teoria della democrazia impostata
normativamente. In questo senso, Jean Cohen definisce il concetto di «deliberative democracy» in
questi termini: «L’idea di democrazia deliberativa è radicata nell’ideale intuitivo di un'associazione
democratica in cui la giustificazione dei termini e delle condizioni di associazione procede mediante
pubblico argomentare e ragionare tra cittadini eguali. In tale ordinamento i cittadini condividono
l'impegno per la soluzione di problemi scelti collettivamente tramite pubblico ragionamento, e
considerano legittime le loro istituzioni fondamentali nella misura in cui esse offrono un quadro per
la libera deliberazione pubblica». Questo concetto discorsivo della democrazia fa assegnamento
sulla mobilitazione politica e sullo sfruttamento della forza produttiva «comunicazione».»
(Habermas 1962, 1990 Storia e critica dell’opinione pubblica, prefazione del 1990 XXXII-XXXIII)
3.2.1.2. Il momento storico del tracollo (ancora insuperato) della dimensione pubblica, dell’uomo
pubblico: «Parlare dell’eredità ottocentesca del tracollo della vita pubblica significa parlare, da un
lato, di forze di ampia portata, quali capitalismo e secolarizzazione; dall’altro, di quattro condizioni
psicologiche: la manifestazione involontaria del carattere, la commistione tra pubblico e privato,
l’astensione come difesa e il silenzio. Le ossessioni dell'Io sono un tentativo di risolvere gli intricati
problemi del secolo scorso negandoli. Il rifugio nell’intimità è un tentativo di risolvere il problema
del pubblico negando l’esistenza del pubblico stesso. Come accade per qualunque negazione, in
questo modo gli aspetti più distruttivi del passato sono diventati quelli più difficili da scalfire. Il
XIX secolo non è ancora stato superato.» (Sennett 1976 Il declino dell’uomo pubblico, 32) L’analisi
storica diventa allora lo studio del «modo in cui il secolo scorso ha preparato il terreno per la
cancellazione della res publica.» (Sennett 1976 Il declino dell’uomo pubblico, 155)
I ruoli pubblici esibiti con evidenza corporea, di atteggiamenti, comportamenti, abbigliamento
nell’età del cosiddetto Ancien Régime, scompaiono o vengono nascosti nelle società democratiche,
sostituiti dall’affermazione del valore personale. Determinante in tal senso è l’impatto del
capitalismo industriale sulla vita pubblica: il feticismo delle merci (di cui parla Marx) è anche
perdita della dimensione pubblica in quanto anche il consumo delle merci standardizza, con il loro
uso feticistico, la personalità; la singolarità, irrompe nella scena pubblica e si impone all’attenzione
collettiva attivando processi di autopercezione emulativa per cui la funzione pubblica passa in
secondo piano o si subordina al privato; viene posta cioè in secondo piano la sfera pubblica intesa
come costruzione e definizione di sé secondo progetti e obiettivi che cooperano all’utilità e al bene
pubblico operando in ruoli sociali. A descrivere con accurata abilità percettiva e raffigurativa
l’irrompere narcisistico del privato nella dimensione pubblica sono le opere di Thomas Carlyle e
soprattutto di Honoré de Balzac, cui Sennett dedica una dettagliata analisi sociologica.
32
3.2.2. I fattori e le dinamiche del declino dell’uomo pubblico: 1. Narcisismo personalistico, 2.
comunità distruttiva, 3. la società (comunità) intimistica, 4. imbarbarimento del carisma.
3.2.2.1. narcisismo personalistico e crisi dell’uomo pubblico. «L’universalismo democratico si
tramuta in un «particolarismo generalizzato».» (Habermas 1962, 1990 Storia e critica dell’opinione
pubblica, XXXI).
Per narcisismo si intende…: «Il significato clinico del narcisismo si discosta dall’accezione
popolare di amore per la propria bellezza; in senso stretto, come disturbo caratteriale, denota un
assorbimento in se stessi che impedisce di distinguere ciò che appartiene alla sfera dell'Io e
dell’autogratificazione da ciò che è esterno. Ne consegue che il narcisismo è un’ossessione
riguardante “il significato che questa persona o quest’evento hanno per me”. Tale interrogativo
sull’importanza, per il soggetto, degli altri e degli avvenimenti esterni si ripete con tale insistenza da
pregiudicare una percezione chiara delle persone e degli eventi. Stranamente, questo assorbimento
in se stessi impedisce la soddisfazione dei propri bisogni; nel momento in cui sta per raggiungere
uno scopo o comunicare con un altro, l’individuo è portato a pensare che, questo non era quel che
voleva. Quindi, il narcisismo ha una doppia valenza: è al tempo stesso un assorbimento vorace nei
bisogni dell’Io e un ostacolo al loro soddisfacimento.» (Sennett 1976 Il declino dell’uomo
pubblico, 9)
Gli effetti e la deriva: «L'attuale disturbo narcisistico nasce dal fatto che il nuovo tipo di società
stimola la crescita delle componenti psichiche e cancella l’importanza dei contatti sociali — dei
contatti in pubblico — al di fuori dei confini del singolo Io. […]… come l’aumento dell’importanza
attribuita alle questioni psicologiche faccia diminuire il valore di un’azione sociale. […] L’attuale
commistione d’interesse pubblico e privato… ha ridestato gli elementi più corrosivi dell’etica
protestante in una cultura che non è più né religiosa né convinta che la ricchezza materiale
costituisca un capitale etico. […] La visione intimista del mondo si sviluppa nella misura in cui la
sfera pubblica è abbandonata in quanto vuota.» (Sennett 1976 Il declino dell’uomo pubblico, 9, 1314) «L’attore privato della sua arte. L'immagine del theatrum mundi mostra qual sia il potenziale
espressivo della società, mentre il declino della vita pubblica mostra il destino subito da questo
potenziale espressivo: nella società moderna, gli individui sono diventati attori senz'arte. Si può
continuare a concepire astrattamente la società e i rapporti sociali in termini teatrali, ma gli uomini
hanno smesso di recitare.» (Sennett 1976 Il declino dell’uomo pubblico, 383) «A poco a poco,
quella forza misteriosa e pericolosa che è l’Io divenne il criterio con cui definire i rapporti sociali. A
quel punto, la sfera pubblica dei valori e delle azioni impersonali cominciò a inaridirsi.
La società nella quale viviamo oggi porta il peso delle conseguenze di questo processo storico: la
convinzione che i valori sociali siano il prodotto dei sentimenti individuali ha cancellato la res
publica.» (Sennett 1976 Il declino dell’uomo pubblico, 415)
3.2.2.2. comunità distruttiva; la Gemeinschaft distruttiva o l’enorme importanza attribuita alla
comunità (Sennett richiama le tesi del sociologo Fernand Tönnies) e il formarsi di una personalità
collettiva che assorbe in sé il bene pubblico, cioè lo annulla perché lo fa coincidere con il bene
specifico della comunità di appartenenza, (o “L’imbarbarimento della comunità”)
La logica della Gemeinschaft : «La logica della personalità collettiva è l’epurazione; ogni alleanza,
ogni cooperazione, ogni “fronte unito” sono suoi nemici. ln generale, quando gli uomini oggi
cercano di avere rapporti pieni e aperti, l'unico risultato che ottengono è ferirsi a vicenda. Questa è
la logica conseguenza della Gemeinschaft distruttiva sorta con l'ingresso della personalità nella
società.» (Sennett 1976 Il declino dell’uomo pubblico, 276) Nella costruzione della comunità e dei
meccanismi di appartenenza rigorosa esclusiva ed escludente è di fondamentale rilevanza il ruolo
del leader. Nel rappresentare emozioni in pubblico (Sennett richiama la differenza e il legame tra
espressione e rappresentazione) il leader strategicamente costruisce comunità passive che portano
ad escludere e annullare la dimensione dell’uomo pubblico nel cittadino. «…la comunità si formò
gradualmente intorno a una personalità collettiva che divenne l’interesse principale dei membri
della comunità stessa. […] Quando un gruppo di persone si riunisce per fini politici, adotta alcune
posizioni comuni e poi assume un comportamento ad esse conseguente, comincia anche
33
gradualmente a credere e ad aggrapparsi alle proprie posizioni, così come a difenderle. Invece di
una mossa in un gioco per il potere, queste posizioni finiscono per diventare la reale definizione
dell'identità del gruppo.» (Sennett 1976 Il declino dell’uomo pubblico, 369, 374)
È una strategia e un processo di “decodificazione” da ruoli politici attivi. «Da questi atti di
decodificazione può nascere il senso di appartenenza a una comunità politica. Si osservano i dettagli
del comportamento delle persone che hanno un determinato credo politico per decidere quali
corrispondano meglio alla visione che si ha di sé. Questi dettagli diventano una rivelazione del vero
carattere del conflitto, simboleggiandone la sostanza. […] Una simile comunità è ostile agli
estranei, e al suo interno c’è una forte competizione su chi sia la “reale” incarnazione della
personalità collettiva, su chi sia realmente un americano “leale”, un ariano “puro” o un
rivoluzionario “genuino ”.» (Sennett 1976 Il declino dell’uomo pubblico, 295, 296) (Un noto caso
storico di Gemeinschaft distruttiva è l’affare Dreyfus, che Sennett ricostruisce e analizza [297-310];
«L’affare Dreyfus implicò la formazione di un sentimento comunitario a livello nazionale» [324] )
Gli effetti della Gemeinschaft: essa induce «… una rigidità per sentirsi integrati in un gruppo, una
sfida agli stridori della storia per il bene della comunità.» (Sennett 1976 Il declino dell’uomo
pubblico, 315) annullando la natura politica e pubblica del cittadino che si ispira alla «… possibilità
di agire insieme senza dover essere necessariamente identici.» (Sennett 1976 Il declino dell’uomo
pubblico, 316)
Di contro: «…il potere comunitario non può che essere un’illusione in una società come quella
dell'Occidente industrializzato, in cui la stabilità è il frutto della progressiva espansione a livello
internazionale delle strutture di controllo economico.» (Sennett 1976 Il declino dell’uomo pubblico,
415)
3.2.2.3. la società (comunità) intimistica (un legame tra personalità, comunità, intimismo). «La
convinzione diffusa oggi è che l’intimità tra persone sia un bene morale, mentre l’aspirazione
principale è lo sviluppo della personalità individuale attraverso esperienze d’intimità e cordialità. Il
mito dominante è che i mali della nostra società siano il frutto dell’impersonalità, dell'alienazione e
della freddezza. Questi tre elementi che caratterizzano il tempo in cui viviamo formano nel loro
insieme un’ideologia intimista: i rapporti sociali — di qualunque tipo — sono reali, credibili e
autentici quanto più si avvicinano alle intime problematiche psicologiche di ciascun individuo.
Questa ideologia trasforma le categorie politiche in categorie psicologiche. […] La convinzione che
l’intimità sia un bene morale è in realtà il risultato di una profonda distorsione […] … la storia della
vita pubblica mette in discussione il mito dell’impersonalità come male sociale. […]
L’impersonalità sembra delineare un paesaggio disumanizzato, una totale assenza di rapporti umani.
Ma è questa stessa identificazione dell’impersonalità con il vuoto a creare la perdita dei rapporti.
[…] Il rifiuto di ogni trattativa e la costante espulsione degli estranei derivano dal desiderio,
considerato umanitario, di cancellare l’impersonalità dai rapporti sociali. Questo mito
dell'impersonalità porta all'autodistruzione: il perseguimento dell’interesse comune è impedito dalla
ricerca di un’identità comune. […] Il timore dell’impersonalità che domina la società spinge la
gente a concepire la comunità su una scala sempre più ridotta. Se l’Io si riduce alla pura
intenzionalità, la condivisione dell’Io collettivo si restringe a un numero limitato di persone,
escludendo coloro che, per classe sociale, opinione politica o stile, sono troppo diversi. Localismo e
culto della motivazione sono le strutture di una cultura costruita sulla crisi del passato. Queste
strutture ordinano la famiglia, la scuola, il quartiere, ma portano al disordine nella città e nello
Stato.» (Sennett 1976 Il declino dell’uomo pubblico, 319, 321, 324)
«È la perdita dell’espressione di certe capacità creative — le capacità ludiche — che tutti gli esseri
umani possiedono potenzialmente, ma che esigono un ambiente distinto dalla sfera dell’Io per
realizzarsi. È così che la società intimista rende l’individuo un attore privo della sua arte.
L’ossessione narcisistica della motivazione e la localizzazione del sentimento comunitario svolgono
un ruolo determinante in entrambi i traumi.» (Sennett 1976 Il declino dell’uomo pubblico, 235 e
cfr. p. 34)
34
«Per quanto riguarda l’inciviltà, il discorso va rovesciato. L'inciviltà consiste nel gravare il
prossimo con il proprio Io; è la riduzione della socievolezza ad opera di questo peso. […] La prima
è l’inciviltà dei dirigenti politici contemporanei, in particolare dei leader carismatici…. mettendo
eccessivamente in mostra la vita privata del leader e oscurandone contemporaneamente le azioni
concrete. […] La seconda forma d’inciviltà è la distorsione della fratellanza nell’esperienza
comunitaria moderna. Quanto più è piccola la comunità formata da una personalità collettiva, tanto
più distruttiva diventa l’esperienza del sentimento fraterno. Gli stranieri, gli estranei, i diversi,
diventano persone da evitare; i tratti personali condivisi dalla comunità diventano sempre più
esclusivi, e la condivisione si basa sempre di più su decisioni di appartenenza o esclusione.»
(Sennett 1976 Il declino dell’uomo pubblico, 326-327) «Le uniche azioni che la comunità
intraprende consistono nel disciplinare le emozioni, escludendo dalla comunità coloro che —
avendo sentimenti diversi — non ne fanno realmente parte. La comunità non può accettare,
assorbire o includere elementi esterni, perché comprometterebbe la propria purezza. La personalità
collettiva si oppone quindi alle interazioni sociali, che costituiscono l'essenza della socievolezza. La
comunità psicologica entra in conflitto con la complessità sociale.» (Sennett 1976 Il declino
dell’uomo pubblico, 382) Siamo di fronte al diffondersi di un’etica (una rete di trame sociali di
valori e azioni condivise e praticate) senza morale (incapace di riconoscere, difendere e promuovere
i diritti e le aspirazioni universali dell’umanità e del vivente proprie di ogni singolarità) (cfr. le tesi
di Avishai Margalit: Margalit Avishai 2004 L’etica della memoria, il Mulino, Bologna 2006).
3.2.2.4. imbarbarimento del carisma o « il significato dell'inciviltà di una personalità carismatica
profana» (il riferimento è agli studi di Max Weber sul tema carisma e alle analisi di Sigmund
Freud). « Chi subisce il fascino di una personalità forte diventa passivo e si dimentica dei propri
bisogni. Il leader carismatico finisce così per controllare il proprio uditorio in modo più completo e
più misterioso dell’antico rituale “civile” della Chiesa. […] Il carisma profano illustrato si presta
molto bene alle modalità con cui una tipologia di politici si rapporta con una certa categoria di
persone. Si tratta di politici di umili origini, che riescono a farsi strada istigando la gente contro
l'Establishment, i poteri costituiti e il vecchio ordine, pur non ponendosi come ideologi, anche se in
alcune versioni americane di questo modello rivelano tendenze populiste. Il loro non è un impegno
per un nuovo ordine, ma puro risentimento contro l’ordine esistente. La loro è una politica
conservatrice ed elitaria; la classe a cui si rivolgono detesta i privilegiati, ma non ha alcuna
intenzione di eliminare i privilegi. Attaccando l’Establishment, sperano di aprire nelle sue mura una
breccia in cui ciascuno possa farsi strada per conto proprio.[…] Il capo carismatico è il piccolo
uomo che è diventato l’eroe di altri piccoli uomini. È un divo: accuratamente confezionato,
sottoesposto e schietto nei sentimenti, domina su un regno in cui nulla cambia sostanzialmente
finché non si giunge a una crisi insolubile. » (Sennett 1976 Il declino dell’uomo pubblico, 333,
341, 359-360)
«…la maggior parte dei gruppi comunitari che cominciano a lottare in questi termini usano la loro
autentica indignazione morale come un mezzo per autolegittimarsi. I codici di credenza dominanti
nella società moderna li inducono a credere progressivamente che questa indignazione sia talmente
preziosa da escludere ogni possibilità di compromesso o soddisfazione, dal momento che essa
diventa una definizione della loro identità collettiva. A questo punto, alla politica si sostituisce la
psicologia. […] …la gente iniziò a «credere in ciò a cui prima aveva fatto mostra di credere» […]
La condivisione dell’indignazione aveva abituato — progressivamente e impercettibilmente — la
gente a considerare questa ostentazione di rabbia come un legame comunitario. L'indignazione
condivisa divenne il centro del dialogo all'interno della comunità, e chiunque non la condividesse
era ritenuto sospetto.[…] La ragione di questa isteria non è l’innata distruttività dell’uomo in preda
al sentimento comunitario, ma il fatto che la cultura moderna ha finito per assumere una struttura in
cui, senza qualche sollecitazione e forzatura, i legami sociali appaiono innaturali.
In una società in cui gli spazi sociali sono atomizzati, il timore costante della gente è l'isolamento.
Gli strumenti che questa cultura mette a disposizione degli individui per “legarsi” agli altri sono
simboli instabili d’impulsi e intenzioni. Data la problematicità di questi simboli, è inevitabile che la
35
gente che li usa sia sempre portata a saggiarne la forza.» (Sennett 1976 Il declino dell’uomo
pubblico, 374, 379)
3.2.3. Indicazioni per l’uscita o per la ripresa: elogio dell’impersonalità, recupero del gioco.
3.2.3.1. Elogio dell’impersonalità. «La gente imparerà a perseguire con forza i propri interessi
sociali nella misura in cui imparerà ad agire impersonalmente.» (Sennett 1976 Il declino dell’uomo
pubblico, 416) (e riprendendo anche: Stiglitz E. Joseph 2012 Il prezzo della diseguaglianza. Come
la società divisa di oggi minaccia il nostro futuro, Einaudi, Torino 2013).
«L’idea stessa di sconosciuto può sembrare un prodotto del capitalismo: così come l’uomo è
distante dal suo lavoro, lo è altrettanto dai suoi simili. La folla è l’esempio più emblematico al
riguardo: la folla è un male perché è formata da sconosciuti. Se si accetta questa idea, coerente dal
punto di vista emotivo, se non addirittura logico, l’eliminazione dell’“ignoto”, delle differenze tra la
gente, sembra coincidere con il superamento di alcuni mali fondamentali del capitalismo. Per
cancellare questa estraneità, si cerca di ristabilire l’intimità dell'esperienza umana su scala locale: si
cerca, cioè, di rendere moralmente sacro il territorio locale. Si ha così un’esaltazione del ghetto.
Ciò che si perde in questa esaltazione è l’idea che la gente “cresce” solo attraverso processi
d'interazione con l'ignoto. Oggetti e persone insoliti possono mettere in discussione le idee note e le
verità assodate: l’ignoto svolge una funzione positiva nella vita degli esseri umani, abituandoli ad
assumersi dei rischi. La passione per il ghetto, e in particolare per il ghetto borghese, toglie alla
gente la possibilità di arricchire le proprie percezioni ed esperienze e di apprendere la più preziosa
di tutte le lezioni umane: la capacità di mettere in discussione le condizioni usuali della vita
quotidiana. […] … sperimentare quegli “choc” che possono verificarsi in un ambito ignoto. Questi
choc sono indispensabili a un essere umano per avere quel senso di provvisorietà delle proprie idee
che ogni persona civile deve possedere. La distruzione di una città ghettizzata è una necessità
politica e psicologica.» (Sennett 1976 Il declino dell’uomo pubblico, 362, 363)
«Una società che teme l’impersonalità favorisce fantasie di vita collettiva di natura limitata.
L’immagine dell’identità del “noi” diventa sempre più selettiva: comprende solo il vicinato, i
colleghi, la famiglia. […] Non si tratta d’indifferenza, ma di rifiuto; è una restrizione intenzionale
dell’esperienza che l’Io collettivo permetterebbe. Pensare questo rifiuto in termini strettamente
politici non coglierebbe il fenomeno in tutta la sua forza: l’elemento centrale in questione è il grado
di rischio che una persona è disposta ad affrontare. Quanto più il suo senso di un Io comune è legato
alla dimensione locale, meno rischi sarà disposta a correre. Da un certo punto di vista, il rifiuto di
affrontare, assimilare e sfruttare la realtà al di fuori dei ristretti limiti della propria comunità è un
desiderio umano universale: è semplicemente la paura dell’ignoto. Il sentimento comunitario che
nasce dalla condivisione degli impulsi svolge un ruolo di rafforzamento della paura dell’ignoto,
trasformando la claustrofobia in un principio etico. […] Sfiducia e solidarietà, apparentemente
opposte, procedono di pari passo.» (Sennett 1976 Il declino dell’uomo pubblico, 381)
3.2.3.1.1. la città, il luogo storico della impersonalità e della vita civile: «Quest’ultima [la città] è lo
strumento della vita impersonale, la struttura in cui la diversità e la complessità delle persone, degli
interessi e dei gusti sono fruibili come esperienza sociale. […] Al riparo nei giardini ordinati di
Highgate o Scarsdale, la gente evoca gli orrori di Londra o di New York: qui, perlomeno,
conosciamo i nostri vicini, è vero che non succede quasi mai nulla, ma se non altro la vita è sicura.
È un ritorno al tribale. I termini “urbano” e “civile” indicano oggi l'esperienza elitaria di una classe
ristretta, accusandola di un certo snobismo. Sono proprio la paura di una vita impersonale e il valore
attribuito all’esperienza intimista a rendere l'esistenza civile, in cui le persone si trovano a proprio
agio tra le esperienze più diverse — delle quali, anzi, si nutrono — una prerogativa di un’élite ricca
e colta. In questo senso, l'intimismo è il tratto distintivo di una società incivile. […] … per gran
parte della storia della civiltà, la città è stata il centro della vita sociale attiva, dei conflitti e dei
giochi d'interesse, dell’esercizio delle potenzialità umane. Quelle potenzialità “civili" che appaiono,
oggi, assopite.» (Sennett 1976 Il declino dell’uomo pubblico, 416) «E qui deve istituirsi un nuovo
equilibrio non già tra poteri dello Stato, ma tra diverse risorse di integrazione sociale.[…] La forza
sociointegrativa dell'agire comunicativo ha il suo luogo anzitutto in quelle forme e quei mondi
36
particolari della vita che sono intrecciati con tradizioni e sfere d’interessi di volta in volta concreti.»
(Habermas 1962, 1990 Storia e critica dell’opinione pubblica, prefazione del 1990, XXX)
Agire nella società “impersonalmente” è richiamare e rilanciare una partecipazione in termini di
assunzione di responsabilità civile secondo ruoli e possibilità; va ripreso il concetto di “professione”
come risposta a una chiamata in contesto sociale (vocatio di carattere etico civile), concetto centrale
nelle analisi e nelle proposte sociali e politiche di Max Weber.
3.2.3.2. Recupero del gioco o ripresa politica della capacità di mettersi in gioco: « Il gioco come
energia per l’espressione pubblica» (Sennett 1976 Il declino dell’uomo pubblico, 386). E si tratta di
una dimensione antropologica, sociale e culturale (persona, società, cultura: i tre mondi espressione
formalizzata e sempre formalizzabile del mondo vitale [Husserl, Habermas, Popper]).
3.2.3.2.1. Osservando il gioco dei bambini (gioco, regole e tempo). «Il gioco delle biglie è dunque
un affare complesso. È solo costruendo delle regole che i bambini si mantengono liberi dal mondo
esterno non ludico e, quanto più le regole sono complesse, tanto più a lungo i bambini si
mantengono liberi. Ma lo scopo dei bambini non è prolungare all’infinito questa libertà: nelle
partite di biglie spesso all’inizio le regole sono confuse, per poi complicarsi ulteriormente nel corso
del gioco, ma alla fine c’è sempre una conclusione chiara. Le regole del gioco sono atti di
distanziamento per due ragioni. In primo luogo, perché non si ha fretta di vincere. È incredibile
quanto si arrabbino i bambini quando scoprono che qualcuno sta imbrogliando. Quando un bambino
cerca di acquisire una rapida supremazia sugli altri contravvenendo alle regole, tutti i partecipanti
ritengono che il gioco sia compromesso. Pertanto, le convenzioni del gioco rendono il bambino
“distaccato” dal piacere di dominare, anche se si gioca per vincere e il desiderio di vincere è forte.
In secondo luogo, le regole agiscono da fattori di distanziamento, compensando le disuguaglianze
nelle abilità dei giocatori. Per esempio, il gioco delle biglie richiede una buona coordinazione
muscolare per tirare con precisione la biglia che deve andare a colpirne una lontana. Ne risulta che
un bambino di quattro anni e mezzo è fisicamente svantaggiato rispetto a uno di sei. Quando
bambini di età differente si trovano a giocare a biglie da distanze lunghe, i bambini più grandi
decidono subito di modificare le regole, per evitare l’eliminazione immediata dei più piccoli,
escogitando un “handicap” per se stessi, in modo da mettere i giocatori tutti sullo stesso piano e
prolungare di conseguenza il gioco. Anche in questo caso, le regole impediscono ai bambini
un’autoaffermazione immediata, una vittoria rapida. Ancora una volta, è la distanza dall’Io a
strutturare il gioco.» (Sennett 1976 Il declino dell’uomo pubblico, 390)
In sintesi, un triplice distanziamento: distanziamento da un esterno (da un non-gioco; traducendo:
dall’impolitico); distanziamento dalla volontà di dominare a tutti i costi (ed entrare nella logica del
gioco che è accettazione di regole e coinvolgimento: volontà di giocare); distanziamento dall’Io
come da un assoluto-personale, anzi la volontà di giocare spinge all’attenzione alle differenze fino
allo stratagemma di creare un handicap per il più forte (e creare così una situazione comune, una
“sfera pubblica” diversa nella sua specificità dall’affermazione di individualismi puri).
3.2.3.2.2. Come conclusione. Il tempo delle regole e la libertà partecipata nel gioco democratico.
Contro la “personalizzazione” narcisistica, il fallimento del potere nel carisma personalistico e del
sociale nel comunitarismo identitario arroccato in autodifesa la ripresa della dimensione pubblica.
Una ripresa di Aristotele: la società è luogo antropologico per eccellenza (chi non vi fa parte è
perché o è bestia o è dio) in quanto nel sociale e solo nel sociale si attua la scoperta e la
valorizzazione della propria complessità e si acquisisce quella molteplicità di habitus, di virtù etiche
che fanno perfezione etica.
Perfezione storica variabile che emerge in un recupero dei ruoli (Sennett) e in un agire
comunicativo (Habermas) finalizzato all’intesa, nei processi relazionali veicolati dal linguaggio
rispettato e analizzato nella complessità delle sue forme quotidiane secondo regole e libertà.
Come nel gioco: le regole e solo le regole rendono possibile il gioco, ma il gioco c’è solo se le
regole impediscono che la partita risulti prevedibile nel suo realizzarsi e nel suo esito.
3.2.4. Progettare in apertura storica, sociale e antropologica (come conclusione generale).
37
3.2.4.1. Apertura storica. Osserva Habermas: «Ogni costituzione storicamente esistente ha un
duplice riferimento temporale. Come documento storico essa ricorda — interpretandolo — l’atto
della fondazione e indica così un punto d’inizio. Nello stesso tempo il suo carattere normativo ci
ricorda che il compito d’interpretare e sviluppare il sistema dei diritti si pone daccapo per ogni
nuova generazione. Come progetto di società giusta, una costituzione articola l’orizzonte d’attesa di
un futuro che è ogni volta presente. Sotto questo aspetto — di un incessante processo costituente di
lungo periodo — il procedimento democratico della produzione giuridica legittima acquista una
posizione tutta particolare.» In questo cammino, il ruolo e il senso delle crisi: «Crisi di questo
genere risultano sempre spiegabili, almeno sul piano storico. Esse non connotano intrinsecamente le
strutture delle società funzionalmente differenziate, e neppure smentiscono a priori il progetto con
cui una comunità di «liberi ed eguali» vorrebbe ascrivere a sé ogni potere vincolandosi al diritto.
Tuttavia queste crisi sono rivelatrici di come un sistema politico regolato in Stato di diritto
s’inserisca in maniera tipicamente asimmetrica dentro processi circolari altamente complessi. Di
questi ultimi gli attori devono farsi un’idea precisa, se vogliono impegnarsi con successo e in
atteggiamento performativo (in veste di cittadini, deputati, giudici, funzionari ecc.) nella
realizzazione del sistema dei diritti. Siccome questi diritti devono essere interpretati in modi diversi
col mutare dei contesti sociali, la luce che essi gettano su tali contesti si frange nello spettro di
paradigmi giuridici mutevoli. Le varie costituzioni storiche si lasciano intendere come altrettante
interpretazioni d’una sola e medesima prassi: quella con cui consociati giuridici liberi ed eguali si
autodeterminano. Ma come tutte le altre prassi, anche questa è situata nella storia. Gli interessati
non possono che partire dalla loro prassi determinata, se vogliono mettere in chiaro ciò che questa
prassi significa in generale.» (Habermas Jürgen 1992 Fatti e norme. Contributi a una teoria
discorsiva del diritto e della democrazia, Guerini e Associati, Milano 1996, 456, 458)
3.2.4.2. Apertura antropologica sociale. L’incontro tra mondo della vita e sistema nell’agire
comunicativo sociale. Osserva Habermas: «La teoria dell’agire comunicativo è intesa a mettere in
luce un potenziale razionale insito nella prassi comunicativa quotidiana. Con ciò essa spiana
contemporaneamente la strada a una scienza sociale dal procedere ricostruttivo, che identifica in
tutta la loro estensione i processi di razionalizzazione culturale e sociale, ripercorrendoli anche oltre
la soglia delle società moderne; allora non si avrà più bisogno di ricercare potenziali normativi solo
in una formazione specifica di un’epoca. […] … collegare il concetto di mondo della vita
introdotto nella Logik der Sozialwissenschaften (1967; «Logica delle scienze sociali») col concetto
di sistema che mantiene i confini. Da questo si sviluppa nella Theorie des kommunikativen Handels
(1981; «Teoria dell’agire comunicativo») la concezione binaria della società come mondo della vita
e come sistema. Questa comporta infine radicali conseguenze per il concetto di democrazia.»
(Habermas 1962, 1990 Storia e critica dell’opinione pubblica, dall’Introduzione del 1990, XXVIII,
XXIX)
3.2.4.3. Nei processi deliberativi, non nelle volontà, meno ancora nelle (demagogiche) emozioni;
come le emozioni dei bambini nel gioco danno vita a regole frutto di deliberazioni e fonte di
vincolo, fatti salvi i problemi della realtà che pongono nuovi aspetti, così il gioco democratico ha la
propria validità nei processi deliberativi e non in generiche “volontà generali”; occorre sottoporre a
critica «la «democrazia dell’opinione non pubblica» di Rousseau, perché egli concepisce la volontà
generale più come «consenso dei cuori che degli argomenti».
3.2.4.3.1. La consapevolezza critica circa la debolezza democratica e i rischi plebiscitari
demagogici di un consenso costruito sulla pubblica opinione intesa come richiamo alla volontà
generale o alla buona volontà. «Con il doppio presupposto di una limitazione del pubblico ai privati
borghesi e della limitazione del loro dibattere alle fondamenta della società borghese come sfera di
disposizione privata, va in pezzi anche la vecchia base di convergenza delle opinioni e non ne sorge
certo una nuova per il fatto che gli interessi privati che irrompono nella sfera pubblica ne
mantengono la finzione. Al consenso generato nel segno di un fittizio public interest mediante
raffinati opinion-molding services [servizi di formazione (fabbricazione, modellazione) d’opinione]
mancano in generale i criteri della ragionevolezza. La critica avveduta che si esercita su questioni
38
pubblicamente discusse è sostituita dalla disposizione alla conformità con le persone o le
personificazioni pubblicamente presentate; il consent coincide con il good will, prodotto dalla
publicity. […] L'effetto immediato della pubblicità non si esaurisce in quell'effetto pubblicitario
decommercializzato di una aura of good will che produce una disposizione al consenso. Questa
pubblicità, oltre a influenzare le scelte dei consumatori, serve anche come pressione politica, perché
mobilita un potenziale inarticolato di disposizione al consenso che, in caso di necessità, può tradursi
in acclamazione di tipo plebiscitario.» (Habermas 1962, 1990 Storia e critica dell’opinione
pubblica, 224,232)
3.2.4.3.2. La proposta: ripresa della comunicazione volta all’intesa come base del consenso e non il
«consenso dei cuori» (si può notare, in proposito, come nelle kermesse dei partiti, marcatamente in
quelli nei quali la leadership personalistica gioca un ruolo primario, nel momento della massima
emozione, della emozione partecipativa, si canta l’inno [l’inno di appartenenza] con lo sguardo
ispirato, rapito e perso e con la mano sul cuore). «In suo luogo, la morale che Rousseau pretende dai
cittadini dello Stato e che egli colloca nelle motivazioni e nelle virtù del singolo, deve venire essa
stessa ancorata nel processo della comunicazione pubblica. Bernard Manin concettualizza tale
conclusione: «È necessario modificare radicalmente la prospettiva comune alle teorie liberali e al
pensiero democratico: la fonte della legittimità non è la volontà predeterminata degli individui, ma
piuttosto il processo stesso della sua formazione, vale a dire la deliberazione... Una decisione
legittima non rappresenta il volere di tutti, bensì è una decisione che risulta dalla deliberazione di
tutti. È il processo per cui è formato il volere di ciascuno quello che conferisce al risultato la sua
legittimità, piuttosto che la somma di voleri già formati. Il principio deliberativo è individualistico
non meno che democratico... Noi dobbiamo affermare, a rischio di contraddire una lunga tradizione,
che il diritto legittimo è il risultato della generale deliberazione, non l’espressione della volontà
generale». Con ciò l’onere della dimostrazione si sposta dalla morale dei cittadini a quei
procedimenti della formazione democratica dell’opinione e della volontà che sono destinati a
fondare la presunzione di raggiungere risultati razionali.» (Habermas 1962, 1990 Storia e critica
dell’opinione pubblica, dall’Introduzione del 1990, XXXI-XXXII).
39