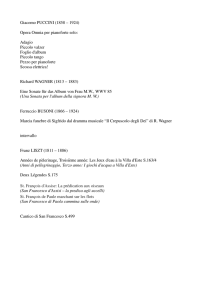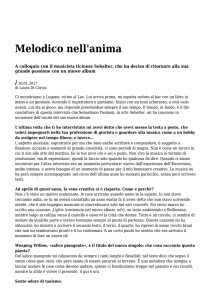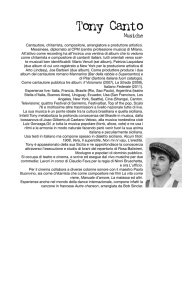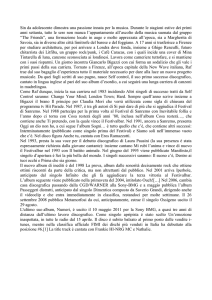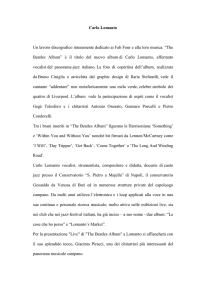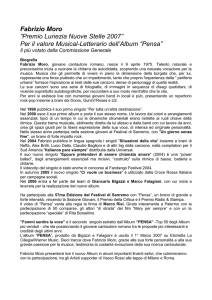la Voce
del popolo
la Voce
del popolo
QUEEN
IQUARANT’ANNI
DI BOHEMIAN
RHAPSODY
spettacoli
www.edit.hr/lavoce
Anno 1 • n. 6
martedì, 29 dicembre 2015
IL PERSONAGGIO
INTERVISTA
MUSICA
RECENSIONE
Woody Allen
ha compiuto 80 anni
Una chiacchierata
con Veljko Bulajić
I dieci migliori
album di sempre
Il film «Colpi di fulmine»
di Parenti
Il rinomato regista montenegrino parla
della sua ricca carriera e del nuovo
progetto in cantiere
La rivista “Rolling Stone”
ha compilato una lista dei 500 dischi
migliori della storia
Una classica commedia romantica
a episodi pensata per allietare il
periodo festivo
3
L’instancabile cineasta americano gira
un film all’anno e non intende fermarsi.
L’ultimo è “Irrational man”
4|5
6|7
8
2
martedì, 29 dicembre 2015
ANNIVERSARI
spettacoli
la Voce
del popolo
QUARANT’ANNI FA VENNE
PUBBLICATO IL SINGOLO
«BOHEMIAN RHAPSODY»
DEL GRUPPO INGLESE
QUEEN, UNA DELLE
CANZONI PIÙ IMPORTANTI
NELLA STORIA DELLA
MUSICA LEGGERA
S
entire un brano dei Queen
per la prima volta è per molti
un’esperienza particolare. A parte
la voce straordinaria del frontman
Freddie Mercury e la bravura degli
strumentisti (Brian May alla chitarra
elettrica, Roger Taylor alla batteria e
John Deacon al basso), ciò che affascina
nella musica di questa leggendaria band
inglese sono le linee melodiche che
hanno un che di inaspettato nel modo
in cui si sviluppano. Ciò vale soprattutto
per i brani composti dallo stesso Freddie
Mercury, nei quali il geniale musicista
si è avventurato in tutta una serie di
generi, sperimentando con la struttura,
la durata del brano (una categoria di
notevole importanza nella musica pop/
rock, al fine di venire incontro ai tempi
radiofonici e televisivi) e con le armonie.
Ebbene, abbiamo appena descritto
una delle canzoni-simbolo della band:
“Bohemian Rhapsody”, il capolavoro di
Mercury.
Un successo enorme
La canzone venne scritta per il quarto
album dei Queen, “A Night at the Opera”
del 1975, e pubblicata come primo
singolo il 31 ottobre del 1975. Il brano
ottenne un enorme successo e rimase
al vertice della classifica britannica
dei singoli per ben nove settimane,
arrivando a vendere un milione di copie
nel gennaio del 1976.
Nonostante il suo straordinario
successo, “Bohemian Rhapsody”
non venne accolta con entusiasmo
da tutti i critici. C’è chi la descrisse
come un “pastiche superficialmente
impressionante” di stili operistici e chi
le rimproverava di essere “un tentativo
di avvicinarsi alla furia demente di
una società operistica amatoriale”, ma
sono molto più numerosi coloro che
ne parlarono in termini superlativi.
Questo vale soprattutto per i musicisti,
tra cui anche Brian Wilson dei Beach
Boys, il quale fece riferimento al brano
nel 1976 come a “una delle cose più
competitive apparse dopo tanto tempo”,
descrivendolo come “la preghiera
esaudita di un adolescente desideroso
di musica artistica”. Con “Bohemian
Rhapsody” al vertice della classifica
inglese, il cantante Greg Lake dovette
accontentarsi del secondo posto per
il suo brano natalizio “I believe in
Father Christmas”, confessando di esser
stato “battuto da una delle più grandi
canzoni mai scritte” e descrivendolo
come “un’incisione che avviene una
volta nella vita”. Il brano venne definito
“un’operetta di rock progressivo” e “un
ponte tra il meglio del progressive rock
e uno stile musicale più aggressivo”.
Una particolare struttura musicale
In linea con la propensione di Freddie
Mercury al gioco con i generi musicali
e alla sperimentazione, “Bohemian
Rhapsody” si distingue per la sua
particolare struttura musicale. Il brano
è composto, infatti, da cinque parti
diverse: un’introduzione corale cantata
a cappella, un segmento in stile ballata
che termina con un assolo di chitarra, un
passaggio d’opera, una sezione di hard
rock e un altro segmento in stile ballata
che si chiude con una sezione solo piano
e chitarra. Questa forma sarà ripresa da
Mercury quindici anni più tardi, nella
canzone “Innuendo”, tratta dall’omonimo
album.
Data la complessa struttura della
canzone, le registrazioni iniziarono
appena dopo tre settimane di prove,
|| I Queen negli anni Settanta
UN’AFFASCINANTEFUSIONE
TRAOPERETTAEROCKPROGRESSIVO
|| La copertina dell’album “A Night at the Opera”
mentre l’incisione richiese altre sei
settimane di lavoro. In alcuni segmenti
della parte cantata a cappella, le voci dei
Queen vennero sovraregistrate diverse
volte raggiungendo un totale di circa
180 parti vocali. Si tratta di un risultato
davvero impressionante per gli standard
dell’epoca, in quanto sembra che gli
studi stessi non fossero in possesso di
nastri capaci di contenere il numero di
registrazioni necessario per l’incisione
del brano.
Due volte al vertice delle classifiche
Un altro elemento insolito è pure la
durata del brano, di quasi sei minuti.
Per questo motivo la sua diffusione
radiofonica pareva improponibile, finchè
un giorno Freddie Mercury non si mise
in contatto con l’amico disc jockey,
Kenneth Everett, consegnandogli una
copia della canzone sotto la promessa
di non mandarla in onda. Certo che
Freddie sapeva esattamente che la
promessa non sarebbe stata mantenuta e,
|| La band durante una performance
infatti, Everett cominciò a trasmettere il
brano di continuo, arrivando a proporlo
addirittura quattordici volte in due
giorni. Il successo fu tale che la casa
discografica dovette pubblicare il singolo,
che vinse il disco di platino e rimase in
cima alle classifiche per nove settimane.
Effettivamente, “Bohemian Rhapsody” è
l’unico singolo che riuscì a raggiungere
il vertice delle classifiche due volte (la
seconda volta accade qualche mese
dopo la morte di Mercury, nel 1992.
La canzone rimase al primo posto per
cinque settimane).
Il significato del testo rimane un mistero
Freddie Mercury fu sempre riluttante
a spiegare il significato del brano e
si limitò a dire che parlava di una
relazione; la band protegge ancora
oggi il suo segreto, nonostante May
sostenga la tesi che la canzone contenga
velati riferimenti ai traumi personali
del frontman. “Freddie fu una persona
molto complessa: vivace e divertente
in superficie, nascondeva insicurezze
e difficoltà nel conciliare la sua vita
con la sua infanzia. Non spiegò mai il
testo della canzone, ma credo che vi
investì molto di sé stesso”, dichiarò May.
Tuttavia, numerosi critici, giornalisti e
studiosi continuarono a speculare sul
significato del testo. Alcuni sono convinti
che vi sia descritto un omicida che sta
per suicidarsi, perseguitato da demoni,
o che parli di eventi immediatamente
precedenti a un’esecuzione. Quest’ultima
spiegazione fa riferimento al romanzo
“Lo straniero” di Albert Camus che tratta
un tema simile. Certi si limitano, invece,
a sostenere che il testo venne scritto
unicamente per accompagnare la musica
e che non abbia un significato preciso.
Quale che sia la verità, rimane il fatto
che si tratta di una delle canzoni più
emblematiche nella storia della musica
leggera, tanto che venne votata in diversi
sondaggi come il brano più bello di
sempre.
Helena Labus Bačić
spettacoli
la Voce
del popolo
IL PERSONAGGIO
“T
Desiderio, repressione, ansia e sessualità
Tuttavia, il concetto freudiano della
psicanalisi e la sua formula magica di
desiderio, repressione, ansia e sessualità
rimane una sua costante tematica. Nel
testo “The Denial of Death” (La negazione
della morte) di Ernest Becker, che Alvy
compra all’amata Annie nel film Annie
Hall, vengono citate due strategie per
evitare la moralità: la sessualità, che
Allen accetta senza barriere, e il Dio che
deride. Oltre che da Freud e Bergman,
era ossessionato anche da Dostoevskij
fin dal 1975, anno in cui girò Love and
Death. “Il mondo è un grande ristorante”.
“La soggettività e oggettiva”. “Se Cristo
fu un falegname, chissà quando prendeva
per uno scaffale”. La cornice storica della
trama sono le guerre di Napoleone nelle
quali viene coinvolto Allen con la sua
psiche da “neurotico ebreo”.
L’INSTANCABILE
CINEASTA AMERICANO
WOODY ALLEN HA
COMPIUTO 80 ANNI
L’ossessione per Dostoevskij prosegue
anche nei Crimini e misfatti nei quali Judah
(Martin Landau), un medico benestante,
organizza l’omicidio dell’amante (Anjelica
Huston) dopo che la donna ha minacciato
di trasformare la sua vita in un inferno.
Dapprima viene assalito dal senso di
colpa, poi riesce a dimenticare per poter
nuovamente vivere una vita normale,
senza il fardello dell’orribile crimine che
ha commesso. I riferimenti a due opere
seminali di Dostoevskij - “Delitto e castigo”
e “I fratelli Karamazov” - sono più che
evidenti.
Match Point a Londra
|| Locandina di “Irrational man”
3
di Dragan Rubeša
CRIMINI E MISFATTI
DELL’UOMOIRRAZIONALE
utta la tua vita è nichilismo,
cinismo, sarcasmo e orgasmo.
In Francia potrei condurre una
campagna politica e vincere le elezioni con
questo slogan“, dice il protagonista del film
di Allen, Decostructing Harry. Oppure, come
puntualizza un altro suo protagonista, “la
commedia non è altro che tragedia più il
tempo”. In queste due frasi è concentrato
praticamente tutto l’opus del grande Woody
Allen.
Anche se i suoi primi film, come Take
the Money and Run, Bananas e Sleeper,
nei quali lo “schlemiel” - una figura
quintessenzialmente comica nella genesi
dell’umorismo “yiddish”, è adattato
all’estetica “slapstick” -, sono il meglio che
ci ha dato questo opus, dopo le commedie
dolceamare quali Annie Hall e Manhattan si è
orientato verso lavori di stampo bergmaniano
che culmineranno con il film Interiors.
martedì, 29 dicembre 2015
Questi sono riproposti anche in uno dei
film più recenti di Allen, Match Point, in
cui, proprio come in Crimini e misfatti,
il protagonista uccide l’amante. Però, a
differenza di Judah, Chris (il protagonista di
Match Point) non soffre di rimorsi, anche se
nella pellicola troviamo lo spirito e lo stile
di Patricia Highsmith. In quell’occasione,
Allen ha sostituito Manhattan con Londra,
il punto di partenza della sua tournèe
europea che ha toccato Parigi, Barcellona
e Roma. Dal momento che la giustizia
cosmica non esiste, c’è poca speranza che
ci sia giustizia alcuna. L’universo non è
morale, ma indifferente. “Nella vita reale
razionalizziamo, neghiamo o non siamo
più capaci di vivere”. Con queste parole,
l’oftalmologo Judah cerca di giustificare
il suo crimine. La scelta morale consiste
essenzialmente nella questione se la colpa
sia più grave nell’ottica del protagonista
oppure in quella del mondo che lo
circonda. Allen elabora questo dilemma in
un miscuglio perspicace di commedia di
carattere, di parabola e di film giallo.
Nell’ultimo film di Allen Joaquin Phoenix
interpreta un professore di filosofia che
perde il senso del mondo che continua ad
alienarlo. Ma chi è effettivamente questo
“uomo irrazionale” che troviamo nel titolo
del film? Secondo Allen, egli è ancora una
variazione su Dostoevskij e Raskolnikov,
i quali lo perseguitano fin dagli anni
Settanta, periodo in cui nel film Amore e
morte, nel ruolo di un “codardo militante”,
competeva con il famoso scrittore russo su
chi fosse più misantropo. “Mi piacciono gli
scrittori russi, particolarmente Dostoevskij,
lui capiva tutto”, dice Phoenix.
L’omicidio come siero di vita
Si tratta, quindi, di un uomo che cerca di
sabotare l’approccio filosofico razionale e
in quest’ambito le citazioni di Allen vanno
da Kant e Kierkegaard a Husserl e Hannah
Arendt. L’assassinio di un uomo ingiusto è
tutto ciò che serve al regista per riattivare
il meccanismo hitchcockiano McGuffin
(L’altro uomo è soltanto uno dei numerosi
nessi) – un espediente narrativo attraverso
il quale si fornisce dinamicità a una trama
(ndr). Ma qui non si tratta di uno scambio
di omicidi, ma di un assassinio senza
motivo il cui scopo è quello di rendere
le indagini più difficili per la polizia.
L’omicidio di un giudice corrotto nella
speranza che con la sua morte il mondo
diverrà un posto “un po’ migliore”.
L’omicidio come una terapia che dovrebbe
curare il professore dall’impotenza e che
gli permetterebbe di vivere la vita fino
in fondo. Ossessionato da Dostoevskij,
egli commetterà un crimine per gustare
nuovamente la vita. Come in Misterioso
omicidio a Manhattan e Scoop, l’omicidio
diviene un siero di vita.
Emma Stone, musa e alter-ego di Allen
Il personaggio della studentessa
(interpretata da Emma Stone, la stessa
che nell’ultima scena di Magia al chiaro
di luna ritrova il suo illusionista) riprende
nuovamente il ruolo di musa e alter-ego
di Woody Allen. In lei c’è molto più Allen
che in Abe, il cui “conservatorismo in stile
liberale” è a prima vista molto più vicino
al suo abito mentale. Il suo compagno è
un professore alcolizzato e depresso che
giunge occasionalmente nella cittadina
costiera in cui vive la ragazza. Il film si basa
su una doppia narrazione – da un lato c’è la
voce narrante della studentessa, dall’altro
quella del professore. In tal modo, l’opera di
Allen diventa una sorta di idra a due teste.
|| Joaquin Phoenix ed Emma Stone
Una commedia poliziesca e un dramma
metafisico. La commedia è in effetti antiromantica in quanto Stone e Phoenix sono
ritratti come una coppia impossibile.
Emma Stone è quindi una tipica eroina
alleniana, al contempo innocente e
metodica, ma fantasiosa fino al delirio. Le
indagini sono per lei fonte di agitazione,
ma anche di competizione, e fondono l’etica
e la strategia. Sta proprio qui la bellezza
del suo personaggio, anche se la nostra
simpatia sta dalla parte della pazza Parker
Posey nel cammeo di una professoressa
afflitta dalla solitudine che chiede al suo
amante occasionale, Abe, di salvarla dal
matrimonio infelice.
Una carriera che non tramonta
Che cosa resta infine della cinematografia
di Woody Allen? Forse una risposta la può
dare il professore Phoenix in quell’eccellente
dialogo a cena con la studentessa in cui
cerca di trattenerla dall’innamorarsi di lui.
“Perché?”, chiede lei. “Perché tu sei più
buona di me”, risponde lui regalandole un
vecchio libro di poesie. Allen ha ancora la
forza di trovare la sua “musa” e regalarle un
film, “le ‘stardust memories’ emotive come
l’unica risposta possibile alla crisi umana e
professionale del suo protagonista”, come
rileva il critico del cinema Piero Masciullo.
Questo film pone una virgola sulla
carriera dell’autore. Quel famoso “treno
notturno” di Truffaut che veniva citato
tempo fa nell’opus di Woody Allen. Il
regista americano ha compiuto 80 anni,
ma continua a lavorare instancabilmente.
Ogni anno un film. Un nuovo “progetto
senza titolo di Woody Allen” è annunciato
per il 2016, con Kristen Stewart e Jesse
Eisenberg, più una serie televisiva, anche
questa ancora senza titolo.
L’infaticabile macchina commediografica
di Allen non ha nessuna intenzione di
fermarsi. Mai un punto, soltanto una
virgola.
4
lalaVoce
Voce
del popolo
del popolo
martedì, 29 dicembre 2015
INTERVISTA
di Sandro Damiani
L’OPERACINEMATOGRAFICAÈUNRICOM
DACAPOCONL’ENTUSIASMODELL’ESOR
A COLLOQUIO CON IL RINOMATO REGISTA VELJKO BULAJIĆ, AUTORE DI NUMEROSI FILM DI SUCCESSO, ATTUALMENTE
IMPEGNATO NELLA PREPARAZIONE DI UN NUOVO PROGETTO, AMBIENTATO IN ISTRIA
È
stata presentata recentemente la
voluminosa monografia “Vlak bez
voznog reda” dedicata al regista,
montenegrino di nascita ma croato di
adozione, Veljko Bulajić, classe 1928, il
decano della cinematografia dell’area ex
jugoslava.
Il titolo del libro è quello del film
d’esordio del Cineasta, appunto Il treno
senza orario, uscito nel 1959 e che a
tal punto piacque agli organizzatori del
Festival di Cannes da ammetterlo in
concorso, insieme a opere di mestri e
maestri in pectore, quali Bunuel, Soldati,
Zoltan Fabri, i francesi Camus, Resnais e
Truffaut...
Il film non ottenne nessun ulteriore
premio – essere alla rassegna già
di per sé lo costituiva - ma grazie a
Cannes e alla positiva accoglienza della
critica internazionale, gli permetterà
una diffusione sino a quel momento
inimmaginabile per qualsiasi pellicola
jugoslava e dell’Est europeo: Il treno...
infatti sarà acquistato da oltre sessanta
Paesi di tutto il mondo. “Nacque una
stella”, si potrebbe dire. Chissà, forse
qualcuno lo disse pure.
Bulajić, che allora aveva trent’anni, al
momento può vantare un’esperienza
abbastanza singolare per un regista di
un “Paese socialista”, ovvero un robusto
tirocinio a Cinecittà, dove ha modo
di vedere all’opera fior fiore di registi
italiani. Conosce Cesare Zavattini,
collabora con Luigi Zampa; e si fa valere
come assistente sul set di La strada lunga
un anno, girato in Jugoslavia, da Giuseppe
De Santis: questo film nel 1958 sarà
candidato all’Oscar per la miglior pellicola
straniera (o meglio, in lingua non
inglese). Quando, in quel medesimo ‘58
gli viene data l’occasione di girare il primo
lungometraggio, ma senza “paracadute”
ossia con una équipe di esordienti, al
pari di lui, egli è tutto preso dalla cultura
cinematografica appena introiettata e
fatta di Neorealismo...
Uno studio tappezzato di manifesti
|| Locandina della “Battaglia della Neretva”
|| Locandina della “Kozara”
Mi trovo a casa del Regista, a Zagabria.
Lo studio - uno spazio comodo per due,
massimo tre persone - è tappezzato
di manifesti dei suoi film; fa bella
mostra quello firmato da Pablo Picasso
per La Battaglia della Neretva. Libri
in ogni dove: a occhio si capisce che
non è un disordine artificioso, del tipo
“facciamo finta che...”, ma quello di chi
in continuazione sfoglia, legge, cerca.
Qua e là medaglie, placche, un Leone
della Mostra che fa da sponda a una pila
di riviste, diplomi. Adocchio un vecchio
numero di “Cinemasessanta”. Neanche
a farlo apposta, poco più in là c’è pure
“Cinema Nuovo”, fondata nei primi
Cinquanta da Guido Aristarco. Ricordo
al mio interlocutore che l’Aristarco,
Ugo Casiraghi e Camillo Marino, tre
(come si sarebbe detto in altri tempi)
“benemeriti” rispetto al cinema italiano,
per anni collaborarono a “Panorama” di
Fiume.
“Lo so – mi risponde con un sorriso
che disvela un’immagine, un ricordo
balenato in quel preciso momento con Casiraghi ci vedevamo oltre che
ai festival, pure a Crikvenica, dove
veniva in vacanza. Una volta c’era pure
tuo padre” (Alessandro Damiani, ndr).
In proposito, si trattò del loro primo
incontro, seconda metà dei Sessanta.
E quando Bulajić girerà in Bosnia La
Battaglia della Neretva, chiamerà del
Dramma Italiano, oltre a Nereo Scaglia,
Raniero Brumini, Glauco Verdirosi e
Bruno Petrali anche il Damiani. Ma gli
ultimi quattro, se non ricordo male, non
arriveranno a Sarajevo. Mentre Scaglia
aveva già girato le sue scene gli altri si
apprestavano a farlo: la mattina all’alba
di non ricordo che giorno mese anno
(probabilmente 1967 o ‘68) montano
in macchina, guida Petrali, non fanno
in tempo ad arrivare a Delnice che un
matto su un Moskvić dalla parte opposta
gli monta addosso, li capotta... A Fiume
ci arriva la notizia, Diego Brumini ed
io veniamo informati a scuola, al Liceo.
Spavento. Mia madre, tira moccoli da
uccidere un santo. Ma non è niente di
grave: Brumini si è fratturato un polso
in due punti, Glauco Verdirosi s’è ferito
a un piede, mio padre s’è procurato
una decina di punti tra bocca e mento
e Bruno Petrali – ricorderanno divertiti
(dopo!) i tre disgraziati presenti “saltava come un ragazzino: Non me go
fato niente, non me go fato niente!”.
Un Premio alla Carriera
Da quando ci siamo dati appuntamento
per questo incontro, che ha per scopo
anche un’intervista per “La Voce”, mi
chiedo come iniziare non tanto il pezzo
che ne scaturirà, ma la parte ufficiale
della conversazione. Non ci vedevamo da
un anno. L’ultima volta era all’indomani
del suo rientro da Roma, dove il Festival
del Cinema Mediterraneo gli aveva
conferito un Premio alla Carriera. Nel
corso della serata era venuto a trovarlo
Franco Nero e gli organizzatori avevano
proiettato le edizioni italiane de La
Battaglia... e Libertas.
Sfoglio la monografia, ottimamente
confezionata: centinaia di pagine, foto a
sfare, articoli in una decina di lingue. Mi
soffermo su L’uomo da uccidere del 1979,
uno dei film minori di Bulajić, ma al pari
di quasi tutti gli altri, premiato al Festival
di Pola e, in ambito internazionale, a
una rassegna catalana a Bercellona nella
neonata Spagna democratica. Fu grazie a
questo film che avvicinai Bulajić la prima
volta. Si era a Roma. Avevo saputo che
in una saletta di Cinecittà si proiettava la
pellicola per un pubblico di “eletti”. Tra
costoro c’era Gian Luigi Rondi, sincero
estimatore del Nostro. Avrei ricordato la
serata per “Panorama” con un’intervista.
Il treno senza orario
L’incipit dell’odierna conversazione,
però, mi viene dato dal titolo della
monografia... Ah, noticina per i
lettori: non amo la convenzione della
“correttezza formale”, del “lei” nelle
interviste tra persone che altrimenti si
danno del “tu”. Con Veljko, inoltre, la
frequentazione è stata sempre affettuosa.
Dopo la summenzionata serata romana,
pochi mesi dopo, in estate, ci furono
incontri quasi quotidiani a Pola, quando
mi ci avevano catapultato, per seguire
il Festival, sia Tele-Capodistria che “La
Voce” e il “Primorski Dnevnik” triestino.
Dopo pochi anni ci ritrovammo a Firenze,
lui ovviamente da cineasta, io da coorganizzatore di una manifestazione
di un certo peso: “Il Segno d’Argento”,
convegno cinematografico con
l’assegnazione dell’omonimo premio
da parte dell’Istituto di Scienze
Cinematografiche diretto da Fabrizio
Guarducci e presieduto (“Honour
chairmen”) da Bernardo Bertolucci,
Martin Scorsese e Tinto Brass. Infine,
una decina di incontri giornalieri durante
le riprese di “Libertas”, in Istria. Penso più
per amicizia che altro, aveva visto in me(?)
il contadino toscano che accoglie Marino
(Držić) e la sua compagna, in fuga (Sven
Medvešek e Sandra Ceccarelli) da Firenze
a Venezia inseguite dai bravi degli oligarchi
di Ragusa. Mi si permetta una dolorosa
digressione: la mia di compagna, in quelle
sequenze era la cara Andreja Blagojević.
Partiamo, è proprio il caso di dirlo, dal
“Treno...”. Come t’è nata l’idea?
“Negli anni immediatamente precedenti,
avevo girato dei ‘corti’, incentrati su vicende
squisitamente umane: la vita nel dopoguerra,
i problemi quotidiani della gente dei campi,
di mare, ecc. Convinto sin da quei tempi (lo
sono tutt’ora) che i grandi film si possono
fare unicamente su grandi temi della vita,
quotidiani o collettivi che siano, mi ricordai
di mia madre che un giorno alla stazione
di Sarajevo, dove vivevamo, vide vagoni e
vagoni strapieni di gente, intere famiglie,
alcune con animali al seguito, provenienti
dall’entroterra dalmata, dall’Erzegovina,
che andavano... nemmeno loro lo sapevano
dove. Alcuni cantavano, altri piangevano,
chiedendosi cosa fosse, dove fosse la
Slavonia, il Banato... Andavano, o meglio
venivano mandati al nord a colonizzare la
Slavonia e la Vojvodina, ove i fertilissimi
campi erano rimasti senza che nessuno
potesse fruttarli per il bene comune e
perdippiù in un periodo di fame e carestie
senza precedenti. Oltre tutto, lasciavano terre
aride, avare, miseria incalcolabile. Avendo
di mio una qual sensibilità verso quelle genti
e avendo appreso qualcosa dalla “lezione
neorealista” non mi fu difficile, pur lavorando
con una équipe, come me di esordienti,
di evocare questo dramma, quest’epopea
con un’equilibrata dose di pathos e con
un occhio critico, quanto me lo poteva
permettere, prima che il regime, la mia stessa
formazione”.
La tua formazione... intendi quella di
persona, di essere umano...
“Certo. I miei ed io siamo montenegrini.
L’onore, l’ogoglio, l’onestà... non sono aria
fritta per noi. Vivevamo a Sarajevo, io avevo
sei anni (1934, nda) quando in occasione di
una celebrazione del “sacrificio” di Gavrilo
Princip mio padre, a nome dell’associazione
degli insegnanti della città, disse che se
il Princip fosse resuscitato e avesse visto
in che condizioni si viveva nel Regno di
Jugoslavia, sarebbe ritornato tra i morti.
Applausi dei presenti... e due giorni dopo
mio padre finisce in galera. Secondo aspetto
della mia formazione: come la maggior
parte dei coetanei, da ragazzino vivevo e
giocavo in strada. Nel giro di cento metri
quadrati avevamo la chiesa cattolica e quella
ortodossa, la sinagoga e la moschea, inoltre
né lo si sapeva né la cosa importava, tra
di noi, l’appartenenza etnica, nazionale,
religiosa e le relative, tante!, festività le
passavamo girando per le case e mangiando
i cibi tradzionali e i dolci... Terzo aspetto
della mia formazione. Ho appena tredici anni
quando Germania, Italia, Ungheria e Bulgaria
invadono la Jugoslavia e neanche quindici
quando mi aggrego ad una formazione
partigiana. Ho da aggiungere altro?”
Da qui, anche da qui, l’amore per i film
con argomento principale la guerra?
“Beh, essere cresciuto con la guerra e con
le sue conseguenze, come minimo ti fa
pensare, ti rende particolarmente sensibile
al tema, ti porta a volerne parlare per farlo
conoscere, scongiurare. Non per vantarmi,
la Voce
spettacoli
del popolo
martedì, 29 dicembre 2015
5
MINCIARE
ORDIENTE
ma sono tra i pochi cineasti che, trattando
questioni relative a fatti di guerra, ha sempre
perlomeno tentato di mettere in luce il
meglio che essa nonostante tutto riesce,
per contrasto, a scatenare: la solidarietà,
l’attaccamento alla vita, il recupero di valori
che appunto la follia e i massacri portano
all’annullamento”.
Già nel tuo terzo lungometraggio infatti –
parlo di ‘Kozara’ - protagonista non è tanto
la guerra in sé, i suoi eroi, quanto chi la
subisce, il popolo...
“Esatto, ma su questa falsariga si muove
anche La Guerra (Rat), che lo precede.
Diciamo che il film, con l’ottimismo un
po’ ludico di Cesare Zavattini, che ne fu lo
sceneggiatore, ingenuamente scongiura il
conflitto nucleare, di cui al tempo si parlava
con timore, quasi fosse predestinato”.
Con i tuoi primi tre film, due dei quali
cosceneggiati da cineasti italiani (il citato
Zavattini ed Elio Petri) sei di casa a Cannes
e a Venezia. Ad un certo momento invece
di pigiare sull’acceleratore, fare cioé un
ulteriore film da festival internazionale, da
mercato mondiale, fai un passo indietro.
È il 1963, Skopje, la capitale macedone,
viene distrutta da un potentissimo
terremoto... Bulajić “ricorda” di essere
stato un buon documentarista.
“Prendemmo immediatamente atto delle
proporzioni della tragedia, di cosa e quanto
avrebbe avuto bisogno la città, la Macedonia,
il Paese per tornare alla normalità. E ciò
era possibile solo con un forte contributo
internazionale. In men che non si dica
predisponemmo un’agenda di lavoro. Forte
del nome guadagnatomi, ottenni tutto ciò
che chiesi in tema di mezzi e uomini. Tre
giorni dopo il sisma, con la città letteralmente
fumante cominciamo a girare. Tra riprese
e montaggio se ne andrà quasi un anno di
lavoro. Alla fine la pellicola va a Venezia e a
Cannes. Arrivano numerosi premi, compreso
uno dell’UNESCO. Skopje è sulla bocca di
tutto il mondo, oltre i doverosi due, tre
giorni del dopo sisma. Cominciano anche ad
arrivare ingentissimi aiuti”.
Dai drammi veri crudi reali passi ovvero
torni a quelli cinematografici. Nel 1966
abbiamo “Lo sguardo nella pupilla del
sole” (Pogled u zjenicu sunca). Ancora
guerra, protagonisti questa volta sono i
singoli, non un popolo, non “la gente”.
Singoli, ma non “eroi”.
“A parte il fatto che personalmente sono
legato a tutti i miei film, devo dire che La
pupilla... è stato di capitale importanza per
convincermi ad affrontare il tema legato
alla pellicola che poi mi segnerà per il resto
della carriera, cioè La Battaglia della Neretva.
Mi spiego. Ne La pupilla... in primo piano
abbiamo il dramma di quattro combattenti
colpiti dal tifo... ma cosa succede quando
invece di quattro sono a migliaia, in piena
guerra, i feriti malati invalidi infermi
mutilati...
Al centro della cosiddetta “quarta offensiva
tedesca” è appunto la folle idea di un
capo partigiano che al rischio di perdere
definitivamente la guerra contro il nemico
– in campo accanto ai tedeschi c’erano
gli italiani, i cetnici e gli ustascia – vuole
assolutamente portare in salvo qualche
migliaio di feriti e malati, perché lasciarli
sul campo significherebbe condannarli a
sicura morte, dato che il nemico non era un
semplice esercito avverso, ma un insieme di
criminali uno peggio dell’altro”.
E arriviamo finalmente a ciò che ad
ogni comune mortale nato in questi loci
in tempi bui, interessa: come te la sei
vista con Tito, visto che era lui il capo
partigiano matto che vuole salvare capra
e cavoli? D’altronde, come non sentire il
parere, quando si parla di vicende in cui
è storicamente coinvolto, il PadrePadrone?
“Come immaginavo, il papa è papa, non...
papista. Mentre tutti – colleghi politici
amici, per non dire dei consiglieri di Tito
– mi dicevano che era una sciocchezza
fare un film in cui il vero protagonista
della vicenda ne è assente, non lo si
vede mai in campo, e poi – figuriamoci!
– senza di lui, che è un patito di cinema,
ecc., ecc. Ebbene, proprio Josip Broz Tito
in persona a quattrocchi, una volta che gli
spiegai il perché della mia scelta, mi disse
di andare per la mia strada - ‘e non ascolti
i miei consiglieri!’”.
creazione (collettiva, d’accordo) che ha
una gestazione molto lunga, a volte anni
di lavoro, tra preparazione produzione
e postproduzione; e non è finita, spesso
l’opera va poi accompagnata nella sua
promozione... Il nostro lavoro è sempre
un ricomiciare da capo, con alla base un
forte entusiasmo, oserei dire da ragazzini,
da esordienti. Insomma, tutto ciò di
cui mi sono occupato nel Treno..., nella
Neretva, nel Grande trasporto (premiato
a Firenze, nda), di tutto ciò mi sono poi
ri-occupato in Libertas ed ora, ma sono
appena agli inizi, del prossimo film che
entro il 2016 girerò”.
Cosa lo aveva convinto?
A quasi dieci anni da “Libertas”... torni
in Istria.
“Non me lo disse, ma penso due cose
fondamentali. La prima. Tutti avrebbero
visto nel film un’opera oleografica,
un ulteriore strumento di propaganda
politica e di innalzamento del culto della
personalità. E tutti, compresi coloro
che la storia della ‘quarta offensiva’ la
conoscevano, ne avrebbero messo in forse
la veridicità. Penso che ciò gli avrebbe
fatto molto male. Tito non rischiò la pelle,
né in quella né in altre occasioni, per
‘passare alla Storia’, ma perché credeva in
ciò che stava facendo. Se poi oggi, specie
in quest’area, che lui ha preservato dalla
guerra fratricida per quarantacinque anni,
c’è chi pensa il contrario, beh, non posso
che compatirli”.
Alla Storia, invece è “passato” il
tuo film: un istituto britannico (o
americano?) lo ha inserito nei dieci
migliori film di guerra di tutti i tempi.
Non c’è pellicola jugoslava, né tanto
meno croata che abbia ottenuto
un successo delle dimensioni
della “Neretva”: centinaia
di milioni di spettatori,
migliaia di articoli,
critiche, saggi. Che dire
poi della presenza di
tante riconosciute star,
anche solo per poche
inquadrature: Orson
Welles, Yul Brynner,
Sergej Bondarchuk,
Curd Jürgens, Oleg
Vidov, Sylva Koscina,
Franco Nero, Hardy
Kruger, Anthony
Dawson nonché tutto
il gotha attorale
jugoslavo, fatti salvi
(perché altrove
impegnati) Bekim
Fehmiu e Ljuba
Tadić... Che effetto
ti fa?
“Mi inorgoglisce.
Ma, bada, è
un sentimento
che nel mondo
cinematografico
abbiamo tutti.
Non esiste una
‘stanchezza’
un’‘abitudine’
al premio, al
riconoscimento,
ecc. L’opera
cinematografica,
pensaci bene, è una
“Sì, ma
mentre
allora
il paesaggio istriano rievocava le
campagne toscane, questa volta l’azione si
svolge proprio in Istria”.
Inutile chiederti i particolari. È tua
abitudine parlarne quantomeno
durante la lavorazione, non prima, ma
qualcosa mi potresti pur anticipare.
Non lo dico a nessuno. Non lo giuro!
“Appunto.... Allora. Reggiti forte. È una
storia d’amore, di ricordi, ricordi brutti
– la guerra – e belli, un incontro tra un
uomo e una donna, giovani entrambi;
un incontro ulteriore dell’uomo con
un’umanità insperata dentro i vortici della
guerra. Quindi, dopo tanti anni, il ritorno
in quelle terre del dramma e del giovanile
e occasionale amore. Una riflessione sulla
vita”.
Una rapsodia crepuscolare?
“Sarebbe ridicolo, al crepuscolo, parlare
di aurore”...
Sono le nove di sera. Ci lasciamo con un
“a rivederci sul set”: peraltro, pare che
tornerò a vestire i panni del contadino,
questa volta istriano e magari armato
di fucile (spero “contro l’invasor”).
Zagabria è avvolta nella caciara
prenatalizia, orgogliosa del titolo di
“destinazione prediletta per le festività
decembrine”. La cosa mi fa sorridere...
avendo vissuto inverni interi tra Roma e
Firenze, la capitale croata mi pare solo un
po’ più illuminata del solito e molto più
scopertamente consumistica.
Altro che Santo
Natale...
6
spettacoli
martedì, 29 dicembre 2015
MUSICA
la Voce
del popolo
a cura di Ivana Precetti
Q
uello di Fine Anno è sempre un
periodo di riflessione, su noi stessi
e sul nostro operato, un periodo in
cui si tirano le somme e ci si prepara per
affrontare al meglio ciò che ci prospetta
il futuro. Se, poi, lo si fa ascoltando
un buon disco, i pensieri scorrono più
facilmente e risultano anche più belli.
Perché la musica ha questo magico dono:
farti sentire meglio in ogni momento
della tua vita, anche quando le cose non
sembrano andare per il verso giusto.
Ma già che ci siamo, in tema di musica
avete mai tentato di stilare una vostra
classifica di quelli che potrebbero essere
gli album più belli di sempre? La storica
rivista statunitense “Rolling Stone” –
ampiamente considerata la principale
forza promozionale per la musica nella
cultura americana, assieme a MTV – lo ha
fatto compilando una lista dei 500 dischi
migliori di tutti i tempi.
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band
Noi ci limiteremo ai primi dieci iniziando
dal primo posto che spetta a “Sgt. Pepper’s
Lonely Hearts Club Band” dei Beatles. Si
tratta dell’ottavo album della discografia
ufficiale dei Fab Four. Messo in commercio
il 1° giugno 1967, è fra i più famosi della
storia del rock e uno dei primi concept
album della musica rock. Secondo una
stima delle vendite dei dischi musicali
riportata dalla stampa, “Sgt. Pepper“
ha totalizzato più di 32 milioni di copie
vendute. Vinse un Grammy Award nel
1967 come miglior album dell’anno.
Wikipedia scrive che “già pochi anni dopo
l’uscita del disco, il critico letterario Guy
Aston, dopo aver affermato che grazie a
tale album ‘i Beatles sono riusciti a fare
della musica pop qualcosa che si ascolta
seriamente, e che si potrebbe trattare
come qualsiasi altro tipo di espressione
artistica’, osserva che ‘l’influenza di
Sergeant Pepper sul pop è stata enorme’,
in quanto questo disco avrebbe dato
ispirazione a tutta una serie di album di
altri musicisti, che ambiscono a proporsi
come ‘discorsi definitivi sulla condizione
umana’. ‘I Beatles erano sempre stati
l’espressione di un mondo di adolescenti:
qui essi assumono volontariamente il
ruolo che in un primo tempo era stato
loro imposto dalla stampa, quello di capi
spirituali. Sergeant Pepper è per molti
aspetti un disco didattico per il pubblico;
i Beatles hanno scoperto la ‘liberazione
spirituale’ e vogliono estenderla al
mondo. Nelle canzoni che compongono
l’album, i Beatles cercherebbero di
insegnare una via per ‘migliorare la vita’ e
‘diminuire la solitudine attraverso vari atti
di liberazione psicologica, imparando ad
avere visioni, ad amare’”.
TRA I PRIMI DIECI DISCHI NELLA CLASSIFICA DELLA RIVISTA «ROLL
GLIALBUMPIùBELLI
LACORONASPETTA
Pet Sounds
Il secondo posto della classifica di
“Rolling Stone” è occupato da “Pet
Sounds” dei Beach Boys. È l’undicesimo
album in studio del gruppo statunitense,
pubblicato nel 1966 dalla Capitol Records.
Unanimemente riconosciuto come uno
degli album più influenti della storia della
musica pop, è spesso stato posto alla
prima posizione in numerose classifiche
di album migliori di tutti i tempi – scrive
Wikipedia –, come in quella del Times e
del New Musical Express. L’album, che
include brani celebri come Wouldn’t It
Be Nice e God Only Knows, è considerato
essenzialmente un lavoro solista di Brian
Wilson più che un album vero e proprio
dei Beach Boys, e fu creato nel periodo in
cui Wilson smise di andare in tour con il
gruppo per focalizzare la sua attenzione
sulla scrittura e la registrazione dei
brani. In “Pet Sounds“ Wilson arriva
a una musica molto più matura e
lontanissima dal sound originario, grazie
anche alla sperimentazione di strumenti
insoliti come campanelli di biciclette,
clavicembali, flauti, il Theremin e
l’abbaiare dei cani (tra cui Banana, quello
di Wilson). Anche la complessità delle già
intricate armonie vocali riceve un’ulteriore
spinta in avanti con l’impiego di elaborate
stratificazioni sonore a formare una sorta
di “sinfonia pop barocca”.
Revolver
Al terzo posto c’è invece “Revolver“, il
settimo album della discografia ufficiale
dei Beatles; venne messo in commercio
nel Regno Unito il 5 agosto 1966. In
esso si ritrovano, per la prima volta
nella discografia del gruppo di Liverpool,
elementi del rock psichedelico. “Revolver“
nasce dall’intreccio di questi filoni e la
traccia finale, Tomorrow Never Knows, ne è
la sintesi più eloquente. Come ebbe a dire
il tecnico di studio Geoff Emerick – che
giocò una parte rilevante nelle sonorità
dell’album –, “Dal giorno in cui uscì,
Revolver cambiò per tutti il modo in cui si
facevano i dischi. Nessuno aveva mai udito
niente di simile“. Il lavoro costituisce anche
il punto di equilibrio nelle dinamiche del
duo Lennon e McCartney. Se il primo aveva
fino ad allora rappresentato l’elemento
più autorevole, e perciò a lui era riservata
la linea vocale della traccia di apertura e
quella di chiusura nella maggioranza degli
album precedenti, dopo “Revolver“ Paul
avrebbe giocato un ruolo primario nella
restante parte della carriera dei Beatles, e
non solo dal punto di vista musicale.
Highway 61 Revisited
Segue, al quarto posto, “Highway 61
Revisited” di Bob Dylan, pubblicato
nell’agosto del 1965. Cuore della cosiddetta
“trilogia elettrica” (iniziata con Bringing It
All Back Home e proseguita con Blonde On
Blonde), è universalmente considerato uno
dei migliori lavori di Dylan, nonché una
fondamentale pietra miliare della musica
contemporanea. “Highway 61 Revisited“
fu inciso in soli sei giorni. La Highway 61 è
una strada americana che va dal Minnesota
(Stato di nascita di Dylan) fino alla foce del
fiume Mississippi. L’album fu decisamente
rivoluzionario, soprattutto per i testi, ma
anche per Dylan stesso: segnò finalmente
il definitivo passaggio del cantautore alla
chitarra elettrica. La canzone di apertura
dell’album, Like a Rolling Stone (che
alcuni ipotizzano scritta pensando a Edie
Sedgwick, musa di Andy Warhol e amica di
Dylan), ha riscosso un enorme successo ed
è diventata un inno generazionale.
Rubber Soul
La rivista “Rolling Stone“ ha piazzato al
quinto posto un altro disco dei Beatles,
“Rubber Soul” uscito nell’autunno del
1965. È un album pubblicato quando il
gruppo di Liverpool era al culmine della
popolarità. È il primo disco dei Beatles
a non riportare il nome del gruppo sulla
copertina. Nella discografia dei Fab Four,
“Rubber Soul“ è considerato uno degli
album più curati sul piano tecnico e uno dei
più innovativi dal punto di vista musicale,
e c’è chi vi ravvisa il raggiungimento
della maturità artistica del gruppo
inglese. Ritenuto l’anello di raccordo fra
la musica ancora legata a quella degli
esordi di “Help!“ e lo sperimentalismo di
“Revolver“, “Rubber Soul“ rappresenta
indiscutibilmente un salto di qualità nella
produzione beatlesiana per la maggiore
ricchezza e pienezza del suono ma anche
perché i quattro Beatles cominciavano
in quel periodo ad acquisire maggiore
consapevolezza e coinvolgimento delle fasi
tecniche di registrazione e di missaggio.
L’album fu registrato in sole quattro
settimane, al termine di un tour negli Stati
Uniti apertosi il 15 agosto di quell’anno con
la storica esibizione allo Shea Stadium di
New York. A soli quattro mesi dall’uscita
di “Help!“ fu pubblicato nel Regno Unito,
in tempo per le festività natalizie, il 3
dicembre, contemporaneamente al singolo
We Can Work It Out/Day Tripper, facendo
ottenere così al gruppo, per il terzo anno
consecutivo, il primo posto nella classifica
delle vendite natalizie di dischi sia a 33 che
a 45 giri. Paul contribuì a rendere il suono
più pieno e ricco sostituendo in studio di
registrazione il fidato Höfner – che avrebbe
continuato a utilizzare nelle esibizioni
dal vivo – con un basso Rickenbacker
appositamente costruito per mancini.
Per “Rubber Soul“ – scrive Wikipedia –
spettacoli
la Voce
del popolo
martedì, 29 dicembre 2015
7
brani pop come Lost in the Supermarket;
altri generi in cui spazia l’album sono il
reggae, il rockabilly, il rhythm and blues,
il jazz. È considerato, sempre dalla rivista
“Rolling Stone“, come il migliore album
degli anni Ottanta, pur essendo uscito nel
dicembre 1979. Con oltre due milioni di
copie vendute nel mondo, l’album è stato
certificato disco di platino e disco d’oro
negli Stati Uniti, oltre che disco d’oro e
d’argento nel Regno Unito, dando una
notorietà a livello mondiale al gruppo.
Blonde on Blonde
“Blonde on Blonde“ di Bob Dylan si è
classificato al nono posto dei migliori
album di sempre. È il settimo album
discografico del celebre cantautore
pubblicato nel 1966 dalla Columbia
Records. Il disco è ritenuto il primo
significativo album doppio della storia
del rock, anticipando di un mese “Freak
Out!“ di Frank Zappa, e segna il definitivo
passaggio dall’era del 45 giri a quella
del 33 giri. Viene spesso indicato dalla
critica come uno dei più grandi album
di tutti i tempi. Conclude la cosiddetta
“trilogia elettrica” di Dylan, cominciata con
“Bringing It All Back Home“ e proseguita
con “Highway 61 Revisited“ (ambedue del
1965). Le sessioni di registrazione ebbero
inizio a New York nell’ottobre del 1965,
con la partecipazione di numerosi session
men, inclusi i membri della backing band
di Dylan dal vivo, i “The Hawks“ (più tardi
“The Band“). Le sedute continuarono fino
al gennaio 1966, ma soltanto una traccia
che finì sull’album fu completata, One of
Us Must Know (Sooner or Later). Dietro
suggerimento del produttore Bob Johnston,
Dylan, accompagnato dal tastierista Al
Kooper e dal chitarrista Robbie Robertson,
si trasferì a Nashville, Tennessee. Queste
sessioni, con l’apporto di alcuni musicisti
della scena locale, furono maggiormente
fruttuose, e nel febbraio-marzo ‘66 si
ebbe la registrazione di tutte le rimanenti
canzoni dell’album. L’album raggiunse
la posizione numero 9 nella classifica
statunitense Billboard 200, diventando
doppio disco di platino, e la posizione
numero 3 in Gran Bretagna. Dall’album
furono estratti due singoli di successo:
Rainy Day Women #12 & 35 e I Want
You. Due canzoni presenti sull’album, Just
Like a Woman e Visions of Johanna, sono
considerate tra le migliori composizioni di
Dylan, e sono state entrambe inserite nella
lista delle 500 migliori canzoni di sempre
redatta dalla rivista “Rolling Stone“.
LING STONE» CE NE SONO BEN QUATTRO DEI FAB FOUR
White Album
LIDITUTTIITEMPI:
AIBEATLES
furono utilizzate tecniche di registrazione
innovative, poi evolutesi nelle moderne
forme di missaggio elettronico e digitale.
What’s Going On
Il sesto posto della classifica RS è occupato
da “What’s Going On“ di Marvin Gaye,
pubblicato nel 1971 dall’etichetta discografica
Tamla-Motown Records. L’album tratta temi
come l’abuso di droga, la povertà e la guerra
del Vietnam, e per questo inaugurò un nuovo
corso nella musica soul. Viene considerato
una sorta di concept album, dato che alcune
tracce fanno da introduzione alla successiva.
Viene anche catalogato come album Song
cycle, perché la traccia finale riprende la
traccia iniziale dell’album. I temi trattati sono
interpretati dal punto di vista dei veterani
della guerra del Vietnam, che fatto ritorno
a casa non vedono altro che ingiustizia,
sofferenza e odio.
Il successo commerciale e critico dell’album
fu immediato. Rimase per oltre un anno
nella classifica degli album pop di Billboard
e le vendite superarono i 2 milioni di copie
fino alla fine del 1972, diventando così
l’album del cantante con le migliori vendite
fino a quel momento. Inoltre “What’s Going
On“ ricevette anche i migliori punteggi
da varie riviste musicali e non, tra le quali
“Time“, “Rolling Stone“ (per il quale diventò
Album dell’anno), “The New York Times“
e “Billboard“, che gli attribuì il Billboard
Trendsetter Award del 1971. Un sondaggio
del 1999 condotto dal giornale inglese
“Guardian/Observer“ lo nominò Miglior
album del XX secolo.
Exile on Main Street
Al settimo posto figura “Exile on Main
Street“ dei The Rolling Stones, pubblicato
nel 1972. Si tratta della decima uscita in
Gran Bretagna e la dodicesima negli Stati
Uniti della band. Album doppio, uscito il
12 maggio in Inghilterra e il 22 maggio
negli USA, “Exile on Main Street“ aveva
come titolo provvisorio “Tropical Disease“
(“malattia tropicale”) poi sostituito con
quello noto. Raggiunse il numero 1 sia
nella classifica inglese, sia in quella
statunitense, rimanendovi rispettivamente
per una e quattro settimane. Il 23 maggio
2010 la riedizione dell’album ha esordito
direttamente alla prima posizione della
classifica di vendita inglese. Il titolo
dell’album, che in italiano è traducibile
come “In esilio sulla strada principale”,
allude all’esilio della band dall’Inghilterra
a causa di problemi con il fisco con
conseguente trasferimento in Francia.
Infatti, le registrazioni sono state fatte
nella cantina della villa in Francia di
Keith Richards. In questo album – scrive
Wikipedia – si instaura un duello tra blues e
boogie, tra rumore e silenzio, tra armoniche
country e chitarre slide in giubilo. La
canzone più famosa è probabilmente
Tumbling Dice, ma molto note sono pure
Rocks Off, Shine a Light, Sweet Virginia,
All Down the Line e Happy. Quest’ultima
fu incisa da Keith Richards insieme al
produttore Jimmy Miller e al sassofonista
Bobby Keys mentre aspettava gli altri
membri che erano in ritardo in studio.
London Calling
L’ottavo posto della classifica RS spetta
ai The Clash con “London Calling”. È
un album doppio uscito nel 1979, con il
quale il gruppo si impose negli Stati Uniti.
L’album si compone di 19 brani, accreditati
a Joe Strummer e Mick Jones, tranne The
Guns of Brixton di Paul Simonon, Brand
New Cadillac di Vince Taylor e Revolution
Rock di Jack Edwards e Danny Ray. Il
disco presenta una notevole complessità
compositiva e mescolanza dei generi:
sebbene non vi siano ravvisabili canzoni
classificabili come puro punk, vi sono
pezzi ska, come Rudie Can’t Fail, insieme a
Concludiamo la lista con “White Album“
(o “The Beatles”) dei Fab Four, al decimo
posto della classifica RS. È il nono album
ufficiale della storica band inglese. Meglio
noto come ”White Album“, per via della
copertina totalmente bianca (con il nome
del gruppo stampato semplicemente
in rilievo), il disco fu pubblicato il 22
novembre del 1968 dalla Apple Records.
Verso la fine del maggio 1968, poco
prima di iniziare a lavorare al nuovo
album, i Beatles si ritrovarono nella casa
di George Harrison a Esher, nel Surrey, e
con un registratore Ampex a quattro piste
incisero i nastri di prova delle loro recenti
composizioni, materiale denominato
“The Kinfauns Demos“ o “The Esher
Session“, di mediocre qualità tecnica però
rivelatore della genesi di molti pezzi del
prodotto finale. La formazione era reduce
dalla trasferta in India e dall’esperienza
della meditazione trascendentale nel
ritiro di Rishikesh, sotto la guida del
guru Maharishi. L’ashram di Rishikesh fu
determinante per la crescita compositiva
e strumentale dei quattro musicisti: la
serenità e il tempo libero, che concedevano
loro spazi di creatività e tempi per comporre
nuove canzoni, e l’assenza di elettricità che
li costrinse a utilizzare le chitarre acustiche,
raffinandone le competenze strumentali e
imparando da Donovan (altro discepolo del
Maharishi) la tecnica del finger-picking – che
sarebbe stata usata in più di una traccia
dell’album – contribuirono in maniera
fondamentale alla realizzazione del disco.
Il gruppo tornò dall’India con una trentina
di composizioni, molte delle quali finirono
nei “Kinfauns Demos“. Il produttore George
Martin – scrive Wikipedia – si disse subito
contrario a che si realizzasse un album
doppio, avanzando con forza l’opinione che
la carta vincente sarebbe stata piuttosto
un album singolo di alta fattura. I Beatles
però erano ormai orientati a incidere un
doppio album, e nonostante il parere di
Martin scelsero di insistere nel loro progetto
iniziale.
8
martedì, 29 dicembre 2015
LA RECENSIONE
IL FILM «COLPI DI
FULMINE» DI NERI
PARENTI È UNA
CLASSICA COMMEDIA
ROMANTICA A EPISODI
L
a soluzione migliore per
evadere dalla realtà troppo
spesso pesante e opprimente
e allontanarsi dal flusso incessante
di informazioni con le quali
il mondo contemporaneo ci
sommerge quotidianamente è
l’abbandono a risate spensierate.
Ma qual è il periodo dell’anno
più idoneo? Il mese di dicembre.
Le sale cinematografiche italiane
propongono ormai da decenni,
tradizionalmente nel periodo
natalizio, i cosiddetti cinepanettoni, il cui solo intento è far
ridere e divertire.
I film di carattere prevalentemente
comico sono la “condicio sine qua
non” nel periodo festivo. Quattro
risate e un lieto fine sono la formula
vincente.
Quest’anno la Comunità degli
Italiani di Fiume ha promosso
una serie di proiezioni di film
italiani per dare il benvenuto alle
festività natalizie, proponendo
un programma composto da un
genere particolare di film: la
commedia all’italiana. Al posto dei
cine-panettoni qui si riprende una
tradizione più seria, meno volgare
ma ugualmente divertente: la
commedia all’italiana è un genere
particolare in cui, nelle situazioni
comiche, anche assurde, troviamo
sempre una dose di serietà. Infatti,
i temi ruotano spesso intorno
alla corruzione e non manca un
atteggiamento critico verso la
società. Il tutto è condito con un
umorismo disarmante.
la Voce
del popolo
Anno 1 /n. 06 / martedì, 29 dicembre 2015
IN PIÙ Supplementi è a cura di Errol Superina
[email protected]
SPETTACOLI
Edizione
Caporedattore responsabile f.f.
Roberto Palisca
Redattore esecutivo
Helena Labus Bačić
Impaginazione
Denis Host-Silvani
Collaboratori
Sandro Damiani, Ivana Precetti, Dragan Rubeša, Ana Varšava
Foto
Creative Commons
spettacoli
la Voce
del popolo
di Ana Varšava
L’AMOREALL’ITALIANA
Film selezionati da Mario de Luyk
I tre film proposti, selezionati dal
noto critico triestino Mario de Luyk
e proiettati nel Salone delle Feste
del Palazzo Modello, sono opere di
celebri registi italiani: Il ragazzo
invisibile (2014), di Gabriele
Salvatores, Sotto una buona stella
(2014), diretto da Carlo Verdone,
e Colpi di fulmine (2012), di Neri
Parenti, sul quale è incetrato questo
testo.
Il filone dei cine-panettoni ha le
sue origini nel 1983. Molto spesso
è caratterizzato da volgarità e da
rappresentazioni stereotipiche di
italiani in diverse situazioni. Uno
degli esponenti di spicco del filone è
Neri Parenti, il regista del succitato
film Colpi di fulmine. Nel film ci
troviamo di fronte a una situazione
particolare del momento che il
regista evita di utilizzare i motivi
caratteristici del genere. La pellicola
è invece definita come una “classica
commedia romantica a episodi“,
nonostante abbia qualche punto in
comune con un cine-panettone: la
sua première si è svolta nel mese di
dicembre del 2012. Il film racconta
due storie il cui punto in comune è
appunto il colpo di fulmine, ossia il
tema dell’amore.
“Il Prete” con Christian de Sica
Nel primo episodio, intitolato “Il
Prete”, Christian de Sica, nei panni
dello psichiatra Alberto Benni,
si trova in una situazione poco
invidiabile: mentre guarda dalla
finestra vede arrivare la guardia
di finanza giunta per arrestarlo,
in quanto ingiustamente accusato
di corruzione. Chiama il fratello
avvocato Carlo per un consiglio.
Egli è innocente, ma il fratello gli
suggerisce di fuggire e cambiare
identità. Ci penserà dopo a chiarire
la situazione. Il dottor Benni si
troverà in seguito in una serie di
situazioni comiche, a partire dalla
scena in cui si traveste da prete.
Durante la fuga conosce per caso don
Dino; il prete è in viaggio verso un
paesino in cui nessuno lo conosce e
gli offre un passaggio. Ben presto i
due hanno un incidente stradale e il
prete vero perde permanentemente
la memoria. A Benni non resta altro
che approffitare della situazione.
Trova, pertanto, un rifugio perfetto
nel paese di don Dino. Nei panni di
prete Alberto attira numerosi fedeli
grazie ai suoi metodi poco ortodossi,
soprattutto durante le confessioni
che gli riescono molto bene, essendo
psichiatra di professione. A piano a
piano, le cose si complicano, ma alla
fine tutto si risolverà, nonostante
si tratti di un episodio in cui non
mancano le forzature nella trama.
Ci sarà il “colpo di fulmine” tra
“il prete” Alberto, un innocente in
fuga dalla legge, e il maresciallo
dell’Arma, Angela, ma tutto si
concluderà con un lieto fine.
“Corpo de Furmine”
La seconda parte, che porta il titolo
“Corpo de Furmine”, si concentra
sulla storia d’amore a prima vista tra
Adele, una pescivendola popolana
con i modi volgari, e un’ambasciatore,
Ermete Maria Grilli, un’uomo erudito
e poliglotta. Insistendo sull’alto grado
di conoscenza della lingua francese,
sui modi cortesi e sull’alta cultura
egli assume l’autista Ferdinando che
dimostra di possedere tutte queste
qualità. Tuttavia, il colpo di fulmine
porterà l’ambasciatore a trasformarsi
in un “romanaccio” dopo che il
suo autista accetta di insegnargli i
modi “alla romana“, che prima di
innamorarsi detestava.
All’inizio, il modo di parlare dei due,
in un italiano colto, viene scambiato
per un’altra lingua dai pescivendoli
“romanacci” al mercato. Nel suo
tentativo di diventare un vero romano,
Ermete si trasforma in maniera
tale da mettere addirittura nei guai
sé stesso e il suo fedele autista.
Impara a parlare il dialetto romano
e in occasione di una protesta dei
pescivendoli, tra i quali c’è pure la
sua adorata Adele, viene costretto a
portare una maglietta con la scritta
“Ermete Maria Grilli è uno stronzo”
davanti all’ambasciata e a protestare
contro sé stesso. Si dimostra, però,
un uomo coraggioso con un grande
cuore, sempre pronto ad aiutare
il prossimo. Nell’epilogo ci sarà
un rovesciamento dei ruoli in cui
Adele, ora nel ruolo di futura moglie
dell’ambasciatore, attraverserà dei
grandi cambiamenti e fingerà dinanzi
alla madre di Ermete di conoscere
il francese che studia sotto la
supervisione del marito. Così come
lui un tempo cercava di adeguarsi a
lei. Il matrimonio a Ginevra chiude
una storia complessa e ricca di scene
comiche. Le interpretazioni degli
attori nel secondo episodio sono
convicenti il che rende la storia
particolarmente intrigante. Speriamo
che con questo vi abbiamo spronati
a vedere qualche film a lieto fine nel
periodo festivo. Buone Feste!