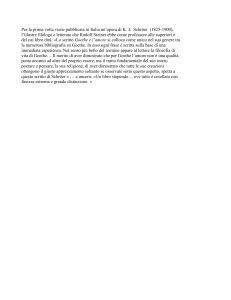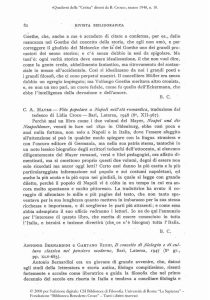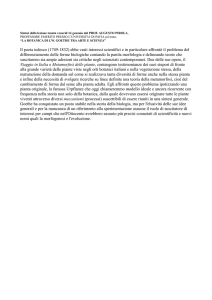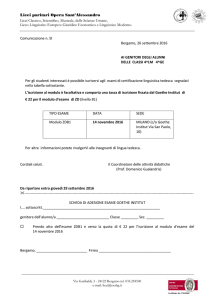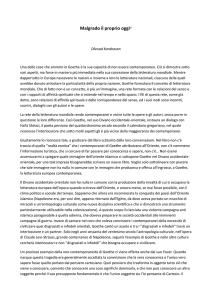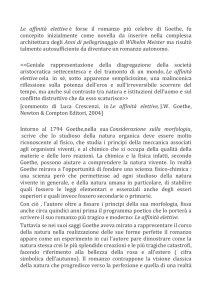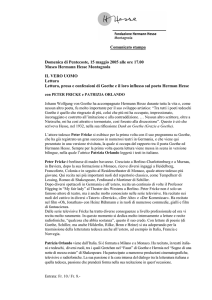La formazione della forma.
Note su come partire da un elefante
e arrivare a una tartaruga∗
Chiara Cappelletto
Se c’era in loro una parte umida di qualche succo e terrosa,
questa passò a fungere da corpo;
ciò che era solido e impossibile a piegarsi, si mutò in ossa;
quelle che erano vene, rimasero, con lo stesso nome.
[. . . ] i sassi scagliati dalla mano dell’uomo assunsero l’aspetto di uomini,
dai lanci della donna rinacque la donna.
(Ovidio, Metamorfosi, libro I, vv. 407-413)
«Una mattina Gregorio Samsa, destandosi da sogni inquieti, si trovò mutato
in un insetto mostruoso»1 . Nella sua camera, un giorno qualsiasi di buon’ora, un
commesso viaggiatore emerge da un sonno agitato, si sveglia e si riconosce nel corpo di uno scarafaggio: senza tentare di pensare «Io sono come uno scarafaggio»
egli ammette invece «Io sono uno scarafaggio»2 . E così, tra le mura domestiche di
una famiglia in ansia per la propria situazione economica, un uomo si aggrappa ai
bordi del letto con zampe da insetto e la stanza risuona dell’eco del battito d’ali delle figlie di Minia trasformate in pipistrelli3 . Dalla creazione mitica all’invenzione
∗ Questo saggio è stato presentato al convegno Animalità. Etica ed estetica animale, organizzato da Maddalena Mazzocut-Mis e svoltosi presso l’Università degli Studi di Milano il 13 e
18 Dicembre 2002.
1 F. Kafka, La metamorfosi, tr. it. di A. Rho, “Introduzione” di G. Baioni, Rizzoli, Milano 1975,
p. 53.
2 Si veda G. Baioni, “Introduzione”, in F. Kafka, op. cit.
3 Si veda Ovidio, Metamorfosi, a cura di P. Bernardini Marzolla, con uno scritto di I. Calvino,
Einaudi, Torino 1994, libro IV, vv. 400-415.
c 2002 ITINERA (http://www.filosofia.unimi.it/itinera/)
Copyright Il contenuto di queste pagine è protetto dalle leggi sul copyright e dalle disposizioni dei trattati internazionali.
Il titolo e i copyright relativi alle pagine sono di proprietà di ITINERA. Le pagine possono essere riprodotte e
utilizzate liberamente dagli studenti, dagli istituti di ricerca, scolastici e universitari afferenti ai Ministeri della
Pubblica Istruzione e dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per scopi istituzionali, non a fine
di lucro. Ogni altro utilizzo o riproduzione (ivi incluse, ma non limitatamente a, le riproduzioni a mezzo stampa,
su supporti magnetici o su reti di calcolatori) in toto o in parte è vietata, se non esplicitamente autorizzata per
iscritto, a priori, da parte di ITINERA. In ogni caso questa nota di copyright non deve essere rimossa e deve
essere riportata anche in utilizzi parziali.
ITINERA – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura
letteraria, gli uomini si trasformano in animali, e noi conosciamo metamorfosi senza causa e senza ritorno, cui siamo pronti a rifiutare ogni spiegazione scientifica,
e che siamo però altrettanto disponibili ad ammettere come “possibili”. Possibili, tuttavia, in modo affatto preciso e particolare. Nessuna figura retorica di senso
è sufficiente a trasformazioni simili; l’intraducibilità della metafora non potrebbe
equivalere all’infondatezza cui aprono quei “sogni inquieti”, la cui unica funzione
è di dirci che una notte – il tempo senza storia – è passata, incorniciando l’evento
e risolvendo così la necessità di un incipit causale. Non si tratta qui della possibilità della finzione fantastica; noi non abbiamo infatti bisogno di credere a tali
metamorfosi, né di ammetterle: anzitutto, noi le concepiamo.
Cosa può significare, allora, riconoscere qualcosa come possibile e, insieme,
irrealizzabile e infattibile? In uno dei lavori dedicati a quella che potremmo definire un’epistemologia del mito, Paul Valéry scrive: «“Spiegare” non è altro che
descrivere una maniera di fare, significa rifare col pensiero. Il perché e il come,
che sono solo espressioni che questa idea esige, si inseriscono in ogni discorso,
pretendono di essere soddisfatte a ogni costo. La metafisica e la scienza non fanno
che sviluppare senza limiti questa esigenza. È anche possibile che essa conduca
a fingere di ignorare quel che si sa, quando quel che si sa non è riconducibile in
modo chiaro a qualche saper fare. . . Ecco ripresa la conoscenza alla sua origine»4 .
«Come è inevitabile in materia di supposizioni, quel che si suppone è dedotto da
quel che si ha bisogno di supporre [. . . ]. Ecco qui il movente del nostro famoso
Principio di Causalità»5 . Possiamo allora dire, in prima istanza, che il decorso
metamorfico si pone a lato del sistema scientifico e tecnologico di matrice newtoniana, escludendo l’eziologia da un lato e il perseguimento di risultati dall’altro. Il
divenire metamorfico è oggetto di una descrizione in cui si portano a espressione
processi.
Proviamo quindi a considerare il concetto di possibilità rispetto alla sua sola
valenza descrittiva, proteggendola da proposte esplicative che vogliano dar conto
del fatto che “a un certo punto è avvenuto che” un signore si sia svegliato scarafaggio. La domanda non cadrà così sulle molteplici condizioni di possibilità in virtù
delle quali un evento può o meno essere indotto o previsto, ma sui criteri secondo i quali descrivendolo, lo si accetta come possibile. Non è difficile immaginare
che il mondo sia diverso da quello che è. Tale diversità può essere imputata a un
particolare evento catastrofico coerente con il mondo al cui interno si verifica –
un repentino innalzamento del livello delle acque che arrivano così finalmente a
sommergere del tutto la città di Venezia –, oppure può essere postulata, immaginando un mondo che, a un certo momento, si trovi a essere diverso in quanto tale,
un mondo in cui siano cambiate le regole del gioco che, mutando, hanno mutato il
gioco in cui vigono. Il primo è il mondo di Robinson Crusoe, il secondo quello di
Alice.
4 P. Valéry, “L’uomo e la conchiglia”, in All’inizio era la favola.
di R. Gorgani, a cura di E. Franzini, Guerini, Milano 1988, p. 62.
5 Ibid., p. 70.
2
Scritti sul mito, tr. it.
ITINERA – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura
In ciascuno di essi si avrà una declinazione specifica della meraviglia. Nel
primo si prova meraviglia per qualcosa che siamo abituati a conoscere e che ci sorprende quando e perché si presenta differente per alcuni aspetti: mi meraviglio per
la taglia di un cane, che conosco come più piccolo, e che però posso effettivamente
immaginare di dimensioni diverse. Nel secondo la meraviglia è rivolta alla forma
eidetica stessa dell’oggetto considerato ma, come scrive Wittgenstein qualche tempo dopo aver affrontato il problema della forma logica nel Tractatus: «Dire “mi
meraviglio di questo e di quest’altro” ha senso solo se posso immaginarmi che le
cose non stiano così»6 , e dunque «non ha senso dire che mi meraviglio per l’esistenza del mondo, poiché non posso immaginarmelo come non esistente. [. . . ]
Se, per esempio, avessi una tale esperienza mentre guardo il cielo azzurro, potrei
meravigliarmi del suo essere azzurro, invece che coperto di nubi. Ma non è questo
che voglio dire. Mi sto meravigliando del cielo, comunque esso sia»7 . Mentre
nel primo caso posso solo considerare che si realizzi una modificazione in linea di
principio già possibile, nel secondo non faccio che esprimermi secondo la forma
della tautologia, meravigliandomi per la semplice esistenza di qualcosa che è come
è. Il primo atteggiamento è di matrice scientifica, il secondo di matrice metafisica:
la doppia morsa ricordata da Valéry ci tiene ancora. Potremmo allora sollevare il
dubbio che, seppur celato, un elemento fondativo viga tanto per Robinson Crusoe
quanto per Alice e sia, semplicemente, quel gesto istitutivo e demiurgico che presiede a ogni creazione. È dunque l’individuazione del momento della creazione,
dell’origine, del principio che pone problemi all’ambizione descrittiva di ciò che
semplicemente incontriamo come esistente.
Lo studio del regno animale oppone diverse resistenze a questa logica del cominciamento che è, in certo senso, allopatica per la posizione di osservatore estraneo che assegna all’essere umano. Gregorio Samsa è uno scarafaggio che non può
che comportarsi da uomo: come già ci indica Kafka, la metamorfosi è una variazione che non dimentica la propria origine, sebbene nulla si possa dire sulla sua
genesi. All’alba del logos filosofico Senofane poteva criticare l’atteggiamento antropomorfico, affermando che «gli Etiopi asseriscono che i loro dei sono camusi e
neri, i Traci che sono azzurri di occhi e rossi di capelli»8 , e continuava: «Se avessero mani i bovi, i cavalli e i leoni, o fossero in grado di dipingere e di compiere con
le proprie mani opere d’arte come gli uomini, i cavalli rappresenterebbero immagini di dei e plasmerebbero statue simili a cavalli, i bovi a bovi, in modo appunto
corrispondente alla figura che ciascuno possiede»9 . Nell’epoca della sua genealogia non possiamo non riconoscere che è l’uomo a essere animale, sottomesso come
ogni animale alle leggi dell’universo. In L’occhio di Medusa, dedicato a descrivere
le analogie dei modi in cui uomini e animali esprimono la propria natura rivelando6 L. Wittgenstein, Lezioni e conversazioni sull’etica, l’estetica la psicologia e la credenza
religiosa, a cura di M. Ranchetti, Adelphi, Milano 1995, p. 13.
7 Ibid., pp. 13-14.
8 Senofane, Testimonianze e frammenti, a cura di M. Untersteiner, La Nuova Italia, Firenze 1956,
fr. 16.
9 Ibid., fr. 15.
3
ITINERA – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura
ne le affinità, Roger Caillois si chiede: «Perché allora [dal momento che l’uomo è
un animale come gli altri] supporre aprioristicamente che sia necessariamente una
mania, un’illusione o un miraggio la pretesa di ritrovare altrove le proprietà della
sua natura o, inversamente, di ritrovare in lui le leggi che si constatano reggere le
altre specie?»10 . Questa sarebbe infatti una supposizione altrettanto presuntuosa
che la precedente, solo espressa con un diverso grado di ingenuità.
Al Muséum National d’Histoire Naturelle di Parigi si possono visitare le Galeries d’Anatomie comparée et de Paléontologie, cui lavorarono Georges Cuvier e
Geoffroy Saint-Hilaire, che lo chiamò nel 1795. All’entrata, il visitatore è accolto
da una statua d’uomo. Alle sue spalle una teoria di scheletri, tutti similmente bianchi e arcuati; essa mostra il regno animale nelle sue diverse forme, che trovano la
propria espressione nella catena evolutiva secondo una segreta legge di affinità. La
funzione di cornice che quella statua è chiamata ad assolvere, fungendo insieme da
punto sorgivo della conoscenza di tutto ciò che le si apre dietro e da punto finale di
un cammino teleologico è, nella sua forza ideologica, estremamente ambiziosa.
Come possiamo infatti rappresentarci un continuum che si modifica permanentemente, secondo variazioni infinitesimali cui noi partecipiamo e che insieme miriamo a descrivere? Infatti, «non possiamo immaginare il processo vivente se non
attribuendogli un’andatura che ci è propria e che è del tutto indipendente da quel
che accade nell’essere che osserviamo»11 . Il ritmo evolutivo del mondo naturale
sembra mettere in scacco l’aspirazione alla conoscenza di ogni singolo uomo, limitato dal ritmo biologico a lui proprio. Alla risoluzione del problema della «doppia
andatura» dello sviluppo naturale e della sua descrizione si dispone l’universalizzazione dell’indagine scientifica cui mira il sistema deduttivo con la sua ambizione
eternante e olistica. Di tale ambizione esiste, però, anche una diversa declinazione;
come scrive Goethe in una nota massima: «Per capire che il cielo è azzurro dappertutto non c’è bisogno di fare il giro del mondo»12 . La totalità non è, come tale,
qualcosa che si possa cogliere solamente con una visione panoramica, da una vetta
raggiunta per un cammino diairetico. Essa è piuttosto una rete di analogie, ciascuna delle quali si presenta come variazione che condivide con le altre il medesimo
archetipo, la medesima Ur.
Nel secondo decennio dell’Ottocento Goethe dedica alcuni studi alla meteorologia, approfittando del compito di supervisore della costruzione di una stazione
meteorologica a nord di Weimar. Nel 1815 legge On the Modification of Clouds,
and the Principles of their Production, Suspension and Destruction di Luke Howard, farmacista, chimico, meteorologo dilettante, e finalmente, nel 1820, pubblica
La forma delle nuvole secondo Howard. Il lavoro goetheano non mira a essere classificatorio come quello dello studioso inglese, così come, discostandosi da Linneo,
non vi aveva mirato negli studi di botanica. Piuttosto, Goethe trovava auspicabile
«dar forma all’informe, conferire una normativa all’infinito mutare delle figure»13 .
10
R. Caillois, L’occhio di Medusa, Cortina, Milano 1998, p. 11.
P. Valéry, op. cit., p. 74.
12 J.W. Goethe, Massime e riflessioni, a cura di S. Giametta, BUR, Milano 2002, n. 568.
13 Id., La forma delle nuvole, a cura di G. Rovagnati, Archinto, Milano 2000, p. 55.
11
4
ITINERA – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura
Se questa è la ragione e la meta della sua indagine, le nuvole ne sono un oggetto
particolarmente adatto: il loro mutamento è imprevedibile e incessante, la loro conformazione mutevole, il loro sviluppo indipendente dalla volontà umana. Goethe
chiamerà ciò «il vecchio gioco delle nuvole che si dissipano e riprendono corpo,
senza risultati»14 . Esse si mostrano in variazioni che non raggiungono stadi determinati e determinabili. In una sorta di diario, di tale gioco Goethe annota le regole:
i conflitti che si susseguono fra le regioni atmosferiche, le condizioni climatiche,
i venti e le temperature; infine distingue strati, cirri, cumuli e nembi, e descrive
modificazioni semplici, modificazioni intermedie, modificazioni miste. Allo stesso modo ne La metamorfosi delle piante aveva discriminato i tre modi in cui tale
metamorfosi si manifesta, per poi raccontare la storia della parentela dei diversi
organi della pianta.
Perché tale attenzione all’articolazione delle distinzioni se l’interesse non è
volto alla classificazione? Perché da un lato l’apparente omogeneità nel modo
di presentarsi di ciò che vediamo genera confusione, e dall’altro, come avverte
Valéry, l’intelligibilità alla vista può essere accompagnata dall’opacità della riflessione, ogni volta che necessità e libertà, regole ed eccezione risultino convocate
insieme. Caso e caos sembrano infatti le uniche leggi, finché non si guardi alla trasformazione dei fenomeni come all’oggetto cui riconoscere perspicuità attraverso
la descrizione. È per tale ragione che, come nota Caillois, mirando all’archetipo
«Leonardo [. . . ] con tutto il suo genio non è riuscito a creare una sola macchina
in grado di funzionare: i suoi velivoli assomigliano troppo a degli uccelli e manca
poco che i suoi sommergibili abbiano le branchie. Non si è nemmeno sognato di
sostituire l’ala con l’elica, cioè l’organo con il motore»15 . Specularmente, ricorda
Goethe in Poesia e verità, Lavater, nonostante il suo grande talento osservativo che
gli permetteva di procedere con sicurezza nelle differenze fisiognomiche, mancava tuttavia della capacità di comprendere e organizzare le infinite distinzioni che
individuava via via.
Se lo scopo è dunque indagare la variazione, perché cogliendola esercitiamo un
modo di conoscere capace insieme di dar conto dell’esistente e di salvaguardarne il
principio formativo, allora bisogna mostrare la formazione della forma: «La teoria
delle forme è una teoria della trasformazione»16 . Per far ciò un processo esclusivamente analogico sarebbe fuorviante; esso porterebbe solamente a un puzzle di
giustapposizioni che terrebbe conto della figura, ma non della forma degli animali,
e il risultato non sarebbe diverso da una delle teste di Arcimboldo: composizioni evocative, che tuttavia non rendono più comprensibili né la figura umana, né
i pesci o i frutti che la compongono né l’acqua o le stagioni che richiamano nei
titoli. Esse sono un calembour visivo che presume la descrizione della morfologia
degli elementi rappresentati, ma non mira a essa, limitandosi a richiamarla come
presupposto per la comprensione del gioco figurale.
14
Ibid., osservazione di domenica 30 aprile, p. 34.
R. Caillois, op. cit., p. 8.
16 J.W. Goethe, Leopoldine Ausgabe, I, vol. X, p. 128, tr. it. in P. Giacomoni, Le forme e il vivente.
Morfologia e filosofia della natura in J.W. Goethe, Guida, Napoli 1993, p. 151.
15
5
ITINERA – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura
Mostrare la formazione della forma e delle sue metamorfosi è lo scopo della
morfologia. Il termine metamorfosi, sebbene già utilizzato da Linneo nella sua
Philosophia botanica, ha continuato per lungo tempo a suggerire più le ovidiane
trasformazioni fantastiche ricordate all’inizio che non un principio euristico per lo
studio della natura. Tale valenza si modifica con gli studi che Goethe dedica alla
natura: il processo metamorfico è il modo d’essere del regno vivente e la morfologia ne è la scienza. Come si sa, è ancora Goethe a introdurre il termine morfologia
nella storia naturale, utilizzandolo per la prima volta pubblicamente nel 1817 come
titolo dei Morphologische Hefte. La morfologia goetheana non è un’ontologia della forma, ma un’arte descrittiva del modo in cui le cose appaiono visibilmente, del
modo, cioè, in cui esse si presentano sulla scena del mondo. Ciò non significa che
esse trovino a ogni stadio metamorfico la propria ipostasi. Piuttosto, per comprendere la valenza di un tale stadio, possiamo pensare alle composizioni anamorfiche
proposte e studiate da Jurgis Baltrušaitis, in cui «si tratta di una distruzione [della forma] che prelude a un ripristino»17 . La morfologia sembra infatti valersi del
principio di conservazione, qui della conservazione della forma attraverso la variazione. È scienza di una forma sempre in divenire, la cui Bildung unisce il proprio
farsi e l’esperienza dell’osservatore. Se la forma è, infatti, riconoscibile sensibilmente, oggetto proprio di uno sguardo attento e talentuoso, l’esperienza che se ne
fa vive dell’esercizio dell’osservazione.
Nel 1784 Goethe scopre la presenza dell’osso intermascellare nell’uomo e ne
scrive nel Saggio di osteologia comparata; si tratta di un osso che «si inserisce tra
le due ossa principali della mascella superiore»18 e che ha conformazioni diverse
a seconda degli animali in cui si trova. Tale scoperta ha conseguenze rilevanti per
il modo di considerare il mondo naturale organico e la posizione che l’uomo vi detiene. L’assenza dell’ox intermaxillare nel cranio umano veniva infatti considerata
come segno di distinzione dai suoi cugini primati. Negarne la presenza significava quindi negare la contiguità tra quadrumane e zôon politikón e confermare
l’eccezionalità di quest’ultimo, negare dunque quella stessa contiguità che Goethe
voleva invece difendere, convinto come era che in natura non esistano eccezioni,
nello stesso senso in cui non esiste l’errore. All’interno del paradigma morfologico,
l’eccezione è una goccia d’acqua dolce nell’oceano, l’errore è differenza.
La posizione di Goethe sembrerebbe essere rivoluzionaria. Tuttavia, già Galeno aveva trattato il problema per giungere alle sue stesse conclusioni, come Goethe
del resto ben sapeva e come aveva ricordato nel Saggio19 . Egli ignorava invece
che solo qualche anno prima, nel 1780, l’anatomista francese Félix Vicq D’Azyr
avesse sostenuto la medesima tesi con un lavoro presentato all’Académie Royale
des Sciences. Non era dunque la prima volta che l’ox intermaxillare veniva tratta17 J. Baltrušaitis, Anamorfosi o Thaumaturgus opticus, Adelphi, Milano 1990, p. 15. Si veda a questo proposito M. Mazzocut-Mis, Deformazioni fantastiche. Introduzione all’estetica di
Jurgis Baltrušaitis, Mimesis, Milano 1999.
18 J.W. Goethe, “Saggio di osteologia comparata”, in Gli scritti scientifici, tr. it. di C. Mainoldi e
A. Pinotti, a cura di E. Ferrario, Il Capitello del Sole, Padova 1999, vol. II, p. 13.
19 Si veda ibid., p. 13.
6
ITINERA – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura
to pubblicamente nelle discussioni di osteologia e di anatomia comparata, seppure
con scarso successo. Ciò nonostante, Goethe non inserisce la propria ricerca nel
dibattito scientifico dell’epoca, sottoponendola piuttosto alla prova, apparentemente ossimorica, dell’evidenza dell’apparenza sensibile: «Se nelle cose naturali non
prevalesse l’apparenza sensibile, avrei timore a farmi avanti affermando che questa
sezione ossea si trova pure nell’uomo»20 .
Ciò che allora scopre Goethe non è solamente la presenza nell’uomo di un
elemento osteologico fino ad allora censurata dai maggiori specialisti dell’epoca.
In senso proprio, non si tratta neppure di una scoperta. Negli animali esso era
noto da tempo; nell’uomo è invece come mimetizzato, i suoi confini sono quasi
totalmente fusi con la mascella superiore. Nell’uomo è, dunque, quasi invisibile:
Goethe lo riconosce, quasi invisibile, guardando l’apparenza sensibile. Fu infatti
guardando e riguardando serie di crani di animali collezionati e avuti in prestito che
egli vide l’osso intermascellare, scorgendone le tracce rimaste nel cranio umano.
“Vide”, e non “dedusse”. Pur concedendo a Goethe il senso di orientamento che
appartiene a ogni scienziato, egli non cercò l’osso intermascellare spinto da quel
«bisogno di supposizione» esecrato da Valéry. Al contrario, egli rinunciò «alle
previsioni e alle profezie», così come riteneva necessario all’indagine scientifica.
Tale rinuncia consente, crediamo, di fugare ogni dubbio sul fatto che si tratti qui
di un’operazione indebita con cui si tenterebbe, ancora una volta e sotto mentite
spoglie, di rappresentare il mondo in virtù di un’antropomorfizzazione della natura
surrettiziamente mascherata da parentela. «Caduta e spinta: voler spiegare con
esse il moto dei corpi celesti è in realtà antropomorfismo mascherato; è l’andare
del viandante per i campi. Il piede sollevato si abbassa, quello rimasto indietro si
slancia in avanti e cade, e così via dalla partenza fino all’arrivo»21 : questo è per
Goethe antropomorfismo, la traduzione dell’apparenza in schema intellettuale.
Le metamorfosi mitiche raccoglievano e raccontavano tutto ciò che può essere
raccolto e raccontato secondo un principio di economia per cui nulla di ciò che
era nelle forme antiche viene perso nelle nuove, in ragione dell’affinità di tutto
il vivente. Un abisso separa le parole di Narciso da quelle che Eco gli rimanda:
Narciso confuso «Qui riuniamoci», ed Eco felice «Uniamoci», ma quando lui, vistala, la fugge: «Preferisco morire che darmi a te», «Darmi a te» echeggia22 . Pari
è quell’«abisso tra l’osso intermascellare della tartaruga e quello dell’elefante! Eppure si possono individuare tutta una serie di forme intermedie che li mettono in
connessione»23 . La specificità del gioco di possibilità di cui si è detto all’inizio
consiste, finalmente, nel riconoscimento delle forme intermedie tra loro simili, per
la cui individuazione servono criteri descrittivi sofisticati che si possono ottenere
solamente attraverso un prolungato esercizio dell’osservazione. Possibilità plurali
dunque, che si scorgono guardando l’oggetto da molteplici punti di vista. Pos20
Ibid.
J.W. Goethe, Massime e riflessioni, cit., n. 1242.
22 Ovidio, op. cit., libro III, vv. 385-392.
23 J.W. Goethe, “Saggio di osteologia comparata”, cit., p. 19.
21
7
ITINERA – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura
sibilità in cui convivono l’invenzione della libera fantasia e il metodo del rigore
scientifico.
Come rileva uno dei massimi strutturalisti russi, Ju.K. Šceglov, nel suo Alcuni
tratti strutturali delle Metamorfosi24 – e si pensi a quanto lo strutturalismo deve alla morfologia – Ovidio, per il quale forma e corpo sono il medesimo, ce ne
presenta le metamorfosi permettendoci di concepirle perché propone un’impressione di naturalità, giocando sui caratteri fisici e spaziali come quello di estensione,
dimensione, posizione e volume. La trasformazione dell’uomo in rana viene descritta secondo i medesimi criteri della trasformazione dell’acqua in ghiaccio25 . Le
Metamorfosi ovidiane sono un’enciclopedia delle forme del mondo organizzate, di
cui vengono proposti «campioni» tra loro commensurabili. Scrive Goethe: «Con
questo modello [della pianta originaria] e con la sua chiave si potranno inventare
piante all’infinito, che saranno conseguenti, vale a dire che, anche senza esistere
nella realtà, potrebbero tuttavia esistere»26 . La natura è un archivio di forme che
l’osservazione moltiplica, mutando l’angolo prospettico, con la medesima regolata imprevedibilità di un caleidoscopio. Di tale archivio l’uomo è parte. Secondo
Hans Reichenbach, senza il principio di induzione «la scienza non avrebbe più il
diritto di distinguere le sue teorie dalle creazioni fantastiche e arbitrarie della mente di un poeta»27 . Goethe gli obietterebbe che «in se stesso e in quanto si serve di
sensi sani, l’uomo è il più grande e preciso apparecchio fisico che ci possa essere,
e la peggiore disgrazia della fisica moderna è proprio quella di avere per così dire
separato gli esperimenti dall’uomo e di riconoscere la natura solo per quello che
mostrano gli strumenti artificiali, anzi di voler con essi limitare e dimostrare ciò
che essa può operare»28 . La morfologia mostra come ricerca scientifica e ricerca
estetica abbiano nel problema della forma il loro punto di sintesi, la loro contiguità che trova nell’esercizio osservativo dell’uomo la sua forza agente e il suo
intermediario.
24
In R. Faccani, U. Eco (a cura di), I sistemi di segni e lo strutturalismo sovietico, tr. it.
di R. Faccani e G.L. Bravo, Bompiani, Milano 1969.
25 Ibid., p. 143.
26 J.W. Goethe, “Viaggio in Italia”, in Opere, Sansoni, Firenze 1963, p. 493.
27 Citato in K. Popper, Logica della scoperta scientifica. Il carattere autocorrettivo della scienza,
tr. it. di M. Trinchero, Einaudi, Torino 1970, p. 6.
28 J.W. Goethe, Massime e riflessioni, cit., n. 706.
8