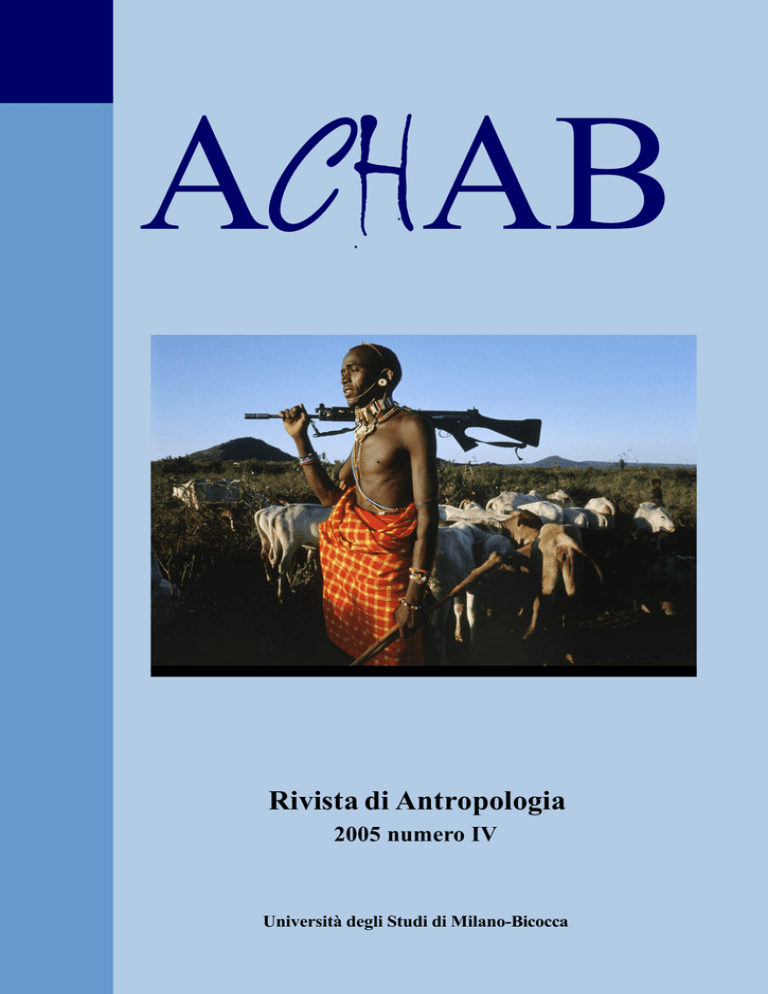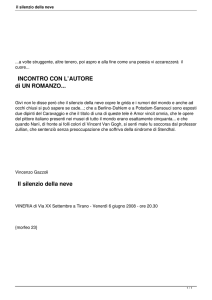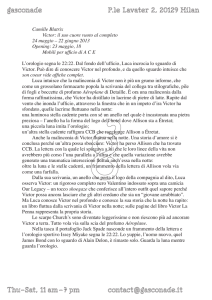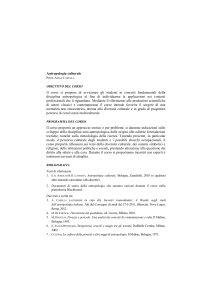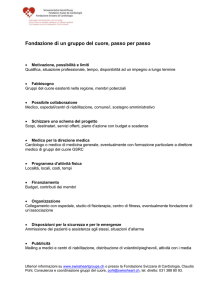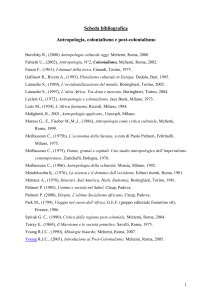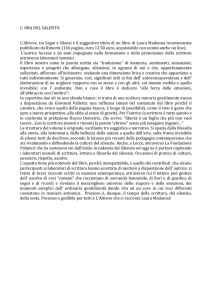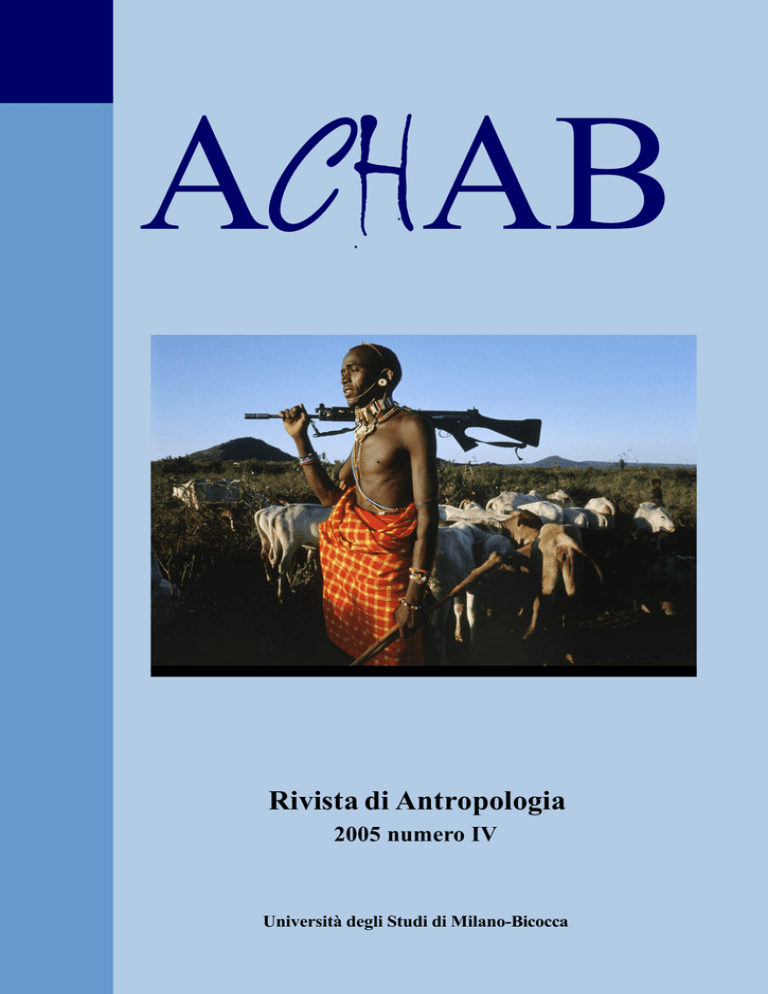
ACHAB
Rivista di Antropologia
2005 numero IV
Università degli Studi di Milano-Bicocca
AChAB
Rivista di Antropologia dell'Università di MilanoBicocca - Numero IV
Redazione
Lorenzo D'Angelo, Antonio De Lauri, Michele Parodi
Se volete collaborare con la Rivista
inviando vostri articoli, oppure,
contattare gli autori, scrivete a:
[email protected]
Ha collaborato
Fabio Vicini
Progetto Grafico
Lorenzo D'Angelo
Impaginazione
Amanda Ronzoni
Tiratura: 400 copie
Non siamo riusciti a rintracciare i titolari del domino di alcune immagini
utilizzate in questa rivista. Gli autori sono invitati a contattarci.
*Immagine in copertina e a lato tratte da: www nationalgeographic.com
*Immagine a pag. 19 tratta dal sito: www.capperi.net
Visitate il sito www.studentibicocca.it/achab
Gli articoli pubblicati in Achab non rispecchiano necessariamente il punto di vista della Redazione.
In questo numero...
2
Claude Meillassoux
di Fabio Viti
4
Antropologia sociale e storia dei processi etnogenetici nell'altomedioevo
di Amalia Rossi
11
Dolori che migrano in corpi che ricordano.
Congetture sulla fine di un rapporto terapeutico
di Lorenzo D'Angelo
19
Il silenzio e la memoria.
Riflessioni sulla memoria culturale fra i Roma
di Paola Toninato
27
Retoriche dello sviluppo: da Harry Truman a Colin Powell
di Paolo Borghi
31
Achab segnala...
33
Garden of Peace
1
Claude Meillassoux (1925 - 2005)
di Fabio Viti
Claude Meillassoux è morto a Parigi il 2 gennaio 2005.
Antropologo e africanista, era nato a Roubaix il 26 dicembre
1925. Dopo aver compiuto studi di economia e scienze politiche,
in Francia e negli Stati Uniti, e aver lavorato nel settore
commerciale e finanziario (compreso nell'amministrazione del
piano Marshall), era giunto all'antropologia relativamente tardi, in
seguito al decisivo incontro con Georges Balandier.
Sotto la direzione di Balandier aveva compiuto la sua prima
ricerca sul campo in Costa d'Avorio (1958), dalla quale sarebbe
scaturita la sua tesi di dottorato presso la VI sezione dell'Ecole
Pratique des Hautes Etudes (1962), pubblicata due anni dopo con
il titolo di Anthropologie économique des Gouro de Côte d'Ivoire.
In questo importante lavoro, Meillassoux è stato il primo studioso
a mettere in atto una antropologia economica di ispirazione
marxista, ribadita un decennio più tardi nel suo lavoro forse più
famoso, Femmes, greniers & capitaux (1975), più volte
ristampato e tradotto in sei lingue. Da allora, il suo nome rimane
legato all'applicazione del concetto di modo di produzione alle
società di auto-sussistenza e alle innovative analisi sulla
riproduzione sociale e sui fenomeni dello sfruttamento e della
dominazione esercitati dagli anziani sulle donne e sui giovani
all'interno delle comunità domestiche, abitualmente ritenute
egualitarie.
L'altro grande campo di ricerca di Claude Meillassoux è stato lo
studio della schiavitù cosiddetta domestica, iniziato alla fine degli
anni '60, quando questo tema era ancora avvolto nell'ombra, e
culminato con il fondamentale Anthropologie de l'esclavage
(1986), al tempo stesso studio storico e magistrale sintesi teorica.
In questo saggio, anch'esso tradotto nelle principali lingue,
Meillassoux presenta una teoria compiuta dello schiavo come
anti-parente, nato dal ventre di ferro e di denaro, al quale si
contrappone non la figura astratta del "libero", bensì quella
dell'ingenuo, del co-generato, preso in una rete di dipendenze
familiari multiple, che assicurano la sua protezione e
inalienabilità.
In quello che rimane il suo ultimo libro pubblicato, Mythes et
limites de l'anthropologie. Le sang et les mots (2001), Claude
Meillassoux si è impegnato inoltre in una revisione critica delle
categorie della parentela e in particolare della nozione di
consanguineità, contestando allo strutturalismo un approccio
fondamentalmente ancora intriso di naturalismo.
Entrato al CNRS nel 1963, vi ha svolto tutta la sua carriera,
conseguendone anche la medaglia d'argento nel 1984. Lontano
dai riflettori delle più note università e senza sostegni
istituzionali, Meillassoux ha organizzato per anni seminari
tematici di ricerca e discussione (i famosi "séminaires
Meillassoux"), da cui sono scaturiti importanti volumi sulla
schiavitù, la guerra, la colonizzazione, con la partecipazione dei
migliori specialisti.
L'impegno intellettuale e scientifico di Meillassoux, che si è
rivolto principalmente all'Africa Occidentale (Costa d'Avorio,
Mali e Senegal), ma anche al Sudafrica e all'India, agli Inuit e agli
Inca, ha sempre coinciso con un preciso impegno politico, in
particolare contro l'apartheid e lo sfruttamento neo-coloniale del
sud del mondo, impegno e che lo aveva visto recentemente al
fianco di immigrati e sans papiers, rappresentanti di un nuovo
proletariato internazionale migrante, "riprodotto" a beneficio
dell'Occidente in seno a quella comunità domestica che era stata
l'oggetto dei suoi primi interessi.
Fotografia di Claude Meillassoux a Siena.
Chi scrive ha intrapreso il suo primo terreno in Costa d'Avorio,
nel 1981, grazie a una lettera di Claude Meillassoux, latore Ugo
Fabietti. Quel viatico così autorevole alla semplice richiesta di
informazioni generiche di uno studente che non sapeva niente del
terreno che incautamente si apprestava ad affrontare, dissolse gli
ultimi dubbi e mi impegnò in una esperienza di cui avevo un'idea
ancora molto vaga, come se la prestigiosa cauzione le accordasse
un fondamento che per altri aspetti le faceva ancora del tutto
2
difetto.
Complici forse le mode intellettuali del momento, nonché la sua
posizione istituzionalmente appartata, non ho poi molto
frequentato Meillassoux nei miei anni parigini, tra il 1985 e il
1991, anche se non mancavo mai di andarlo a sentire quando
veniva invitato a parlare all'Ehess o nei diversi convegni e
continuavo a leggere i suoi lavori. Solo più tardi avrei riscoperto
i temi a lui più cari, la schiavitù, il commercio, la guerra, i rapporti
di dominio, come se, passate le ventate più effimere, venisse
spontaneo ritornare a quei luoghi, a quei grandi temi di fondo che,
evidentemente, continuavano a covare in un angolo neanche tanto
remoto, solo in apparenza accantonati. E insieme ai suoi temi è
stato facile ritrovare il suo stile, sobrio, misurato ed essenziale,
laddove domina troppo spesso la contorsione del verbo fine a se
stessa.
Allo stesso modo, è venuto del tutto naturale, preparando insieme
ai colleghi più vicini un convegno del nostro gruppo di lavoro sui
rapporti di dipendenza, pensare proprio a lui, come quando si
vuole andare sul sicuro. Così, Claude Meillassoux aveva
partecipato recentemente al convegno "La vita in prestito. Debito,
dipendenza e lavoro" (Certosa di Pontignano, Siena, 24-26
settembre 2004). Piuttosto provato nel fisico ma sempre
lucidissimo, aveva presentato una densa comunicazione sul
debito di vita ("A qui doit-on la vie?"), nella quale coniugava i
suoi interessi demografici più recenti con quelli legati alla
produzione e alla riproduzione. Finito il convegno, l'avevo
accompagnato a Firenze, dove si sarebbe trattenuto un altro
giorno per una visita agli Uffizi, in cerca di opere del suo pittore
preferito, il Pinturicchio.
Claude Meillassoux ha lasciato un'opera importante ma
incompiuta. Due volumi sono in attesa di pubblicazione
(Anthropologie de case, t. 1; Anthropologie de salon, t. 2), mentre
un terzo, a cui stava lavorando, è rimasto nel suo computer (La
Bible sans Dieu). Con lui scompare uno studioso di fama
internazionale, ancora molto attivo e coerentemente legato a una
ispirazione marxista non dogmatica, per la quale aveva subito
negli anni una progressiva emarginazione dagli ambienti
intellettuali più alla moda. Non per questo il suo contributo a una
antropologia critica sarà dimenticato.
Bibliografia delle principali opere
Meillassoux, C., "Essai d'interprétation du phénomène économique dans les sociétés traditionnelles d'auto-subsistance", Cahiers
d'Etudes africaines, 1, 4, 1960: 38-67.
Meillassoux, C., Anthropologie économique des Gouro de Côte d'Ivoire, Paris - La Haye, Mouton, 1964 (ristampa, Paris, Ehess, 1999).
Doucoure, L., Meillassoux, C., Simagha, D., Légende de la dispersion des Kusa: épopée soninke, Dakar, Ifan, 1967.
Meillassoux, C., Urbanization of an African Community: Voluntary associations in Bamako, Seattle, American Ethnology Society,
University of Washington Press, 1968.
Meillassoux, C., a cura di, The Development of Indigenous Trade and Markets in West Africa, London, Iai - Oxford University Press,
1971.
Meillassoux, C., a cura di, Qui se nourrit de la famine en Afrique?, Paris, Maspero, 1974.
Meillassoux, C. a cura di, L'esclavage en Afrique précoloniale, Paris, Maspero, 1975.
Meillassoux, C., Femmes, greniers & capitaux, Paris, Maspero, 1975 (ristampa, Paris, L'Harmattan, 1992; trad. it., Donne, granai e
capitali, Bologna, Zanichelli, 1978).
Meillassoux, C., L'economia della savana. L'antropologia economica dell'Africa occidentale, a cura di P. Palmeri, Milano, Feltrinelli,
1975.
Bathily, A., Meillassoux, C., Lexique Soninke (Sarakole) - Français, Dakar, Clad, 1976.
Meillassoux, C., Terrains et théories, Paris, Anthropos, 1977 (ristampa, Lausanne, Page Deux, 1999).
Meillassoux, C., Les derniers blancs: le modèle sud-africain, Paris, Maspero, 1979 (trad. it., Gli ultimi bianchi. Il modello sudafricano,
Napoli, Liguori, 1982).
Meillassoux, C., Anthropologie de l'esclavage. Le ventre de fer et d'argent, Paris, Puf, 1986 (trad. it., Antropologia della schiavitù,
Milano, Mursia, 1992).
Meillassoux, C., Messiant, C., a cura di, Génie social et manipulation culturelle en Afrique de l'apartheid, Paris, Arcantère, 1991.
Gendreau, F., Meillassoux, C., Schlemmer, B., Verlet, B., a cura di, Les spectres de Malthus, Paris, Edi-Orstom, Ceped, 1991.
Meillassoux, C., L'économie de la vie. Démographie du travail, Lausanne, Page Deux, 1997.
Meillassoux, C., Mythes et limites de l'anthropologie. Le sang et les mots, Lausanne, Page Deux, 2001.
Su Claude Miellassoux:
Schlemmer, B., a cura di, Terrains et engagements de Claude Meillassoux, Paris, Karthala, 1998.
3
Antropologia sociale e storia dei processi
etnogenetici nell'altomedioevo (secoli V-X)
di Amalia Rossi
Premessa: un curioso confronto interdisciplinare
le quali producono, diffondono e custodiscono i testi e le
tradizioni del gruppo, basando su tali repertori la legittimità del
loro potere e la persistenza del nucleo originario attraverso i
secoli.
Questo parrebbe il tenore delle riflessioni di Smith e Armstrong:
il primo, con il ripristino del concetto di etnia (etnie, dal francese,
dato che in inglese il termine si presenta solo in forma di
aggettivo, ethnic), si fa carico della risoluzione della tensione tra
prospettive eraclitee (strumentaliste e moderniste) e parmenidee
(sostanzialiste ed essenzialiste) dell'etnicità. Ciò significa che la
sua riflessione si vorrebbe discostare tanto da coloro che
professano l'esistenza delle etnie come realtà chiuse, astoriche e
immutate al pari della definizione dell'Essere parmenideo, quanto
dai teorici che, consapevoli del carattere processuale dell'etnicità,
sottolineano il carattere contingente e l'uso strumentale e
meramente politico delle classificazioni etniche e nazionali. Per
Smith la definizione dell'appartenenza etnica non si sottrae alla
storicità; tuttavia i caratteri dell'appartenenza di volta in volta
esplicitati sarebbero parte di un corredo stabile nel tempo e
appannaggio delle elites, vere protagoniste del processo di
mantenimento della matrice etnica (occupazione di un territorio,
difesa dei confini, condivisione di idiomi e costumanze, mitologia
e universi simbolici comuni). E' possibile, sulla base di tale
impostazione, ricucire i brandelli della storia delle etnie europee e
di svelare l'intima connessione tra momenti storici
apparentemente distanti, nel segno della continuità tra i fenomeni
etnici del presente e quelli del passato. I frequenti revival etnici
contemporanei sarebbero dunque spia di un legame etnico latente,
il quale, dal punto di vista teorico, rende possibile riconnettere
fasi storiche apparentemente inconciliabili: per fare qualche
esempio, sulla base di tale prospettiva le sorti politiche del regno
dei franchi possono essere considerate come momento
propedeutico alla Francia di Robespierre (o meglio, a quella di Le
Pen); l'Inghilterra di re Artù può venire riconnessa a quella
dell'attuale nazionalismo antieuropeista; oppure l'organizzazione
politica dei pastori baschi del X secolo può essere vista come la
base storica da cui acquisterebbe legittimità il movimento
indipendentista basco dei giorni nostri. É in gioco la chiara
pretesa di de-biologizzare il discorso etnico, restituendogli
contemporaneamente un quid perenne di significati simbolici e
qualità politiche che contraddistingue un'etnie dall'altra.
Il secondo studioso, Armstrong, anche se ispiratore del testo di
Smith, in modo meno imprudente e più creativo escogita la
definizione di mythomoteur, definito come un repertorio più o
meno stabile di simboli, stereotipi e cliché identitari del gruppo
etnico attivato e trasportato nel corso dei secoli dalle élites del
gruppo, le quali, per propria natura rivestono l'importante ruolo di
garanti della sua continuità, persistenza e compattezza nel tempo
Il problema della formazione degli stati nazione europei
costituisce un interessante spazio di riflessione entro cui il
discorso storico e quello antropologico tendono a convergere,
sviluppando un dibattito interdisciplinare ricco di suggestioni e
volto, tra l'altro, a determinare le implicazioni teoretiche e gli usi
legittimi del concetto di etnicità. Una folta schiera di antropologi,
storici e sociologi, come B. Anderson, E. Hobsbown, T. Ranger,
A. Cohen e E. Gellner, per citarne solo alcuni tra i più autorevoli
del dibattito, sostengono che i movimenti nazionalistici a base
etnica costituiscano dei fenomeni del tutto inediti nella storia
europea, che siano contingenti e che scaturiscano da un uso
strumentale delle categorie etniche a fini politici. I sostenitori di
una tale impostazione, definiti modernisti e strumentalisti,
ritengono dunque che non vi sia né possa esservi una continuità
tra le finalità e i mezzi della conservazione e mobilitazione
dell'identità etnica nei diversi periodi della storia. Tali
impostazioni derivano da un atteggiamento costruttivista, che
enfatizza la natura 'immaginata', 'fittizia' e 'costruita' delle formule
etniche e dei loro derivati politico-ideologici, e poiché prendono
le mosse dalla crisi dei paradigmi in auge prima degli anni
sessanta sono apertamente avverse alle prospettive funzionalista e
neo-positivista. L'oggetto dell'indagine non è tanto il gruppo
etnico in sé, quanto le sue relazioni interne (tra i suoi membri) ed
esterne (con altri gruppi, istituzioni ecc.).
A tale insieme di prospettive altri studiosi come A. D. Smith e J.
Armstrong contrappongono alcune teorie volte ad enfatizzare
l'oggettività dell'appartenenza etnica (lingua, discendenza,
condivisione del territorio, memoria di guerra ecc.) da cui
prenderebbero forma nel tempo diverse forme di rivendicazione
politica. In particolare l'esistenza stessa degli stati nazione, così
come dei processi culturali e politici che hanno portato alla loro
affermazione, sarebbero la continuazione di una progettualità
politica sorta in concomitanza con la formazione dei regni etnici
della tardoantichità. La ragione della periodica ricomparsa delle
rivendicazioni etniche in chiave nazionalistica, in Europa come
nel resto del mondo, andrebbe rintracciata nell'esistenza di nuclei
stabili di trasmissioni di valori etnici legati alla interpretazione
unidirezionale del materiale storiografico locale. I teorici in
questione concentrano l'attenzione sulla capacità dei gruppi di
conservarsi grazie alla stabilità delle componenti oggettive
dell'appartenenza, come la condivisione di una stessa lingua,
territorio, memoria, sistemi simbolici. I documenti e le fonti
storiografiche, così come i materiali etnografici e le opere
letterarie, vengono presi in esame in quanto testimonianze sincere
e imparziali della storia e della vitalità del gruppo etnico. In
quest'ottica un ruolo teorico fondamentale è assegnato alle élites,
4
e nello spazio. Secondo Poutignat e Streff-Feinart vi è così il
rischio di compiere 'un giro del quadrante', ovvero di risostanzializzare i gruppi etnici, in aperta controtendenza rispetto
alle acquisizioni di Frederick Barth (1969), che hanno reso
possibile pensare i gruppi etnici come prodotti di relazioni sociali
ed ambientali storicamente date e non come entità capaci di
attraversare il tempo e lo spazio senza che ne venga scalfita la
sostanziale unità e compattezza.
Rappresenta quasi una curiosità il fatto che su tale punto siano
indirettamente intervenute le più recenti riflessioni della
storiografia contemporanea: le opinioni di Smith e Armstrong
sono infatti state messe in discussione da W. Pohl, professore
all'Accademia delle Scienze di Vienna ed esperto di questioni
etniche nell'altomedioevo. Tale autore, attraverso l'analisi della
complessa trama del panorama etnico tra il IV e il X sec. d.C.,
nega che nell'altomedioevo esistessero dei popoli compatti
(franchi, germani, goti, burgundi, longobardi, sassoni ecc.), e
dimostra come le identità del passato fossero ancora più fluide e
manipolabili di quelle del presente, e che fondare la propria forza
politica sull'idea di un origine ancestrale comune costituisce
un'ottima strategia di cui spesso e volentieri ci si serve, tanto nel
passato quanto nel presente. Come vedremo le istanze che
portarono alla genesi dei regni etnici non erano ascritte agli
individui ed ai gruppi seguaci del progetto politico dei vari capi,
ma venivano accuratamente selezionate da chi vi prese in qualche
modo parte in base ai vantaggi che tale posizione garantiva,
ovvero secondo una logica relazionale, contingente e situazionale.
In quest'ottica il tentativo di ricomporre un mythomoteur
simbolico per dare giustificazione dell'esistenza oggettiva di un
etnia e del suo periodico revival è ostacolato dalla frantumazione
dei documenti e dei reperti storici in enunciati discutibili e aperti
ad interpretazioni. Appare curioso che la proposta di Pohl fornisca
una conferma del fatto che il passato di un presunto gruppo etnico
sia vincolato al presente della nazione in funzione di un uso
strumentale della memoria locale presente e non in virtù di una
fantomatica ed immutata sostanza simbolica, come vorrebbero
Armstrong e Smith.
In alcuni suoi interventi in convegni e seminari tenuti in Italia
(Venezia, febbraio 2001; Bologna, ottobre 2002; Spoleto, aprile
2004) Pohl avverte esplicitamente come la comprensione del
passato sia indispensabile alla comprensione del presente,
soprattutto in una fase di intense interdipendenze, come quelle
che caratterizzano anche gli scenari contemporanei in una fase di
globalizzazione. Lungo la trattazione saranno analizzati alcuni
temi trasversali all'opera di Pohl e dei suoi colleghi, che
permetteranno di capire come il sistema di interdipendenze
europeo nel medioevo si basasse su dinamiche comparabili a
quelle operanti nel mondo contemporaneo. Rappresenta una
curiosità anche il fatto che gli stessi strumenti teorici corroborati
dagli studi sociologici sulla contemporaneità migrino nell'area
disciplinare della storia medievale, i cui esperti sopperiscono alla
carenza di dati e materiali storiografici mediante l'adesione ad
alcuni concetti del discorso filosofico e della teoria antropologica
degli ultimi quarant'anni, restituendo tono al corpo dalla critica
anti-funzionalista ed anti-positivista ed accettando le
trasformazioni da questa suscitate sui metodi della classificazione
ed analisi delle fonti.
Una prima argomentazione prende in considerazione il potenziale
'etnogenetico' della mobilità geografica e dei processi migratori
nel medioevo, in cui Pohl e altri studiosi mettono alla prova le
conoscenze sociologiche sulle migrazioni e sulle diaspore
contemporanee acquisite recentemente dagli etnologi. Un
secondo spunto è dato dalla problematica del contatto culturale tra
romani e barbari, che sfocia nelle dinamiche di classificazione
(sapere) e controllo (potere) delle componenti barbariche
all'interno e presso le regioni di frontiera fino a cui si estendeva
l'impero romano. Si tratta ancora una volta di un tema che
riguarda da vicino altri concetti prodotti dagli studi socioantropologici contemporanei. Una terza questione, derivante dalle
prime due, implica una presa di coscienza della complessità dei
sistemi di interdipendenza generati dal contatto culturale ed porta
alla assunzione dell'ipotesi dell'esistenza di processi globalizzanti
anche in contesti diversi dalla presente modernità.
Viene sviluppata un'ipotesi e posto un quesito: l'ipotesi è che il
sistema raccolga in sé diverse relazioni di potere, di cui
l'organizzazione statuale ufficiale rappresenta solo un livello
specifico tra altri, e che la latenza di questi agenti paralleli emerga
a fronte di particolari fenomeni ecologici e demografici, oltre che
politici paralleli. É a partire da tali relazioni apparentemente di
second'ordine che, nell'Europa tardoantica, in situazioni di densa
interazione, si crea lo spazio per l'emersione di nuove forme di
potere, culminante nell'ufficialità dei regni romano-barbarici, forti
dell'uso strumentale delle categorie etniche e capaci di adottare
registri e strutture di potere universalistiche a fini particolari e
contingenti. Infine, a quali trasformazioni si va incontro, in un
mondo, quello di oggi, in cui l'interdipendenza tra i gruppi e la
mobilità umana raggiungono livelli non ancora sperimentati? Il
quesito rimane aperto per varie ragioni, ma indubbiamente
l'analisi di Pohl permette di interpretare con maggior cognizione
di causa la genesi violenta di nuove forme politiche nella
contemporaneità, nuove forme di potere e reclutamento capaci di
lacerare il tessuto compatto degli attuali imperi economici e
politici. Ci si accorge che, forse, ciò che definiamo medioevo non
si è ancora concluso.
Il potenziale etnogenetico della mobilità umana e delle
migrazioni
Un primo accenno va fatto al potenziale etno-genetico della
mobilità umana e dei fenomeni migratori. Notoriamente è a
seguito di una lunga fase di 'decadenza' delle istituzioni e
dell'autorità dell'impero romano che sul continente europeo si
delinea una "ininterrotta crisi etnica", ovvero un rimescolamento
di gruppi etnici e popoli di enorme complessità (Gasparri, 1998:
15). Le tendenze della storiografia sono state generalmente quelle
di considerare la fase tardo-antica come una fase di declino,
dovuto principalmente alle incursioni di gruppi di barbari, al
lassismo della popolazione autoctona e alla tracotanza degli
5
invasori. Questi ultimi sono stati dipinti come popoli compatti dai
testimoni coevi (i Goti, i Longobardi, i Franchi, gli Unni, i
Burgundi, i Germani ecc.), ed in questi termini li si è concepiti
fino ad oggi, tanto che la tesi di Smith sembrerebbe per certi versi
plausibile.
Le Voelkerwanderungen, migrazioni di popoli, sono fenomeni
demografici prodottisi a seguito di massicci spostamenti di gruppi
nomadi dalle steppe asiatiche; si riferiscono all'oggettiva
incapacità, per le strutture del potere imperiali, di sostenere
politicamente il carico demografico nelle frontiere a nord
dell'impero. Appare significativo che parte della storiografia, ed
in particolare quella francese ed italiana, le abbiano definite
univocamente invasioni barbariche. Evidentemente la mobilità
umana, essendo il presupposto per la comunicazione ed il contatto
socio-culturale tra gruppi anche molto diversi, incide fortemente
sui processi identitari, e ciò è vero per ogni periodo della storia.
Diversi sono i modi attraverso cui storici e sociologi hanno
argomentato la questione. Smith, sempre in riferimento
all'esperienza dei popoli delle steppe che confluirono nei territori
dell'Impero, sostiene che la formazione dei mythomoteur che
garantì la continuità del gruppo sia dovuta all'emergere di un
sentimento nostalgico nelle collettività che da poco tempo erano
passate da uno stile di vita nomadico a quello sedentario. La
nostalgia per i tempi passati deriva dall'insicurezza della vita
sedentaria e favorisce, secondo Smith, il coagularsi di miti e
leggende intorno al passato del gruppo, alle sue origini in una
patria lontana (1986: 121).
Gasparri (1997), in modo più analitico, evidenzia il potenziale
etnogenetico delle migrazioni a partire dalla tardoantichità. In
primo luogo egli distingue tra le pratiche semi-nomadiche dei
gruppi "tribali" ai confini dell'impero e le vere e proprie
Wanderungen. I territori "tribali" erano piuttosto stabili e la
circolazione dei gruppi vincolata a spazi determinati. Gli
spostamenti dei villaggi erano periodici e di breve distanza. Altra
cosa erano le migrazioni. Pur usando un lessico non ancora del
tutto consapevole delle dinamiche micro-relazionali messe allo
scoperto da Pohl negli anni più recenti, egli esamina alcune
mitologie relative alla migrazione dei Longobardi, che giunsero in
Italia con Alboino nel 568 d.C. e che rivendicavano origini
ancestrali in Scandinavia. Dello spostamento del gruppo etnico
designato con questo nome si hanno molte informazioni: si stima
che i primi movimenti migratori verso sud si siano avuti intorno
al III sec. d.C.
Come direbbe Pohl, ciò che è interessante non è tanto la capacità
di un popolo barbarico di sfidare e vincere un'organizzazione
mastodontica come quella imperiale. Il pregio maggiore starebbe,
infatti, nel fatto che piccoli gruppi siano riusciti a concepirsi come
popolo, in termini contrastivi rispetto alle strutture esistenti. Le
migrazioni ebbero un ruolo fondamentale nel rimescolare questi
gruppi e ridisegnarne i confini etnici1. Il traffico umano, insomma,
è intimamente connesso alla genesi e alla persistenza di istanze
identitarie particolari, al mutamento culturale e alla
politicizzazione dell'etnicità e le dinamiche ad esso connesse
sembrano sfuggire alla capacità euristica di dicotomie teoretiche
molto
diffuse
(comunità/società,
centro/periferia,
tradizionale/moderno ecc.).
Per tornare alle teorie sulla fine dell'Impero romano, la tesi di
Gibbon (1776: 240-455) sulle invasioni barbariche, sintesi
emblematica dell'approccio tradizionale, si rifà alle testimonianze
dei personaggi del tempo ed il suo affresco è ancora oggi la
sistemazione più rigorosa del materiale storiografico a
disposizione sul tema. Per Gibbon, che si riferisce a questi eventi
soprattutto sulla base delle testimonianze di Ammiano
Marcellino, i barbari invasori sarebbero stati radicalmente alieni
ai romani, nell'aspetto, nelle costumanze, nell'organizzazione. Le
diffuse pratiche di mobilità nell'Europa altomedievale, anche
prima delle Voelkerwanderungen, connessi alle usanze seminomadiche dei gruppi, ai commerci, all'azione amministrativa
degli eserciti e all'evangelizzazione proto-cristiana non
coincidono con questa visione. L'approccio di Gibbon ha
restituito un'immagine dicotomizzata del rapporto tra romani e
barbari, che ha favorito la concezione di una cesura fatale tra
l'universalismo imperiale ed il particolarismo della fase
medievale. La percezione della decadenza da parte dei cronisti
portatori dell'identità romana ha sicuramente favorito l'adozione
di tale prospettiva. Essa ha altresì giustificato operazioni
euristiche non proprio legittime. A partire dalla riflessione di
Gibbon, Tylor elaborerà l'ipotesi di regresso culturale, come
quello che si avrebbe avuto a partire dalla caduta dell'impero
romano d'occidente (in Fabietti, Storia dell'antropologia, 1990).
A seguito della migrazione, secondo le teorie tradizionali, vi
sarebbe stata una radicale separazione tra la popolazione
autoctona e gli invasori, riprodotta tanto nella separazione etnica
degli spazi urbani, quanto nelle differenze nei costumi,
nell'abbigliamento e nell'aspetto, nelle armi ecc. Come si vedrà
nel paragrafo successivo, l'argomentazione di Pohl ruota intorno
all'idea di una lenta e capillare trasformazione che non implicò
assolutamente l'apartheid sistematico, ma che anzi favorì
radicalmente il meticciamento culturale, già molto tempo prima
dell'invasione dei Goti.
L'integrazione dei barbari e la trasformazione dell'impero
L'assunzione del paradigma etnico implica una revisione radicale
della dicotomia barbari/romani, come questa traspare dai testi del
tempo e dalle interpretazioni storiografiche. Pohl ritiene che la
realtà fosse molto più complessa e che la discesa in Italia degli
Ostrogoti, dei Longobardi e dei Franchi non possa essere
interpretata indipendentemente dalla politica di frontiera praticata
dall'amministrazione imperiale. Nel quinto secolo, al di là dei
confini dell'Impero, sopra il Reno, oltre il Danubio, vi erano
gruppi che i Romani definivano Gentes, o Ethnos, o Nationes, o
Tribus. Negli scritti la distinzione tra questi termini è piuttosto
vaga. Foederati erano quei gruppi che, assoggettati all'impero,
fornivano braccia per la coltivazione della terra e uomini, da
impiegare come soldati nelle conquiste successive. L'esercito
romano era molto composito e per esso combattevano proprio
quei barbari apparentemente così diversi. La conoscenza di lingue
6
straniere era piuttosto diffusa, sia nelle province vicine che in
quelle lontane da Roma. Il latino era ovviamente lingua franca,
mezzo universale del culto cristiano, della diplomazia, dei
commerci, del diritto e dell'arte; il greco, se possibile rivestiva
ancora più prestigio. Il cristianesimo si era già diffuso ovunque,
come religione dell'Impero, e la sua affermazione era dovuta
proprio alla capacità del suo messaggio universalistico, di
adattarsi, mediante il culto dei santi, alle pratiche politeiste diffuse
un po' ovunque.
La diffusione capillare del cristianesimo aveva fatto in modo che
questo si confondesse in sincretismi particolari con le forme
cosiddette 'pagane'. Dall'universalismo giudaico-cristiano viene
confermata la visione di un'umanità divisa in popoli e stirpi, non
diversamente da quanto suggerivano le sistemazioni
storiografiche ed etnologiche dell'antica Grecia. Le implicazioni e
gli usi politici di simboli e rappresentazioni fluttuanti nello spazio
e nel tempo, come nella visione di Armstrong, sono stati
effettivamente utilizzati come carburante nelle costruzione e
mantenimento delle identità passate e presenti. Si tratta di un
crogiuolo di culture, appartenenze, distinzioni. La versione
ufficiale di tale groviglio etnico-culturale era data dall'Impero,
che conquista dopo conquista registrava i nomi dei gruppi con cui
veniva in contatto, descrivendone talvolta i costumi, ma
soprattutto dando conto delle relazioni diplomatiche e militari che
essi intrattenevano con le élites. Qualcosa di non diverso da ciò
che viene descritto da Amselle in Logiche meticce a proposito
dell'uso delle categorie etniche nei contesti coloniali, e delle
finzioni di conoscenza e controllo insiti nella registrazione scritta
della diversità.
Già a partire dal III secolo d.C., l'arrivo dei gruppi dall'est fu
qualcosa di graduale, con picchi non molto elevati di qualche
decina di migliaia di uomini. La loro discesa non fu improvvisa,
la composizione dei gruppi non omogenea, ed il fenomeno va
legato alle complesse fasi di assimilazione ed integrazione delle
nationes, che implicavano riconoscimenti pecuniari notevoli agli
ufficiali di origine barbarica, una loro partecipazione attiva alle
sorti politiche dell'impero, già molto tempo prima dell'arrivo degli
"invasori". Il sistema imperiale era già in crisi al momento della
divisione tra Impero romano d'Oriente ed Occidente2. Pohl nota
come gli ufficiali originari delle province avessero compreso
come trattare con i romani, ai fini di ottenere vantaggi per sé, per
i propri eserciti e la propria gente.
Fenomeni di mimesi sono piuttosto frequenti. Pohl si riferisce ai
racconti che riportano le gesta di generali romani che, una volta
arrivati nella provincia, adottano gli usi delle popolazioni
straniere, si tingono i capelli di rosso, ai modi dei germani,
prendono a vestire come loro e a parlare il loro dialetto. Allo
stesso modo moltissimi ufficiali stranieri si romanizzano (o
meglio ellenizzano, dato che l'ondata universalista anteriore
trasportava i significati culturali elaborati in seno alla tradizione
ellenistica). Le élites dei gruppi di frontiera avevano un'idea
precisa dei vantaggi che avrebbero potuto ottenere dall'Impero,
che concedeva anche la cittadinanza, Romanitas, con lo scopo di
integrare gli stranieri nel proprio sistema. Verso la metà del V sec.
più della metà degli ufficiali dell'impero erano di origine
barbarica: scrive Pohl che "l'aristocrazia senatoriale, nonostante le
sue immense ricchezze e la sua influenza, aveva perso il controllo
delle forze armate, ampliando così il fossato che separava
l'esercito imbarbarito e le autorità civili. Specialmente nell'impero
d'Occidente l'accesso al potere richiedeva ora di avere familiarità
con entrambi i mondi, e nel lungo termine questo diede ai barbari,
che invidiavano e imitavano i modi romani, un chiaro vantaggio
sui Romani, i quali disprezzavano i barbari e non potevano
ispirare una duratura lealtà ai soldati che pagavano. Barbari
romanizzati, come il vandalo Stilicone, lo svevo Recimero, il
burgundo Gundobaldo, e lo sciro Odoacre dominarono i giochi di
potere in Occidente per tutto il V secolo. Nel 476 Odoacre chiude
la serie di insignificanti imperatori d'Occidente e continua a
governare come re nel nome dell'imperatore d'Oriente: uno dei
più famosi non-eventi della storia, la non-fine dell'impero
romano" (Pohl, 2000: 45-46).
Una lenta e travagliata trasformazione, non un'eclissi improvvisa,
quella dell'Impero Romano. I comandanti degli eserciti avevano
una chiara consapevolezza di essere considerati dai romani dei
popoli, alla maniera biblica, ed una serie di percorsi alternativi a
quelli ufficiali si aprivano negli interstizi della società complessa,
percorsi entro cui guadagnano spazio strategie inedite di accesso
al potere. Altri tipi di alleanze e legami di lealtà, altre forme di
potere avrebbero preso il posto dell'organizzazione imperiale.
Non è la guerra tra una società con stato ed una società senza
stato, non si tratta di un conflitto tra barbari e romani.
Ancora secondo Pohl "il processo di assimilazione venne
facilitato dal fatto che il sistema di potere che controllava l'impero
lasciava spazio a forme di lealtà personale all'interno del sistema
burocratico, a legami etnici o regionali al di sotto della
sovrastruttura imperiale (corsivo nostro); quelle che definiremmo
le strutture del potere barbariche e romane non erano mai in
opposizione nel corso della storia romana" (ibidem, 44). Gli stati
successori barbarici si fondavano su forme di lealtà etniche e
regionali che resero possibile l'accesso collettivo al potere da
parte di nuovi gruppi: l'emblema di tale forma di organizzazione
era il re. Gruppi etnicamente molto compositi, assoldati da capi
carismatici volti contro Roma, finirono per costituire popoli
compatti agli occhi delle élites imperiali. La rilevanza
dell'identificazione etnica per l'integrazione dei barbari nel
sistema imperiale venne facilmente trasferita alla coscienza degli
ufficiali stranieri. In un mondo così vario, ciò fece in modo che
proprio l'enfasi sull'appartenenza ad un popolo divenisse
strumento imprescindibile all'ottenimento di vantaggi simbolici e
materiali. Vantaggi che erano per lo più rappresentati dalle cariche
simboliche, dalle imponenti ricchezze, dalle strutture del potere
su cui si era retto l'Impero. L'etnogenesi è dunque, prima di tutto,
un processo relazionale, ed in casi di intensa interazione tra
gruppi, l'etnicità tende ad essere utilizzata in termini strumentali,
a fini politici. La frase conclusiva del testo di Pohl, relativa alla
sconfitta dell'esercito avaro da parte di franchi bulgari e slavi è
sicuramente indicativa di quelli che furono processi molto
intricati ed eterogenei. Gli insuccessi contro questi gruppi
7
"lasciavano ormai apparire alla nuova generazione poco
promettente identificarsi ancora come Avari" (2000: 237).
apparenza più contrastanti. Ciò vale tanto per la storia quanto per
l'antropologia.
Il documento/monumento non può più essere interpretato solo in
base agli eventi che esso descrive e ai suo contenuti espliciti.
Limitare l'analisi e la comparazione dei testi al problema della
loro veridicità, potrebbe significare rinunciare alla comprensione
del contesto in cui tale testo compare, rinuncia a vederlo come un
'nodo di un reticolo' in cui convergono altre esperienze,
rappresentazioni, testi. Nelle discrepanze tra un racconto e l'altro
potrebbero insinuarsi una serie di variabili determinanti capaci di
riassumere in sé altre infinite variabili. Tra queste lo status dello
scrivente, la sua personalità, la circostanza della stesura del testo,
il suo pubblico potenziale e molti altri fattori. Rilevare tutte
queste possibilità circostanziali permette di far dire al documento
molto più di quello che esso generalmente rivela. Pohl fa sua la
lezione di Foucault e ciò lo porta a considerare la dimensione
performativa della parola scritta, ma anche la natura politica delle
designazioni etniche: egli scrive infatti che "per noi è importante
il modo in cui i testi contribuirono alla formazione dell'identità
(…). Gli autori greci e latini che dal IV secolo impiegano
designazioni etniche e informano sui loro rappresentanti erano per
lo più direttamente vicini a questo inquietante mondo di popoli:
sia che prendessero parte alle guerre contro i capi di quelle genti,
come Ammiano Marcellino, che con loro trattassero, che fossero
loro subordinati in qualità di clerici come Gregorio di Tours,
Isidoro e Beda, che per essi coprissero alte cariche amministrative
come Cassiodoro, che si vantassero essi stessi di un'origine
barbarica, come Giordane e Paolo Diacono. Si può rimproverare
loro che ognuno di essi, quantomeno retrospettivamente, è
orientato verso fini politici e scrive in maniera tendenziosa. Ma
proprio questo permette di nuovo di compiere deduzioni
relativamente a quelle strategie politiche nelle quali le identità
etniche dovevano affermarsi (…). Innanzitutto i testi
contribuirono alla costruzione della realtà (…) e crearono lo
spazio nel quale le etno-genesi potevano avere successo"
(Ibidem: 17-18).
Gli interessi politici celati dal discorso etnico mostrano, almeno
nel contesto altomedievale, come l'ascesa di personalità di origine
barbarica sulla scena politica ufficiale fosse dovuta all'azione
congiunta del sistema di integrazione (sviluppato dall'esercito e
dalla burocrazia romani) e delle pressioni migratorie dei gruppi
modellati dalla stessa 'nomenclatura' romana: queste resero
possibile l'innestarsi di nuove relazioni di potere nella struttura
costruita dalla potenza imperiale. Più ancora che confermare la
prospettiva strumentale che, come è stato sottolineato, non riesce
a dar conto completamente della persistenza dei gruppi al di qua
del confine che le separa da un esplicito attivismo politico, la
teoria di Pohl sembra dimostrare la bontà del concetto di salienza
(vedi Poutignat, 2000: 136-150) e presentare l'etnicità come una
dinamica contingente. L'identità etnica diviene saliente in
particolari situazioni: in un'ottica situazionale gli individui
tendono ad agire in base alla rilevanza che l'ostentazione o
l'occultamento di una particolare identità possono avere per
l'auto-accrescimento e la difesa del Sé individuale e collettivo.
Globalizzazione, potere ed etnicità nell'altomedioevo
L'etnicità politica non è un fenomeno moderno, come giustamente
rileva Smith. Contemporaneamente però l'uso politico
dell'etnicità è totalmente contingente, e non se ne può dimostrare
la continuità a priori, sulla base di un Traditionskerne stabile che
si fa veicolo di un mythomoteur compatto. Solo a posteriori,
mediante un'analisi dei comportamenti strumentali che regolano il
fluttuare instabile di simboli e formule politiche universalistiche è
possibile immaginare (non dimostrare) una continuità tra le
formule etniche del passato e le formazioni politiche del presente.
In poche parole, le fratture, le incoerenze nei testi e nelle
narrazioni, gli oblii e le riesumazioni funzionali rendono troppo
frammentario il mythomoteur che ha orientato la formazione dei
regni da quello che guida le élites nazionaliste dell'ottocento, a
maggior ragione per quel che riguarda la comunanza di fini
postulata da Smith.
Quello che Pohl ha in mente è un mondo di continue
rielaborazioni, rifrangenze e dispersioni di forme e significati
universali (la confessione cristiana, il latino e il greco, i testi
biblici, le cariche politiche e le pratiche giuridiche, ad esempio),
rese possibili da pratiche relazionali contrastive, fortemente
vincolate a meccanismi psico-sociali e alle configurazioni
contingenti degli eventi. L'esistenza ed i contenuti del
mythomoteur dipendono sempre dall'esistenza e contenuto di
modelli analoghi, e la loro costituzione ed uso dipende
direttamente dal vantaggio contingente che l'élite di un gruppo
può trarne. L'elaborazione della memoria del gruppo è
discontinua e contingente: esattamente come per lo stato nazione,
il modello del regno prende le mosse da forme di 'segmetarietà'
apparentemente inferiori al modello centralizzatore, ma
contemporaneamente capaci di sfruttare le sue stesse tecniche
classificatorie, militari, politiche ai propri fini. L'accentramento
tuttavia non significa il passaggio ad una forma statuale
contrapposta ad una forma segmentaria, come il passaggio dal
sistema tribale a quello del regno. Il quadro di forti
interdipendenze tra gruppi, come quello postulato da Pohl in
riferimento alla teoria dei sistemi di Luhmann, andrebbe
privilegiata una prospettiva segmentaria, che possa tener conto
dell'esistenza di diversi livelli ed articolazioni dei rapporti di
potere e di diversi livelli di conflittualità cui questi danno, e non
di una contrapposizione netta tra civiltà e barbarie, forme statuali
e forme segmentarie. Solo in questo modo si possono spiegare
molti eventi e molti non eventi.
Pohl è particolarmente consapevole del fatto che la dicotomia
barbari-romani, pur emergendo chiaramente nei racconti dei
personaggi del tempo, non renda conto del fatto che tutti questi
gruppi appartenessero ad un medesimo sistema di
interdipendenze. Buona parte del materiale storiografico a
disposizione degli storici, se interpretato in termini strumentali, è
suscettibile di far combaciare anche i testi documentari in
8
Pohl avverte il suo pubblico di quanto possa essere fuorviante
concepire i nazionalismi etnici come delle forme 'naturali' di
realizzazione politica, e giustifica quest'ipotesi dimostrando come
la formazione dei regni, a partire da formule di coesione
segmentarie, non sia dovuta all'isolamento e al 'mantenimento
simbolico' di un'etnia, ma alla accresciuta
interazione tra gruppi nell'ambito di un medesimo
sistema socio-politico.
Le considerazioni di Pohl mostrano come una
profonda collaborazione tra paradigmi socioantropologici e le teorizzazioni di lungo periodo
operate dagli storici possano rinnovare le perplessità
riguardo alla legittimità delle dicotomie civiltàbarbarie, universalismo-particolarismo, societàcomunità, segmentarietà-statualità, tradizionemodernità. In particolare una visione bipolare di un
sistema tribale barbaro contrapposto ad un sistema
statale romano nella tarda antichità è del tutto
fuorviante e non spiega né i molteplici sincretismi, il fluttuare di
simboli e forme universalistiche in Europa, né dà conto dei
continui conflitti e guerre che si succedono nei territori ai confini
dell'impero.
Il riferimento di Pohl al Soziale Systeme di Niklas Luhmann
(1988) è costante. Si prendano ad esempio le sue considerazioni
sul rapporto tra i centri del potere avari ed unni e Costantinopoli:
"Dall'analisi della loro contrapposizione all'impero diventa chiaro
che i vecchi spauracchi della letteratura storica occidentale, i
cavalieri e i distruttori dalle steppe dell'oriente, mai corrisposero
in realtà allo stereotipo della dissolutezza e della ferocia.
Anch'essi dovevano seguire regole implicite, altrimenti non
avrebbero potuto salvaguardare il loro dominio. Proprio il centro
di potere avaro ed unno svilupparono una vivace
comunicazione con la corte imperiale, da cui
Bisanzio poteva imparare ancora alcuni secoli più
tardi (…). Dal punto di vista della teoria dei sistemi
i barbari non erano al di fuori del sistema. Niklas
Luhmann ha sottolineato che i conflitti non
costituiscono affatto una crisi, anzi, una rottura
della comunicazione, ma un periodo di
comunicazione intensa, anche se specifica,
attraverso la quale il sistema si trasforma" (Pohl,
2001: 204). Più avanti, nel testo, si scorgono altri
riferimenti alla conflittualità come qualcosa di
legato alla interdipendenza troppo elevata (2001:
234) tra gli eserciti barbarici e lo stato romano. Era evidente che
l'esercito romano non era riuscito ad integrare completamente i
gruppi assoggettati, ed il mito di una pax romana celava a
malapena l'evidenza che i conflitti etnici ed i regionalismi
nell'area mediterranea erano ben vivi. Scrive Pohl "nel corso di
queste battaglie tra fazioni aumentò lo spazio per la nascita di
posizioni di comando, che non si fondava solo sull'incarico
imperiale, ma anche sulle lealtà etniche" (p.235).
NOTE
1
Scrive Gasparri: "La Wanderung era un processo plurisecolare che dislocava lentamente una data etnia (ma Pohl preferirebbe il
termine gruppo etnico) dalle sue sedi originarie alternando periodi lunghi di stabilità, (…), a periodi di movimento. D'altra parte una
tribù migrante non migrava tutta intera. Una parte dei Longobardi rimase sull'Elba mentre gli altri migrarono sotto il Danubio; gli Eruli,
stanziati nell'area balcanica ancora nel VI secolo chiedevano ai loro consanguinei, rimasti in Scandinavia, di mandare loro un re."
(1997: 68). L'identità dei primi migranti non può non aver subito radicali mutamenti in più di tre secoli di 'dispersione'. E' significativo
che vi si faccia riferimento in un contesto in cui l'assenza di autorità e rappresentatività spinge il gruppo degli Eruli, in questo caso, a
richiamarsi al passato così lontano.
2
Alcuni passi del libro di Pohl sono particolarmente convincenti e annunciano un modo nuovo di concepire la storia, cui altri autori
contribuiscono. Pohl cita Geary, per il quale "Il mondo germanico è stato forse la più grande e durevole creazione del genio militare e
politico romano. Il fatto che questa creatura finì col tempo per sostituire il suo creatore, non deve far dimenticare che essa doveva la
sua stessa esistenza all'iniziativa romana (…) per modellare il caos della realtà barbarica in forme di attività politica, sociale ed
economicache essi potevano comprendere e forse controllare (da Geary P., Before Germany and France, N.Y., 1988).
9
BIBILIOGRAFIA
Amselle J.L., Connessioni. Antropologia dell'universalità delle culture,Bollati e Boringheri, Torino 2001.
ID (1991) Logiques metisses. Anthropologie de l'identitè in Afrique et Ailleurs, Peyo, Parigi, 1991.
Armstrong J., Nations before nationalism, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1993.
Barth F., I gruppi etnici e i loro confini, in Maher V., Questioni di etnicità Rosenberg & Sellers, Torino, 1994.
Fabietti U., L'identità etnica, Carocci, Roma, 2000.
Foucault M., L'archeologia del sapere. Una metodologia per la storia della cultura, Rizzoli Libri, Milano, 1980,
Gibbon E., Declino e caduta dell'impero romano, Mondatori editore, Milano, 1986 (ed. originale 1776).
Gasparri S., Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra antichità e medioevo, Carocci, Roma, 1997.
Gellner E., Nazioni e Nazionalismi, Editori Riuniti, Roma, 1998.
Hobsbawn E.J. e Ranger T., L'invenzione della tradizione, Einaudi, Torino, 1987.
Pohl W., Le origini etniche dell'Europa, Viella, Roma, 2000.
ID (a cura di) (1998), Telling the difference: signs of ethnic identities, in Strategies of distinction: the construction of ethnic
communities, 300-800, Brill, Leiden-Boston-Köln, 1998.
ID (1997), The Empire and the Lombards: Treaties and Negotiation in the sixth century, in Kingdoms of the Empire. The Integration
of Barbarians in Late Antiquity, Brill, Leiden-New York-Köln, 1997.
Smith A.D., Il revival etnico, Il Mulino, Bologna, 1983.
ID (1986), Le origini etniche delle nazioni, Il Mulino, Bologna, 1986.
Streiff-Fenart P.e Poutignat J., Teorie dell'etnicità, Mursia Editore, Milano, 2000.
10
Dolori che migrano in corpi che ricordano
Congetture sulla fine di un rapporto terapeutico
di Lorenzo D'Angelo
"Nessun presente potrebbe esistere senza la capacità di dimenticare"
(F. Nietzsche, Genealogia della morale, Adelphi, 1984, II, 1).
Premessa. Segni, sintomi, malattia
La medicina razionale occidentale affonda le sue radici nell'opera
di Ippocrate e della sua scuola. L'influenza di questo autore è stata
tale che nel XVII sec. le sue opere (e quelle dei suoi successori)
potevano essere considerate ancora una fonte autorevole del
sapere medico (Civita 1999). L'opera di Ippocrate rappresenta, in
effetti, una vera e propria rivoluzione epistemologica per
l'antichità. Con l'autore del Morbo Sacro, infatti, la pratica medica
si affranca da quella visione mitico-religiosa del mondo che aveva
fino allora dominato ogni spiegazione del dolore e della
sofferenza umana. Quella di Ippocrate è nella storia della
medicina una mossa fondazionale preliminare che ha aperto la
strada ad uno sguardo sul patologico che non si accontenta più di
connettere i fenomeni da spiegare a qualche entità fantasmatica
ma si preoccupa, invece, di indagare il sistema di segni incarnato
dal malato al fine di produrre una diagnosi e prescrivere una
terapia adeguata. Come ben sintetizza Cosenza:
dalla "clinica del visibile", empiricamente ancorata
all'immanente, di Ippocrate. Da un punto di vista psicopatologico,
Ippocrate ha fornito il suo contributo più importante individuando
quelli che il pensiero medico successivo definirà come sintomi
psichici e malattie psichiche (malattie con prevalenza di sintomi
psichici). Occorre precisare, a questo proposito, che per Ippocrate
i sintomi che la tradizione medica riconosce come espressioni di
una malattia della psiche, non sono affatto distinti dai sintomi
fisici. Tutte le malattie hanno una base somatica e non esiste il
concetto di malattia mentale che sarà un'acquisizione della
modernità (Civita 1999). Quel che però qui ci preme sottolineare
è che l'eziologia ippocratica è tanto ampia e variegata da includere
fattori ambientali, di costume, o persino sventure, come nel caso
tragico della moglie di Delearce che, a seguito di un'imprecisata
disgrazia, muore:
"A Taso la moglie di Delearce, che giaceva malata presso una
spianata, a seguito di una sventura fu colta da febbre con brividi,
acuta [...] Febbre, al tatto leggera; gelo alle estremità. Il nono
giorno delirò molto e poi tornò quieta: taceva. Il quattordicesimo
respiro intermittente, ora profondo ora breve [...]. Il ventunesimo
giorno molti discorsi e poi di nuovo s'acquietò: restò afona,
respiro breve. Il ventunesimo morì" (cit. in Civita 1999, p. 29).
"...l'arte occidentale della cura presuppone la caduta degli dei
come agenti della patologia e della fisiologia, della malattia e
della salute. L'esperienza umana del dolore trova così una nuova
possibilità di ricondurre a una ragione il patire che la caratterizza,
e una nuova modalità di intervento su di esso per placarne le
manifestazioni, sottraendosi così alla cecità tragica e
insopportabile dell'insensato: dal senso trascendente di un decreto
o di una punizione divina, per una qualche colpa legata ad atti
commessi o per volontà imperscrutabile degli dei, si passa alle
cause immanenti all'organismo di colui che patisce il dolore, al
rapporto fra tale organismo e le condizioni ambientali esterne
entro cui l'uomo malato è situato" (Civita, Cosenza 1999, p. 14).
Questo breve passo, ci permette di apprezzare solo in parte
l'accuratezza con cui il medico greco componeva il quadro clinico
dei suoi pazienti, un'accuratezza che gli derivava, oltre che da una
personale perspicacia, dal chiaro possesso della distinzione
concettuale tra segno, sintomo e malattia. Tale distinzione per la
medicina è di capitale importanza ed ha conosciuto una sempre
maggiore precisazione. Se con Ippocrate i segni sono dotati di un
significato circoscritto ed univoco, mentre i sintomi si
caratterizzano per la loro genericità o, persino, per la loro
equivocità (Colombo 1999), è con la scuola anatomica francese
del XVIII sec. che diviene evidente come i sintomi siano associati
Il sintomo insomma è da ricondurre alla persona e questa non può
essere disgiunta dall'ambiente in cui vive. Il campo clinico è
delimitato da queste variabili; solo il ciarlatano rintraccia nella
malattia i segni di un'intenzionalità invisibile, esterna al
sofferente. In ciò il sapere non scientifico si discosta nettamente
11
al punto di vista del sofferente (e quindi secondari), mentre i segni
rimandino inequivocabilmente ad organi e tessuti lesi o anomali
(Foucault 1998).
Secondo Foucault, in questo modo il corpo del malato è
cadaverizzato, concepito come un semplice portatore di un
malessere la cui oggettività, per essere riconosciuta, non solo
deve rimanere confinata entro i limiti spaziali del corpo ma deve
corrispondere ai criteri universalizzanti del sapere medico
scientifico. La diagnosi, pertanto, è definizione del malessere,
ossia, della realtà stessa della malattia (o della salute).
L'individualizzazione corporea della malattia diventa allora uno
dei principi fondamentali della medicina1. La clinica medica - in
quanto semiotica della sofferenza inscritta nei corpi - si assume
l'incarico e la prerogativa di localizzare la malattia interpretando
un linguaggio comprensibile solo per l'esperto. In questa
prospettiva, il malato non
può nemmeno fidarsi più
dei suoi sensi e deve
delegare
ad
altri
il
significato
della
sua
personale
sofferenza
(Taussig 1980).
Caso clinico
I incontro
Il formicolio itinerante
Victor è un ragazzo nigeriano di 25 anni. La sua cartella clinica
è lunga: una serie di visite, incomprensioni, tentativi di spiegare
un malessere senza "disease"2 apparente. Nella sua scheda
troviamo allegati anche i risultati clinici di controlli ospedalieri
effettuati sui livelli di ematocrito, urine, feci... tutto nella norma.
Il suo problema è e sente la pelle "pizzicare" (con le dita di una
mano fa pressione su più punti del braccio, poi il busto, le gambe,
poco dopo indicherà anche la pianta dei piedi) e avverte spesso
una fastidiosa sensazione di calore all'ano ("very hot"ripete più
volte). Per farsi passare la sensazione di formicolio e di prurito sì
da delle pacche, oppure strofina con una mano la parte di pelle
interessata. Queste sensazioni sono cominciate sei anni fa mentre
era in Nigeria. All'epoca aveva deciso perciò di consultare un
medico dell'ospedale di Benin City, città in cui è nato. Tuttavia,
dopo le visite del caso, gli era stato detto che non aveva "niente".
La madre, quindi, aveva pregato per lui affinché guarisse [...]. La
psicologa chiede al ragazzo di spiegarci da dove hanno inizio
questi "dolori". Victor, si alza, si toglie felpa e maglietta e ci
indica un punto sulla scapola destra: da lì la sensazione si dirama
sul braccio destro e sinistro, sul busto, sul collo, negli arti
inferiori, sulla pianta dei piedi [...].
***
Senza la pretesa di essere
esaustivo,
di
seguito
analizzerò un caso clinico
seguito
personalmente
nell'ambulatorio medico di
un'associazione
di
volontariato
di
Milano
che
Michel Foucault
offre assistenza medicolegale a stranieri senza regolare permesso di soggiorno. La
disponibilità e la fiducia concessami dal Gruppo Psicologi di
questa associazione, mi ha consentito di partecipare, per alcuni
mesi, ad alcune sedute condotte da una psicologa volontaria. Nel
ruolo di osservatore-partecipante ho potuto così raccogliere
diverse storie di persone che si sono rivolte all'associazione per i
più svariati problemi di salute. Il caso che presento è estrapolato
da una ricerca da me condotta - e ancora in svolgimento - sul tema
dell'immigrazione irregolare a Milano.
Vista la mia inesperienza in un campo così delicato e complesso,
e in accordo con la psicologa che ho affiancato, ho limitato al
minimo i miei interventi durante gli incontri, cercando di porre
questioni pertinenti ai temi di mio specifico interesse, solo
laddove la situazione lo permetteva.
Quella che segue è la storia di Victor, un ragazzo nigeriano che è
in Italia senza permesso di soggiorno (il nome è di fantasia). Gli
incontri con Victor sono avvenuti nel mese di aprile del 2004. Le
mie note sul campo sono state opportunamente selezionate per
ragioni di spazio e nel rispetto della privacy di Victor.
Il segreto
Quando il disturbo si è manifestato per la prima volta Victor era
uno studente del primo anno di una scuola d'Arte di Benin City. A
Victor piaceva disegnare e andare a scuola non gli dispiaceva per
niente. Il disturbo gli procurava però un tale disagio che non
riusciva a stare seduto. Per questo decise di abbandonare la
scuola senza spiegare agli amici la vera ragione della scelta.
Victor parla in proposito di un "secret" che non ha mai voluto
raccontare a nessuno, a parte i familiari. La motivazione
"ufficiale" del suo abbandono scolastico fu che desiderava
trovare un lavoro per racimolare soldi sufficienti a visitare
l'Europa. Così Victor è andato a lavorare in fabbrica.
La psicologa cerca di indagare le aspettative di Victor - prima di
partire - sull'Europa, l'Italia, il suo futuro. Victor afferma di
ringraziare Dio per essere in Europa, è contento di stare in Italia,
lo ha sempre desiderato fin da piccolo. Noto nei gesti e
nell'espressione di Victor un certo disagio ed imbarazzo in questa
parte del dialogo (guarda il tavolo, sfugge allo sguardo).
Intervengo per spiegare al ragazzo le ragioni di
quell'interrogare: ci interessa conoscere/ricostruire vari aspetti
della sua vita, per meglio capirlo e trovare una connessione con
il suo disturbo. Il ragazzo fa cenno di comprendere e la
discussione continua.
Il sogno
La psicologa chiede a Victor di cercare di ricordare episodi o
situazioni che possano avere un legame con la sue fastidiose
sensazioni e di riportarle per l'incontro della settimana
successiva (n.b.: già all'inizio dell'incontro Victor era stato
12
sollecitato a ricordare episodi, o altro che potesse avere un
legame con il suo disturbo. Il ragazzo aveva però reagito con una
smorfia, come di chi "preferisce non ricordare"). Quando stiamo
per congedarci Victor (con l'espressione un po' sorpresa di chi
ricorda improvvisamente qualcosa) ci racconta di un sogno avuto
proprio sei anni fa: una pistola puntata all'ano e poi sulla scapola
[...]. Dopo aver cercato di capire qualche dettaglio in più
decidiamo di chiudere la seduta e fissare un appuntamento per la
settimana successiva. Spieghiamo a Victor che durante questa
settimana penseremo al suo caso e che consulteremo altri esperti.
Saluto Victor con un "see you next friday". Il ragazzo fa sì con la
testa ed esce accompagnato dalla psicologa.
considera come fatti naturali, dati di fatto, non solo si mistificano
i segni e i sintomi della malattia ma, inevitabilmente si ri-produce
l'ideologia che li ha prodotti. E questo è uno dei principali rischi
cui va incontro tanto il medico che si preoccupa di alleviare la
sofferenza quanto l'antropologo medico.
Per questo motivo, all'antropologo che, maieuticamente, cerca di
portare alla luce la complessità dell'esperienza del malato e del
contesto in cui si situa - con le contraddizioni che lo
caratterizzano - si profila un compito arduo. Da un lato, infatti, si
tratta di operare una fenomenologia del quotidiano, di prestare
una particolare attenzione a tutto ciò che "goes without saying"
(Bloch 1989) nel convincimento che:
"The real task of therapy calls for an archaeology of the implicit
in such a way that the processes by which social relations are
mapped into diseases are brought to light, de-reifed, and in doing
so liberate the potential for dealing with antagonistic
contradictions and breaking the chains of oppression" (Taussig
1980)
Ma, una volta operata questa "archeologia dell'implicito", si tratta
di prendere anche una posizione, ancor prima che metodologica,
etica e politica.
***
II incontro
Ricordati di dimenticare
Victor entra nello studio, pantaloni scuri e una camicia con
qualche disegno fantasioso, un cappellino color senape in testa.
Mentre ci salutiamo si siede e la psicologa, presa in mano la sua
scheda e fatto un breve preambolo, chiede al ragazzo se può
raccontarci nuovamente il sogno descritto la volta precedente.
Scopriamo così che in realtà i sogni sono stati tre (tutti avvenuti
dopo il manifestarsi del disturbo e quindi non "premonitori").
Nel primo sogno (che sembra corrispondere a quello raccontatoci
la settimana prima), Victor vede una pistola puntata sulla sua
scapola destra (fa anche il gesto di più pistole puntate sul suo
corpo). Nel secondo sogno scopre un foro di pistola nella scapola
sinistra. Nel terzo sogno la pistola è puntata sulla scapola
sinistra. Durante il sogno Victor non ricorda di aver avuto
alcun'emozione, né paura né terrore o altro. Chiedo a Victor se
riesce a vedere chi impugna la pistola e mi risponde che vede
appena il volto ma non lo riconosce. Il risveglio si accompagna
con la sensazione di calore all'ano. La mattina dopo il primo
sogno ricorda, inoltre, di aver avuto la sensazione che qualcuno
gli strappasse il cuore (mima il gesto di strapparsi il cuore e
gettarlo in aria) e di aver sentito "the mind boiled" (bollire
l'anima? Indica il petto). Ha perciò raccontato il sogno alla
madre e insieme sono andati dal pastore. Quest'ultimo ha
consigliato al ragazzo di dimenticare il sogno, che era meglio
dimenticarlo, e di pregare. Victor ha pregato, così come la madre.
Successivamente, madre e figlio sono andati anche in ospedale.
Tuttavia, i medici che lo hanno visitato gli hanno detto di
dimenticare il suo sogno perché gli esami dicono che "non ha
***
Se consideriamo la metafora della malattia come linguaggio ci
rendiamo conto che segni e sintomi, per come sono stati intesi fin
qui dai medici consultati da Victor, appaiono come termini di un
linguaggio referenziale in cerca di una corrispondenza fattuale
con la realtà organica del corpo, una realtà che, per essere
manipolabile a fini terapeutici, deve essere univocamente ed
oggettivamente riconosciuta. Sorge qui, immediato, un dubbio
che formuliamo in questi termini: esiste una "realtà dei fatti" o
questa deve essere considerata come la sedimentazione di
significati socialmente e storicamente stabiliti dai gruppi
dominanti in modo da perpetuare i propri specifici interessi? E, se
questa realtà dei fatti non esiste qual è allora il significato sociale
della sofferenza? Solo se ai segni e ai sintomi di un malessere
restituiamo la loro intrinseca multidimensionalità - e se non ci
limitiamo a considerarli ingenuamente come rimandi a qual-cosa
- solo così essi possono disvelare i rapporti sociali, morali ed
economici che incorporano e la malattia o la sofferenza, allora,
potranno sprigionare il proprio potenziale critico rappresentando
un tentativo di sovvertire l'ordine costituito attraverso gli idiomi
culturalmente condizionanti del corpo. Il riduzionismo medico
scientifico con l'apparente intento di de-opacizzare la sofferenza,
in effetti, non fa altro che cannibalizzarla nascondendo o, peggio
ancora, mascherando tutte quelle dimensioni a cui si accennava
sopra e che le sono essenziali. Quando, inoltre, si trascura di
considerare le dinamiche sociali (spesso asimmetriche) e le si
13
nulla" [...].
Il colloquio appare faticoso. Victor risponde sempre alle
domande della psicologa la quale è, tuttavia, "costretta" ad
intervenire spesso per sollecitare il ragazzo a parlare di sé. La
psicologa cerca quindi di far capire l'importanza, per noi, che lui
parli liberamente di ciò che vuole, che parli soprattutto di sé, in
modo da poter avere elementi che ci consentano di aiutarlo. La
terapeuta parla anche di "cooperare" nella soluzione del suo
problema.
Victor, da parte sua, afferma di capire l'importanza di parlare ma
di non avere voglia di farlo. La Nigeria ha molti problemi e lui
vuole dimenticare. "Ora sono qui e penso al futuro in Italia, al
lavoro, al permesso di soggiorno..." afferma in sintesi [...].
III incontro
Victor non si presenta.
Alcune riflessioni
Victor, ad oggi, non è ancora tornato. Forse non lo farà mai. Forse
ha scelto altri percorsi terapeutici o, forse ancora, ha pensato che
questo non fosse il momento giusto per intraprenderne uno. Quale
che sia la ragione della sua scelta - perché questo è il nostro
assunto di partenza per le riflessioni che seguono: la sua è stata
una scelta di non venire più -, a noi non resta che interrogarci su
quanto è accaduto (o non è accaduto) durante questi pochi incontri
avuti e formulare ipotesi e congetture sia sulle motivazioni che
possono aver spinto Victor a non venire più sia sulle possibili
ragioni delle difficoltà riscontrate e percepite, da parte dei
terapeuti, durante i colloqui.
Il corpo, la mente; il passato e il futuro
"I'm tired of these questions" afferma ad un certo punto Victor,
con la sua solita voce pacata e sommessa, dopo un tentativo della
psicologa di riprendere il discorso circa la sua vita in Nigeria. La
psicologa gli spiega così che non vuole forzarlo a dire cose che
non vuole ricordare ma è importante che sia più "collaborativo".
Capita, alle volte, che le persone percepiscano che le cose non
vanno come dovrebbero o che si è semplicemente stressati o
preoccupati e così è il corpo ad esprimere questi disagi anche se
la mente, magari, pensa ad altro, al futuro, spiega la psicologa.
Per far capire meglio cosa intende riporta un esempio: ci sono
persone che quando sono particolarmente stressate hanno
problemi di pelle (macchie, eritemi, pruriti...); ognuno ha il suo
modo di comunicare i propri disagi. Esprime quindi la sua idea
circa il percorso terapeutico da intraprendere: trovare il modo di
mettere insieme corpo (passato) e mente (futuro). Si tratta di
trovare, insieme, una via verso la soluzione del suo problema.
Victor sembra ascoltare con interesse.
***
Da un punto di vista biomedico ci troviamo di fronte ad un caso
di somatizzazione: il paziente lamenta sensazioni di prurito estese
su quasi l'intera superficie epidermica; avverte calore all'ano;
tuttavia, gli esami clinici di controllo effettuati dallo stesso
paziente non mostrano alcun segno di disfunzione organica né
alcuna anomalia che possa rendere conto del quadro
sintomatologico illustrato dal paziente. In questa prospettiva ci
troviamo ad un'impasse. Da questo vicolo cieco cerchiamo perciò
di muoverci in un'altra direzione, opposta, e, abbandonati gli
strumenti dei cartografi della sofferenza, proviamo a seguire le
deboli tracce di quelle traiettorie che si iscrivono nei paesaggi
umani vissuti. Domandiamoci: che cosa sappiamo del malessere
di Victor?
Innanzi tutto sappiamo che esso ha un momento e un luogo di
inizio: sei anni fa a Benin City. Sappiamo anche da dove ha
origine: il più delle volte, il dolore, si dirama nel resto del corpo
a partire da un punto preciso nella schiena, sulla scapola. E' qui e
là che il dolore ha origine. Una fastidiosa sensazione itinerante
che migra nel corpo e con il corpo. Victor ha anche raccontato di
un sogno avuto in notti diverse che, a parte alcuni dettagli tra una
versione e l'altra, rappresenta essenzialmente una pistola
impugnata da qualcuno e rivolta in maniera minacciosa alle spalle
di Victor. Il fatto che la minaccia sia "da dietro" probabilmente
non è casuale. Il dorso della schiena, infatti, è una delle zone del
proprio corpo di cui non possiamo avere un'immagine visiva
diretta e fedele. L'essere "presi alle spalle" è non a caso un modo
per dire che si viene colti di sorpresa, ci si scopre
improvvisamente vulnerabili e, in talune circostanze, persino
passivamente impotenti di fronte ad una possibile intrusione del
proprio spazio corporeo d'azione. Victor non riferisce alcuna
particolare emozione vissuta durante il sogno ma la mattina
seguente, al risveglio, è talmente scosso da sentire il cuore quasi
schizzare via dal corpo, come se gli fosse strappato da qualcuno.
Victor non vede il volto di chi lo minaccia ma, avverte
distintamente la presenza di una pistola che punta il suo corpo
Chiusura
Sul finire Victor chiede un farmaco per alleviare il suo fastidio
ricordandoci, ancora una volta, quanto sia doloroso ("hot, very
hot") per lui andare in bagno.
La psicologa propone di consultare il medico che per primo lo ha
visitato in associazione. Esce e torna diversi minuti dopo
accompagnata dal medico. Quest'ultimo consiglia al ragazzo un
lassativo a base di frutta per "rinfrescare" l'intestino. Consiglia
anche di bere molta acqua.
...nel frattempo
Poco dopo che la psicologa è uscita dallo studio Victor mi guarda
e dice "thank you" come a dire che apprezza i nostri sforzi per
aiutarlo. Dopo un momento di silenzio, mi spiega nuovamente il
suo dolore all'ano. Mi dice che alle volte gli è quasi impossibile
sedersi. Gli chiedo di descrivermi nuovamente il prurito/pizzicore
sulla pelle. Il dolore lo equipara a punture d'ago (like a needle).
Parliamo di calcio (sorride rilassato). C'è qualche momento di
silenzio durante i quali Victor guarda verso la porta. Poi entrano
la psicologa e il medico.
14
proprio lì dove dice hanno inizio le sue fastidiose sensazioni di
calore e prurito. Victor non vede chi lo minaccia così come non
vuole parlare della sua vita in Nigeria. Ma il suo è un passato che
non vuole "passare" e che lo stesso Victor non può "lasciarsi alle
spalle" perché è proprio a partire da lì, dalle spalle, che
quell'invisibile presenza si concretizza come una minaccia capace
di violare i confini corporei, attraverso una delle sue aperture. La
schiena, la pelle, l'ano; dunque, il corpo. Una pistola, un volto
invisibile e Benin City - città in un paese attraversato da
complesse contraddizioni che fanno sentire i loro effetti sulla vita
di tutti i giorni degli individui: la società. Corpo e società: l'uno
rimanda all'altra. In Purezza e pericolo Mary Douglas sostiene
che in talune società l'angoscia per i margini esterni del corpo
esprime il pericolo per l'integrità e l'ordine sociale. Quest'idea di
mettere in relazione il corpo individuale con il corpo sociale, la
salute o la malattia del primo con l'ordine o il disordine del
secondo, è per noi di estremo interesse e ci permette di prendere
in considerazione un'altra antropologa americana.
In un suo recente studio, Cocker, si è occupata dei "traveling
pains"3 di alcuni rifugiati sudanesi in Egitto (Cairo). Preso atto
dell'inadeguatezza della nozione di "somatizzazione",
l'antropologa americana cerca di mettere in evidenza il ruolo
metaforico che giocano la malattia e il corpo nell'esprimere lo
scompiglio e il disordine che pervade la cultura e la comunità
sudanese rifugiata nel Cairo. Attraverso l'analisi delle illness
stories di questi rifugiati, Cocker si rende conto di come spesso il
dolore descritto si muova attraverso il corpo seguendo le
vicissitudini storico-biografiche dei rifugiati. Con le parole
dell'autrice: "their pain was historicized, moving through the body
and stopping at various locations, only to move on to another spot
later on, sometimes years later. Respondents would describe pain
as literally "traveling" through them, stopping from place to place
and then continuing on elsewhere" (Cocker 2004, p. 20).
I pochi elementi etnografici a disposizione su Victor non ci
permettono di spingere troppo oltre questo fugace accostamento
tra il suo prurito "itinerante" e i "traveling pains" dei rifugiati
sudanesi. Nelle riflessioni che seguono, pertanto, a partire dalla
prospettiva che prende in esame questi malesseri come metafore
e metonimie incorporate di più ampi processi sociali (Cfr.
Quaranta 2003) proveremo ad esplorare alcune ipotesi che
proiettano le nostre riflessioni al di là del caso specifico di Victor
ma che finiscono per gettare una luce sulle strategie terapeutiche
e non, emerse nella sua storia. E' in quest'ottica che condividiamo
l'impostazione di fondo della Cocker quando afferma:
contextual and dependent upon the integrity of the culture and
community that is under assault" (Cocker 2004, p. 35)
Nella storia di Victor colpisce che lui e la madre abbiano cercato,
ancor prima di "guarire" quel fastidioso disturbo, di dare ad esso
un senso, in questo caso religioso, morale - in ogni caso:
intersoggettivo, pubblico o collettivo. La domanda di
medicalizzazione in ospedale fa seguito ad una risposta di senso
non soddisfacente da parte del sacerdote il quale, forse,
sottovaluta il significato del disturbo o, semplicemente, si
preoccupa dell'"anima" ma dimentica il "corpo" e i suoi messaggi.
I medici, da parte loro, non si comportano in maniera molto
differente e gli offrono la loro verità biomedica. Ecco, allora, che
quel "messaggio (onirico) nella bottiglia" (Scheper-Hughes, Lock
1991) che ha angosciato le notti di Victor sembra essersi
definitivamente allontanato da ogni possibile approdo. Quel
prurito e quel bruciore rimangono confinati nel mondo privato e
segreto di Victor: è tutto suo. Colpisce ancor di più la "strategia
della memoria" della comunità di Victor. Il termine ricorrente è
"dimenticare". Il pastore ha consigliato di pregare e di non far
troppo caso al sogno; i medici gli hanno detto di dimenticare il
sogno perché è fisicamente sano e non ha nulla di cui
preoccuparsi; lo stesso Victor preferisce non parlare della Nigeria
e dimenticarla: "Nigeria has a lot of problems.... I want to forget
it..", dichiara espressamente. La memoria è qui l'elemento chiave.
Una memoria che sembra trattenere e filtrare di ciò che è stato
quanto basta per rimanere pro-iettati nel futuro, l'unica
dimensione temporale che sembra veramente interessare Victor.
Secondo Beneduce:
"uno degli aspetti più delicati della psicoterapia di alcuni cittadini
immigrati si nascond[e].... nel rapporto complesso e
contraddittorio con la loro memoria e con il loro presente. Il
lavoro di analisi volto a guardare nel loro passato deve
fronteggiare infatti una rimozione diversa da quella consueta,
forse più complessa: non solo rimozione inconscia di un evento,
di una scena o di un trauma, ma tentativo di rimuovere
attivamente una parte di sé a fronte dell'indifferenza o dell'ostilità
altrui, tentativo di cancellare un tempo ed un luogo che evocano
insieme le proprie radici ed il proprio dolore: ma quel tempo e
quel luogo d'altronde restano insopprimibili perché
continuamente presentificati dal loro nome, dalla loro condizione,
dalla loro identità" (Beneduce 1993).
Come sono stati percepiti da Victor gli sforzi della psicologa di
cercare di portare a galla i legami e gli intrecci tra il disturbo e la
sua storia passata per sondare quel secret così a lungo custodito?
E quanto ha influito sul processo terapeutico che si è cercato di
avviare il mio atteggiamento da "europeo ossessionato dal
passato" (Last 2000) che giustifica l'interrogare della psicologa
con la necessità di costruire un quadro coerente e ben informato
del suo percorso biografico? Ci sono comunità che lavorano in
direzione opposta - o comunque diversa - a quella che "noi,
occidentali" ci aspetteremmo essere la maniera "corretta" di
"Pain [...] needs to be listened to not just for what it communicates
about the state of the physical body, but what il communicates
about the social and moral realm as well. Through their embodied
metaphors and illness talk, the southern sudanese refugee in Cairo
are communicating a message about the existential crisis in which
their community is embodied" (Cocker 2004, pp. 34-5)
e ancora:
"...the integrity of the individual, or the individual body, is highly
15
affrontare le proprie lacerazioni interne e collettive. Occultare
piuttosto che evocare può essere una risposta attiva di una
comunità per riparare e ricucire gli strappi provocati dalle
"patologie del potere" (Farmer 2003) e permettere così ai suoi
membri di affrontare il dolore e la sofferenza:
l'interpretazione e l'elaborazione di vicende che, spesso,
riguardano l'intera collettività, impedendo così il confronto e la
negoziazione tra verità più ampie ed intersoggettive.
Murray Last, nel suo lavoro dedicato alle strategie di
riconciliazione e alle contraddizioni che ne sono conseguite in
Nigeria dopo la guerra civile nel Biafra, propone di partire dalla
premessa che in una società strutturalmente malata e vulnerabile
come può esserlo quella che esce da una guerra sanguinosa e
devastante, è comunque la comunità a doversi far carico del
proprio risanamento (Last 2000). Lasciare ai singoli individui o ai
gruppi di individui l'interpretazione di fatti ed avvenimenti che
hanno coinvolto l'intera comunità produce contraddizioni
pericolosamente disastrose nella società stessa e sui singoli
individui che si trovano a dare un senso al "reale collettivo", con
strumenti e strategie improprie perché non adatte alla costruzione
di verità egemoniche (Gramsci 1977)
Victor vive il suo presente in Italia pensando al suo futuro.
Dimenticare il passato, o una sua porzione, gli serve per
raggiungere i suoi obiettivi. Lo strappo con la sua comunità,
paradossalmente, sembra derivare proprio dal suo essere in piena
sintonia con essa.
Ogni terapia che abbia la forma di una confessione
scientificamente codificata è votata all'insuccesso se non tiene
conto del contesto extra-clinico che lega il sofferente alla sua
comunità. Ogni terapia è un atto politico di integrazione in un
contesto sociale (cfr. Desjarlais et al. 1998, p. 249). Questo ci
ricorda la storia di Victor.
"[a]lcune ricerche infatti dimostrano che inchieste dettagliate
sulle esperienze passate possono aggravare i sintomi. Questo è
particolarmente vero per alcuni rifugiati politici provenienti
dall'Africa e dal Sudest Asiatico, che hanno modalità diverse di
vivere e di riprendersi dai traumi da quel modo narrativo proprio
delle culture occidentali, legate alla tradizione cristiano-giudaica
di catarsi, confessione, riparazione e redenzione" (Desjarlais e al.
1998, p.249).
Quando si intende il lavoro terapeutico come una sorta di
archeologia della memoria4 fatta per evocare e portare alla luce le
stratificazioni delle proprie vicende vissute (drammi, dolori,
traumi, emozioni, gioie...) con persone appartenenti a comunità la
cui strategia di riconciliazione con il passato lavora in direzione
opposta (occultare invece che evocare), quando ci si trova in
simili circostanze, per quanto possa essere ben intenzionato, il
lavoro terapeutico può apparire eccessivamente invasivo da parte
del sofferente. "I'm tired of these questions" afferma ad un certo
punto Victor. Dall'altra parte, il rischio a cui va incontro una
comunità come quella di Victor è di innescare dinamiche culturalmente informate - che finiscono per delegare ai singoli
Salvador Dalì,La persistencia de la memoria
16
NOTE
Questa idea va di pari passo con la progressiva parcellizzazione del sapere: si ritaglia un fenomeno o un aspetto della realtà per
analizzarlo nella sua atomicità perdendo di vista così il carattere storico dei fatti che si trovano alla sua base (Lucacks).
1
Sulla distinzione tra illness, disease e sickness vedi: (Young 1982).
I sintomi più comuni riconosciuti come "traveling pains" sono: mal di stomaco, dolori al petto, tosse, dolori generici in tutto il
corpo, dolori muscolari o cardiaci, sensazioni di bruciore, e un imprecisato prurito che può manifestarsi in qualsiasi parte del corpo
(Cocker 2004).
4
Per un approfondimento di questo aspetto "confessionale" del rapporto medico-paziente si veda, ad esempio, la lezione del 19
febbraio del 1975 al College de France di Foucault. Il filosofo francese espone una storia della confessione che ha come suo filo
conduttore il rituale della penitenza. Se per il cristianesimo primitivo la penitenza "era uno statuto che si prendeva una volta per tutte
e aveva un carattere per lo più definitivo" (Foucault 2000), già nel VI sec., tuttavia, cominciava ad emergere un nuovo tipo di
penitenza, la "penitenza tariffata": ad ogni peccato corrisponde una penitenza prestabilita. E' chiaro che il prete, come il giudice, per
poter applicare la giusta penitenza deve conoscere e farsi raccontare la colpa o l'errore commesso. E' perciò, a partire da questo
momento storico che nasce la confessione. Significativo, all'interno del nostro discorso, è il parallelo di Alcuino, teologo del secolo
VIII, tra prete e medico. Egli, infatti, si domanda: "Come potrà il potere sacerdotale assolvere da una colpa, se non conosce i vincoli
che incatenano il peccatore? I medici non potranno più far nulla il giorno in cui i malati rifiuteranno di mostrare loro le ferite. Il
peccatore deve dunque andare a trovare il prete, così come il malato deve andare a trovare il medico, spiegandogli di cosa soffre e
qual è la sua malattia" (cit. in Foucault 2000, p. 156).
2
3
BIBILIOGRAFIA
Beneduce, R. (1993), "Geografia della memoria. Considerazioni clinico-antropologiche su migrazione e salute mentale", in: De
Micco, V. e Martinelli, P. (a cura di), Passaggi di confine. Etnopsichiatria e migrazione, Napoli, Liguori Editore, pp.125-143.
Beneduce, R. (2003), "L'etnopsichiatria della migrazione. Fra eredità coloniale e politiche della differenza", in: 900. Rivista
semestrale di storia e cultura contemporanea, 8-9, pp.29-46.
Bloch, M. (1989), "What goes without saying: the conceptualizazion of Zafimaniry society", in: How we think they think, Westview
Press, pp. 22-38.
Bourdieu, P. (2003), Per una teoria della pratica. Con tre studi di etnologia Cabila, Milano, Raffaello Cortina Editore.
Civita, A. (1999), Psicopatologia. Un'introduzione storica, Roma, Carocci.
Cocker, E. M. (2004), "Traveling pains: embodied metaphors of suffering among southern sudanese refugees in Cairo", in: Culture,
Medicine and Psychiatry, 28, pp. 15-39.
Colombo, L. (1999), "Il linguaggio della psicopatologia", in: Civita, A. e Cosenza D. (a cura di), La cura della malattia mentale.
Storia ed epistemologia, Milano, Bruno Mondadori, 1999, pp.133-154.
Coppo, P. (2003), Tra psiche e culture. Elementi di etnopsichiatria, Torino, Bollati Boringhieri.
Cosenza, D. (1999), "La costruzione del campo clinico", in: Civita, A. e Cosenza D. (a cura di), La cura della malattia mentale.
Storia ed epistemologia, Milano, Bruno Mondadori, 1999, pp.7-29.
Douglas, M. (1996), Purezza e pericolo, Bologna, Il Mulino.
Farmer, P. (2003), Pathologies of power. Health, human rights, and the new war on the poor, London - England, University of
California Press.
Foucault, M. (1993), Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino, Einaudi.
Foucault, M. (1997), Archivio Foucault 2. 1971-1977. Poteri, saperi, strategie, Milano, Feltrinelli.
Foucault, M. (1998), Nascita della clinica. Il ruolo della medicina nella costituzione delle scienze umane, Torino, Einaudi.
Foucault, M. (2000), Gli anormali. Corso al Collège de France 1974-1975, Milano, Feltrinelli.
Foucault, M. (2004), Il potere psichiatrico. Corso al Collège de France 1973-1975, Milano, Feltrinelli.
Galimberti, U. (1982), Il corpo, Milano, Feltrinelli.
Good, B. (1999), Narrare la malattia. Lo sguardo antropologico sul rapporto medico-paziente, Torino, Edizioni di Comunità.
Gordon, D. R. (1988), "Tenacius assumptions in western medicine", in Lock, M. e Gordon, D.R. (a cura di), Biomedicine examined,
17
Kluwer Academic Publishers, pp. 19-56.
Gramsci, A. (1977), Quaderni del carcere, Torino, Einaudi.
Kirmayer, L. (1992), "The Body's Insistence on Meaning: Metaphor as Presentation and Representation in Illness Experience", in:
Medical Anthropology Quarterly, vol. 6, 4, pp.323-346.
Last, M. (2000), "Reconciliation and memory in postwar Nigeria" in: Das, V., Kleinman A., Ramphele, M. Reynolds, P., (a cura di),
Violence and subjectivity, Berkley, University of California Press, 2000, pp. 315-332.
Ongaro-Basaglia, F. (1982), Salute/Malattia. Le parole della medicina, Torino, Einaudi.
Quaranta, I. (2003), "AIDS, sofferenza e incorporazione della storia a Nso'", in: Annuario di Antropologia, 3, pp. 43-74.
Scheper-Hughes, N., Lock, M. (1991), "The message in the bottle: illness and the micropolitics of resistance", The Journal of
Psychohistory, 18, 4, pp. 409-432.
Scott, J. (1985), Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance, New Haven Conn, Yale University Press.
Taussig, M. (1980), "Reification and the Consciousness of the Patient", in: Social Science and Medicine, vol. 14, pp. 3-13.
Young, A. (1982), "The anthropologies of illness and sickness", in: Annual Review of Anthropology, vol.11, pp. 257-285.
18
Il silenzio e la memoria
Riflessioni sulla memoria culturale fra i Roma1
di Paola Toninato
Lo scopo principale di questo articolo è di riflettere su alcuni
aspetti della 'memoria' fra i Roma - definiti spesso con il termine
dispregiativo di 'Zingari' - che restano ancora poco indagati e
sostanzialmente fraintesi dai Gage (non-Roma).
Il mio oggetto d'indagine sarà l'atteggiamento dei Roma nei
confronti del loro passato, inteso sia nel senso di memoria
comunitaria o 'di gruppo' (la 'memoria collettiva') sia nel senso di
memoria individuale e 'privata' (per lo più ristretta alla famiglia
consanguinea). In particolare, mi soffermerò sul significato del
silenzio osservato dai Roma a proposito di eventi drammatici
come l'Olocausto - che rappresenta il culmine delle persecuzioni
patite fin dal loro arrivo in Europa, nel XV secolo. 2 Questo
silenzio è stato finora erroneamente interpretato dai Gage come
sintomo di 'ignoranza' o di 'disinteresse' da parte dei Roma verso
il loro passato. Il mio obiettivo è appunto quello di dimostrare
che questa interpretazione è il frutto di una concezione
etnocentrica della storia e della memoria culturale. Per
comprendere appieno l'atteggiamento dei Roma nei confronti del
passato (in particolare il silenzio rituale), è necessario prendere
atto dell'esistenza di forme molto diverse di memoria,
riconducibili a sistemi socio-culturali ben distinti. È necessario
inoltre considerare con attenzione il contesto sociale in cui i Roma
sono immersi, soprattutto il legame fra la memoria culturale e il
modo in cui essi concepiscono e vivono la loro identità all'interno
del rapporto con i non-Roma.
La nozione di 'memoria' è notoriamente complessa e difficile da
definire. A rigor di termini, sarebbe opportuno parlare di
'memorie' al plurale, e non di 'memoria' tout court, dal momento
che essa può assumere connotati assai diversi a seconda dei
gruppi umani in questione.
La prima distinzione da fare è quella fra memoria individuale e
memoria collettiva.3 Ogni individuo ha un 'bagaglio' di memorie
che riflette le sue personali esperienze di vita e che è perciò unico
e irripetibile. D'altro canto, come ha sottolineato Halbwachs, la
memoria individuale è strettamente legata alla memoria del
gruppo sociale, che fornisce al singolo gli stimoli e gli strumenti
necessari per 'ricostruire' il passato:
Memory depends on the social environment […] it is in society
that people normally acquire their memories. It is also in society
that they recall, recognize, and localize their memories.4
Da questo punto di vista, la memoria non è mai un fenomeno
puramente idiosincratico, ma reca sempre la 'traccia' del contesto
sociale in cui è emersa e ha preso forma. Questo ci porta a
distinguere fra la 'memoria' in un contesto di tipo 'tradizionale' e
in un contesto 'post-industriale'.
La memoria secondo i Gage
In genere i non-Roma tendono ad assimilare la nozione di
'memoria' e quella di 'storia', e identificano la Storia con la
memoria scritta - ne è prova il fatto che essi parlano in genere di
'memoria storica' tout court. In altre parole, quando ci riferiamo
alla 'memoria' di un gruppo umano tendiamo ad associarla
istintivamente all'uso della scrittura, che rappresenterebbe il
mezzo più affidabile per registrare fedelmente eventi e ricorrenze.
La memoria storica per antonomasia è perciò legata
indissolubilmente al codice scritto, ed è ad essa che le società
occidentali si affidano per la trasmissione dei fatti del passato.
D'altro canto, la storia orale, percepita come labile e inaffidabile,
viene generalmente relegata in una posizione marginale. Essa
viene considerata esclusiva delle società 'senza scrittura' (le
cosiddette società 'primitive' o 'selvagge'), che devono affidarsi
alla 'memoria etnica' per trasmettere le conoscenze di generazione
in generazione.
Jacques Revel osserva che nelle società occidentali la memoria è
diventato l'oggetto privilegiato della storia ed ha assunto un
carattere quasi ossessivo:
Memoria
19
È come se le nostre società fossero diventate delle
imprese produttrici di memoria, che impiegano buona
parte della loro narcisistica attività a riflettere sui mezzi
per fissare la loro immagine mentre sono ancora viventi. 5
Queste società si sforzano in tutti i modi di 'preservare' la
memoria, di 'fissarla' e di staccarla dal flusso temporale per
renderla 'eterna' e salvarla dall'oblio. Questo atteggiamento
sembra in linea con la nozione tucididea della storia intesa come
'possesso perenne': il compito della storia sarebbe insomma quello
di strappare al tempo il ricordo di eventi che altrimenti andrebbero
perduti. Una volta fissata in forma scritta, la memoria diventa
'oggetto' da catalogare, accumulare, commemorare e venerare.
Questo processo di 'fissazione' della memoria attraverso la
scrittura può essere ricondotto al modo in cui i Gage costruiscono
e confermano la propria identità. È solo conservando la memoria
del gruppo, mettendola al riparo dalle imprevedibili modifiche
legate al passare del tempo, che i Gage preservano la loro identità.
La memoria secondo i Roma
Abbiamo appena visto l'importanza che la scrittura riveste fra i
Gage in relazione alla memoria.
Ora, uno degli stereotipi più ricorrenti nei riguardi dei Roma è che
siano appunto un popolo 'senza scrittura'. Questa convinzione
rientra in un paradigma antropologico di tipo 'detrattivo', che
continua a condizionare il nostro modo di rappresentare questo
gruppo etnico. Agli occhi dei Gage, i Roma sono un popolo che
sembrerebbe privo delle componenti che stanno alla base della
'civiltà' occidentale: un patrimonio storico e culturale comune,
una lingua unificata e scritta, una patria dai confini territoriali
netti. Lo stesso termine 'Zingari'6 significa letteralmente
"intoccabili". Questa tendenza a definire i Roma in termini
puramente negativi è anche all'origine della loro inclusione nel
novero dei popoli 'senza scrittura'. Ed è su questa particolare
definizione che vale la pena di soffermarsi.
I Roma, pur essendo immersi da secoli in una società altamente
alfabetizzata come quella europea, hanno preservato un sistema
comunicativo prevalentemente orale. Tuttavia, ciò non significa
che essi non abbiano alcuna conoscenza del ruolo fondamentale
della scrittura fra le società 'ospitanti'. Al contrario. Studi recenti 7
hanno dimostrato che i Roma, pur disponendo di una cultura
prevalentemente orale (che è peraltro perfettamente funzionale al
loro sistema sociale, dominato dal gruppo primario), sono in
possesso di una molteplicità di sistemi grafici più o meno
elaborati - dai segnali stradali ai codici di tipo 'criptico' legati ad
attività come la cartomanzia.
Inoltre, in tempi recenti
(sostanzialmente a partire dagli anni '50) essi hanno iniziato a
utilizzare in modo sempre più significativo la scrittura alfabetica,
dando vita a una letteratura scritta che gode di una crescente
diffusione, sia fra i Roma che fra i non-Roma.
Alla luce di questo uso diversificato della scrittura, appare del
tutto improprio continuare a definire i Roma come un popolo
sprovvisto di ogni codice grafico.
Eppure il mito
dell'analfabetismo 'intrinseco' dei Roma continua a godere di
un'ampia diffusione fra i Gage. Questo stereotipo è direttamente
legato all'immagine del popolo 'zingaro' come un popolo 'al di
fuori della storia', immagine perpetrata dai Gage in una serie
innumerevole di opere di carattere 'scientifico' e letterario.
Esistono molti studi, molte 'storie degli Zingari' (più o meno
fantasiose), ma fino a poco fa mancava una storia scritta dai Roma
su stessi. 8 Questo ha incoraggiato il fiorire di stereotipi e di veri e
propri 'miti' letterari. Nel 1889 Colocci9 diffuse l'immagine degli
'Zingari' come popolo al di fuori della storia. Secondo l'autore
questa 'strana' gente dai 'volti bruni e malinconici' non è affatto
cambiata nel corso dei secoli: 'il tempo non ebbe la menoma presa
su questa razza di bronzo',10 ribadisce lo studioso. Questo
stereotipo sopravvive ancora nelle rappresentazioni
contemporanee dei Roma, soprattutto in quelle letterarie. In un
romanzo di Carlo Sgorlon, Il Caldèras, il giovane protagonista si
rivolge ai Gage per conoscere la propria storia. Egli è costretto a
spingersi al di fuori dei confini del proprio gruppo, in un ambiente
potenzialmente ostile, per avere conferme circa il suo passato.
Purtroppo la sua inchiesta è destinata a rivelarsi infruttuosa:
Una storia degli zingari non si trovava, nessuno di loro ne aveva
mai vista una, nessun cliente l'aveva mai chiesta, era probabile
che non fosse mai stata scritta;
[…] nessuno aveva mai compilato una storia degli zingari perché
gli scrittori avevano sempre ritenuto che essi non possedessero
una storia, così come non avevano una patria, perché erano un
popolo bambino e fuori dal tempo.11
Rappresentazioni di questo tipo alimentano la convinzione che i
Roma siano un popolo 'privo di interesse per il passato', e per la
storia in generale. E come potrebbe essere altrimenti, visto che la
maggioranza dei non-Roma è ancora convinta del fatto che essi
non conoscano la scrittura? Come e cosa potrebbero mai
'ricordare' i Roma, si chiedono i Gage, se non sono dotati degli
strumenti essenziali per conservare la memoria e per trasmetterla
in modo efficace?
La risposta ci viene dagli stessi Roma, fra i quali la memoria
assume forme diverse e per molti versi irriducibili alle categorie
culturali dei Gage. Nella parte seguente dell'articolo, analizzerò
tre contesti diversi, tre diverse manifestazioni della memoria fra i
Roma, iniziando dalle memorie dell'Olocausto e dalle recenti
rappresentazioni scritte della memoria culturale romani per poi
passare al caso del silenzio rituale fra i Manuš francesi.
L''Olocausto dimenticato' 12
Pur essendo stati oggetto di un vero e proprio sterminio di massa
durante il periodo nazista (anche se non ci sono dati numerici
certi, si ritiene che circa 500.000 'Zingari' siano morti nei campi
di sterminio), i Roma non hanno avuto alcuna rappresentanza al
processo di Norimberga. Fino ad ora essi sono stati praticamente
esclusi sia dal dibattito sull'Olocausto, sia dalle opere e dai
monumenti volti a commemorarlo - un'esclusione che sembra
20
riflettere la marginalizzazione dei Roma sul piano politico e
sociale.
È stato inoltre fatto notare che sono stati gli stessi Roma a
contribuire a questo processo di 'esclusione' dalla memoria. Essi
mostrano un'evidente riluttanza a parlare delle persecuzioni subite
dal loro popolo nel corso dei secoli, e sembrano preferire il
silenzio alle commemorazioni pubbliche. Questa reticenza, questa
apparente 'negazione del ricordo' da parte dei Roma è stata
erroneamente ricondotta a una mancanza di interesse nella storia
del loro popolo. È stato persino insinuato che i Roma non parlino
dell'Olocausto perché ne sono completamente 'all'oscuro'.
Questi giudizi - del tutto infondati - contribuiscono a diffondere la
convinzione che i Roma siano un popolo 'fuori della storia',
immerso in un eterno presente e fatalmente escluso dalle leggi del
progresso e dalle dinamiche in atto nelle 'società storiche'.13 In
realtà questa convinzione è il frutto di un'interpretazione
etnocentrica della storia. Come abbiamo visto, secondo i Gage la
Storia (quella con la 'S' maiuscola, in opposizione alle
innumerevoli e frammentarie 'storie' individuali) è la storia scritta,
la storia documentaria, considerata come l'unica depositaria
affidabile della memoria di un popolo. La storia orale invece,
quella dei popoli 'senza scrittura', è percepita come qualcosa di
fluido, come un flusso ininterrotto che segue percorsi
imprevedibili, che può affievolirsi fino a scomparire per poi
riaffiorare inaspettatamente, come un fiume sotterraneo risale
all'improvviso in superficie. Questo tipo di storia, considerata dai
Gage inaffidabile e inadeguata a preservare la memoria, è
confinata alle società 'tradizionali', come appunto quella dei
Roma.
Quali sono le principali differenze fra la storia scritta, lineare e
cumulativa, e la storia dei Roma? Innanzitutto quest'ultima non è
mediata e filtrata dalla scrittura, non è sistematizzata e
organizzata secondo un criterio di tipo lineare. Ma il fatto che non
ci siano testimonianze scritte sulla storia dei Roma non significa
ovviamente che essa non sia affatto esistita. Significa che occorre
cercarla in una dimensione diversa rispetto a quella scritta. La
memoria culturale dei Roma è essenzialmente una memoria 'viva',
è 'agita' nella vita quotidiana e non nella sfera pubblica; essa è,
come ha scritto Williams
dell'Olocausto, a proposito del quale i Roma osservano un
silenzio interpretato dai Gage - in modo affrettato e semplicistico
- come 'vuoto', come assenza di memoria. Jerzy Ficowski, un
poeta polacco che ha raccolto e trascritto le poesie di Papusza
(considerata la 'madre' della letteratura romani) afferma che ad
eccezione di due canti dedicati ad Auschwitz - peraltro cantati
molto di rado - egli non ha trovato alcuna traccia di memorie di
guerra fra i Roma polacchi. Costoro non commemorano
l'Olocausto e non amano parlarne: sembrerebbero avere
completamente dimenticato le atrocità subite nei campi di
concentramento. La giornalista Isabel Fonseca, autrice di un
fortunato libro sui Roma europei,15 conferma le impressioni di
Ficowski. Secondo l'autrice, fino a questo momento i Roma
hanno cercato di 'reprimere' e di 'cancellare' le tracce del loro
passato (Fonseca parla di un 'istinto' dei Roma a 'reprimere il
passato'):
The Jews have responded to persecution and dispersal with a
monumental industry of remembrance. The Gypsies - with their
peculiar mixture of fatalism and the spirit, or wit, to seize the day
- have made an art of forgetting.16
Abbiamo quindi il caso di due gruppi etnici, i Roma e gli Ebrei,
che sembrano essere agli antipodi per quanto riguarda il modo di
guardare alla loro 'memoria etnica'. Per gli Ebrei il ricordo, la
testimonianza, rappresenta un 'dovere' a cui è impossibile
sottrarsi. È quindi necessario ricordare, è necessario conservare i
resti dei campi di concentramento, le barricate, il filo spinato, i
forni crematori, perché i segni tangibili dello sterminio 'parlano da
sé', raccontano una storia che grazie alla commemorazione viene
di volta in volta 'rivissuta' e sottratta all'oblio.
Elie Wiesel, parla di una 'necessità di farsi 'testimoni', di
conservare il ricordo di Auschwitz:
to have survived only to forget would be blasphemy, a second
catastrophe. To forget the dead would be to have them die a
second time.17
Dimenticare lo sterminio, lasciare svanire il suo ricordo,
equivarrebbe a considerarlo niente più che una sorta di 'errore', un
incidente di percorso che va rimosso dalla coscienza collettiva.
Per Wiesel questo è semplicemente inconcepibile, è un affronto
nei confronti delle vittime. Ricordare è quindi una sorta di
'imperativo categorico'. Ma qual è il modo migliore per ricordare
questi eventi? Com'è possibile 'ridire l'indicibile'? Come dare un
significato a un evento che sembra sfidare qualsiasi logica?
La memoria di eventi traumatici come le persecuzioni e in ultima
istanza il genocidio ha delle caratteristiche particolari. Essa è
stata descritta come m
' émoire profonde' (memoria profonda),
ovvero come una forma di memoria così satura di emozioni e
sofferenza da causare un dolore fisico: è ciò che Primo Levi
definisce come 'la cicatrice del ricordo', il trauma, la cui intensità
impedisce ai sopravvissuti di parlare della loro esperienza.
Questa forma di memoria è ben diversa dalla 'mémoire ordinaire',
Una memoria che non fa discorso, una memoria che non mira
all'esplorazione del passato e all'accumulazione di conoscenze;
[…] la commemorazione, così come è organizzata [fra i Roma],
provoca la conservazione di ricordi sempre più intimi e non
suscita affatto l'edificazione di una memoria comunitaria,
memoria-saga, memoria-epopea, memoria del gruppo in quanto
tale.14
La memoria a cui si riferisce l'antropologo vive nei piccoli gesti
di tutti i giorni, quei gesti che agli altri - i Gage, coloro che non
conoscono le tradizioni dei Roma - passano inosservati. Questa
memoria si nutre soprattutto di silenzi, di rispettosa 'astensione
dal ricordo'.
Questo atteggiamento si riscontra chiaramente nel caso
21
ovvero la memoria di eventi ordinari, quotidiani, che rimane in
qualche modo esterna al soggetto. Questo tipo di memoria,
filtrata dalla ragione, si inserisce all'interno di una struttura
narrativa di tipo sequenziale (tanto che viene anche definita
'memoria intellettuale').18 Ben diverso è il caso della memoria
romani, che nasce e si forma in un contesto orale, in cui i fatti del
passato non sono oggettivati attraverso la scrittura, ma rimangono
intrinsecamente legati al loro referente umano. Per questo fra i
Roma la rievocazione dei ricordi legati all'Olocausto è circondata
da un grande rispetto. È appunto al principio del rispetto che i
Roma si attengono quando scelgono di onorare con il silenzio, e
non la parola scritta, la memoria dei morti del genocidio nazista.
Questo silenzio non può essere interpretato come 'mancanza di
interesse' per la storia del loro popolo.
Per i Gage, il silenzio non è altro che 'assenza di comunicazione',
è l'oblio. Ma l'oblio non è il vuoto. Secondo la poetessa Paula
Schöpf (che vive fra i Sinti estrekarja), il silenzio può avere due
significati distinti: il primo è il silenzio come segno di
vigliaccheria, è la paura di dare testimonianza. Ma vi è anche un
altro tipo di silenzio, che presenta un significato molto diverso: è
il silenzio causato dal ricordo delle sofferenze patite. Questo
silenzio non è indice di un'assenza', ma al contrario, è così carico
di afflizione e di angoscia da sfidare il linguaggio ordinario.
Come vedremo nella sezione seguente, alcuni Roma hanno deciso
di accettare questa sfida, e lo hanno fatto ricorrendo al linguaggio
della poesia.
aleggia nell'aria la nenia della morte!
Da queste pietre, grigie pietre,
da ogni rovina, dalle cornici infrante,
esala disperazione di sangue e lacrime.
Il mio spirito s'impiglia nel filo spinato
E la mia anima s'aggrappa alle sbarre,
prigioniera in casa nemica!
Chi sono? Nessuno! Tu chi sei? Nessuno!
Voi Sinti chi siete? Nessuno! solo ombre,
nebbia! Nebbia che per abitudine è rimasta
prigioniera della più grande infamia
della storia dell'uomo!
'È finita la storia dei sinti
I violini tacciono
Le chitarre non hanno più voce
Le giovani donne non danzano più
Non hanno più piedi per danzare
I fuochi si sono spenti
Gelida è la notte
La nebbia ha dissolto i cuori dei sinti
La terra si è dissetata con il sangue dei sinti
Non ci sono più carrozzoni
Nella verde periferia
Né violini innamorati
Né fiori nei capelli bruni'.21
I poeti e l'Olocausto
In tempi recenti, un numero crescente di autori rom ha dedicato
racconti e componimenti poetici al ricordo dell'Olocausto e alla
storia del loro popolo, nel tentativo di rafforzare il senso
dell'identità romani e di forgiare una sorta di 'memoria collettiva'.
Si tratta di una tendenza recente che per ora interessa solo una
minoranza di Roma, ma è comunque importante darne
testimonianza ed evidenziare le sue peculiarità rispetto alla forma
di memoria basata sul rispetto e sul silenzio. L'attività di questi
poeti è strettamente legata alla formazione di una 'intelligentsja',
che utilizza la scrittura e i canali comunicativi finora
monopolizzati dai Gage per sfatare gli stereotipi più odiosi che
ancora circondano gli 'Zingari' e per mantenere viva, fra i Roma,
la percezione delle proprie radici storiche e culturali. Nei loro
scritti l'Olocausto è rappresentato come il simbolo
dell'intolleranza e dell'ostilità della società dominante, che ha
sempre cercato di escludere e di negare la diversità dei Roma in
quanto 'devianza' rispetto alle norme della società maggioritaria.19
I primi due testi sono poesie di Paula Schöpf (già menzionata in
precedenza), mentre gli ultimi due sono testi di Santino Spinelli,
Rom abruzzese e membro attivo della nascente 'intelligentsja'
romani.
In queste poesie l'Olocausto è innanzitutto silenzio: il silenzio
della morte, dell'annullamento totale, dell'etnocidio. Le immagini
presentate nel testo rievocano una disperazione senza scampo. La
musica, la danza, i canti - cioè le manifestazioni ritenute quelle
più tipiche dell'arte romani - sono stati zittiti per sempre. Di
fronte allo sterminio dei Roma e ai tentativi da parte dei Gage di
mascherarlo o di rimuoverlo dalla 'coscienza collettiva', la
poetessa reagisce con una denuncia perentoria e improrogabile
(l'Olocausto è definito come 'la più grande infamia della storia
dell'uomo'). Ecco allora il dispiegarsi, all'interno delle sue poesie,
di una successione incalzante di domande retoriche, volte a
enfatizzare la violenza brutale e assoluta (Voi Sinti chi siete?
Nessuno! solo ombre,/nebbia!) che ha travolto il suo popolo.
Lo stesso atteggiamento di denuncia sembra animare le poesie di
Santino Spinelli, caratterizzate dalla deformazione surrealistica
del linguaggio poetico :
AUSCHWITZ 22
Faccia incavata,
occhi oscurati,
labbra fredde;
silenzio.
Cuore strappato
senza fiato,
OLOCAUSTO DIMENTICATO20
Silenzio, desolazione, oscura notte
il cielo è cupo, pesante di silenzio!
22
senza parole,
nessun pianto.
MALEDIZIONE ZINGARA 23
Gelide mani nere rivolte al cielo,
la palude ricopre la testa
schiacciata,
un grido soffocato si eleva,
nessuno ascolta.
Un popolo inerme
al massacro condotto,
nessuno ha visto
nessuno ha parlato.
Cadaveri risorti
dalla palude,
orribili visi mostrati al sole,
il dito puntato
verso chi ha taciuto!
Anche in questi componimenti, in cui la struttura narrativa è
sostituita da una sequenza di immagini giustapposte quasi 'per
accumulo', sono dominati dalla desolazione e dagli effetti della
violenza cieca e brutale dei persecutori nazisti. In questo
paesaggio da inferno dantesco, tutto è assenza di vita, di luce e di
calore (Faccia incavata,/occhi oscurati,/labbra fredde;/silenzio).
Ma verso la fine della poesia un altro silenzio si fa strada: è il
silenzio che, imposto dalla società maggioritaria sul passato dei
'popoli senza storia', è riuscito a oscurare il ricordo di quanto è
accaduto. È contro questo silenzio 'colpevole' e criminale che si
leva il grido oltraggiato del poeta: il dito puntato/verso chi ha
taciuto!
Il grido del poeta rompe il silenzio con cui molti vorrebbero
cancellare l'orrore delle persecuzioni e del genocidio: esso è
quindi rivolto a coloro innanzitutto che vogliono annullare il
passato e deformare intenzionalmente la storia, piegandola ai
propri fini. Questo silenzio non ha nulla a che vedere con il
silenzio rituale dei Roma. Nel primo caso (l'infamia taciuta) il
silenzio equivale alla soppressione della memoria e alla sua
falsificazione, mentre nel caso dei Roma il silenzio è un modo per
proteggere alla memoria, per non farle torto. Per illustrare questa
differenza cruciale mi soffermerò brevemente sul silenzio rituale
fra i Manuš francesi studiati da Williams.
L'antropologo francese ha analizzato con grande finezza le
reazioni dei Manuš di fronte alla morte all'interno del gruppo
familiare, evidenziandone la diversità rispetto alle tradizioni della
società maggioritaria. Fra i Gage il modo più naturale di
'rielaborare' - e quindi in qualche modo superare - il trauma della
perdita di un parente stretto è quello di rievocarne la figura, il
carattere, le abitudini e così via. I Manuš al contrario, come ci
spiega Williams, onorano i loro morti distruggendone gli oggetti
personali, astenendosi dal consumare le loro bevande o i loro cibi
preferiti, evitando con grande cautela il luogo dove è avvenuto il
decesso, e soprattutto evitando di pronunciarne il nome.24
23
Nella lingua dei Manuš non esiste un termine specifico per
definire la 'memoria': essi usano il termine 'era', cioè 'rispetto', per
indicare ciò che noi chiamiamo 'memoria'.25 La memoria insomma
non è oggettivata, non è espressa in termini linguistici. Il
linguaggio infatti introduce una cesura temporale, separa le
persone dagli eventi e quindi anche dal ricordo dei propri cari.
Per i Manuš, il modo migliore di ricordare i morti è quello di
riviverne la perdita nella vita di tutti i giorni, evitando di
pronunciare il nome del defunto, o curandosi di farlo con il
ricorso a perifrasi ('il mio defunto fratello', 'il mio povero defunto
padre' e così via).
I Manuš sanno che la memoria umana è fallace, inaffidabile. Essa
potrebbe in ogni momento alterare il ricordo, intaccando così
anche il rispetto con cui si devono onorare i morti. Osservando il
silenzio, i Manuš proteggono la memoria del defunto da possibili
abusi. Del resto come si può 'parlare' in modo adeguato di chi non
c'è più? Non ci sono parole al mondo che possano fare giustizia
alla memoria di chi è scomparso. La morte è innanzitutto perdita,
è silenzio. È oblio. Che senso ha cercare di 'possedere' questo
silenzio, o cercare di esprimerlo razionalmente? Tutto ciò non
solo non porterebbe a niente, ma equivarrebbe soprattutto a una
terribile mancanza di rispetto.
La memoria culturale dei Roma e il contesto sociale
Nel corso dell'articolo è stato osservato che le nozioni di memoria
e di storia fra i non-Roma sono fortemente influenzate dall'uso
della scrittura. Secondo i Gage la Storia (con la 'S' maiuscola, in
opposizione alle innumerevoli e frammentarie 'storie' individuali)
è fondamentalmente la storia scritta, la storia documentaria,
considerata come l'unica depositaria affidabile della memoria di
un popolo. Le società occidentali sembrano protese nello sforzo
di registrare, conservare e 'patrimonializzare' le vestigia del
passato, perché è attraverso questo processo di fissazione della
memoria che esse riescono a confermare e rafforzare la loro
identità. In contrasto con questo atteggiamento, i Roma non si
affidano alla scrittura per trasmettere e conservare la memoria.
Come abbiamo visto a proposito dell'Olocausto, essi preferiscono
affidare al silenzio il ricordo traumatico delle persecuzioni. A
parte il caso recente dei poeti, i Roma non hanno finora
manifestato la volontà di costruire, come gli Ebrei, un''industria
della memoria', non hanno espresso le loro memorie nella sfera
pubblica. Come interpretare questo atteggiamento? Come
concepire questa enfasi posta sull'oblio più che sulla memoria?
Per cercare una possibile risposta a questi interrogativi è
necessario rivolgerci al complesso sistema delle relazioni fra
Roma e non-Roma.
La configurazione della memoria romani in termini di 'assenza' e
astensione dal ricordo riflette il modo in cui i Roma concepiscono
il loro rapporto con i Gage. Per preservare la loro specificità
culturale, i Roma hanno scelto di restare ai margini del sistema
sociale del gruppo dominante. Così facendo, essi si rendono
'invisibili' agli occhi dei non-Roma, minimizzando i rischi di
assimilazione culturale e al tempo stesso riaffermando la propria
identità e l'unicità della propria visione del mondo. Ai Gage può
sembrare strano che i Roma ricorrano a questa forma di 'autorimozione' dal contesto sociale per definire se stessi. Per
comprendere questa strategia, è necessario considerare le
peculiari caratteristiche della loro presenza all'interno della
società dominante. I Roma vivono in una realtà in cui i Gage
esercitano un'egemonia incontrastata sia dal punto di vista socioeconomico che dal punto di vista culturale e ideologico. Essi
sono in continuo contatto con questa realtà, contatto da cui non
possono prescindere per ovvie ragioni di sopravvivenza
economica e culturale, e questa prossimità rappresenta una
minaccia costante per la loro identità. Scegliendo il silenzio e
l'invisibilità sociale come strategie per gestire il loro rapporto con
la storia (scritta) e con la società dominante, i Roma creano una
distinzione simbolica che li distingue dai Gage, garantendo la loro
sopravvivenza come un gruppo separato.
L'unico modo per interpretare il significato simbolico del silenzio
fra i Roma consiste quindi nel metterlo in relazione con il contesto
sociale più generale. Considerare - come è stato fatto finora - il
silenzio in termini assoluti, svincolati da ogni contesto (il silenzio
in sé) porta a classificarlo semplicemente come un'assenza o una
carenza nel sistema comunicativo. Nella prospettiva dei Roma, al
contrario, il silenzio non ha una connotazione puramente
negativa, ma è il modo migliore per riaffermare la propria
diversità culturale dal gruppo maggioritario. Ci troviamo qui di
fronte a un'opposizione dialettica altamente significativa. Mentre
i Gage confermano la propria identità attraverso la preservazione
della memoria e la sua trasmissione in forma scritta, i Roma popolo arbitrariamente definito 'senza scrittura' e 'senza storia' - ci
rivelano un approccio completamente diverso alla memoria.
Invece di concentrarsi sull'articolazione del ricordo in una forma
verbale, invece di optare per la catalogazione della memoria e per
il suo accumulo, essi hanno scelto di proteggere la memoria degli
eventi passati con l'astinenza e il rispetto, e hanno trovato nel
silenzio la forma suprema di possesso e di definizione della
propria identità etnica.
NOTE
1
Adattato da 'Memory and Oblivion in the Construction of Romani Identities', comunicazione per la conferenza Translation,
Memory and Culture (ACUME project & University of Warwick 2003). Pubblicato nel 2004 per all'interno dei Warwick Working
Papers in Translation and Cultural Studies.
2
L'articolo si ispira alle ricerche di Piasere e di Williams - autori di pregevoli monografie sui Roma sloveno-croati e i Manuš
francesi - e a un mio studio sulla funzione della scrittura fra i Roma sloveno-croati.
3
Non mi addentrerò qui nelle altri possibili distinzioni relative al concetto di memoria, per esempio su quella fra memoria
'specifica' (che garantisce la fissazione dei comportamenti fra le specie animali), contrapposta alla memoria 'etnica' (caratteristica
delle società umane), e memoria 'artificiale' (in particolare quella elettronica).
4
M. Halbwachs, On Collective Memory (Chicago: University of Chicago Press, 1992), pp. 37-38.
5
J. Revel, 'La memoria e la storia' URL: http://www.emsf.rai.it (28 Maggio 2003).
6
Dal termine greco athínganoi, cioè 'intoccabili', in origine il nome di un'antica setta religiosa della Frigia (IX secolo). Questo
termine verrà utilizzato nel presente articolo tra virgolette (a sottolinearne l'arbitrarietà) unicamente a scopo classificatorio e servirà
ad indicare tutti i gruppi 'zingari' in generale.
7
Si veda ad esempio i lavori di Piasere (in particolare l'articolo 'I segni "segreti" degli Zingari', Ricerca Folklorica, 31 (1995), 83105) e Patrick Williams (si veda il suo articolo 'La scrittura fra l'orale e lo scritto', in Daniel Fabre, (a cura di), Per iscritto:
Antropologia delle scritture quotidiane, trad. it. di Anna Iuso (Lecce: Argo, 1998), pp. 79-99).
8
Questa lacuna è stata recentemente colmata da alcuni membri dell'intelligentsja romani (ad esempio Rajko Djuric e Ian Hancock),
che si sono interessati in particolare della documentazione relativa allo sterminio nazista.
9
Autore del trattato Gli Zingari. Storia di un popolo errante (Torino: Loescher, 1889).
10
Colocci, op. cit, p. 3.
11
C. Sgorlon, Il Caldèras (Milano: Mondadori, 1989), p. 115.
12
Il termine usato dai Roma per definire l'Olocausto è 'Porrajmos', ovvero 'divoramento'.
24
13
Sulle rappresentazioni degli 'Zingari' come 'popolo senza storia' si veda Katie Trumpener, 'The Time of the 'Gypsies', Critical
Inquiry, 18 (Summer 1992), 843-884, e sul processo di 'dislocazione temporale' dell''Altro' in antropologia cfr. J. Fabian, Time and
the Other: How Anthropology Makes its Object (New York: Columbia University Press, 1983).
14
P. Williams, Noi, non ne parliamo: I vivi e i morti tra i Manuš (Roma: CISU, 1997), pp. 11-12.
15
I. Fonseca, Bury Me Standing. The Gypsies and Their Journey (London: Vintage, 1996).
16
I. Fonseca, op. cit., p. 276.
17
Citato in L. Rapaport, Jews in Germany after the Holocaust: Memory, Identity, and the Jewish-German Relations (Cambridge:
Cambridge University Press, 1997), p. 23.
18
Cfr. C. Delbo, Days and Memory (Vermont: Marlboro, 1990) (orig. francese 1985), p. 2.
19
La persecuzione dei Roma, che presenta caratteri molto simili al genocidio ebraico, trova le sue origini nella tesi nazista della
natura 'asociale' (e perciò pericolosa) degli 'Zingari'. Secondo i nazisti l'asocialità zingara era irrecuperabile, in quanto legata a una
'tara' di tipo genetico (si veda in merito anche le teorie dell'antropologia criminale positivista, soprattutto la teoria del 'delinquente
nato' di Cesare Lombroso).
20
BISTARDI LAIDA. Stil, phari, tunkel rathy / u himlo hì kalo. pharo fon stilapen! / Givela an u lufto muldrengri gili! / fon kala
brar, grau bar, / von haki zugrunda fon pargerdé raume, / kant fon rat und treni. / Mu gaisto hangela an u stekeltrota. / Mar zela
hengrelpes pù sasstar, / plandli an fremdo them! / Kun hone? Keck! Tu kun hal? Keck! / Tume sinti kun han? Keck! Nur shata, /
nebla! Nebla furr braucha cass / Phlandli fon brardar cilacipen / fon mencengri historia! Poesia di Paula Schöpf pubblicata in M.
Karpati (a cura di), Zingari ieri e oggi (Roma: Lacio Drom, 1993), p. 208.
21
Dalla poesia 'Il viaggio è finito', in La mendicante dei sogni (Bolzano: Atelier grafico, 1997), p. 16.
22
Muj šukkó, / kjá kalé / vušt šurdé; / kwit. / Jiló cindó / bi dox, / bi lav, / nikt rubvé. Santino Spinelli, Gilí Romaní / Canto Zingaro
(Roma: Lacio Drom, 1988).
23
KUSIBBÈ ROMANÒ. Surdè vašt kalè šdinè ku thèm, / panì milalò a ciarèl u širò / sa tritimmè, / ni lùk a šunèp pandindò, / nikt a
šunèl. / Ginè bi nafèl / ku mirribbè 'ngirdè, / nikt a dikkià / nikt a vakirià. / Mulé riggidè / andrè u panì milalò, / xalè muj angiàl ku
khàm, / u 'ngustò a sìnnl / angiàl ki kòn / u kwit a cilò! S. Spinelli, Romanipè / Ziganità (Chieti: Solfanelli, 1993).
24
In chiave simbolica, il significato del silenzio manuš può essere inteso semioticamente come 'scarto differenziale'. Così come
l'introduzione di un fonema ci permette di distinguere una parola da un'altra, e questa distinzione genera una variazione di
significato, la rimozione di un nome dal contesto in cui esso era inserito introduce una differenza significante. Ciò che è rilevante in
questo caso non è tanto il silenzio in sé, il 'contenuto materiale' del silenzio (o meglio l'assenza di contenuto), quanto la sua
relazione dinamica con il contesto sociale. Il silenzio rituale crea una interruzione simbolica nel flusso del discorso, e questa
interruzione assume un significato simbolico molto importante.
25
P. Williams, op. cit., p. 13.
BIBLIOGRAFIA
Assmann, Jan, 'Collective Memory and Cultural Identity' New German Critique 65 (1995), 125-133.
Colocci, Adriano, Gli Zingari. Storia di un popolo errante (Torino: Loescher, 1889).
Delbo, Charlotte, Days and Memory (Vermont: Marlboro, 1990) (orig. francese 1985).
Fabian, Johannes, Time and the Other: How Anthropology Makes its Object (New York: Columbia University Press, 1983).
Fabre, Daniel (a cura di), Per iscritto: Antropologia delle scritture quotidiane, trad. it. di Anna Iuso (Lecce: Argo, 1998).
Fentress, James e Chris Wickham, Social Memory (Oxford: Blackwell, 1992).
Ficowski, Jerzy, The Gypsies in Poland: History and Customs, trad. inglese di Eileen Healey (Interpress, 1991).
Fonseca, Isabel, Bury Me Standing (Londra: Vintage, 1996).
Fraser, Angus, The Gypsies (Oxford: Blackwell, 1992).
Graff, Harvey J., The Legacies of Literacy (Bloomington: Indiana University Press, 1991).
Halbwachs, Maurice, On collective memory (Chicago: University of Chicago Press, 1992) (ed. orig. 1925).
Hancock, Ian, The Pariah Syndrome: An Account of Gypsy Persecution and Slavery (Ann Arbor: Karoma, 1987).
Karpati, Mirella (a cura di), Zingari ieri e oggi (Roma: Lacio Drom, 1993).
Jakobson, Roman, Six leçons sur le son et le sense (Parigi: Editions de Minuit, 1976).
Langer, Lawrence, The Holocaust and the Literary Imagination (New Haven: Yale University Press, 1975).
Le Goff, Jacques, Storia e memoria (Torino: Einaudi, 1977).
Levi, Primo, 'Revisiting the Camps', in James Young (a cura di), The Art of Memory: Holocaust Memorials in History (Monaco:
Prestel, 1994), 185.
25
Mitchell, W.J. Thomas (a cura di), On Narrative (Chicago: University of Chicago Press, 1980).
Okely, Judith, The Traveller-Gypsies (Cambridge: Cambridge University Press, 1983).
Ong, Walter, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word (Londra: Methuen, 1982).
Piasere, Leonardo, Mare Roma: Catégories humaines et structure sociale: Une contribution à l'ethnologie tsigane (Parigi: Études et
Documents Balkaniques et Méditerranéens, 1985), monografia no 6).
_________, 'I segni "segreti" degli Zingari', Ricerca Folklorica, 31 (1995), 83-105.
Rapaport, Lynn, Jews in Germany after the Holocaust: Memory, Identity, and the Jewish-German Relations (Cambridge: Cambridge
University Press, 1997).
Revel, Jacques, 'La memoria e la storia' URL: http://www.emsf.rai.it (28 Maggio 2003).
Schöpf, Paula, La mendicante dei sogni (Bolzano: Atelier grafico, 1997).
Sgorlon, Carlo, Il Caldèras (Milano: Mondadori, 1989).
Sibley, David, Outsiders in Urban Societies (Oxford: Blackwell, 1981).
Spinelli, Santino, Gilí Romaní / Canto Zingaro (Roma: Lacio Drom, 1988).
_________, Romanipè / Ziganità (Chieti, Zolfanelli, 1993).
Steiner, George, Language and Silence: Essays 1958-1966 (Londra: Faber, 1967).
Toninato, Paola, L'uso femminile della scrittura fra i Roma sloveno-croati, in Leonardo Piasere (a cura di), Italia Romani (Rome:
CISU, 1999), II, 147-168.
Trumpener, Katie, “The Time of the 'Gypsies'”, Critical Inquiry, 18 (1992), 843-884.
Young, James, Writing and Rewriting the Holocaust: Narrative and the Consequences of Interpretation (Bloomington: Indiana
University Press, 1988).
White, Hayden, Tropics of Discourse: Essays on Cultural Criticism (Baltimore e Londra: John Hopkins University Press, 1978).
Williams, Patrick, Noi, non ne parliamo: I vivi e i morti tra i Manuš (Roma: CISU, 1997).
_________, 'La scrittura fra l'orale e lo scritto', in Daniel Fabre, (a cura di), Per iscritto: Antropologia delle scritture quotidiane, trad.
it. di Anna Iuso (Lecce: Argo, 1998), pp. 79-99.
26
Retoriche dello sviluppo:
da Harry Truman a Colin Powell
di Paolo Borghi
Il 20 gennaio 1949 Harry Truman, presidente degli Stati Uniti, nel
discorso annuale sullo stato dell'Unione preannuncia il sostegno
del suo paese alle "nazioni sfavorite". E' il battesimo della nuova
dottrina dello sviluppo promossa dagli U.S.A., dottrina che verrà
abbracciata da gran parte dei paesi "occidentali" nei decenni
successivi. Ha inizio un cinquantennio di magnifiche imprese,
immaginate come risolutive di ogni mancato sviluppo nei paesi
definiti tradizionali, arretrati, sottosviluppati o in via di sviluppo,
Terzo Mondo1, Sud del mondo. Cinquantasei anni dopo, il
presidente degli U.S.A. George W.Bush, per mano del suo
Segretario di Stato Colin Powell, ridisegna la cornice di questa
impresa benefica che in un futuro, non sappiamo quanto
prossimo, giungerà a compimento.
Si intende qui confrontare il discorso di Truman2 , già analizzato
accuratamente da Gilbert Rist in Lo sviluppo.
Storia di una credenza occidentale, e il testo di
Colin Powell3 per evidenziare analogie e
differenze nel tracciare i contorni del
paradigma dello sviluppo.
Verranno ripresi gli assunti di fondo di Rist, in
particolare l'idea di sviluppo come credenza
occidentale, dimostrando quanto il testo di
Colin Powell conservi gli stessi tratti
ideologici di fondo del discorso visionario di
Truman mantenendo allo stesso tempo una sua
originalità dettata dal contesto storico
specifico in cui si inserisce e dalla mutata
sensibilità sociale frutto, in parte, delle stesse
retoriche di potere.
Harry
Progresso, benessere, sviluppo, e forse anche
democrazia (quando è esportata come un pacco dono) sono parole
feticcio o parole di plastica (Plastikwörter), per usare un termine
usato da Pörksen4 , la cui caratteristica è di essere appartenute al
linguaggio corrente con un senso chiaro, di essere poi passate al
linguaggio scientifico e successivamente al linguaggio dei
tecnocrati con un senso così estensivo da non significare più
niente. Si potrebbe aggiungere che il loro valore principale risieda
nella capacità di rinviare ad un simulacro, mutevole e sfuggente,
la cui distanza rimane costante lasciando però sul cammino tracce
della sua presenza che permettono di continuare a sperare. Come
definite da Rist "le credenze non costituiscono delle verità
dogmatiche alle quali ciascuno aderirebbe per intima
convinzione, ma si esprimono sotto la forma di semplici
proposizioni considerate vere in modo diffuso: vi si crede perché
si crede che tutti vi credano" 5. Progresso, benessere, sviluppo,
democrazia, diventano così strumenti retorici per "far credere" e
per "far fare" tanto più quando servono a definire o ridefinire
l'agenda setting della politica internazionale.
I due testi qui messi a confronto appartengono a fasi storiche assai
diverse ed il contesto di enunciazione determina un diverso grado
di esaustività e dettaglio. Il primo, quello di Truman, si colloca in
un contesto storico ricco di cambiamenti: la ricostruzione
dell'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'assestamento e il
consolidamento dei due blocchi, l'incombente Guerra Fredda, la
nascita di Israele, l'affermarsi dei movimenti d'indipendenza
(Indonesia1945; India 1947) e l'ascesa al potere di Mao Tse Tung
(Cina 1949). Scritto per l'annuale discorso sullo stato dell'Unione
si rivolge ai propri concittadini ma parla a tutto
il mondo: ribadisce il sostegno all'ONU e il
sostegno economico all'Europa con il Piano
Marshall, annuncia la creazione di
un'organizzazione comune di difesa (la
NATO) per contrastare la potenza sovietica e
al punto IV, quello su cui verrà calamitata
l'attenzione di tutta la stampa americana nei
giorni successivi, inaugura l'"era dello
sviluppo", enunciata ancora prima di essere
pianificata in profondità: passeranno infatti
quasi due anni prima del suo inizio vero e
proprio. Il punto IV rappresenta un'abile
passaggio retorico che getta le fondamenta di
una politica estera che si estende nel tempo
fino ai giorni nostri.
Truman
Il testo di Colin Powell ha per molti aspetti una
valenza diversa. Si colloca nella fase di passaggio fra il primo e il
secondo mandato presidenziale di George W.Bush. Powell ha
rappresentato l'ala moderata dell'amministrazione nelle recenti
guerre asimmetriche in Afghanistan e Iraq seguite alla distruzione
delle Twin Towers; il suo scritto, che è anche di commiato (verrà
sostituito dopo pochi giorni da Condoleeza Rice), è allo stesso
tempo un documento programmatico per il secondo mandato
dell'amministrazione Bush e una celebrazione del suo operato.
Powell non parla di guerre ma di sviluppo tratteggiando il volto
umano e altruista della politica estera U.S.A. in un quadro
internazionale che richiede un riavvicinamento all'Europa per la
gestione dei conflitti in corso. Crescita economica, sviluppo, lotta
al terrorismo ed esportazione (armata) della democrazia sono i
27
nodi centrali ed inseparabili della stessa politica.
Sebbene i due testi divergano in quanto a stile e profondità di
dettagli, sono accomunati dal tono messianico e dal ruolo da
protagonista indiscusso che ritagliano per gli U.S.A. nella grande
avventura dello sviluppo mondiale. Entrambi mirano a fondare un
"nuovo inizio" in un'impresa votata necessariamente al successo,
infallibile quanto lo spirito divino. L'apologia di se stessi e del
proprio operato, pur nella discontinuità richiesta da un ambizioso
e miracoloso progetto "nuovo", si nasconde dietro una analisi
fasulla perché privata delle ambiguità proprie di ogni contesto
sociale specifico e complesso. Ecco quindi che, nell'occultare la
storia naturalizzando le disparità realmente esistenti tra i diversi
paesi del mondo, Truman e Powell riescono, a distanza di
cinquantasei anni a tagliare i nastri di una nuova sfida, limpida,
lineare, audace come devono essere tutte le imprese epiche.
Passiamo ora al confronto e all'analisi dei due testi.
Truman (d'ora in poi T.): "Più della metà delle persone di
questo mondo vive in condizioni prossime alla miseria. Il loro
nutrimento è insoddisfacente. Sono vittime di malattie. La loro
vita economica è primitiva e stazionaria. La loro povertà
costituisce un handicap e una minaccia…"
Powell: (d'ora in poi P.) citando direttamente il presidente
W.Bush: "non è giusto ne stabile un mondo nel quale a vivere
nell'agio e nell'abbondanza sono solo alcuni mentre l'altra metà
del genere umano vive con meno di due dollari al giorno" e poi
direttamente "Metà della popolazione di questo pianeta, circa tre
miliardi di esseri umani, vive nell'indigenza".
Una delle caratteristiche del discorso messianico consiste nel
mostrare la mèta da raggiungere collocandola in un futuro
indefinito, tanto lontano quanto potenzialmente raggiungibile; il
punto di partenza deve accentuare la grandezza della sfida a cui si
è chiamati a partecipare. Accostando le considerazioni di partenza
di Truman e Powell non rimane che accantonare le illusioni che i
due discorsi evocano. A distanza di mezzo secolo è sempre la
metà della popolazione mondiale a vivere nell' "indigenza", metà
della popolazione mondiale che si trasforma in un impersonale
fantasma strumentale al dispiegamento di forze e sforzi meno
limpidi di quanto vogliono sembrare.
La coppia di termini sviluppo-sottosviluppo colloca su uno stesso
orizzonte potenziale tutti gli attori sociali, gli stati "sviluppati"
come quelli "sottosviluppati" che in epoca coloniale
rappresentavano invece l'assenza di civiltà ed erano perciò
identificati da un'alterità radicalmente diversa. Sviluppo e
sottosviluppo, in modo ancora più netto di civiltà ed assenza di
civiltà, rappresentano gradi diversi di un'unica gerarchia. Ora,
come sottolinea Rist, sotto l'influenza del paradigma dello
sviluppo, conforme alla Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'Uomo, si fa strada l'idea di un progresso che corre su una
strada comune, tanto ineluttabile quanto standardizzato su
parametri prettamente locali che pretendono di imporsi
universalmente, anche se non universalmente accettati; sono
modelli fondati su tecnocrazia e liberismo che permettono di
esportare sviluppo e democrazia, con la persuasione diplomatica
o con la forza delle logiche di mercato e delle armi.
Perché favorire lo sviluppo?
Lo sviluppo non è un imperativo che si impone per semplice
altruismo o per sensibilità morale, paravento d'obbligo per far
leva sull'opinione pubblica. La povertà è una minaccia (vedi le
frasi sopra citate), ma se la preoccupazione principale di Truman
è il miglior sfruttamento delle risorse umane e naturali del mondo,
obiettivo espresso con candida ingenuità, Powell si concentra
inizialmente sulla lotta al terrorismo. La povertà fa paura quindi e
richiede di essere affrontata con strategie consone alle condizioni
geopolitiche in cui si inserisce. Truman getta le fondamenta per
l'esportazione di un modello di sviluppo basato sulla crescita
economica, Powell ha invece l'arduo compito di delineare un
percorso più complesso: la lotta al terrorismo per favorire il "buon
governo" che combatte la povertà favorendo la crescita
economica. L'imperativo odierno slitta dall'esportazione di un
modello di sviluppo all'esportazione di un modello di "buon
governo" per favorire lo sviluppo, fonte incontestabile di pace e
benessere. Non c'è pace senza crescita economica quindi, le due
analisi differiscono nella formula necessaria per raggiungere lo
stesso obiettivo.
T.: "Quel che prevediamo è un programma di sviluppo basato su
concetti di un negoziato equo e democratico. Tutti i paesi,
compreso il nostro profitteranno largamente di un programma
costruttivo che permetterà di utilizzare meglio le risorse umane e
naturali del mondo. L'esperienza dimostra che il nostro
commercio con gli altri paesi cresce con i loro progressi
industriali ed economici. Una maggiore produzione è la chiave
della prosperità e della pace."
P.: "Nessun Paese, nemmeno il più forte, può garantire la
sicurezza del suo popolo fintanto che l'ingiustizia e la
disperazione economica riescono a mescolarsi alla tirannia e al
fanatismo.
Quello dello sviluppo è una questione centrale per la sicurezza
nazionale. […] La povertà genera frustrazione e risentimento,
che gli 'imprenditori di ideologie' riescono a trasformare in
sostegno o accettazione - nei confronti del terrorismo[…].
Per essere sostenibile lo sviluppo deve essere un processo che
investe e paga dividendi, che semina e raccoglie".
Quali le cause della povertà?
Innanzitutto è interessante notare come nei due testi sia assente
qualsiasi riferimento storico che spieghi le cause della povertà.
Solo nel discorso di Truman si fa un vago accenno al passato
quando dice: "Il vecchio imperialismo - lo sfruttamento al servizio
del profitto straniero - non ha niente a che vedere con le nostre
intenzioni". Un riferimento quanto mai generico utile a prendere
le distanze dal colonialismo europeo per legittimare il nuovo
paradigma neocoloniale dello sviluppo. La povertà in entrambi i
casi è naturalizzata e nazionalizzata; assume per Truman la
connotazione di un nemico immanente dotato di vita propria
aldilà della storia, un "nemico di sempre", una questione locale
28
che ora può diventare di interesse mondiale (interesse della
"famiglia umana") grazie alle nuove possibilità di intervento
messe a disposizione dal progresso scientifico (per i risvolti
tecnocratici si veda più sotto), mentre per Powell "l'ingiustizia
sociale" è il prodotto di singoli governi caratterizzati da
corruzione endemica, soffocamento dell'iniziativa, assenza di
equità. E' l'immagine bizzarra di un mondo di nazioni autarchiche
fin dalla nascita che non rispondono correttamente agli stimoli
fino ad ora messi in atto. Viene negata l'interdipendenza per
esternalizzare le cause del mancato sviluppo. I paesi poveri
assumono le sembianze di malati cronici per volere del destino
crudele.
T.: "E' solo aiutando i suoi membri più sfavoriti ad aiutarsi da
soli che la famiglia umana potrà realizzare la vita decente e
soddisfacente alla quale ciascuno ha diritto.
Solo la democrazia può fornire la forza vivificante che mobiliterà
i popoli del mondo in vista di un'azione che permetterà loro di
trionfare non solo sui loro oppressori ma anche sui loro nemici di
sempre: la fame, la miseria e la disperazione".
P.: "La causa che è alla radice della povertà è
l'ingiustizia sociale e il cattivo governo che la
appoggia. La povertà nasce e persiste dove la
corruzione è endemica e l'iniziativa è soffocata,
dove il concetto elementare di equità è assente.
In circostanze simili la povertà è un assalto alla
dignità umana e in questo assalto sta il seme
naturale dell'odio".
Powell, suo malgrado, deve fare i conti con mezzo secolo di
progetti di sviluppo che nei decenni si è trasformato, come
sottolinea Rist, in "sviluppo sostenibile" e poi in "sviluppo
umano" senza però modificare il suo assunto di fondo:
l'esportazione di modelli universali di crescita.
P.: "Siamo giunti alla conclusione che l'assistenza allo sviluppo
non funziona al suo meglio se concepita come gretto esercizio
economico. Ora più che mai è evidente che gli atteggiamenti
politici e le predisposizioni culturali influenzano il
comportamento economico degli individui e che è la storia ad
aver dato forma alle istituzioni economiche della società […]
Pensiamo che per riuscire ad alleviare la povertà occorra
favorire una crescita economica sostenibile: il che significa che
chi attua piani politici ed economici deve prendere sul serio la
sfida del buon governo."
L'approccio allo sviluppo nel discorso di Powell è
necessariamente più articolato. Politica economia e cultura si
intrecciano nell'idea di una Storia ineluttabile, intrisa di
un'essenza e di un destino già scritti che giustificano il presente e
forse anche il futuro. Più avanti Powell accenna
ai limiti della politiche di aiuto appiattite
sull'emergenza6 , ma allo stesso tempo viene
ribadita la necessità di un forte controllo
centralizzato delle dinamiche dello sviluppo che
passano invariabilmente oggi come cinquant'anni
fa dall'incremento della produzione di merci e
dall'iniziativa privata. E' un altro punto che
accomuna i due discorsi; "l'aiutarli ad aiutarsi da
Quale idea di sviluppo? Con quali strumenti?
soli" è funzionale alla celebrazione del self made
man e della mano invisibile del mercato:
Scienza e crescita economica sono per Truman il
T.: "Con la collaborazione degli ambienti
motore dello sviluppo. La loro pretesa
d'affari, del capitale privato, dell'agricoltura e
universalità e oggettività è necessaria e
del mondo del lavoro del nostro paese, questo
sufficiente per concepire un unico destino
programma potrà accrescere grandemente
Colin Powell
caratterizzato dall'incremento produttivo: più
l'attività industriale delle altre nazioni ed elevare
cibo, più vestiario, più materiale da costruzione. Più merce quindi sostanzialmente il loro livello di vita."
per raggiungere un maggiore benessere. Domina una visione P.: "Nel corso del summit Financing for Development, tenutosi
economicistica e tecnocratica che sottrae l'altro ad una diversità nel 2002 a Monterey, in Messico, si è raggiunto un nuovo accordo
potenzialmente pericolosa e sovversiva perché concorrente. Il per lo sviluppo. Poggia su tre pilastri fondamentali: un impegno
discorso di Truman implica un evoluzionismo tecnocratico al condiviso verso una crescita economica condotta dal settore
servizio del progresso, visione non dissimile dal capitalismo di privato, uno sviluppo sociale e una gestione sicura delle risorse
stato sovietico e cinese.
naturali basata sulle fondamenta del buon governo e del diritto.
T. (è l'inizio del IV punto): "In quarto luogo, dobbiamo lanciare […] L'aiuto può essere un catalizzatore per lo sviluppo ma i veri
un nuovo programma che sia audace e che metta i vantaggi del motori di crescita sono l'imprenditorialità, gli investimenti e il
nostro progresso scientifico e industriale al servizio del commercio.[…] L'MCA7è un incentivo, un sistema per premiare la
miglioramento e della crescita delle regioni sottosviluppate […] diffusione della libertà di parola e di assemblea, per premiare un
Le risorse materiali che possiamo permetterci di utilizzare per maggiore e più ampio accesso al credito tale da permettere a chi
l'assistenza ad altri popoli sono limitate. Ma le nostre risorse in lo desidera di mettersi in affari, nonché per ricompensare
conoscenze tecniche - che fisicamente non pesano niente - l'aderenza al diritto e alla legalità per proteggere la proprietà
crescono incessantemente e sono inesauribili. […]Il nostro scopo privata e far rispettare l'inviolabilità dei contratti".
dovrebbe essere quello di aiutare i popoli liberi del mondo a Prendendo a prestito le parole di Rist potremmo evidenziare che
produrre, con i loro propri sforzi, più cibo, più vestiario, più ci sono più modi di negare l'altro: respingerlo o mangiarlo
materiali da costruzione, più energia meccanica al fine di simbolicamente per appropriarsene e, poi, espropriarlo.
alleggerire il loro fardello."
Sterminio, conquista e assoggettamento, assimilazione,
29
sfruttamento ed espropriazione sono gradi diversi di una stessa
volontà oppressiva. L'applicazione di modelli astratti che si
pretendono universali è alla base sia delle politiche
conservazioniste legate alla nascita di molti Parchi Naturali in
Africa (sorti per regolamentare un'attività squisitamente
coloniale: la caccia sportiva) come nel resto del mondo, sia della
Rivoluzione Verde 8 , causa della distruzione del sapere locale,
dell'equilibrio sociale e produttivo di molte comunità indiane.
Non è un caso che Powell scriva "Crediamo profondamente nel
pilotaggio delle risorse naturali come suggerisce l'armonico
legame tra le parole 'conservazione' nel senso di tutela
dell'ambiente e 'conservatore' ".
L'analisi delle retoriche dello sviluppo andrebbe collegata ad uno
studio puntuale delle azioni messe in atto a dei loro effetti. Si può
qui solo accennare ad un singolo episodio tralasciando aspetti
altrettanto importanti e centrali quali le politiche dei flussi
migratori, lo sfruttamento dei lavoratori stranieri regolari ed
irregolari, la precarizzazione del lavoro, tema quest'ultimo che
investe tutti nella rincorsa al totem dello sviluppo.
L'African Growth and Opportunities Act (Agoa)9 è un accordo
firmato nel 2000 per promuovere i rapporti commerciali tra Stati
Uniti e Africa in cambio del rispetto di quei parametri politici ed
economici a cui faceva riferimento Powell. L'accordo prevede
l'annullamento dei dazi doganali per settemila prodotti destinati al
mercato statunitense. L'80% di questi prodotti è rappresentato dal
petrolio e da suoi derivati e una parte del restante 20% da prodotti
dell'industria manifatturiera. Nel caso del Kenya l'accordo ha
portato alla creazione di fabbriche manifatturiere gestite da
stranieri (indiani, cingalesi, e bengalesi) attirati dalla possibilità di
produrre a basso costo. La parabola ascendente della crescita si è
però arrestata presto sotto i colpi della concorrenza cinese e
indiana richiedendo una repentino miglioramento dei processi di
produzione per abbattere ulteriormente i costi e di aumentare la
quantità di merce prodotta. La crescita economica è in questo caso
legata all'adeguamento forzato alle leggi del mercato globale i cui
rituali di consumo avvengono altrove rispetto ai luoghi di
produzione. L'inconveniente è che pur accettando l'equazione
"più merce a basso costo = più benessere" la distribuzione di
quest'ultimo rimane disomogenea. Il motore dello sviluppo
evocato sia da Truman che da Powell, ovvero il capitale privato
che investe, distribuisce dividendi e permette un più armonioso
sfruttamento delle risorse naturali ed umane, in Kenya si esprime
così: "Questo è un avvertimento, svegliatevi prima che sia troppo
tardi, non potete ignorare la realtà, la direzione non vede
possibilità di sopravvivenza nel prossimo futuro. Vi diamo tre
mesi per aumentare la produzione. Se non noteremo un
miglioramento, chiuderemo " (comunicazione aziendale agli
operai di una fabbrica tessile); "La nostra è un'iniziativa
imprenditoriale, non una missione umanitaria" 11 (T.S.
Sundareswaran, amministratore delegato della società indiana
Mirage).
I discorsi programmatici e opportunisticamente idealisti si
scontrano con le contraddizioni dei contesti locali in cui vengono
applicati. Chi ne subisce le conseguenze negative rimane distante;
quando invece si avvicina è privo di diritti e del diritto di parola,
doppiamente assente12 (nella comunità di origine ed in quella di
arrivo), pronto per essere stritolato dalla grande macchina
selettiva e produttiva; nei casi più rari e fortunati, contribuirà a
riprodurre il modello indiscutibile di sviluppo come piccolo
imprenditore "etnico". Sacrificio di generazioni, si dirà, in vista di
un benessere diffuso. Aspettiamo con fiducia che si realizzino
(lentamente) queste promesse?
NOTE
1
Fu il geografo Sauvy ad usare per primo questo termine nel 1952 per analogia con il Terzo Stato francese.
In Gilbert Rist, Lo sviluppo. Storia di una credenza occidentale, Bollati Boringhieri, Torino, 1997.
3
L'articolo dell'ormai ex Segretario di Stato Colin Powell è stato pubblicato sulla rivista Foreign Policy e tradotto dal settimanale
L'Espresso (n°2 anno LI) con il titolo Stati Uniti del Mondo.
4
U. Pörksen, Plastikwörter. Die Sprache einer internationalen Diktatur, Klett-Cotta, Stuttgart 1989.
5
Ibidem pp. 29-30.
6
"[…] l'assistenza umanitaria è una misura tappabuchi. Il nostro scopo è sradicare la povertà sfidando le autorità dei Paesi in via
di sviluppo a prendere il futuro delle proprie nazioni nelle loro mani."
7
Millenium Challenge Account. Powell lo descrive con queste parole: "Questa simbiosi tra libertà politica e libertà economica
costituisce la base dell'MCA, un'iniziativa che offre un contratto modellato sullo stesso libero mercato - che è la sua parte migliore.
I beneficiari dei fondi MCA devono rispondere a requisiti di eleggibilità prima di poter ricevere anche un solo centesimo di
dollaro…"
8
Con questo nome si individuano molti dei fallimentari progetti di sviluppo agricolo attuati in India negli ultimi decenni e
denunciati da Vanda Shiva in Monoculture della Mente, Bollati Boringhieri, Torino, 1995.
9
Fonte: articolo pubblicato dal Financial Times (GB) e tradotto dal settimanale Internazionale (21-27 gennaio 2005, n°574) con il
titolo Il Kenya nel mercato tessile globale.
10
ibidem
11
ibidem
12
Vedi Abdelmalek Sayad, La doppia assenza, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2002
2
30
AChAB segnala…
Università di Roma "La Sapienza" - anno accademico 2004-05
Corso di Laurea triennale in "Teorie e Pratiche dell'Antropologia"
Corso di Laurea specialistica in "Discipline Etno-Antropologiche"
Seminario "Violenza, corpo, emozioni", marzo-maggio 2005, Roma.
L'esplosione di violenza che ha caratterizzato la fine del XX e l'inizio del XXI secolo pone all'antropologia culturale numerosi
problemi, di carattere sia conoscitivo sia etico. Su un piano generale, la drammaticità degli episodi cui assistiamo, dall'11 settembre
alla guerra in Iraq, dalla scuola di Beslan alle quotidiane stragi di civili in molte parti del mondo, sembra scuotere la disciplina dalla
sua sonnolenza, o perlomeno insidiare la posizione di tranquillo distacco scientifico che si è costruita. Che ne è della scienza dell'uomo,
anzi della scienza degli altri uomini, donne e bambini, quando vaste porzioni dell'umanità sono vittime di una costante carneficina?
Cosa diventa lo studio delle strutture antropologiche "normali" e quotidiane quando il mondo vive uno "stato di emergenza
permanente", per usare l'espressione coniata da Walter Benjamin in un'altra drammatica epoca storica? C'è un uso pubblico possibile
dell'antropologia a sostegno dei valori della pace, della solidarietà, della giustizia? Quale rapporto gli antropologi possono intrattenere
con le agenzie di cooperazione internazionale e di difesa dei diritti umani? Che ne è del confine fra scienza e politica - fra l'istanza,
cioè, di una conoscenza criticamente distaccata e quella di una partecipazione attiva e militante al corso degli eventi?
Più specificamente, la natura degli attuali fenomeni di violenza chiama in causa direttamente una serie di categorie antropologiche,
reclamandone una ridiscussione. In particolare, si tratta spesso di violenza cosiddetta "etnica", che mette cioè in gioco quel terreno di
differenze culturali, religiose e di valori di cui l'antropologia dovrebbe essere competente. Di fronte alla disseminazione del linguaggio
dell'etnicità e dell'identità nel linguaggio comune e nei media, usato spesso come facile spiegazione dei fenomeni di conflitto,
l'antropologia ha un importante lavoro critico da svolgere. Lo stesso vale per l'analisi dei discorsi riguardanti lo scontro fra civiltà, la
difesa dell'identità "occidentale" e così via che hanno segnato pesantemente il linguaggio politico negli ultimi anni.
Ma la categoria antropologica che viene maggiormente sollecitata dalla violenza tardo-moderna è probabilmente quella di corpo.
Sono immagini di corpi violati o minacciosi quelle che dominano l'immaginario politico contemporaneo: i corpi che volano dalle Twin
Towers in fiamme, quelli torturati di Abu-Ghraib, quelli tra le macerie dei bombardamenti o dilaniati dalle esplosioni, i corpi-arma dei
terroristi "kamikaze", le decapitazioni degli ostaggi in Iraq e così via. Un repertorio che si aggiunge alle immagini delle cataste di
cadaveri di Auschwitz, del corpo-simulacro dei "musulmani" sopravvissuti ai campi, della carneficina ruandese a colpi di machete nuclei consolidati della memoria del Novecento. E' come se la politica si declinasse attraverso una sintassi simbolica della violenza sui
corpi. Ciò che distingue questa violenza fisica da quella di altre epoche è la sua riproduzione sistematica e ossessiva nelle
comunicazioni di massa. E' attorno ad immagini della violenza che si organizzano le news televisive, le prime pagine dei giornali e il
surfing in rete; è in esse che sembra concentrarsi il nucleo duro della realtà, forse persino un certo senso del sacro, capace di suscitare
quella partecipazione emotiva che fonda, secondo la teoria antropologica classica, la coesione sociale.
Il seminario si propone di esplorare alcuni aspetti di questa vasta problematica, attraverso l'intervento di studiosi che hanno una
conoscenza diretta di "terreni" investiti dalla violenza, o che in vario modo hanno lavorato sul tema della memoria traumatica e sul
nesso corpo-immagini violenza.
Martedì 8 marzo - APERTURA
Pietro Clemente - Università di Firenze
Alessandro Simonicca - Università di Roma "La Sapienza"
Fabio Dei - Università di Pisa
Martedì 15 marzo - RIFUGIATI
Roberto Beneduce - Università di Torino
Francesca Declich - Università di Urbino
31
Martedì 22 Marzo - FIELDWORK UNDER FIRE
Renato Libanora - Università di Napoli L'Orientale
Patrizio Warren - Università di Roma "La Sapienza"
Luca Jourdan - Università di Torino
Martedì 5 aprile - MEDIO ORIENTE
Setrag Manoukian - Università di Milano "Bicocca"
Antonio De Lauri
Simona Torretta
Martedì 12 aprile - CORPI
Giovanni Pizza - Università di Perugia
Ivo Quaranta - Università di Bologna
Martedì' 19 aprile - BALCANI
Pietro Clemente - Università di Firenze
Lucilla Ruberti - Università di Roma
Piero Vereni - Università di Firenze
Paolo De Simonis - Università di Firenze
Martedì 26 aprile - FONDAMENTALISMI
(presentazione dell'omonimo volume di "Testimonianze")
Severino Saccardi - direttore di Testimonianze
Bijan Zarmandili - scrittore
Martedì 3 maggio - VIOLENZA SIMBOLICA
Martedì 10 maggio - IMMAGINI
Giovanni Fiorentino, Università di Roma "La Sapienza"
Livio Senigalliesi, fotografo, Milano
Caterina Cingolani,. Università di Roma "La Sapienza"
Martedì 16 maggio - LIBRI
A. Simonicca, F. Dei, P. Vereni, M. Van Aken
(Presentazione di volumi: Appadurai, Etnicità cultura violenza, "Antropologie" su rifugiati; "Antropologia della violenza" etc. )
Per informazioni:
[email protected]
[email protected]
32
Garden of peace
Colourful flowers fill the garden of peace
It is fragrant all around
The sky is clear
Birds sing the melody of spring
Everyone is merry and gay
Old and youngs a like enjoy the beauty of the garden
They play in the garden of peace
Harmony is echoed from every corner
Soon the dark clouds appear
Hiding the sun and its glory
War has started
The garden is filled with bloodshed
The crushed flowers are now symbols of death
The buds have withered
Autumn has set in suddenly
War destroys not only the garden of peace
But the soul of every creature
(Huzhabr Shinwari, "The debris of dreams - A collection of poems by Marghana Sharq" ATP, Kabul)
33
In copertina retro:
Schiavetti & D’Angelo, Crimini di pace milanesi, FotoTestimonianze 2005