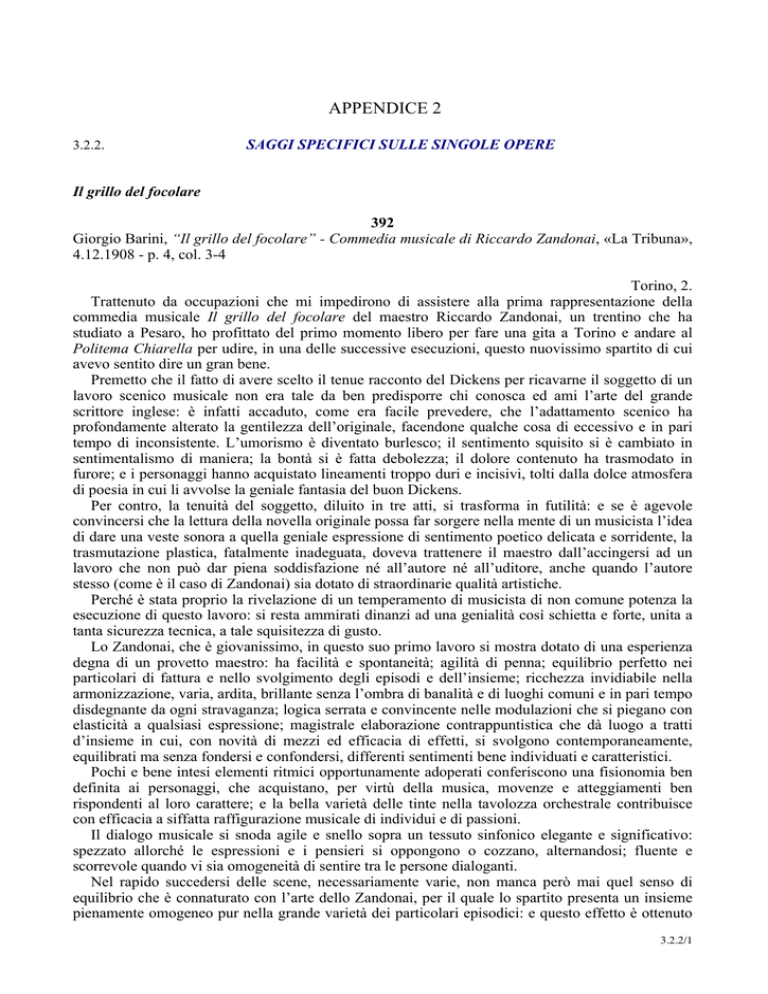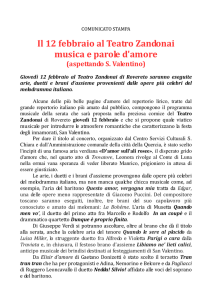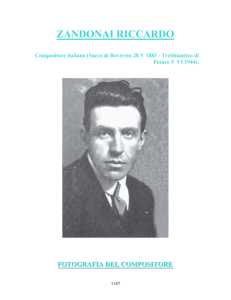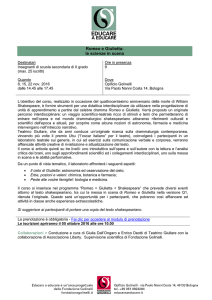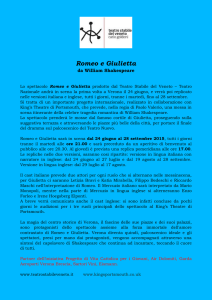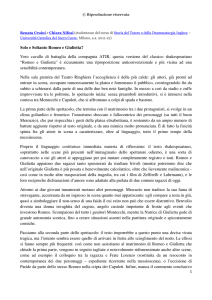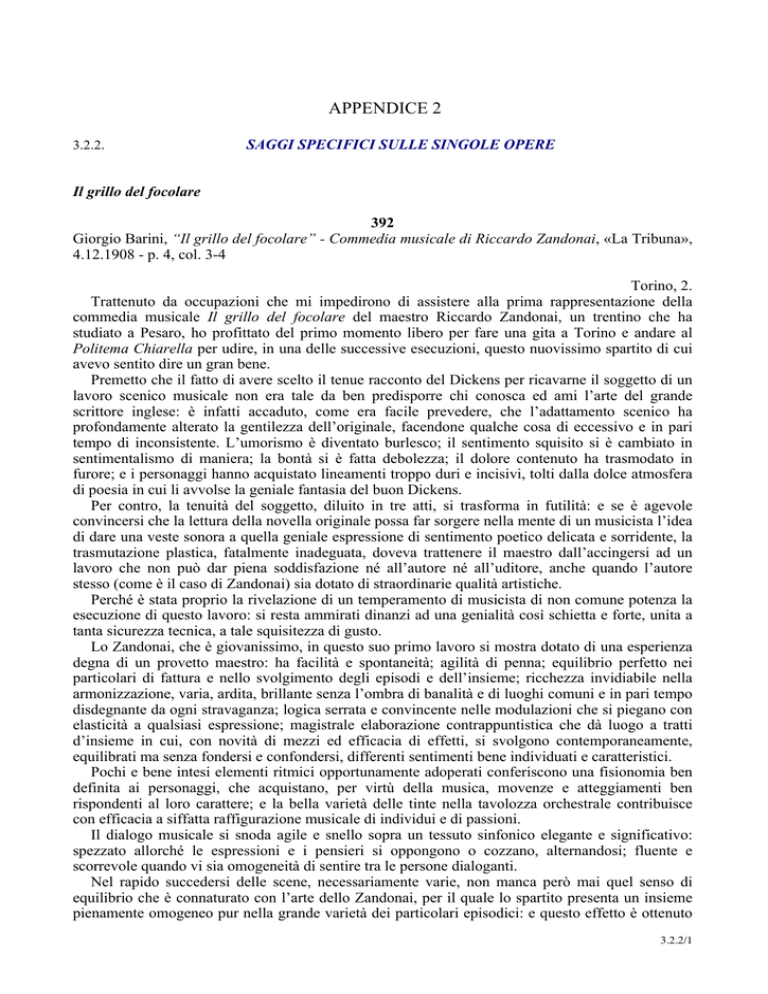
APPENDICE 2
3.2.2.
SAGGI SPECIFICI SULLE SINGOLE OPERE
Il grillo del focolare
392
Giorgio Barini, “Il grillo del focolare” - Commedia musicale di Riccardo Zandonai, «La Tribuna»,
4.12.1908 - p. 4, col. 3-4
Torino, 2.
Trattenuto da occupazioni che mi impedirono di assistere alla prima rappresentazione della
commedia musicale Il grillo del focolare del maestro Riccardo Zandonai, un trentino che ha
studiato a Pesaro, ho profittato del primo momento libero per fare una gita a Torino e andare al
Politema Chiarella per udire, in una delle successive esecuzioni, questo nuovissimo spartito di cui
avevo sentito dire un gran bene.
Premetto che il fatto di avere scelto il tenue racconto del Dickens per ricavarne il soggetto di un
lavoro scenico musicale non era tale da ben predisporre chi conosca ed ami l’arte del grande
scrittore inglese: è infatti accaduto, come era facile prevedere, che l’adattamento scenico ha
profondamente alterato la gentilezza dell’originale, facendone qualche cosa di eccessivo e in pari
tempo di inconsistente. L’umorismo è diventato burlesco; il sentimento squisito si è cambiato in
sentimentalismo di maniera; la bontà si è fatta debolezza; il dolore contenuto ha trasmodato in
furore; e i personaggi hanno acquistato lineamenti troppo duri e incisivi, tolti dalla dolce atmosfera
di poesia in cui li avvolse la geniale fantasia del buon Dickens.
Per contro, la tenuità del soggetto, diluito in tre atti, si trasforma in futilità: e se è agevole
convincersi che la lettura della novella originale possa far sorgere nella mente di un musicista l’idea
di dare una veste sonora a quella geniale espressione di sentimento poetico delicata e sorridente, la
trasmutazione plastica, fatalmente inadeguata, doveva trattenere il maestro dall’accingersi ad un
lavoro che non può dar piena soddisfazione né all’autore né all’uditore, anche quando l’autore
stesso (come è il caso di Zandonai) sia dotato di straordinarie qualità artistiche.
Perché è stata proprio la rivelazione di un temperamento di musicista di non comune potenza la
esecuzione di questo lavoro: si resta ammirati dinanzi ad una genialità così schietta e forte, unita a
tanta sicurezza tecnica, a tale squisitezza di gusto.
Lo Zandonai, che è giovanissimo, in questo suo primo lavoro si mostra dotato di una esperienza
degna di un provetto maestro: ha facilità e spontaneità; agilità di penna; equilibrio perfetto nei
particolari di fattura e nello svolgimento degli episodi e dell’insieme; ricchezza invidiabile nella
armonizzazione, varia, ardita, brillante senza l’ombra di banalità e di luoghi comuni e in pari tempo
disdegnante da ogni stravaganza; logica serrata e convincente nelle modulazioni che si piegano con
elasticità a qualsiasi espressione; magistrale elaborazione contrappuntistica che dà luogo a tratti
d’insieme in cui, con novità di mezzi ed efficacia di effetti, si svolgono contemporaneamente,
equilibrati ma senza fondersi e confondersi, differenti sentimenti bene individuati e caratteristici.
Pochi e bene intesi elementi ritmici opportunamente adoperati conferiscono una fisionomia ben
definita ai personaggi, che acquistano, per virtù della musica, movenze e atteggiamenti ben
rispondenti al loro carattere; e la bella varietà delle tinte nella tavolozza orchestrale contribuisce
con efficacia a siffatta raffigurazione musicale di individui e di passioni.
Il dialogo musicale si snoda agile e snello sopra un tessuto sinfonico elegante e significativo:
spezzato allorché le espressioni e i pensieri si oppongono o cozzano, alternandosi; fluente e
scorrevole quando vi sia omogeneità di sentire tra le persone dialoganti.
Nel rapido succedersi delle scene, necessariamente varie, non manca però mai quel senso di
equilibrio che è connaturato con l’arte dello Zandonai, per il quale lo spartito presenta un insieme
pienamente omogeneo pur nella grande varietà dei particolari episodici: e questo effetto è ottenuto
3.2.2/1
per virtù della intonazione generale del lavoro (se così è lecito esprimersi) e non già mediante
l’impiego di ricorsi melodici o di temi e motivi conduttori.
***
Una minuziosa analisi dello spartito dello Zandonai non può qui trovar posto: me ne
mancherebbe lo spazio; ma non sarà inutile un cenno affrettato di talune pagine tra le più notevoli
del breve e denso lavoro.
Il primo preludio, di efficace varietà, solidamente inquadrato, arguto e vivo, con accenti di
sentimento, elaborato magistralmente e con finezza elegante, dà la fisionomia dello spartito e pone
l’uditore a contatto immediato con l’espressione d’arte propria dell’autore.
La canzone dei fanciulli perduti in mare, cantata dalla buona Dot al grillo del focolare, il piccolo
genio benefico della casa, è incorniciata nella scena che si svolge, melodica e semplice, come
l’anima amorosa della gentile donnina: e il discreto trillare del grillo vi risponde con lieta vivezza.
Né meno sentita è la apostrofe di Dot all’“anima canora della casa”, che si nasconde sotto la cappa
del camino.
Ricche di indovinati contrasti le scene successive: la agitazione prodotta dall’annunzio delle
nozze del vecchio e tristo Tackleton è espressa in pochi accenti profondamente sentiti in cui si
uniscono dolore, sorpresa, sospetto a seconda dei personaggi; alla agitazione segue il finale
dell’atto, vero idillio tutto poesia, serena espressione dell’affetto dei coniugi, Dot e John, si una
dolcezza di sogno argutamente commentata dal trillo che si leva dal focolare domestico.
Nel secondo atto, la canzone della cieca Berta, melodica e appassionata; la descrizione delle
inesistenti bellezze della casa e del paesaggio con cui il vecchio Caleb illude la figlia infelice
contrastano, per il loro poetico sentimento, con le scene successive, vibrate e vivaci: principalmente
la preparazione della mensa ha per substrato un allegro felicissimo, svolto sinfonicamente, che
trova degno riscontro in un allegretto non meno bello e geniale che accompagna le parole con cui
Dot, nel terzo atto, annunzia prossima la letizia ai cuori attristati.
Il brindisi di Dot; la scena concertata delle campane di Natale, si mirabile naturalezza nella sua
varia complessità; il breve episodio amoroso, trovano un forte contrasto nella poderosa scena della
gelosia che termina l’atto secondo.
Nel terzo atto, dopo un vago e sentito preludio svolto sulla frase melodica della gelosia, che qui
assume un carattere dolorosamente malinconico, il monologo di John ha eloquente espressione di
afflizione: potente è la scena di John col maligno Tackleton. Dopo il magnifico insieme, così vario
di passioni e di sentimenti, costretti con robusta mano nella breve cerchia di poche pagine, sorge da
lunge, con effetto straordinario, il cantico solenne del Natale: per la prima volta le voci del coro
sorgono per unirsi a quelle dei solisti nella chiusa dello spartito, larga, grandiosa affermazione della
vittoria conseguita dalla bontà serena che riscalda i cuori e solleva le menti verso un limpido ideale:
l’ideale della famiglia unita e onesta, accolta attorno al modesto focolare animato dal trillo del buon
genio domestico.
***
Non manca qualche difetto nel lavoro dello Zandonai: ma è così poco quel che si può osservare
che davvero non merita il conto di fermarcisi; d’altra parte il giovane maestro dimostra di possedere
tali qualità artistiche da convincere che egli per primo deve essersi accorto di quel che avrebbe
potuto evitare. Inoltre la esecuzione non ha contribuito a porre in luce tutti i pregi di questo spartito
in cui si manifesta uno spirito sano e personale, una fibra solida, una intensità di sentimento
ugualmente interessanti, e che talvolta sono stati in parte offuscati dalla mancanza di finezza e di
chiaroscuro da parte dell’orchestra, che non sa sonar piano ed è poi fiacca quando dovrebbe essere
robusta; dei solisti, che in genere, pure essendo artisti di valore, hanno alquanto caricato le tinte; del
coro, che ha cantato con troppa forza.
E ora dobbiamo augurarci che lo Zandonai trovi un soggetto veramente degno di attrarre la sua
anima d’artista e che gli permetta di unire le sue ispirazioni a qualche cosa di più geniale e durevole
che non al troppo modesto Grillo del focolare: egli che mostra (cosa non comune in un giovane) di
non sentire influenze di musicisti alla moda e pare abbia soltanto tenuto conto, per la forma, del
Falstaff verdiano, potrà darci opere d’arte sincere e forti.
3.2.2/2
Conchita
393
Giorgio Barini, “Conchita” di Riccardo Zandonai, «Nuova antologia», 16.4.1912 - pp. 714-9
Quando, al politeama Chiarella, in Torino, udii la prima opera di Riccardo Zandonai, Il grillo del
focolare, fui profondamente impressionato da quella così lieta e forte affermazione di un
temperamento musicale di indiscutibile potenza: il sottile e sentimentale idillio del Dickens
nell’adattamento scenico aveva perduto, è vero, molto del suo profumo, e la simbolica delicatezza
di quella gentile storia di Natale si era alterata nella inadeguata visione teatrale, inconsistente in
taluni episodî, troppo accentata in altri. Ma il musicista, conquiso della poesia intimamente
affettuosa e commovente diffusa nelle pagine indimenticabili del grande scrittore inglese, era
riuscito a rievocarla, a farla rivivere nelle snelle pagine del suo spartito: la veste sonora
ricomponeva attorno alle deformate immagini del libretto una atmosfera vibrante, luminosa, calda:
quella medesima in cui originariamente le aveva poste il loro ideatore.
Ben di rado il primo lavoro di un giovane maestro si mostra ricco di pregi tanto notevoli e
significativi come Il grillo del focolare: Riccardo Zandonai dava con quello spartito prova di avere
una visione d’arte nobile e pura, di possedere un’anima veramente poetica, mente colta, gusto
squisito; e di sapere estrinsecare con mano sicura ed abile, con ammirevole facilità e giustezza di
linee e di colori, le sue concezioni estetiche. Perché lo Zandonai non soltanto ha quella solida
coltura tecnica che è un dovere per chiunque intenda ed osi affrontare il giudizio del pubblico; ma
tale sua coltura ha caratteri non consueti e non comuni: in lui l’armonista, il contrappuntista
padrone di ogni segreto dell’arte, non ha nessuna traccia di scolasticismo; la sua scrittura è di una
modernità assoluta, pur senza cadere nella imitazione di taluni procedimenti di cui tanto si
compiacciono ai nostri giorni molti giovani, imitatori non sempre incoscienti dei più arditi e recenti
innovatori. Egli non si perde in soverchie divagazioni e rifugge dallo spezzare in minute particelle il
commento musicale al pensiero poetico, al movimento drammatico; ma sa contenere in una cornice
salda ed equilibrata il quadro e l’azione: schiettamente italiano nel concepire con chiarezza e con
senso intimamente organico il pezzo di musica, riesce ad esser fedele alla tradizione dei più puri e
sinceri tra i nostri grandi del passato, i quali sapevano mantenere unità di pensiero e perfezione di
forma: il discorso musicale serrato, logico, si svolge spontaneo e procede snello e vivace sulla
scena, libero, elastico, e pure intimamente connesso, per le idee melodiche e il senso armonistico,
alla trama sinfonica; e l’orchestra ricca e varia, delicata e sonora, tutto avvince e colorisce, senza
mai soffocare le voci umane.
Quando si seppe che lo Zandonai intendeva porre in musica un libretto tratto dal noto romanzo
di Pierre Louys [sic], La femme et le pantin, si presentarono naturali alla mente alcune obiezioni:
l’elegante poeta del Grillo del focolare avrebbe saputo con pari fortuna e mano felice esprimere le
brutalità angosciose, le crudeli raffinatezze di quel soggetto tanto scabroso? Il famoso episodio
degli amori di Giacomo Casanova con la fatale Marianna Charpillon, che seppe con tanto infernale
abilità tenere in scacco l’erotico avventuriero, il quale sembra provi una specie di morbosa voluttà
nel descrivere minutamente le sofferenze inflittegli da quella perversa creatura, è riprodotto con
curiosa fedeltà nel romanzo del Louys; ed è di tal natura da far dubitare, a priori, della possibilità di
una riproduzione scenica: la misteriosa e contraddittoria psicologia di Conchita Perez, strano
impasto di corruzione e ritenutezza, ribelle ad ogni seduzione e vinta d’improvviso dallo scatenarsi
della brutalità nell’amore esasperato, costituisce una specie di enigma vivente, che avvince
fortemente nelle ardenti pagine del romanzo ma non convince nella plasticità della scena.
Inoltre, gli episodi più efficaci e ricchi di citalità sono quelli che non possono avere una esatta
ricostruzione scenica: la tremenda tortura inflitta a don Mateo, con gli ostacoli opposti al suo amore
da Conchita, mentre sembra imminente la sua dedizione; con la impudica danza nel Baile a Cadice;
con la parvenza dei suoi amori con Morenito sotto gli occhi di Mateo stesso al di là dell’inflessibile
cancello, non può dimostrarsi sulla scena se non a scartamento ridotto. Come ricavare da tale
romanzo la trama per un dramma musicale?
3.2.2/3
Non è il caso di fermarsi sulla così detta immoralità del soggetto: molti, è vero, si sono
scandalizzati per qualche scena dichiarata troppo ardita e pericolosa (per chi?), mentre taluno
probabilmente lamentava in cuor suo la mancata esposizione di nudità, non fosse altro nella scena
della danza; ma ancor più alte grida si levarono contro il verismo della Carmen, ormai accettata
senza mormorii dai pubblici più abbottonati: né deve troppo preoccupare la portata più o meno
morale del soggetto, di fronte al suo valore estetico: una vera opera d’arte, eletta, organica, viva,
tale da interessare e appassionare, da scuotere poderosamente l’animo nostro sarà sempre la
benvenuta e potrà bene inspirare il musicista che voglia riplasmarla nella palpitante materia sonora,
quale che sia la moralità o la immoralità delle persone evocate dalla forza creatrice dell’artista. Ciò
che non convince in Conchita è la tenue, meschina consistenza del dramma, la mancanza di rilievo
e di fisionomia dei personaggi.
Per dire il vero, mi pareva, a priori, assolutamente impossibile ricavare dal romanzo-problema
psichico di Pierre Louys un qualsiasi lavoro teatrale: né riusciva a convincermi del contrario l’esito
favorevole ottenuto a Parigi dalla produzione trattane da Pierre Frondaie, col titolo medesimo La
femme et le pantin: quando lessi il libretto allestito per lo Zandonai da Maurizio Vaucaire e Carlo
Zangarini col titolo Conchita, la mia prevenzione recisamente contraria fu scossa alquanto: mi
parve che, dato il soggetto e il suo svolgimento nel romanzo, i librettisti avessero fatto miracoli,
essendo riusciti a tracciare quadri relativamente consistenti sebbene infarciti di parecchie riempiture
episodiche al solo scopo di offrire al musicista occasione di colorature musicali per coprire la tela e
darle dimensioni un po’ più larghe.
Il primo quadro del primo atto si svolge nella “Fabrica”: i brevi tocchi del romanzo, che
tracciano la vivace e torbida visione dello sciame seminudo delle sigaraie procaci e libere negli atti
e nelle parole, si ampliano sensibilmente: si determinano figure e temperamenti, si affermano
particolari caratteristici di vita e di costume: canti di popolo, appelli di venditori ambulanti si
alternano con episodi giocosi e repentine e fiere baruffe. Giunge un ispettore con qualche visitatore:
tra questi è Mateo, che riconosce Conchita e ne è riconosciuto; mentre egli segue gli altri nella
visita, Conchita narra alle compagne come conobbe il bel signore otto mesi prima, quando tornava
a casa dal convento e il treno rimase bloccato dalla neve: don Mateo intervenne mentre essa si
accapigliava con una gitana da lei offesa, per sottrarla ai rigori di un gendarme allora intervenuto.
Don Mateo rientra e, prima di uscire, dà alla fanciulla un napoleone d’oro: Conchita, esultante,
raccoglie le sue robe e lascia le compagne: può concedersi vacanza per un mese. Un intermezzo
sinfonico a sipario calato descrive la via che Mateo e Conchita percorrono per recarsi alla dimora di
lei: si odono le voci dei due, finché, giunti a casa, il sipario si risolleva per lasciar vedere la
stamberga in cui la fanciulla vive con sua madre. Mentre questa va per vino e biscotti, la scena di
abbandoni e ripulse con cui Conchita avvince a sé per sempre Mateo è riprodotta nella forma stessa
del romanzo; ma l’azione precipita nella scena successiva: Conchita, che aveva accettato con tanto
piacere il napoleone, si sdegna vedendo la forte somma che Mateo ha dato di nascosto alla madre e,
trascinando questa con sé, fugge via.
Il secondo atto è a Cadice, nel “Baile” ove Conchita danza, accompagnata dal giovane chitarrista
Morenito, sollevando entusiasmo nel pubblico popolare che la ammira: don Mateo giunge e
Conchita, dopo avere scherzato con vari avventori, siede al tavolo di lui. Mentre un’altra fanciulla
balla e il pubblico accompagna la danza con una canzone, un dialogo vibrante e fiero si svolge tra i
due: egli la rimprovera, essa lo sprezza. Il pubblico esce, ad eccezione di due inglesi con una guida,
i quali attendono che Conchita balli nuda a loro dinanzi: Mateo dà oro ad un garzone, che lascerà
aperta una finestra perché dalla via possa scorgere ciò che avverrà nella stanza. Ed egli vede
Conchita esporsi dinanzi agli stranieri, appena coperta da un sottile sciallo che lascia vedere le sue
belle forme; irrompe furente nella immonda stanza: fuggono gli altri, e i due restano soli: e la sirena
sa riavvincere a sé l’innamorato giovane, gli promette di esser sua, perché lo ama e si è serbata
intatta per lui. L’indomani una casetta silenziosa, di cui Mateo dà a lei la chiave, accoglierà il loro
amore.
Il terzo atto si svolge dinanzi al solido cancello della piccola casa dietro al quale Conchita,
sicura, sfida le ire di don Mateo, dichiarandogli che non lo ama; anzi l’odia; e, schernendolo
3.2.2/4
fieramente, chiama a sé Morenito, si abbandona nelle braccia di lui e con lui entra in casa, mentre
Mateo, pazzo di rabbia, cade a terra tramortito.
L’ultimo atto è in casa di Mateo: egli è affranto per le angosce sofferte, che in una notte gli han
fatto grigi i capelli: quando ecco la infernale fanciulla che viene ancora a sfidarlo: mentre essa canta
una canzone beffarda, Mateo chiude a chiave le porte e la atterra; invano essa cerca reagire e
sfuggirgli: è in potere di lui, ormai senza pietà, e che, alle ripulse di Conchita, perde il lume degli
occhi e la batte fieramente, brutalmente, come un disperato. E Conchita si trascina ai suoi piedi,
vinta, soggiogata dalla prova di un amore che ha potuto fino a tal segno far trascendere un
gentiluomo come Mateo: essa lo ama, ama lui solo, ché la scena orrenda con Morenito fu una
finzione: ella sarà di Mateo suo primo amante...
***
La lettura della produzione eseguita al teatro Antoine, tratta da Pierre Frondaie dal romanzo del
Louys, mi ha poi dimostrato che si poteva far molto meglio di quel che hanno saputo fare il
Vaucaire e lo Zangarini: il Frondaie ha rinunziato alla scena della fabbrica, ma ne ha ricavata una
più viva e varia nella riproduzione della baraonda carnevalesca a Las Delicias di Siviglia, durante la
quale si svolge la baruffa tra la gitana e Conchita e ha luogo il primo incontro di questa con don
Mateo: la macchietta, appena disegnata nel romanzo, della ballerina italiana Giulia, che per due
mesi Mateo tiene seco per cercare di scordarsi di Conchita, si trasforma nella napolitana Bianca,
gelosa e appassionata amante di Mateo, fonte di contrasti efficaci, atti a giustificar meglio taluni
episodî passionali e di movimento scenico più intenso e pieno; così pure Morenito e le sue sorelle
hanno una importanza drammatica e tecnica assai più sensibile; Conchita è alquanto semplificata
psicologicamente, ed è sempre e senza eccezioni assolutamente disinteressata: ciò che, sulla scena,
rende più verosimile lo scatto di indignazione cui essa si abbandona quando sa del danaro dato da
Mateo alla madre di lei; la scena del cancello è meglio giustificata, per le malignità delle sorelle di
Morenito, che destanto fiera gelosia nel cuore di Conchita; e la scena tra don Mateo e il suo amico
Ferger meglio prelude alla violenta e risolutiva scena finale.
Alla minore densità drammatica del libretto vuol riparare la musica, che colorisce, completa,
estende la vita scenica del dramma esilissimo, e che pure sembra protrarsi troppo a lungo per la
insistenza in un solo concetto, in una sola posizione: la promessa d’amore di Conchita a Mateo,
regolarmente seguita da una ripulsa, che par dettata soltanto da un maligno capriccio, fino alla
dedizione finale, che però sappiamo non definitiva né costante. E quanto estesa sia la parte soltanto
ornamentale della musica dello Zandonai è facile determinare da un sobrio esame dello spartito.
Nel primo quadro (la “Fabrica”) il disegno ritmico di cinque ottavi, che inizia lo spartito e vi
riappare frequente, determina subito l’andamento movimentato delle scene tra quelle donne
indiavolate e senza peli sulla lingua: lembi di canti popolari pieni di carattere, appelli di venditori
ambulanti tratti dal vivo, dànno colore e sapore alle pagine scintillanti, e l’atmosfera sonora che
avvolge le persone dà al quadro saldezza e significato. Il folklorismo dello Zandonai è degno di
nota: egli non si serve del materiale offerto dai temi nazionali per costruire intere pagine musicali
con mezzi contrappuntistici più o meno meccanici, come usano spesso quei compositori che
possono definirsi “nazionalisti”; ma come macchie di colore, sprazzi di luce che dànno vivaci
rilievi al tessuto musicale.
Il primo canto di Conchita allorché narra l’incontro (evidentemente inventato) con tre cavalieri, a
due dei quali ha fatto moine volgendo le spalle al terzo, il quale sarebbe colui che essa ama,
facendo in tal guiisa prevedere il suo contegno con Mateo; quel canto vale altresì a fissare i caratteri
fondamentali delle melodie dello Zandonai: melodie tutte scioltezza negli andamenti ritmici, basate
sopra un tessuto armonistico ricco e vario, intimamente significative, plastiche; ma la loro austerità
le tiene come avvolte in un velo geloso, cosicché la loro forza espressiva non si rivela immediata,
non conquide la gran massa del pubblico; laddove la brillante veste orchestrale e la saporosa
contestura armonistica si impongono e quasi distraggono la attenzione dell’uditore, che è tratto a
riconoscere nell’autore più un compositore abilissimo che non inspirato.
L’intermezzo, a sipario calato, tra il primo e il secondo quadro, è una pagina squisita: un
arpeggio insistente, vero pedale armonico, ci dà l’impressione quasi palpabile della atmosfera
densa, immota, di una soffocante giornata estiva: un crepitio di castagnette, la voce di un venditore,
3.2.2/5
un tema melodico popolare definiscono, sto per dire localizzano la impressione, così da farci
rivivere nelle vie ardenti di una città spagnuola nel cuor dell’estate: si odono le voci di Mateo e di
Conchita, che insieme procedono; sottili, ondeggianti armonie par che descrivano l’insinuarsi
insidiosi della passione divoratrice nel sangue di Mateo. Con una ingegnosa e spontanea
transizione, avviene il passaggio dalla via alla casa: il chiacchierare umile, pedestre della madre di
Conchita contrasta con gli scatti e le tormentose contraddizioni del dialogo tra Conchita e Mateo: la
destrezza di quell’anima felina nel conquidere con le ardite attrazioni e le ripulse crudeli il cuore di
Mateo ha evidente rilievo musicale; la frase melodica del bacio, che si ripete più volte nello spartito
a ricordare il momento in cui fu saldato il ferreo legame tra i due, inizia un periodo melodicamente
più spianato del dialogo amoroso: la melodia «Della tua bocca il rosso fiore» si svolge sentitamente
appassionata, al pari di altre che ne sono derivazione e completamento; la scena concitata tra
Conchita e la madre, che chiude l’atto, vi fa acuto contrasto. Nel complesso il primo atto, nella sua
varietà, è alquanto sovraccarico e la eliminazione di qualche lungaggine non può che giovargli
assai.
Il secondo atto è ingegnosamente vivo e organico: la breve danza di Conchita e la Jota, più
sviluppata, danzata dalla Gallega, formano lo sfondo del quadro; mentre la danza prosegue
insistente, i frequentatori del Baile fanno le loro osservazioni, applaudono, cantano, corteggiano
Conchita che civetteggia; e la contemporaneità degli affetti e delle espressioni procede con
ammirevole equilibrio e scorrevolezza anche quando Mateo rivela alla sua tormentatrice quanto
ebbe a soffrire mentre ovunque la cercava; e Conchita risponde altera e sdegnosa.
Dopo la breve danza lasciva di Conchita, si svolge la grande scena tra la fanciulla, che, irata da
prima, giunge al fine a riavvicinare nei suoi modi l’innamorato Mateo; e qui la musica è di una
eloquenza ammirevole: il cromatismo delle idee melodiche si rispecchia nelle armonie sottili e
penetranti che circondano e stringono, come le spire tenaci di un serpe, il cuore di Mateo: la visione
della casetta fiorita, che sarà il loro nido d’amore, si stacca bianca e luminosa tra le affannose,
ardenti promesse.
La scena unica che forma il terzo atto è preceduta da un largo preludio, in parte sinfonico, in
parte anche vocale: è la estrinsecazione musicale di una calda e snervante notte d’estate: fruscii
misteriosi, luci attenuate nell’atmosfera densa, lontani appelli e lamenti d’amore, lente note e rapidi
vocalizzi, languida eco di una languida serenata; passano coppie amorose che la guardia notturna
non soltanto non disturba, ma anche imita. Ecco Mateo, che Conchita, difesa dal solido cancello,
irride e tortura ferocemente: e la musica ha guizzi e contorsioni tormentose, disperate. Così pure, la
scena unica del quarto atto è preceduta da un altro non breve preludio inteso a descrivere il lungo
strazio sofferto da Mateo nella notte infernale; l’insistente ribattere della stessa nota nel basso
esprime la paurosa ossessione della oscena, incancellabile visione, e, salvo i brevi contrasti
provocati dalla impudente fanciulla, sottolinea le espressioni del furore di Mateo, finché giungono
al parossismo, alla brutalità dei colpi violenti. E poi lo slancio erotico risorge: il tema del bacio
riappare e si riafferma, conquistatore, aprendo la via ad un ritmo appassionato che commenta e
solleva le espressioni ardenti dell’amore: e la tela cade, celando gli amanti allacciati, mentre
risuonano ancora di lontano le voci misteriose, vibranti nell’atmosfera sensuale. I pregi di fattura
sono ancora quelli che ammirai nel Grillo del focolare e ho già ricordato; forse anche afforzati dalla
maggiore maturità.
Ora lo Zandonai si accinge a dare veste musicale ad un nuovo lavoro; soggetto romano svolto da
un romantico: Mélaenis di Luigi Bouilhet, notevole rappresentante del periodo di transizione tra il
romanticismo e il parnassismo. Il giovane musicista si avventura così in una via ben diversa da
quelle finora percorse: ma ha in sé tanto vigore ed è così bene allenato da assicurarci che vi
procederà con passo sicuro.
PS. Al teatro Costanzi di Roma Conchita ha avuto una eccellente esecuzione: il maestro Edoardo
Vitale ha concertato e diretto lo spartito con affettuosa e intelligente cura; la signora Ersilde CerviCaroli è stata una protagonista ammirevole, principalmente quale cantatrice: come interprete del
difficile personaggio dimostrava di essere una bella e buona signora che fa di tutto per sembrare
3.2.2/6
depravata e, anche esagerando (anzi forse perché forzava talvolta le tinte), non riusciva ad illudere
gli spettatori. Buono il tenore Taccani, Mateo; sicuri e a posto gli altri; ottima l’orchestra.
394
Gino Monaldi, [Cronaca musicale]
Critica della critica - “Conchita” e “Carmen” - Osservazioni retrospettive - Analisi della
protagonista - Accuse non vere - Quali sono le colpe di Conchita? - Quali sono i meriti e le
deficienze del maestro - Il trionfo della tecnica e la sconfitta della ispirazione - [...], «Rassegna
contemporanea» V/4, aprile 1912 - pp. 133-7
Senza aver l’aria di fare la critica della critica, non so astenermi tuttavia dal cominciare questa
breve conversazione artistica con una affermazione perfettamente contraria a quanto sino ad ora si è
scritto e detto a proposito dell’opera Conchita del M° Zandonai.
Un fenomeno presso a poco uguale lo si ebbe quando Bizet, con nobile ardimento, presentò sulla
scena dell’Opera Comica di Parigi la musica della Carmen. I pedanti e gli aristarchi d’allora, ai
quali l’ispirata musica del Bizet aveva urtato le delicate e pudibonde fibre, si sbizzarrirono nel
gridare la croce addosso all’audace compositore, accusandolo anzitutto del peccato originale del
libretto, peccato che, secondo loro, era stato quello che aveva messo il maestro francese fuori di
strada, facendogli scrivere una musica che portava in sé le stimmate di quel verismo sguaiato e
brutale su cui era tessuta la trama della novella spagnola immaginata dal Merimée. Invece quel
verismo sguaiato e brutale era stato appunto quello che aveva messo le ali alla fantasia del
musicista e lo aveva condotto al capolavoro.
Quanto accadde allora per la Carmen a Parigi si rinnova oggi in Italia per il dramma di Conchita,
tratto integralmente, com’è noto, dal romanzo «La femme e le pantin» [sic] di Pier Louis [sic]. I
dardi della critica furono scagliati infatti, in massima parte, contro il libretto o meglio contro la
favola, e in special modo contro l’eroina di essa.
Il vituperio contro la persona di Conchita ha sorpassato invero ogni misura. Si è arrivato perfino
ad adoperare a suo danno (non sappiamo con quale proprietà di lingua e di logica) l’obbrobriosa
frase di “pervertimento sessuale...!”. Ma che pervertimento d’Egitto! Conchita non è affatto una
pervertita. Essa non è che una esaltata, una semifolle. Per lei il pudore è limitato alla semplice
conservazione della verginità, e qualunque attentato contro essa la rende furiosa. Essa vuole la
sicurezza assoluta di essere amata per sé stessa e non già per il possesso della sua persona. Quando
Matteo infatti, l’uomo che l’ha salvata una volta dall’ingiuria d’un altro, le fa sospettare in un
colloquio intimo ch’egli pure ambisca al possesso del suo corpo, essa gli grida in faccia queste
parole: “io so quello che tu vorresti; ebbene, quello tu non l’avrai!”.
Il sospetto e la diffidenza divengono ira e ferocia quando la mamma le porge il denaro regalatole
da Matteo.
La si vuol dunque vendere, e sua madre è la complice dell’infame mercato! Non c’è più da
esitare: bisogna fuggire, e Conchita fugge e si dà alla vita randagia del Caffè-Concerto, esponendo
la sua persona alla pubblica gogna pur serbando intatta la sua carne di fanciulla.
Quando Matteo la ritrova e la vede danzare seminuda sulle tavole d’un palcoscenico da caffè e,
più innamorato di prima, le propone la vita in comune in un solitario asilo da lui posseduto, essa
accetta col proposito di tentare un terribile esperimento di prova: quello di ricevere Matteo con la
difesa d’un cancello di ferro, torturarlo di desiderio e di gelosia, terminando coll’abbandonarsi, alla
presenza di lui, fra le braccia del giovinetto Maronito [sic].
Come ho detto, si tratta d’un terribile esperimento che poteva trarre al suicidio l’uomo da lei
sospirato: un’azione folle addirittura, ma dove il pervertimento non c’entra per nulla.
Conchita infatti, con la complicità di Maronito, ha simulato quella commedia di voluttà per
vedere fino a qual punto avrebbe resistito l’amore di Matteo. Convinta d’aver giuocato l’ultima
carta, essa viene a verificarne l’effetto nella casa stessa di Matteo e ne ottiene la convinzione a suon
di busse e di maltrattamenti.
3.2.2/7
Conchita, percossa e umiliata, comprende finalmente l’amore di lui e il male e l’offesa da lei
recato a questo amore. Essa non potrà farne ammenda che implorando il perdono di Matteo e
facendogli l’olocausto della sua verginità.
Egli ha saputo conquistarla, è ormai cosa sua: gli appartiene di diritto.
Ecco il ragionamento di Conchita.
Osserviamo bene pertanto questa creatura attraverso la sua strana psiche e ci accorgeremo della
fierezza e della precisione sopratutto della sua volontà: una volontà di acciaio che non si piega che
alla mano punitrice, solo però quando questa mano che la percuote le dà la sicurezza d’essere
veramente amata.
Perché dunque imbestialire su questa figura di donna e accusarla d’una malvagità viziosa o
d’una perfidia crudele che in fondo non esiste? E d’altra parte, quali sono i diritti che Matteo, il suo
innamorato d’occasione, può vantare su lei? Il caso di Carmen è ben diverso. Il soldato José ha dato
alla perversa gitana tutto se stesso: onore, vita, famiglia, libertà. Il disprezzo e l’abbandono di
Carmen sono quanto di più malvagio si possa concepire nell’anima di una donna. Ma lui, Matteo,
che cosa ha dato?
Mentre José aveva quindi tutto il diritto di uccidere, Matteo non aveva invece nemmeno il diritto
di percuotere. Si può scusare, tutt’al più, la sua brutalità, ma non vi sono ragioni per giustificarla.
Fra i due caratteri di Carmen e di Conchita esiste soltanto un’analogia di fatto, non un’analogia
di animo. Carmen è sguaiata, perfida, ingrata, lussuriosa e feroce per istinto; Conchita si mostra tale
– senza esserlo – per artificio e per progetto. Carmen non ama e non ha mai amato José; Conchita
ama ed ha amato sempre Matteo ma le ripugna di cedergli il proprio corpo perché pensa e crede che
sia soltanto e unicamente questo che Matteo voglia e apprezzi in lei.
Naturalmente non è ammissibile che questa fase psichica, difficile e laboriosa, attraverso la
quale si svolge l’episodio drammatico del libretto, possa efficacemente descriversi in poche e
sommarie scene. Chi poteva e doveva darci questa sensazione era il musicista, facendo parlare, non
la voce dei due protagonisti ma le loro anime! Ora questo non ha assolutamente fatto lo Zandonai.
Nei loro quattro dialoghi, o duetti, Conchita e Matteo si scambiano delle frasi espressive ed
efficaci, isolatamente prese, ma nessuna di quelle frasi diventa mai un’idea piena ed intera che
equivalga ad un vero e proprio discorso musicale. È come se l’occhio d’un miope osservasse senza
occhiali un mosaico bizantino a una certa distanza. Esso non vedrebbe che una festa ininterrotta di
contorni, di rilievi e di colori, ma il disegno, l’idea non potrebbe mai afferrarla. Qui, nel caso della
musica di Conchita, anche gli occhiali non basterebbero a vedere... quello che non c’è. Colore e
proprietà di colore fin che se ne vuole, ma disegno o concetto no.
E non è a dirsi che nel libretto manchino situazioni atte a provocare l’estro del compositore.
basterebbe tutto l’atto ultimo, a cominciare dalla prima scena, quella in cui Matteo si accorge
d’essere a un tratto divenuto grigio, sino all’ultima grande scena dove quelle due anime, dopo così
lunga e penosa lotta, s’uniscono finalmente nella tanto sospirata comunione. Invece, caso artistico
curioso, è proprio là dove l’estro musicale del maestro si è mostrato più debole e pigro. Invano
l’orchestra interviene con tutte le sue fastosità ed eleganze a infondere luce e vivezza al quadro: la
tecnica riesce, come al solito, a trattenere e interessare lo spettatore, il suo trionfo però non ci
scuote né ci dà un battito di polso in più.
L’ispirazione in quest’opera è presso che sopita: tutto è subordinato all’effetto: alla impressione
acustica. La conoscenza della tecnica sta alla musica come la versificazione alla poesia. Con questo
sistema non vi sono più idee e nemmeno originalità, poiché col tempo e coll’abitudine si finirà con
lo scrivere sopra una specie di cliché comune a tutti i compositori, ripetendo e ricopiando il già
fatto; e siccome il pubblico non avrà nessuna ragione di fischiare domani ciò che avrà applaudito
ieri, così lascerà che la claque si sfoghi a suo piacere ed escirà dal teatro indifferente e sconfortato
senza il vivo desiderio del ritorno.
Questo su per giù si è verificato e si verificherà ancora per Conchita, a meno che non si trovi una
protagonista d’un talento straordinario e d’un temperamento artistico eccezionale come Tarquinia
Tarquiny [sic] alla quale il maestro Zandonai deve il primo e autentico successo della Conchita a
Milano.
3.2.2/8
Qui a Roma invece la protagonista è mancata. La Cerri Caroli [sic], cantante di bella e fresca
voce e che aveva dato forte prova del suo temperamento drammatico in Manon e Wally, si è trovata
fuori posto in Conchita, della quale ha saputo ritrarre la sentimentalità drammatica, senza poterne
rendere il fascino esteriore, la morbidezza e l’eleganza della persona e sopratutto la modulazione
della parola e l’impeto della frase.
Meno ancora a posto ci è apparso il bravo tenore Taccani a cui, secondo me, è mancata
sopratutto la preparazione scenica, d’una importanza massima in quest’opera.
L’orchestra, diretta dal M. Vitale, ha corrisposto pienamente alle intenzioni tutte del
compositore, colorendo e rilevando ogni minimo dettaglio della complicata partitura.
[...]
3.2.2/9
Melenis
395
Gino Monaldi, [senza titolo], «Rassegna contemporanea» VI/1, 10.1.1013 - pp. 8-111
[...]
E veniamo a Melenis dello Zandonai.
In questo secondo lavoro, il giovane e forte musicista ha voluto affermare la propria cifra in tutta
la sua potenza e dare a Conchita una sorella ancora più fiorente e robusta. E per riuscirvi ha
cominciato col porre una cura maggiore nella scelta del libretto e sopratutto in quella della
protagonista. Dopo l’errore del poco comprensibile personaggio di Conchita, lo Zandonai ha
pensato che l’eroina del suo nuovo dramma lirico dovesse essere una creatura semplice e sincera,
capace d’un tale fascino d’avvincere non solo il suo innamorato sulla scena ma altresì l’anima e i
sensi del pubblico e condurlo a trattenerlo vicino a sé dal primo suo spasimo d’amore sino a quello
ultimo della sua morte.
Il libretto dello Spiritini e dello Zangarini è tolto, come è noto, dal poema di Louis Bouilhet, una
leggenda romana piena di amore e di passione, con uno sfondo imponente e grandioso dell’epoca
imperiale di Commodo. Si può riassumerlo brevemente.
Melenis, l’eroina del dramma, è una delle tante etere di cui la Grecia forniva la Roma imperiale
per saziare il raffinato appetito dei rammolliti discendenti dei Gracchi. E Melenis è satura d’amore
e di lusinghe.
La sua seduzione è irresistibile, tanto che Marzio, il retore, fidanzato della figliuola di Marcello
edile, incontratala a caso nella taverna di Saturnino alla Suburra, ne rimane preso e si lascia
facilmente legare con essa in un voluttuoso nodo d’amore. Senonché quel nodo, che per Marzio ha
la durata appena di qualche ora, per Melenis diviene invece una catena indissolubile di amorosa
passione. Ed è invocando la virtù di questo amore ch’essa rifiuta i baci dell’Imperatore e ottiene da
lui il generoso perdono di quel rifiuto. «Ritorna alla tua gioia», le dice Commodo, lasciandola
libera.
La gioia di Melenis è tutta però nell’amore di Marzio. E questo amore essa viene disperatamente
a invocare da Marzio nella villa suburbana di Marcello edile, la mattina dell’alba nuziale di lui.
Marzio rimane saldo e inesorabile.
Il sogno di quella notte alla Suburra è svanito. «E chi fosti dunque tu?» – gli dice Melenis – «Un
naufrago!», risponde seccamente Marzio.
Io nuotavo nel mar perdutamente
verso la Dea! Tu fosti la sirena
di quel mare! Or, raggiunta ho la mia riva.
La tragica angoscia di Melenis non lo trattiene, né lo commuove:
Con la sua sorte ognun, sia fausta o ria,
seguiti, e non si fermi, la sua via...
Melenis, vinta e percossa, cade a terra sulla soglia della esedra marmorea, e mentre Marzio entra
nella villa senza nemmeno degnarla d’un pietoso sguardo, essa con oscura minaccia esclama
dolorosamente:
Per la tua via se troverai le rose
ricordati di me!
per la tua via se il sangue troverai,
ricordati di me,
1
L'articolo, nella prima parte, tratta delle opere La Cingallegra di Zeppilli, Radda di Orefice, Feuersnot di R. Strauss e Zingari
di Leoncavallo.
3.2.2/10
Marzio!!
E la minaccia ha il suo epilogo sanguinoso.
Melenis attende l’uscita del corteo nuziale in mezzo a un tappeto di rose, e quando i canti ne
annunziano l’arrivo, essa raccoglie un fascio di quei fiori, li serra al petto e traendo dai capelli uno
spillone d’oro se lo infigge nel cuore.
Questa storia di amore e dolore ha suggerito ai librettisti tre brevi quadri poetici: il primo alla
Suburra; il secondo nell’atrio del Circo; e il terzo ed ultimo alla villa di Marcello: quadri che hanno
dato modo allo Zandonai di spaziare con la sua robusta fantasia in tre regioni diverse: quella tutta
ansie e fremiti dell’amore lussurioso e lascivo, nelle sue più vibranti e riposte pieghe; quella
pittoresca e feroce del Circo, con tutte le sue espressioni di pietà e di terrore, dalle lotte dei
gladiatori ai canti dei Cristiani, e quella della passione angosciosa e disperata nelle sue più
spasmodiche e supreme espressioni.
Lo Zandonai, per riuscire a dare una organizzazione stilistica al poema e vestirlo di motivi che
avessero una trama sensata e rispondente all’atmosfera generale dell’argomento, aveva bisogno di
due facoltà essenziali: facoltà creativa e facoltà di mezzi esteriori adatti allo scopo. Ebbene, lo
Zandonai ha dimostrato di possedere ambedue queste indispensabili facoltà.
Egli, con una sicurezza addirittura rara in un giovane compositore, ha pensato – e ciò per la parte
creativa – a dare anzitutto un giusto ordinamento alla trama drammatica, rinchiudendola in un
complesso melodico, organizzato e vivente per una intima coesione di singoli pezzi di musica, in
guisa da infondere al melodramma un carattere determinato e finito. Questo egli ha fatto con un
pensiero fortemente moderno e un po’ troppo lontano, se si vuole, dai caratteri dell’antica opera
italiana.
Oggi è purtroppo passato il tempo in cui il singolo pezzo poteva valere quanto il tutto d’oggidì.
La melodica forma dell’aria, delle cabalette e delle variazioni è già quasi dimenticato; nell’opera
odierna è il tutto che bisogna concepire, disporre, organizzare, con gli stessi procedimenti
d’invenzione e di forma con i quali si organizzava prima il singolo pezzo. Ora è innegabile che lo
Zandonai, pure non creando motivi e temi d’una bellezza peregrina, ha saputo infondere ad essi una
energia passionale e un impeto d’affetto che avvince e soggioga. Tutto il primo duetto d’amore, la
perorazione commovente di Melenis invocante la generosità di Commodo all’atto secondo, la
romanza di Marzio e tutta la grande scena finale del terzo posseggono una ricchezza di risorse
evolutive, una efficacia di accento, una potenza di colore drammatico ed una forza e continuità
d’idee la cui efficacia è irresistibile.
Il pregio massimo, secondo me, quello che assicura a Melenis vita e vita vittoriosa sul teatro, è di
aver saputo far parlare sempre melodiosamente i personaggi, e sempre in armonia con carattere e le
parole del dramma, rendendo visibile il fondo della loro anima e visibili parimenti le impressioni
che ne sfiorano la superficie.
Per ciò che riguarda la parte sinfonica non esitiamo a dichiarare che la orchestrazione di Melenis
è d’una rara sapienza, una meraviglia di abilità tecnica e di elaborazione istrumentale. Si potrebbe
desiderare invero una maggiore importanza della melodia vocale rispetto al lavoro dell’orchestra, la
quale talvolta subisce una continuità di contorsioni foniche un po’ troppo artificiose, ma la
erudizione armonica e quella della istrumentazione non si giudicano in casi isolati bensì nel
complesso dei fatti, e questi fatti hanno nella loro effusione una forza ed una evidenza immediata.
Quanto il Leoncavallo ha indietreggiato con i Zingari, altrettanto ha vittoriosamente camminato
innanzi lo Zandonai con Melenis. E se in questa marcia verso le nuove forme dell’arte il giovane
musicista ha allungato un po’ troppo il passo, non potremmo né vorremmo certo fargliene un
addebito. Quando si ha il passo così sicuro come lo Zandonai, si può anche sfiorare col piede il
precipizio e superarlo bravamente.
Melenis, scritta a breve distanza da Conchita, ci dice come e quanto l’ingegno dello Zandonai
possegga il privilegio della creazione melodrammatica.
Ambedue queste opere sono riuscite difatti a penetrare vittoriosamente, e di colpo, nella piena
attività del nostro repertorio melodrammatico, e la Casa Ricordi, che con felice accorgimento ha
3.2.2/11
saputo impadronirsene, saprà anche farvele vivere con fortuna sua e delle Imprese che avranno il
senno di esporle sulla scena.
3.2.2/12
Francesca da Rimini
396
Giorgio Barini, Riccardo Zandonai e la Francesca da Rimini, «Fanfulla della domenica»,
21.3.1915 - p. 1, col. 1-2-3-4 / p. 2, col. 1
In verità, non è possibile pronunziare il nome di Francesca da Rimini senza che nella nostra
mente sorga come per incanto la visione stupenda che tanto commosse l’anima austera di Dante: la
esangue e sospirosa immagine della donna che resta immobile mentre a lei dintorno si scatena «la
bufera infernal che mai non resta» (la muta figura di Paolo le è da presso, e la tiene avvinta come
per sostenerla e darle forza di narrare la fosca sua storia fino al termine) assorbe ogni nostro
pensiero e tutto si vela e scompare a lei dintorno mentre le parole alate, tutte pervase da una ardente
fiamma amorosa, rievocano la tragedia che in lei sola sembra assommarsi: il resto è ombra vana.
La insuperata arte dantesca ha impresso del suo suggello la visione, idealizzandola,
sublimandola; così che ogni tentativo di ricostruirla materialmente ci sembra vano e irriverente: dar
forma tangibile ad un ideale è impresa disperata: troppo misera cosa è l’opera delle nostre mani in
confronto con le immaginazioni del genio. Sicché tutti i tentativi di portare sulle scene l’episodio
dantesco sono fatalmente e implacabilmente soffocati dalla grande ombra dell’altissimo poeta.
Una delle maggiori difficoltà è quella di completare l’episodio tratteggiato sinteticamente nella
Commedia per dargli normale sviluppo e organica consistenza: ne consegue la necessità di
aggiungere altri episodi numerosi che appaiono appiccicati arbitrariamente attorno alla scena
dantesca, deturpandola come stoffe e gioie (sian pure le più sfarzose e vaghe) poste addosso ad una
statua ellenica pura e muta come la Venere capitolina.
Così è avvenuto che tutte le tragedie e le opere musicali (di queste, due dozzine almeno) ispirate
all’episodio immortale sono sembrate più o meno sensibilmente insufficienti e irrispettose parafrasi
di un capolavoro. Né la veste musicale in cui tante volte è stata drappeggiata la bella peccatrice è
valsa a sollevarne la sminuita potenza di vita.
Non può negarsi che, tra tante Francesche rammollite, quella modellata da Gabriele d’Annunzio
appaia di gran lunga la più eletta e nobile, animata com’è tutta da un caldo alito di poesia: ma la
molteplicità delle preziose ornamentazioni di cui l’ha rivestita il poeta, che fanno così dilettosa la
lettura del suo armonioso poema, le danno sulla scena una inconsistenza tanto più sensibile quanto
maggiormente minuziosa è stata la cura della sua creatura. La tragedia d’annunziana è un mosaico
stupendo, di cui le singole pietruzze, levigate e rilucenti scheggie di marmi rarissimi dalle tinte più
vive e pure, dai riflessi più vari e smaglianti, non giungono a fondersi in un tutto perfettamente
omogeneo: allietano l’occhio ma distraggono la mente, la quale si perde nella contemplazione
analitica delle parti e deve compiere uno sforzo non lieve per assurgere ad una visione sintetica.
Tito Ricordi ha osato sfrondare con felice ardimento il voluminoso poema drammatico del
d’Annunzio per trarne il succo e offrirlo nelle sue linee più semplici ed essenziali al musicista che,
baldanzoso, si accingeva ad affrontare la pericolosa impresa: e, bisogna convenirne, è riuscito a
dare allo schema scenico una snellezza notevolissima, mantenendone viva tutta la parte sostanziale,
nelle sue originarie espressioni di poesia. Tuttavia molta letteratura è rimasta in piedi nelle pagine
del libretto, nel quale il punto culminante ne è irrimediabilmente inquinato: quel prorompere della
passione amorosa davanti alle fredde pagine di un libro su cui sono rivolti gli sguardi dei due
cognati, come se le pergamene levigate bastassero a riflettere e far penetrare negli occhi dell’una la
fiamma che arde negli occhi dell’altro, e che riesce tanto suggestivo nelle terzine dantesche (ma
quivi Francesca narra, non legge!), appare invece artificioso e poco persuasivo nella attuazione
scenica.
Che dire poi dell’intervento del giullare, dei musici, delle ancelle stornellanti, dei guerrieri
vociferanti? Sono vive macchie di colore, ma non animate da vera vitalità e umana consistenza. E
siffatti espedienti scenici sono ingranditi e aggravati dalla elaborazione musicale, per quanto possa
questa essere ingegnosa e gustosa.
–-
3.2.2/13
Ciò premesso, bisogna convenire che esser riuscito a trarre dalla tragedia del d’Annunzio un
dramma musicale scenicamente organico, sobrio e snello a sufficienza e musicalmente forte e
attraente, è cosa tale da destare in noi un lieto senso di ammirazione e di intima soddisfazione. Non
devesi però dimenticare come il valore del musicista che ha dato il commento sonoro alla creazione
del d’Annunzio desse affidamento di concepire e attuare un’opera d’arte eletta e sincera.
Ricordo ancora la lieta sorpresa destata in me dalla prima opera di Riccardo Zandonai, quel
delicato, gaio e sentimentale Grillo del focolare che udii a Torino, al Politeama Chiarella, quando
fu per la prima volta eseguito, e che sarebbe giustizia mantener vivo sulle scene: era la rivelazione
di un temperamento artistico felicissimo, afforzato da una abilità tecnica non comune, e che, pur
mantenendo in onore qualche sano orientamento tradizionale italiano nel disegno scenico, sapeva
con sicurezza eccezionale valersi di ogni risorsa della moderna tecnica, senza mai cadere in
bizzarrie volute e non necessarie, senza ricercatezze artificiose, sempre spontaneo e vivo.
Venne poi Conchita: e l’ardito romanzo di Pierre Louys da cui è ricavato il soggetto (La femme
et le pantin, in cui rivive uno dei più caratteristici ed efficaci episodi delle memorie del Casanova),
soggetto che a priori sembrerebbe incompatibile con una realizzazione musicale, ebbe in Riccardo
Zandonai un interprete eccellente per valore espressivo, per felice abilità coloristica. Melenis,
artificiosa, fredda, sconnessa azione drammatica, male ricavata dal poema del Bouilhet, dal quale
assai diverso e miglior partito si sarebbe potuto trarre, tuttavia permise al giovane maestro trentino
di dare nuova e ancor più convincente prova della sua così ben dotata tempra d’artista.
Delle sue felici attitudini è prova eloquente il fatto che egli, traendo gran profitto dalle nuove
conquiste nel campo della tecnica musicale, ha saputo assimilarsele perfettamente e farne sangue
del suo sangue: eppure non aderisce a nessuna scuola, non subisce pericolosi influssi di lusinghiere
tendenze: egli si avvia a gran passi alla conquista di una personalità originale, perché gli sarà facile
giunger presto a liberare completamente la sua fisionomia artistica da ogni velatura e far sì che i
suoi tratti raggiungano rilievo completamente caratteristico.
Francesca da Rimini segna ancora un passo innanzi nella affermazione della forza intima, della
efficacia espressiva, della magistrale valentia dello Zandonai. Egli è stato accusato (e sotto qualche
aspetto forse non completamente a torto) di abbandonarsi troppo alla gioia del comporre
rapidamente, confidando nella sua straordinaria abilità e facilità di scrittura, facendo opera
impulsiva più che riflessiva e per ciò con tendenza alla superficialità. Ma se qualche sua pagina
contribuì a far ritenere che tale accusa potesse anche apparire non completamente infondata, il
nuovo spartito dimostra nel suo autore una vera sensibilità e una giusta rispondenza col testo
poetico, del quale egli ha subìto l’influenza in bene e in male.
La musica del Zandonai infatti riflette come specchio di terzo cristallo i colori e i sentimenti del
dramma: appassionata e suggestivamente espressiva negli episodi in cui palpita la vita;
squisitamente elegante nelle più belle scene ornamentali, così abbondanti di armoniosi versi e di
immagini fresche e colorite; alquanto superficiale, sebbene ricca di belle sonorità, nei momenti di
grande agitazione materiale non sostenuta da sincero ardore passionale.
ooo
Così il primo atto, che procede snello e brillante nel gaio cinguettare delle garrule ancelle,
vigoroso nelle escandescenze di Ostasio, incisivo nelle astute frasi di ser Toldo, teneramente
espansivo nel dialogo di Francesca con la gentile sorella Samaritana, assume una magnifica
ampiezza e intensità suggestiva di sentimento allorché nell’incontro di Paolo e Francesca sorge e
penetra vittorioso nei loro cuori l’amore possente che li condurrà a morte: qui una nobile frase
melodica, flessuosa e palpitante, si diffonde largamente e pare illumini e faccia vibrare tutta
l’atmosfera, mentre le voci delle ancelle si levano e si intrecciano stornellanti, come un delicato
ricamo policromo sopra un sottile serico velo, e si riodono gli appelli che accompagnano il primo
apparire del Malatesta.
Il secondo atto è tutto traversato e come riempito dai fragori della battaglia, con effetti fonici
strumentali e vocali veramente superbi ma basati su limitati elementi musicali, e per ciò poveri di
contenuto: tra la furia guerresca l’episodio che segna il germinare del sentimento amoroso dei due
cognati resta alquanto soffocato, sebbene non manchi di grazia e di significato nel risorgere del
tema dell’amore ornato dagli echi sottili dello stornellare delle ancelle; così pure non acquistano
3.2.2/14
bastante rilievo alcuni disegni ritmici interessanti, tra cui importantissimo quello che accompagna
Malatestino, «castigo d’inferno!».
Nel terzo atto le canzoni e la danza delle ancelle hanno carattere più riposato e calmo: v’è
alcunché di più intimo e affettuoso nei loro accenti; la scena tra Paolo e Francesca presenta una
ammirevole gradazione d’affetti: dalla freschezza primaverile della visione di lei narrata da Paolo
(«Inghirlandata di violette - m’appariste...»), al ricordo della frase del perdono, detta da lei durante
la battaglia; dal racconto delle visioni che tormentarono il giovane, al riapparire della frase amorosa
a traverso la lettura, frase che prorompe tutta ardore allorché le labbra di Paolo si imprimono sulle
labbra di Francesca, e riappare attenuata come un’eco mentre la tela si chiude. E pure in questa
scena, che la nobile elaborazione musicale rende armoniosamente organica nella sua varietà, Paolo
e Francesca mantengono parvenza di creazioni letterarie (per colpa – o merito? – di Dante?) più che
di creature vive e vitali.
Altra vita, altra potenza drammatica imprime la musica al primo quadro del quarto atto: le
insidiose parole di Malatestino alla cognata, sottolineate dal ritmo incisivo e tormentoso che
simbolizza la perversità del giovinetto, e interrotte dai lamenti strazianti dell’invisibile prigioniero,
assumono ammirevole forza: e nella breve scena di Gianciotto (annunziato e accompagnato da un
caratteristico ritmo che pare scolpisca l’andamento disuguale dello sciancato) con Francesca, quel
disegno insistente mantien viva l’immagine viperea dell’orbo mentre è andato a trucidare il
Parcitadi; i ritmi caratteristici dei due fratelli si alternano allorché si trovano di fronte: ma quel di
Malatestino predomina, insistendo con tragico accanimento durante la delazione orrenda; scena
poderosa, in cui il commento musicale assurge ad una significazione tragica di straordinaria
intensità.
A differenza di Paolo e Francesca, Gianciotto e Malatestino, che non trovano riscontro nella
Divina Commedia (salvo il primo, ma sol per tenue riflesso), appaiono nella tragedia figure
robustamente concepite e plasmate dalla mente del poeta, non fissate nella contemplazione di un
celebrato modello: dai saldi muscoli e vive; e tali si rispecchiano nel commento musicale.
Il secondo quadro, cui da prima si riaffacciano alla mente di Francesca ricordi della nativa
Ravenna, con qualche tema delle canzoni del primo atto, e si rievocano le parole di Samaritana; e
poi gli appelli che annunziarono Paolo al primo apparire si riodono al suo irrompere nella camera
della cognata; non manca di animazione nella nuova scena d’amore, la quale però ha minor forza di
espressione della prima; la scena finale in cui Gianciotto uccide gli adulteri è rapida e tumultuosa
orchestralmente, mentre le voci tacciono; ma, forse per il confronto immediato col magnifico
vigore drammatico delle scene del primo quadro, risulta meno convincente, e il commento
sinfonico nulla aggiunge alla drammaticità della scena.
Concludendo, con questo spartito Riccardo Zandonai ha compiuto un’opera d’arte di grande
importanza, che degnamente illustra la più eletta delle opere drammatiche del d’Annunzio e che
dimostra quanto rapidamente il giovane maestro trentino si elevi ai più alti gradi nell’arringo
musicale italiano. Ora egli si accinge a porre in musica un soggetto comico; il bel saggio dato col
Grillo del focolare assicura un nuovo gustoso spartito, che il mirabile sviluppo dell’arte dello
Zandonai a traverso i quattro spartiti finora dati alla luce renderà ancor più solido e brillante: e ciò
di gran cuore auguriamo per il bene della nostra vita musicale e per nostra maggiore soddisfazione
personale: in questi casi anche una buona dose d’egoismo è sinceramente consigliabile.
397
Gino Monaldi, La “Francesca da Rimini” di Riccardo Zandonai, «Nuova antologia» XLIX/vol.
254, fasc< 1014, 16.3.1914 - pp. 322-5
Finalmente la cronaca musicale delle tante Francesche e Paolo giunte sino ad oggi sulla scena
lirica ha la soddisfazione di poter registrare un successo. Un successo vero, reale, completo,
consacrato dal consenso di un pubblico notevole per quantità e qualità, accorso al teatro Regio di
Torino chiamatovi dalla fiducia migliore nel giovane e fecondo maestro trentino. Il Zandonai aveva
3.2.2/15
infatti diritto a questa fiducia da lui guadagnata con Il grillo del focolare, Conchita e Melenis, tre
lavori ognuno dei quali ha segnato un passo innanzi nella carriera del compositore.
Una osservazione notevole è questa: nei tre argomenti scelti dallo Zandonai per esperimentare la
forza e la misura della sua fantasia e della sua dottrina, si rivela una spiccata disparità di caratteri
scenici e drammatici; eppure, malgrado ciò, lo stile e la personalità dell’artista rimane ugualmente
salda ed integra. L’unità e l’armonia della lingua musicale da lui adoperata per tradurre ed
esprimere le passioni dominanti nei tre disparati argomenti non appare infatti in verun modo
alterata o depressa. Ciò prova che il giovine compositore possiede in sommo grado la coscienza
della sua personalità e a questa non intende recare offesa. Lo Zandonai è e vuol rimanere un sincero
– e vincere, senza porre nessun velo a traverso lo specchio di questa sua bella sincerità. Ciò egli ha
sentito e fatto nelle sue tre opere precedenti e ciò egli ha sentito e fatto altresì adesso nella
Francesca. E bisogna dire che la sua tempra sia davvero ben salda se egli ha potuto conservare
questa sincerità in una tragedia come la Francesca del D’Annunzio, opera di poesia più che di
verità, dove la commozione è dovuta più che altro alla artificiosità delle situazioni, spinte talora alla
iperbole della più sanguinaria ferocia e sempre avvolte in quella tristezza profonda che incombe
sull’atmosfera del dramma. Eppure lo Zandonai ha potuto e saputo qui, meglio ancora che altrove,
conservare alla sua musica i propri caratteri originarî. Soltanto che nella Francesca egli ha sentito il
bisogno di concedere alle persone della tragedia una espansione maggiore, infondendo alle voci
una facoltà melodiosa più confacente alla violenza delle passioni che vivono e turbinano entro le
loro anime.
Naturalmente questa facoltà melodiosa è sempre subordinata alle esigenze della parola,
subordinata, intendiamoci, non però asservita. L’asservimento esiste solo nei momenti in cui
l’azione, come nell’atto secondo, nella scena della battaglia, assume un carattere pittorico collettivo
e quindi necessariamente descrittivo. E allora il commento sinfonico ha impeti selvaggi, terrori,
sgomenti, schianti violenti, grida esultanti di vittoria, gemiti dolorosi e clamori formidabili. È la
tragedia che dall’orchestra sale e invade il palcoscenico, e i personaggi, presi e travolti da
quell’onda istrumentale sempre più grossa e incalzante, ci sembra che sfuggano per un momento
alla nostra attenzione distratta e attratta dalla grandiosità complessa del quadro scenico-musicale.
Per renderci conto di questo fatto, che a taluni è sembrato motivo o argomento di censura,
occorre ricordare che in questo secondo atto, alla serenità melanconica dell’atto primo succede il
furore d’una battaglia. Siamo sullo spalto d’una torre nel maniero dei Malatesta: macchine
infernali, saettare di balestrieri, pioggie di fuoco greco si rovesciano contro l’avanzante nemico.
Trombe, campane, strepito di ferro e di armi risuonano nell’aria in mezzo al guizzo di quadrelli e di
falariche. Lamenti angosciosi di feriti, urla forsennate di ebbrezza vittoriosa si confondono
nell’orrore della mischia accanita. È quindi logico e naturale che voci ed orchestra abbiano contrasti
ed urti continui, dissonanze aspre e concitate. Sono vicende guerresche che bisogna musicalmente
dipingere e la pittura di necessità non può risultare all’orecchio diversa da quello che l’occhio vede
innanzi a sé. Due episodi scenici però giungono in tempo a dare un po’ di tregua all’imperversare
tumultuoso delle voci e degli istrumenti. Il primo è quello in cui Paolo e Francesca si trovano vicini
l’uno all’altro e l’amore scambievole, che mal si celava sotto un’apparente ostilità, li accende
entrambi d’improvviso. Francesca vuole però che Paolo si purifichi prima del peccato da lui
commesso per averla sposata con inganno e invoca il giudizio di Dio: Paolo si toglierà l’elmetto e
lo scudo e privo di quelle due difese combatterà all’aperto, dall’alto degli spalti. Paolo acconsente e
quando, libero ed illeso, si ritira dalla pugna, Francesca, che pavida e trepidante lo crede ferito e gli
cerca invano tra i capelli la piaga, giustificata nella sua idea superstiziosa, può finalmente
abbandonarsi alla segreta gioia del suo amore. Nel musicare questo episodio lo Zandonai si serve
dello spunto dolce e passionale che accompagna l’arrivo di Paolo nella casa di Francesca allorché i
loro sguardi s’incontrano per la prima volta. La frase, che chiameremo “dello sguardo”, abilmente
trasformata giunge molto opportuna a colorire il breve colloquio.
Fortemente significativo è il ritmo puntato che si ripete come un singulto all’arrivo di
Malatestino ferito. Sono poche battute che bastano a disegnare musicalmente la bieca figura del
sanguinario giovinetto. Questo secondo episodio, tanto dissimile dal primo, ci dimostra come lo
Zandonai senta la psiche de’ personaggi della tragedia e con quanta bravura ne sappia tradurre e
3.2.2/16
rendere la fisionomia musicale. Certo che in questo atto secondo non è il caso di ricercare la lirica
musicale in quella sua essenza melodiosa che costituiva la concezione dell’antico teatro
melodrammatico. L’essenza musicale esiste, ma non è visibile e sensibile che ne’ suoi rapporti
soltanto, né potrebbe essere altrimenti, dato il carattere eminentemente descrittivo di tutto l’atto.
Questa essenza melodiosa noi la percepiamo e la gustiamo invece in tutte o quasi le pagine che
costituiscono la partitura musicale degli altri atti. La sentiamo e la gustiamo infatti nei canti di
Biancofiore, di Garisenda [sic], di Altichiara e di Donelba [sic] – le donne di Francesca –: canti
atteggiati ad una soavità e ad una dolcezza spensierata e serena. Questo movimento melodico che
incomincia subito col cicaleccio delle donne sale e si accentua nella scena fra Samaritana e
Francesca «Anima cara, piccola colomba» e si ha sempre più vivo nelle scene successive.
Sopratutto la musica raggiunge accenti di delicata melanconia quando il gaio sciame delle ancelle
ritorna per annunciare a Francesca l’arrivo di Paolo venuto a rogar l’atto nuziale per mandato del
fratello. È un momento musicale pieno di bella e di grande poesia. Con una pennellata magistrale lo
Zandonai ci dà tutta intiera la delicatezza del quadro. La pennellata e costituita dalle note armoniose
e dense di doloroso sgomento vibranti dalle corde d’una viola pomposa che lo Zandonai vi ha
introdotto con raro accorgimento di arte. Mentre la viola svolge il suo canto suggestivo
accompagnato dall’oboe e dal clarone, Francesca e Paolo si osservano turbati, come presi da un
fascino misterioso. La viola continua intanto la sua ispirata melodia: le donne cantano e il velario si
chiude lentamente mentre lentamente si vanno estinguendo altresì le voci e gl’istrumenti.
L’atto terzo, com’è noto, si svolge nella camera di Francesca. Una specie di pedale fisso sopra
una nota ci porge l’immagine plastica del quadro. Le ancelle cantano e danzano, mentre su dalla
loggia echeggiano dolci armonie di liuti e clarini. La musica, senza seguire la solita falsariga
arcaica degli antichi modelli, è viva e leggera e si diffonde da essa come un profumo di sottile
voluttà. Anche qui, come sempre o quasi, lo Zandonai, pure compiacendosi di qualche armonia
inconsueta, si studia affinché la chiarezza del canto non rimanga disturbata.
A questo proposito voglio osservare che nell’armonia dello Zandonai non si fa mai abuso di
quelle famose sovrapposizioni e sonorità complesse in cui si aggrovigliano none, undecime e
tredicesime, tanto care allo Strauss e a qualche altro, e che recano così grave nocumento alla
limpidezza della idea musicale. E poiché abbiamo nominato la parola idea intendiamoci bene sul
valore di essa. Molte volte abbiamo udito dire: la musica moderna è priva d’idee: e quest’accusa si
è ripetuta da taluno, anche oggi, a proposito della Francesca. L’arte odierna, ricordiamolo, è tutta
compenetrata di critica, ma ciò avviene perché noi di essa scorgiamo e avvertiamo le benché
menome pulsazioni, mentre l’arte del passato ci appare nel suo insieme come un oggetto messo a
distanza. Siamo analitici, è vero; ma dobbiamo pur considerare che ciò che è immediato si presta
meglio all’analisi di ciò che è lontano. È naturale quindi che un fenomeno d’arte moderna ci appaia
molto più complesso d’un simile fenomeno d’arte verificatosi in altri tempi.
Il discutere pertanto sulla psiche, diremo così, delle idee musicali è una fatica senza costrutto. Si
chiami frase, motivo, periodo, idea, la musica rimane sempre costituita da quella successione di
suoni misurabili alla quale è sottoposta la sua comprensione.
Quali che sieno pertanto i fattori, quali i rapporti ingegnosi di sonorità e le forme libere e ardite
con le quali la musica si offre alla contemplazione, essa avrà sempre bisogno di significare un
pensiero – e il pensiero non potrà aver mai manifestazione più bella ed efficace della melodia.
Orbene lo Zandonai ha tenuto conto di questo assioma per tradurre e rendere musicalmente la
situazione lirica dell’atto terzo, nella grande scena d’amore tra Paolo e Francesca. Quella
situazione, che aveva già da tempo sedotto – purtroppo invano – la fantasia di altri musicisti anche
illustri, ha trovato così questa volta nello Zandonai un interprete squisito. Anzi che lasciarsi
travolgere dall’onda irrompente della passione egli ha preferito di farci sentire la salita di quella
vampa d’amore con un dialogato melodioso che va, cammina e procede con moto lento e continuo,
e a poco a poco si svolge in linee ampie e suggestive che fissano i contorni d’una serie di frasi
eloquenti che sembrano uscire dai più riposti meandri di quei due giovani cuori. Poche volte l’inno
dell’amore è salito così bello, così alto, così pieno di esultanza come in questa poderosa pagine
musicale descrivente la scena del “libro galeotto”.
3.2.2/17
Ciò non esclude che nell’atto ultimo altresì egli non ci sorprenda e ci avvinca con la forza
incisiva di cui fa magistralmente uso nella scena terribile fra Gianciotto e Malatestino, e non ci
rapisca e ci trasporti con lo scoppio intenso di amorosa passione che esplode dalle anime deliranti
dei due innamorati nella seconda parte dell’atto che prelude alla catastrofe finale. Egli non
solamente possiede l’estro e la dottrina, il senso del teatro e la ragione dell’arte, il culto dell’estetica
e quello della tecnica, ma sa distribuire queste sue facoltà con una misura ed un buon gusto che non
possono non assicurargli la vittoria della scena.
E siccome lo Zandonai ha la sicurezza ormai di proseguire la salita per cui si è messo a
raggiungere la sospirata meta, così senso il bisogno di esporgli un mio parere. I moderni
compositori in generale non trovano più, o la trovano raramente, la ragione organatrice che guidava
un tempo la costruzione della sinfonia, della sonata, del concerto, ecc., e intendono che essa
consista in qualche cosa di più d’una semplice costruzione di parti.
A prima giunta questo sdegno per le forme tradizionali o scolastiche sembra assolutamente un
progresso, e lo è, ma non puro, poiché occorre ricordare che se la fuga, ad esempio, si giudica oggi
un arido artificio, nemico d’ogni verace espressione di sentimento, si deve pur considerare ch’essa
nacque quando l’opera pratica si concepiva con una determinatezza di confronto che oggi è
smarrita. Questo dico e ricordo allo Zandonai, come a colui che oggi a ragione può dirsi il pioniere
della giovine scuola italiana.
Come tale pertanto egli ha il dovere di non dimenticare che la vertiginosa evoluzione del
pensiero moderno, se può essere illimitata nelle scienze positive, non può esserlo parimenti nelle
discipline musicali, soggette a certe leggi occulte della natura che invano si tenterà di scuotere.
Prima di chiudere questa rassegna sento il bisogno d’una sincera parola di lode per Tito Ricordi,
il quale ha saputo evitare che la novella dannunziana, nel suo travestimento musicale, subisse la
sorte poco fortunata di altre sorelle. E il Ricordi ha saputo evitarlo falciando senza misericordia ma
con mano esperta e sicura, nella tragedia del D’Annunzio, limitandola a quelle sole necessarie
vicende imposte dalla chiarezza della favola e adatte ai mezzi d’un libretto per musica. Tanto lo
Zandonai quanto il D’Annunzio debbono essere grati alla abilità del riduttore.
398
Iginio Trifiletti, “Perdonato ti sia con grande amore”, programma di sala del Teatro dell’Opera per
Francesca da Rimini, febbraio 1963.
La dolcissima e pur tragica vicenda d’amore e di morte che, nella sua magnifica veste musicale,
si appresta a celebrare i suoi primi cinquant’anni di vita luminosamente vissuta dentro e fuori i
confini della patria, brillò già di vivido splendore su queste scene liriche quando il Teatro
dell’Opera recava ancora il nome del suo fondatore, il Costanzi. È caro, in proposito, riandare col
pensiero a quell’epoca non più vicina, eppure non lontana.
La Francesca da Rimini di Riccardo Zandonai venne data in una eccezionale edizione, come
inaugurazione della stagione, la sera di Santo Stefano del 1921. La nuova opera, concertata e diretta
dall’autore, apparve in una esecuzione tale da lasciare nel pubblico romano quella profonda
impressione di cui è ancor vivo il ricordo. Così pure indimenticabili, per quanti godettero lo
spettacolo d’arte, le calorosissime dimostrazioni di ammirazione e di simpatia rivolte quella sera a
Riccardo Zandonai e agli altri eccellenti interpreti dell’opera, dal soprano Gilda Dalla Rizza
(Francesca) al tenore Fleta (Paolo), dal baritono Maugeri (Gianciotto) al tenore Palai
(Malatestino). Peraltro, questa della Francesca non è gloria passata ma di sempre, perché tutte le
volte ch’essa riappare sulle scene la sua bellezza si rinnova.
È quindi con l’animo proteso a rigodere le soavi e forti sensazioni che la travolgente passione di
Paolo e Francesca sa destare che ci si appresta a rivivere ancora una volta la dolcezza e le pene
della tragica storia d’amore, la quale, da Dante a D’Annunzio, seppe tener avvinte innumeri anime
al fascino seduttore d’una passione che trasfigura l’umana vicenda.
A questa viva potenza evocatrice è intimamente legata la musica e l’arte di Riccardo Zandonai,
che ai due sommi poeti ispirò il suo estro inventivo, ricreando lo spirito e l’essenza del dramma,
3.2.2/18
che tinse «il mondo di sanguigno», intorno all’episodio storico dell’amore folle e sfortunato dei due
cognati: amore che, traendo origine dall’inganno perpetrato da Messer Guido da Polenta ai danni
della propria figlia, Francesca, d’intesa col feroce Gianciotto Malaspina [sic], rozzo e sciancato,
non tardò a volgere alla sua tragica fine per la furente gelosia d’un triste delatore, il truce
Malatestino dall’Occhio.
È sulla mirabile tragedia dannunziana che il giovane maestro trentino pose il suo accento
inconfondibile.
Era stato, peraltro, il maestro Franchetti ad accostarsi per primo al D’Annunzio, mettendo in
musica una sua tragedia, La figlia di Jorio (Milano, La Scala, 29 marzo 1906), negli anni del più
fervido dannunzianesimo. E più tardi due musicisti, assai diversi per indole e temperamento
musicale, per cultura e tendenze, Pietro Mascagni e Gian Francesco Malipiero, ebbero a musicare
nello stesso anno (1913) due opere del D’Annunzio di ben diversa ispirazione drammatica e
poetica: rispettivamente la Parisina e il Sogno d’un tramonto d’autunno. È infine dell’anno
successivo (Torino, Teatro Regio, 19 gennaio2 1914) l’andata in scena della Francesca da Rimini di
Zandonai, auspice Tito Ricordi, che aveva curato la riduzione per libretto d’opera della tragedia
originale in quattro atti di Gabriele D’Annunzio, i cui lavori teatrali venivano allora richiesti dai
giovani musicisti.
Zandonai appena trentunenne (era nato a Sacco, nel Trentino, il 28 maggio 1883) seppe
dimostrare una preparazione culturale, una sensibilità artistica tali da riuscire a rispettare il clima
poetico dell’“imaginifico”.
Allievo del Mascagni nel Conservatorio di Pesaro, il giovane Zandonai s’era formata una vasta
ed eclettica cultura musicale con lo studio assiduo e col suo grande amore verso Riccardo Strauss e
gli altri musicisti tedeschi che seguivano le orme di Wagner, mentre prestava la più vigile
attenzione anche alla scuola francese con a capo Claude Debussy. Egli poggiava, peraltro, le sue
moderne acquisizioni sulle solide basi fornitegli da un continuo approfondimento dello studio degli
antichi maestri italiani del '500 e del '600.
Da queste premesse chiaro appare come, dopo i suoi primi lavori teatrali, genuina espressione di
realismo (Il grillo del focolare, Torino, 1908) e d’impressionismo, soprattutto pittorico (Conchita,
Milano, 1911) si rendesse agevole all’ancor giovane compositore di raggiungere le più alte vette
della produzione drammatica. Svincolandosi, infatti, sensibilmente dalle tendenze e dalle formule
veriste che aveva seguito – peraltro brillantemente – nella Conchita, il musicista volse la sua
ispirazione fervidissima al teatro dannunziano, che agì in vero da lievito meraviglioso sull’estro del
compositore, con l’offrirgli un’azione costantemente vivificata da figure e situazioni in netto risalto
drammatico e poetico. Un mondo medievale eroico e violento, amoroso e fatale, tale è il clima della
Francesca, che aduna in sé molte possibilità creative, come quella d’una ispirazione semplice e
fresca, voluttuosa e sensuale, lirica e guerriera, poetica e musicale, con un crescendo continuo di
sensazioni e di moti di passione.
Parole e accenti d’una grazia gentile, d’una levità maliosa, si alternano ad episodi e scene d’una
cruda e drammatica azione. Versi e musica si fondono sino a divenire una voce sola, un’unica
espressione sonora, ove il canto palpita alto o sfuma dolcemente nella commozione d’un silenzio
estatico e suggestivo. Così, soavemente, parlano al cuore le voci della Samaritana, la sorella minore
di Francesca, e dell’affettuosa Biancofiore; così echeggiano, vaghe, le voci dei coretti femminili;
così, fieri, risuonano il ghigno di Malatestino e i clamori dei guerrieri durante la battaglia, e più
ancora il belluino urlo di Gianciotto mentre si avventa sugli amanti sorpresi.
Ma non è tutta qui la mirabile bellezza della Francesca. Ad arte piace citare per ultimo i tratti
più belli e più commoventi, più musicali forse di questo singolare poema d’amore e di morte. Così,
nell’atto primo, la “Canzone delle ancelle”, accompagnata dal suono del liuto, e il canto della “viola
pomposa”, che crea l’estatica atmosfera dell’apparizione di Paolo, e la muta suggestiva scena
dell’offerta della vermiglia rosa che Francesca dona al bellissimo Paolo: scena deliziosa con la
quale, alla fine del primo atto, si conchiude armoniosamente – con un commento sinfonico fine e
2
[sic]: ma febbraio.
3.2.2/19
penetrante – il magico incantamento di due anime, il fatale incontro di due giovinezze, subitamente
avvinte dall’amore.
Dello stesso clima passionale, ma potenziato da un soffio lirico interiore di più intensa poesia, è
tutto l’atto terzo, in cui la Francesca da Rimini attinge la sua massima espressione musicale
d’ineffabile bellezza, «una pagina che la storia – afferma il Barblan – ha accolto tra i validi apporti
musicali di questo primo mezzo secolo di teatro». È nel terzo atto, infatti, che culmina il bel poema
amoroso con la toccante scena del bacio, allorquando Francesca baciata sulla bocca da Paolo da lui
si disgiunge, e vacilla, e s’abbandona sui cuscini; e, alla trepida invocazione dell’innamorato:
«Francesca!», ella con voce spenta sussurra: «No, Paolo!».
Nell’alto messaggio d’amore, che quasi redime per la travolgente sua potenza il peccaminoso
connubio, Riccardo Zandonai, musicista, ha trasfuso tutto l’anelito del suo impeto giovanile, del
suo animo di poeta ricco d’un fervore tutto italiano per estro ed espressione. Anche per questo il
giovane interprete dannunziano si identifica col suo sommo ispiratore, il cui verso purissimo egli
adorna della sua più bella veste musicale, onde il senso di calda umanità ch’emana dai «duo che
insieme vanno» si fa dolcissimo e perfetto. Ne scaturisce una commozione che solo può derivare da
un’opera di vera poesia: ed “opera di poesia” è stata infatti definita questa fortunata Francesca:
opera che «al brillante nitore del verso accoppia con naturalezza la pittoresca magìa del suono,
evocando e trasfigurando poeticamente – dice l’Abbiati – i costumi barbari e le passioni violente di
un secolo che usciva con fatica dalla fosca notte medievale».
È così che, in questa passionale fatale vicenda, contro la truce figura di Gianciotto e la perversa
anima di Malatestino, stretti in combutta a compiere la vile nefanda vendetta, stanno l’ardente gesto
amoroso di Paolo e la fragrante, trepida dolcezza di Francesca, quali espressioni di umane creature
che il genio del maestro trentino ha fatto risplendenti e gloriose per sempre con l’atto purificante e
commosso della suggestiva, palpitante sua musica3.
399
Renato Mariani, Felice ambientazione dannunziana, programma di sala per Francesca da Rimini,
Teatro dell’Opera, dicembre 1975
In uno dei Festival internazionali di musica contemporanea che si svolgono annualmente a
Venezia trovò posto una volta un pezzo di Riccardo Zandonai. Mi ricordo la sala della Fenice,
lacerata, nella penombra meridiana alla prova generale, da strisce taglienti di sole. Rivedo, sul
podio, la severa ed autorevole figura di Antonio Guarnieri e, in platea, la sagoma di qualche
assonnato ascoltatore.
Qualcuno, non senza sprezzo ed ironico sarcasmo, sussurrava i versi di Arturo Graf ai quali
s’ispirava – prendendone lo stesso titolo – la breve composizione di Zandonai: «Il flauto notturno»
per flauto e piccola orchestra. (Ci pensate alla poesia di Graf tra le aggressive “novità” del Festival
veneziano del 1932?). La musica di Zandonai procedeva sommessa quando dagli archi si udì
sorgere un motivo, un tema ben profilato che attirò l’attenzione anche dei nolenti. L’autore aveva
utilizzato la calma melodia che spunta, al finale del I atto di Francesca da Rimini, all’incontro dei
protagonisti. E qualcuno fu costretto allora ad ammettere – a bocca amara – che l’indovinata
immediatezza di quel canto prendeva la sua rivincita pur sulla evidente sopportazione di alcuni
ascoltatori.
Ogni qualvolta ascolto questa bella e fervida Francesca da Rimini mi torna in mente la
confessione di quell’ostile ascoltatore veneziano e mi domando – ampliando, naturalmente, i
margini dell’istanza – se la resistenza e la validità dello spartito di Zandonai sussistano ancor oggi,
per la sola presenza di canti immediati ed indovinati. Assentire a questo ipotetico dato positivo è un
troppo modesto riconoscimento dell’operato lirico dell’autore e non significa captarne comunque le
determinanti positive.
3
Il presente articolo di Trifiletti è simile in molte parti a quello pubblicato nel programma di sala del teatro dell'Opera in
occasione delle recite di Francesca da Rimini nel maggio 1960.
3.2.2/20
Francesca da Rimini nasceva, nel 1914, in piena fioritura “veristica”. Tanto è vero che non
mancò qualche critico che indicò come “mascagnana” la fede di Zandonai operista; mentre altri –
con evidente desiderio denigrativo – accusava il pubblico che aveva assentito a Zandonai di
accettare la medesima “pietanza” ammannita da Giordano, quantunque con una salsa più piccante.
Ma cosa restava di una cosiddetta “scuola” e di un comune indirizzo nel mondo di Zandonai?
Tutt’al più le conclusive pugnalate di Gianciotto, prescritte dal poema dannunziano! Sta di fatto che
i canti di Francesca non sorgono da un estro “improvvisativo” del musicista e che i personaggi, sia
pure indirettamente, non vivono nella memoria dell’ascoltatore in virtù di una nuda, ancorché
suadente, individuazione melodica circoscritta.
C’è qualcosa di più. Un di più che dà atto di ben altro impegno e di una statura musicale
ragguardevole per consistenza.
Guardate. La formula di Francesca e la sua meritevole abilità consistono nella centrata ed
integra delineazione di un ambiente. Il musicista ha operato nel vivo del mondo poetico che lo
attraeva senza preoccupazione per i singoli personaggi. E se taluno di questi potrà apparire talvolta,
attraverso le diverse fasi della partitura, leggermente appannato, pure non ne soffre l’ambiente che
mantiene la propria “temperatura" emotiva attraverso il tono intenso di un’evocazione assidua e
corposa. Insomma mi pare che Francesca costituisca uno di quei rari casi di creazione
melodrammatica in cui l’ambiente scenico – o, se preferite, l’istanza poetica – vive in costante
coerenza ed omogeneità con il pregnante e capillare fatto musicale. Constatazione, questa, che non
vuole, né potrebbe, essere elemento di accezione critica in una eventuale graduatoria nei confronti
della storia dell’opera in musica; che non si pone quale dato di fatto per raffronti e giustapposizioni
con saggi operistici di altra mole di autori più dotati. Una verità, soltanto, valevole anche nella
modestia dell’apporto cui si riferisce e che può essere la risultanza, in sede estetica, di un’umile
fiducia di Zandonai: «S’io valgo qualcosa – ebbe a dire molti anni or sono – è nella
strumentazione». Dove la capacità nel calibrare e comporre dimensioni costruttive sonore conta
maggiormente dello stillicidio melodico a favore di questo o di quel personaggio. Capacità
costruttiva in funzione teatrale, naturalmente, tesa cioè all’individuazione di avvenimenti scenici
senza i quali essa si smarrirebbe o non avrebbe senso. Un’indole artistica, dunque, che sonda qua e
là: rigogliosa e fattiva sempre, conseguente e felice quando, come in Francesca o – dopo – in
Giuliano, trovi il suo mondo espressivo rispondente e adeguato. Ecco perché la vicenda medievale
di Francesca lievita tutta, umorosa e morbida, vigile eppur sorvegliata, nella doviziosa partitura di
Zandonai e il linguaggio del musicista affiora a posteriori come congenito alle esigenze poetiche
che lo stimolarono esplicitamente.
Nella storia delle collaborazioni musicali dannunziane colpisce il fatto di un poeta che – cosa
ben rara nell’ambito di una stessa contemporaneità cronologica – abbia saputo sollecitare, come
Gabriele D’Annunzio, l’interessamento di musicisti di orientamenti diversi. Mascagni e Pizzetti,
Montemezzi e Malipiero, Debussy e Franchetti, Puccini, Respighi, Zandonai richiedono a
D’Annunzio l’apporto della sua fantasia poetica ricca e suggestiva.
I rapporti con Zandonai furono spediti e piani. Il compositore aveva parlato del suo desiderio di
musicare Francesca a Tito Ricordi che accettò di ridurre a libretto il dramma. A Parigi, nella prima
settimana del 1913, ebbe luogo, alla presenza di D’Annunzio, la lettura del testo. Si temeva un
verdetto negativo. Il poeta, al contrario, apparve entusiasta del lavoro compiuto da Ricordi tantoché
volle, nel libretto, il nome del riduttore accanto al suo. Ecco Zandonai intensamente all’opera; si
ferma soltanto dinanzi ad alcuni versi del III atto che gli sembrano non musicabili per i troppi
riferimenti a nomi celebri della letteratura. Zandonai chiedeva sostanzialmente la creazione di una
nuova pagina nella tragedia. C’era di che temere le rimostranze di D’Annunzio che invece non
soltanto accettò di scrivere nuovi versi ma – cosa più unica che rara in lui solitamente lento e pigro
– li consegnò al musicista dopo tre ore. Il terzo ed ultimo incontro tra D’Annunzio e Zandonai ebbe
luogo a Parigi, nell’ottobre di quello stesso anno 1913, in casa di Lina Cavalieri. Il compositore
sottoponeva al poeta il dramma musicale del tutto ultimato. Esecuzione pianistica – rapida e
sommaria – alla quale D’Annunzio reagì con piena soddisfazione. Ma quale sia stata la sua
consapevole opinione sulla musica di Francesca non è dato conoscere; oltre lettere e messaggi
occasionali dispersi – insieme col manoscritto dei nuovi versi del III atto – durante l’altra guerra
3.2.2/21
che distrusse la vecchia casa trentina di Zandonai, manca un documento “ufficiale” di D’Annunzio
in proposito. E, per uno strano destino, egli non ebbe mai occasione di assistere ad una recita di
Francesca. Sembra incredibile, ma è così. Tre soltanto furono gli incontri tra il poeta e il musicista.
Poi – dopo un’intesa facile e immediata – il silenzio. Troppo signorilmente semplice ed umile
Zandonai, per accostarsi a chi gloria, fasto ed anche vanità avevano collocato all’apice di una
“posizione” umana esteriormente d’eccezione. Nature opposte, sentimenti diversi, traguardi
antitetici. D’Annunzio e Zandonai non si sono incontrati, non si sono visti mai più.
Come è ben noto, la prima rappresentazione di «Francesca da Rimini» ebbe luogo, a Torino, al
Teatro Regio, il 19 febbraio 1914.
Tra gli interpreti figuravano cantanti allora di alta rinomanza o che tali sarebbero divenuti in
seguito: Linda Canetti [sic], Giulio Crimi, Francesco Cigada, Gabriella Besanzoni, Giuseppe Nessi.
Non tutti ricordano, invece, che protagonista del nuovo spartito di Zandonai avrebbe dovuto
essere il soprano Tarquinia Tarquini, artista a quei tempi e già da alcuni anni molto onorevolmente
ed intelligentemente in carriera. Ma un episodio che ha, al tempo stesso, del misterioso e del
magico costrinse l’interprete ad interrompere per sempre la propria attività, durante una delle ultime
prove dell’opera.
All’inizio della parte seconda del 4° atto, allorché la protagonista intona quel mesto, dolcissimo
canto in cui ricorda la giovane sorella Samaritana («Era dolce la mia sorella, è vero...»), la gola di
Tarquinia Tarquini fu sopraffatta da un improvviso empito emotivo e non resse all’impegno canoro.
Da quel momento finì per sempre, per l’artista, la vita sui palcoscenici. Due anni dopo la cantante
diverrà moglie di Riccardo Zandonai e lo accompagnerà fedelmente fino ai giorni spaventosi della
sua tragica, straziante scomparsa, a Pesaro, il 5 giugno 1944, tra l’infuriare dei bombardamenti e
delle rappresaglie belliche.
Non si diminuisce o altera il valore di «Francesca da Rimini» raccomandando all’ascoltatore
avveduto e provvido soprattutto il I e il III atto nei quali è più facilmente rintracciabile, agli effetti
estetici di una significante “psicologia” musicale, la compiuta espressione di un sentimento
determinante: un’attesa che potremmo qualificare “fatalistica”, già accettata cioè e perfino scontata.
In tal senso il I e il III atto procedono con analogia di carattere espressivo che Zandonai delinea in
modo del tutto suadente. Una attesa che circola nell’aria e che avviluppa personaggi e fatti pur
differenziandoli pateticamente. Nel II e nel IV atto, invece, la risoluzione dell’attesa non trova
sempre un equivalente espressivo ugualmente acuto e la valevole bellezza di alcune pagine è più
circoscritta a “motivi” contingenti anziché, come altrove, alla calda e integra partecipazione
scenica.
Pertanto, lasciando l’ascoltatore in piena libertà di apprezzamento da un punto di vista di
personale appagamento estetico, ci limitiamo a porre stringatamente in rilievo i momenti costitutivi
agli effetti di un’accezione valevole e durevole dell’opera. E avvertiamo, innanzi tutto, che la
questione del “leit-motiv” – più o meno inflessibilmente interpretata – conta, in Francesca, assai
approssimativamente nel senso, cioè, che non deve servire da vincolo all’ascoltatore – come non lo
fu per il musicista – ma tutt’al più come riferimento emotivo, come intimo “ripensamento”
dell’anima; in un proposito e in una intenzione, dunque, riluttanti alla disciplina di un ricorso
puntuale ancorché sensibili alla suggestione di un’analogia psicologica patetica.
Atto I: ambiente fastoso determinato dalle ancelle e dal giullare che intona, con mutevole
carattere, i suoi racconti fino al mesto avvio «Or venuta che fue» utilizzato poi quale cellula
tematica fondamentale. Scena di Ostasio e di Ser Toldo, musicalmente trascurabile. Canto
femminile: una delle pagine più soavi dell’opera. Risucchi dell’orchestra interna sulle scalfitture dei
legni. Una nenia veramente «acerba e dogliosa» – come dicono le parole del testo – che si sviluppa
con acre senso d’insoddisfazione. Avanza Francesca. Le sue prime parole sono fondamentali
musicalmente in tutta l’opera. Frasi bellissime che la donna dice a se stessa ma che l’ascoltatore
deve ritenere poiché misurano compiutamente la psicologia della protagonista («come l’acqua
corrente...») fino al dialogo con Samaritana pieno di trepidi tumulti e di malcelati timori: una
pagina squisita (si noti il largo cantabile «E si morrà, oimè...») che rivela in pieno la profonda
ispirazione di Zandonai. Ma la tensione scenica in questo I atto non ha rallentamenti o vuoti. Ecco
l’orgasmo strumentale ripercuotersi nelle esclamazioni delle ancelle che hanno veduto Paolo, lo
3.2.2/22
smarrimento di Francesca sentito dai violoncelli e dai clarinetti fino alla movenza «Portami nella
stanza». Poi, all’arrivo di Paolo, la gioiosa concitazione si placa sul largo calmissimo dove spunta
l’indovinata figurazione della viola pomposa e del piffero che sottolineano l’incontro dei
protagonisti. Ma è breve sosta; ché i felici motivi si propagano gradualmente in orchestra, con un
prorompente vigore che già è smarrimento e sfrenata esaltazione.
Atto II: la battaglia viene raffigurata con un disegno caratteristico che accenna implicitamente
anche al personaggio di Gianciotto. Il dialogo tra Francesca e Paolo prende corpo all’avvio
«Donarmi un bello elmetto», poi allo slancio della frase «ma sol vidi una rosa» e si prolunga con
efficaci contrasti tra gli episodi scenici della battaglia e col canto «Questo cimento è il giudizio». Il
disagio provocato dal giungere di Gianciotto si riflette nei ruvidi elementi sonori degli archi per
attutirsi all’episodio del vino dove va notata la frase «Bevete, mio cognato...». Gli arcieri portano
Malatestino ferito e l’orchestra misura l’avvenimento con una complessa giustapposizione fino al
rapido frammento corale «Viva la parte Guelfa».
Atto III: un’introduzione strumentale immette nell’inquieta atmosfera della stanza di Francesca.
La donna è china sul libro di Lancillotto e la lettura, velata nel fraseggio da una pàtina di opaca
malinconia, viene cadenzata dal bàttito dei violoncelli. Interloquiscono le ancelle: l’ansiosa attesa di
Francesca è elusa per poco; la scena – tutta sostenuta da un’invenzione adeguata al sotteso
struggimento della protagonista – sfocia nella canzone «Marzo è andato» [!] che dà colore alla
situazione. Il duetto tra Paolo e Francesca è episodio di ragguardevole significato musicale. L’avvio
sosta in pretesti espressivi che raffigurano magistralmente lo stato psichico dei personaggi.
Potrebbe essere numerosa l’esemplificazione. Ecco il movimento «Benvenuto, signore mio
cognato», la calda evocazione «Inghirlandata di violette», la bella frase «Nemica ebbi la luce», la
trepida sensazione degli archi alle parole «Ahi, che già sento». Poi – alla ripresa della lettura – le
risorse melodiche aumentano d’intensità, con notazioni soavi e dolenti («Guardate il mare come si
fa bianco»), con incisive figurazioni che prorompono nelle parole «E la reina vede il cavaliere» e
che conducono alla perorazione conclusiva sentita con rigogliosa e tenera esposizione dei centri
tematici determinanti.
Atto IV - Quadro I: il musicista affronta i personaggi di Gianciotto e di Malatestino ai fini della
tragedia ma fin qui elusi dalla stesura librettistica. La concitazione vive nel fratturato dialogo tra
Francesca e Malatestino e nella torva ripercussione delle urla del prigioniero. L’ambiente
minaccioso e stranito non ha compimento neppure nel colloquio tra Francesca e Gianciotto. Poi la
scena tra i due fratelli, una delle più note dello spartito, porta l’avvio di Malatestino «Non ti
crucciare meco», inquadrata in una pagina strumentalmente magistrale; l’accenno «E se il fratello
vede» prende rilievo dal sussulto represso dei clarinetti e del fagotto; infine la situazione trae vigore
dal motivo «Malatestino castigo d’inferno» con subitanei contrasti.
Quadro II: un senso di pena pesa sul tumultuoso sonno di Francesca; si stempera e si scolora poi
l’inquietudine nella vaga espressione «O Biancofiore, piccola tu sei» e nel caro ricordo di
Samaritana. La scena tra Paolo e Francesca avvampa di un calore fatalistico che non vuole più
ritegno e che determina in precise figurazioni vocali consenzienti all’ambiente strumentale.
Numerosi sono i nuclei tematici rimarcabili; ecco la frase «Non fu mai tanto folle» assopita nel
languente accenno «Un sonno duro» e poi nella trasfigurata evocazione «E non è l’alba», trapuntata
dai violini e appoggiata sull’arpa, cui subentra l’appassionata dichiarazione di Paolo «Ti trarrò».
L’azione precipita. Terzine dei contrabbassi annunziano l’arrivo di Gianciotto e sul faticoso
disegno strumentale cadono trafitti i due amanti.
3.2.2/23
La via della finestra
400
Andrea D’Angeli, La Via della Finestra di Riccardo Zandonai, «Musica» XIII/14-15, 15
settembre-1 ottobre 1919 - p. 2,; col. 2-3
Quando ebbi tra mano lo spartito de La Via della Finestra di Riccardo Zandonai e vi lessi la
dedica alla memoria di Candida Kalchsmidt, cioè della Donna gentile che plasmò l’anima del
giovane musicista, allora almeno, del liceo Rossini, intuii, anche senza averne letta la musica, che la
nuova opera si doveva riannodare al tipo del Grillo del focolare di cui la eletta Signora era
religiosamente appassionata4. E infatti è così, per tutto quel complesso di elementi comici o meglio
umoristici, che nel Grillo sono per ragione del libretto più abbondanti, ma che non mancano nella
Conchita, in Melenis e neppure nella Francesca. Chi conosce bene la produzione operistica dello
Zandonai non può che darmi ragione. È una speciale tendenza della visione musicale di questo
eletto artista che si adagia volentieri nel lirico sentimentale e nel comico umoristico, perché egli
sente che tra questi due poli in via ordinaria è contenuto il mondo della vita e che il drammatico
esasperante non è che fenomeno di eccezione.
Per questa ragione Zandonai ha scelto da musicare il soggetto del vaudeville di Scribe «La
femme qui se jette par la fenêtre» intendendo di scrivere una commedia lirica: giocosa veramente
no, come si legge nel libretto; questo epiteto preoccupa un poco e non giova alla comprensione
dello spirito dell’opera. I maggiori critici dei giornali politici hanno riveduto le buccie al lavoro
dell’Adami; ma degli appunti fatti, mentre alcuni sono giusti, altri non posano sul vero perché non è
esatto il punto di vista del giudizio estetico.
La Via della Finestra è una deliziosa opera lirica, adornata di tutte le grazie della forma e del
sentimento, lumeggiata da preziosi tocchi di colore istrumentale, con alcuni spunti comici
felicemente riusciti, con tre finali d’atto pieni di poesia e di suggestione. Questi, secondo noi, i titoli
di merito del nuovo spartito zandonaiano e le ragioni di un successo, ben delineato e sicuro già
nella prima rappresentazione e che andò crescendo di calore ad ogni rappresentazione; a mano a
mano, cioè, che il pubblico comprese e penetrò la raffinata trama melodica con cui è espressa la
sentimentalità delle figure nelle varie situazioni sceniche.
Si colloca in un punto falso di giudizio chi, per classificare questo lavoro, si riferisce ad un tipo
di commedia musicale come il Matrimonio Segreto del Cimarosa, che si allarga nella concezione
filosofica del Falstaff; o a un tipo di opera buffa che dalle farse napoletane assurge alla ricchezza
rothscildiana dello spirito del Barbiere; o al tipo pseudo-settecentesco delle Donne Curiose o de I
Quattro Rusteghi del Wolf-Ferrari, vere commedie ma inutili, per quanto ingegnosi, rifacimenti
musicali; e neppure è giusto pensare al pucciniano Gianni Schicchi, che a chi guarda bene rivela i
suoi caratteri di una ben riuscita farsa aristocratica. Se mai, come concezione d’opera scherzosa, La
Via della Finestra si avvicina di più a qualche tipo d’opera donizettiana per quel sovrabbondare di
elementi sentimentali che ne è la principale caratteristica; ma è inutile aggiungere che gli elementi
musicali sono troppo diversi.
Resta dunque di considerare La Via della Finestra come presumiamo fossero le intenzioni
dell’Autore: cioè una nuova forma di commedia musicale che ride o sorride, sospira o piange a
seconda delle necessità sceniche, senza la preoccupazione, che le toglierebbe la sincerità, di essere
piuttosto un tipo che un altro d’opera comica.
Così preparato, lo spettatore può seguire senza le consuete pregiudiziali critiche lo svolgimento
dell’opera e, dopo avere assistito al pandemonio della prima baruffa in famiglia, ammirare la gaia
entrata della servetta (Giovanna) e i sospirosi rimpianti dello sposo (Renato) e il poetico stornello
popolare che viene di lontano (ammonitore di ciò che sarà il trucco della commedia) e i
commoventi ricordi lirici delle dolcezze familiari in cui abbastanza largamente si espande l’anima
di Renato e la caricatura musicale della suocera caparbia (la Marchesa) e la scena delle tre donne –
4
«Nonna» era l'affettuoso appellativo con cui Zandonai amava rivolgersi a Candida Kalchsmidt, la signora che con il marito
Ernesto aveva accolto a pigione il giovane musicista fin dai suoi primi passi pesaresi.
3.2.2/24
questa sì veramente giocata con arte cimarosiana – e il ritorno corale dello stornello sopra un
magnifico tessuto istrumentale e il nuovo colpo scenico della sposa (Gabriella) con la minaccia
tragica del suicidio e quindi il frammento dello stornello ripetuto dal cantore lontano, mentre si
odono i rintocchi di una campana, per blandire l’anima dell’ascoltatore e portarlo in un delizioso
ambiente di poesia.
Come si vede, è tutto un avvicendarsi di momenti psichici che variano nelle gradazioni del
sentimento lirico, passando qua e là per il comico caricaturale e l’umoristico. Altrettanto potrebbe
dirsi per il secondo atto dove, accanto ad elementi decorativi e abilmente incastonati come il
trescone e la caccia, si apre una soave oasi lirica, preparata dalle più suggestive tinte istrumentali,
perché Gabriella, uscita così stranamente dalla casa maritale, effonde la sua malinconia fatta di
rimpianti e di rimorsi; dove emerge la signorile finezza del Marchese zio, che domina nel quartetto
e nel significante duetto con Gabriella. La rivelazione dell’inganno pensato dalla sposa «La via di
quella finestra m’apparve sicura» e la frase della servetta Giovanna nel terzo atto «in paradiso si va
con le scale» sono i getti limpidissimi di una gaiezza sincera che oggi sono piuttosto rari. Anzi, dal
momento in cui, a metà del terzo atto, Gabriella e Giovanna appaiono sorreggendo a gran fatica la
scala e credono di essere sole mentre sono spiate da Renato e dal Marchese zio, l’opera assume un
tale carattere di rispondenza fra la situazione scenica e la musica da avvincere a sé strettamente
l’anima dell’ascoltatore e da procurare al Maestro la forma più bella e più completa del successo.
L’inno alla notte del cantore popolare, mentre i due sposi riconciliati si avanzano sul balcone per
riprendere finalmente l’inno interrotto del loro amore beato e la prima luna li avvolge come una
carezza d’incanto, era ed è infatti riuscito il mezzo più geniale per conseguire la vittoria.
L’esecuzione deve giudicarsi ottima da parte di tutti: si ammira nella Caracciolo (Gabriella) la
grazia del canto e dell’azione nutrita di vivissimo sentimento artistico; nel Ciniselli (Renato) la
simpatica spontaneità dell’interpretazione e il calore vocale; nella Casazza (la Marchesa) la
padronanza assoluta di una parte vocalmente e scenicamente difficoltosa; nel Baldini [sic]
(Marchese zio) una insuperabile signorilità di accento, di gesto, di gioco scenico: nella Avezza
(Giovanna) una mirabile briosità di spirito congiunta alla bontà dei mezzi vocali. Né minore
importanza ebbero per la riuscita dell’opera le buone voci del Cilla (lo stornellatore) e del Beracchi
(il falciatore).
L’orchestra, in cui le prime parti sono sostenute da artisti di eccezionale valore, con la precisione
dei dettagli e la fusione dell’insieme dà al maestro Edoardo Vitale, che dirige l’opera con fraterno
impegno, le più alte soddisfazioni: l’intermezzo infatti viene bissato, e il Vitale, insieme con quel
mago del coro che è il Veneziani, viene ad ogni atto chiamato all’onore della ribalta.
Riccardo Zandonai è sempre festeggiatissimo: come nella prima sera, che ebbe veramente tutta
l’entusiastica solennità di un trionfo, anche nelle altre il pubblico gli vuol dimostrare la sua simpatia
e la sua ammirazione col più caldo augurio di nuove vittorie e di nuovi successi.
–––––
Andrea D’Angeli riferisce all’indomani della prima rappresentazione avvenuta a Pesaro nel luglio
scorso. L’opera di Zandonai, ugualmente diretta dal maestro Vitale, è stata giorni [or] sono
ripetuta, e con gran successo, a Lugo di Romagna.
401
Giorgio Barini, “La Via della finestra” - commedia giocosa di G. Adami e Riccardo Zandonai,
«Nuova antologia», 16.9.1919 - pp. 223-6
Il 19 aprile 1847 fu rappresentata a Parigi sulle scene del teatro del Gymnase dramatique una
commedia-vaudeville in un atto di Eugenio Scribe, con la collaborazione di Gustavo Lemoine: da
tempo il fecondissimo scrittore aveva superato il periodo delle farse vivaci, di cui il nostro pubblico
ben conosce la più viva e spassosa, L’ours et le pacha, nella fedele traduzione meneghina di E.
Giraud, I due orsi; quello dei “vaudevilles” brillanti, tra cui non può dimenticarsi la irresistibile
comicità del Diplomate; aveva già prodotto molte delle più organiche sue commedie, come
Bertrand et Raton, La camaraderie, La calomnie, Le verre d’eau, Une chaîne, che dovevano esser
3.2.2/25
seguite da altre di uguale e anche maggior forza organica, come Adrienne Lécouvreur, Les contes
de la reine de Navarre, Bataille de dames. La commedia-vaudeville del 1847, Une femme qui se
jette par la fenêtre, possiede le caratteristiche migliori dell’arte dello Scribe nel periodo della
maturità, nel quale fu concepita e scritta: azione svolta con abilità grande; figurine disegnate con
spirito a malgrado della loro superficialità alquanto manierata; dialogo scorrevole e piacevole, con
qualche lieve tocco sentimentale: brillante e, se non molto arguto, di buona comicità.
Un giovane sposo (uno di quei tipi anodini di primo amoroso che lo Scribe si compiace fare
oggetto delle più vive passioni femminili) rivela allo zio, allora giunto, come dopo un primo
incantevole periodo di luna di miele le relazioni con sua moglie Gabriella siansi turbate da che
giunse in sua casa la marchesa suocera, e inacerbite fino al punto che, dopo una scena di gelosia per
un invito ad un ballo in una villa vicina, la sposina si gettò dalla finestra: fortunatamente v’era
sotto, dalla vigilia, un gran mucchio di fieno, sul quale essa cadde senza farsi nessun male. La
suocera condusse la figlia seco al vicino castello, ed egli è da un mese solo, non essendo riuscito a
riveder più Gabriella: innamoratissimo, ha scritto alla moglie per chieder pace. Ed ecco Giovanna,
la fattoressa, con la risposta... della suocera: vada al castello a chiedere scusa alla moglie, alla
presenza della madre e, forse, potrà esser perdonato.
Lo zio chiede pieni poteri per ricondurre Gabriella al marito, dolce e sottomessa; e comincia con
esortare Giovanna a preparar subito, per festeggiare il compleanno del suo matrimonio, il pranzo e
il ballo che erano stati sospesi per riguardo alla malinconia dello sposo; e questi è indotto dallo zio
ad accettare un invito alla caccia della signora della villa vicina, ed a prender parte alla rustica festa
della fattoressa. Giunge Gabriella con la madre, che è presa da collera violenta nel sorprendere il
genero che danza gaiamente con Giovanna; questa dà a Gabriella una pratica lezione di politica
coniugale: esser sempre sottomessa ed obbediente al marito, facendo però in modo che questi ordini
sempre e soltanto quel che piace alla moglie. Gabriella, innamorata del marito cui vorrebbe riunirsi,
rivela alla madre che, allorquando si gettò dalla finestra, sapeva benissimo esservi sotto il fieno
salvatore: il dubbio già sollevato dallo zio divien certezza; e lo sposo, che ha udito, firmerà
senz’altro l’ultimatum già preparato dallo zio medesimo, da prima risolutamente respinto. Ed ecco
lo zio, il quale, mostrandosi indignato dell’enormità di tale ultimatum, si induce a darne
comunicazione: Gabriella sarà accolta con gioia ed amore nella casa del marito purché, uscitane
dalla finestra, dalla finestra vi rientri.
La suocera va su tutte le furie; lo zio si diverte ad eccitarla ancor più, ed essa parte inferocita. Il
marito teme di avere ecceduto: ma ecco Gabriella che torna, mentre cala la notte, con Giovanna:
esse trascinano una lunga scala e Giovanna l’alza ed appoggia al balcone. Gabriella esita alquanto,
nel timore di cadere: ma spinta dall’amore, riesce ad arrampicarsi su per i pioli ed a scavalcare il
davanzale; il marito, a stento trattenuto dallo zio, ha la consolazione di udire le proteste affettuose
della moglie pentita e sottomessa; e la suocera, accorsa alla notizia maliziosamente comunicatale
trovarsi una giovane signora nella camera del genero, assiste confusa, coi testimoni da lei stessa
condotti, alla propria sconfitta, al trionfo dell’amor coniugale.
Per ricavare tre atti da quest’atto unico che, sebbene un po’ denso, ha uno svolgimento completo
ed esauriente, Giuseppe Adami ha da prima sceneggiato la parte narrata dal marito allo zio, fino al
momento in cui Gabriella, visto che il marito non intende rinunziare alla festa da ballo, si getta dal
balcone. Naturalmente, al principio del secondo atto, tutto questo è di nuovo raccontato allo zio:
l’episodio festoso in onore di Giovanna è svolto largamente in scena, e Renato, il marito, si
diffonde in lunghe chiacchiere svenevoli alle ragazze intervenute; in fine, è inscenato anche
l’episodio della caccia: Renato si unisce al gruppo dei cacciatori con cui si allontana, e le cose
restano ancora al punto medesimo del primo atto. Nel terzo si riprendono le trattative; vien fuori
l’ultimatum di Renato (il quale non ha udito la confessione di Gabriella circa il famoso fieno) e
l’azione seguita a svolgersi come nella commedia.
Alle ripetizioni imposte da siffatta elaborazione, debbonsene aggiungere altre ancor più sensibili:
ad esempio, Renato confida i suoi dispiaceri da prima alla cameriera (che li conosce benissimo),
poi, rimasto solo, li ripete al pubblico, poi li riconfida allo zio, e ci ripensa ancora ogni tanto; le
scenate della suocera si riproducono in forme sempre identiche; Gabriella ripete anch’essa senza
economia i suoi timori e le sue delusioni. Né è meno sensibile l’intento riempitivo dei canti e degli
3.2.2/26
stornelli contadineschi che intervengono ogni tanto addossandosi all’azione scenica, e della
aggiunzione e dilatazione di episodi di colore, come il ballo e la partenza per la caccia: ne risulta
una sensazione di stentatezza e di inconsistenza scenica, non abbastanza celate da artificiosità
alquanto ingenua. Aggiungasi il carattere ibrido assunto dal soggetto in questa rielaborazione, che
giunge, alla fine del primo atto, ad una parvenza quasi tragica, perché né il marito, né la madre, né
la cameriera cedono al naturale istinto di cercare di trattenere la suicida, o almeno di correre al
balcone da cui si è gettata Gabriella per vedere che ne sia successo; bensì, dopo grida e improperi,
escono di corsa, restando pertanto viva negli spettatori la impressione dell’atto violento, che ha
l’apparenza di esser compiuto sul serio; ed ha frequente intonazione malinconica per le insistenti
lamentazioni di Renato, cui fanno eco i rimpianti di Gabriella.
Riccardo Zandonai (che è assai fedele interprete dei suoi librettisti), nel dar veste sonora allo
schema offertogli dall’Adami, ne ha ben sentito, oltre i pregi, anche i difetti: ma il suo forte e sano
temperamento d’artista gli ha permesso di sollevare la tenue trama, anche dove è più logora e
sdrucita, e afforzarla e riplasmarla in una organica manifestazione di vita musicale agile e animosa.
Nell’udire le pagine scorrevoli e fresche del nuovo spartito, mi tornavano limpide alla mente le
sensazioni provate nel 1908, quando Il grillo del focolare, il primo spartito dello Zandonai, fu la
prima volta eseguito a Torino, inaugurandosi il Politeama Chiarella. Se, dopo quella lieta
affermazione artistica, il maestro trentino seguì altra via nella creazione musicale, scegliendo
soggetti profondamente drammatici quali Conchita, Melenis, Francesca da Rimini, non per questo
egli aveva rinunziato alla forma intimamente e sovranamente italiana della commedia musicale: la
visione che allora gli aveva sorriso balenava sempre ai suoi occhi, e La via della finestra, frutto
succoso della maturità del suo ingegno, risponde pienamente al primo fiore profumato della sua
giovanile fantasia. Intimo e forte è il legame tra i due spartiti, non soltanto per l’equilibrato
alternarsi delle espressioni liete con le sentimentali, ma anche per l’orientamento del pensiero e
perfino (tenuto conto del mirabile continuo perfezionarsi della perizia tecnica del maestro) nelle
modalità formali della scrittura musicale dello Zandonai.
La vena melodica, limpida e gustosa, se non abbondantissima; l’armonizzazione sapiente e
significativa; la strumentazione ricca, colorita, multiforme già affermavansi nelle pagine del primo
lavoro: e in quello già ebbi a rilevare una caratteristica elaborazione che vale a conferire a molte
pagine dello spartito salda organicità. Come per Il grillo del focolare, così assistendo alla
rappresentazione de La via della finestra lo spettatore, mentre segue con diletto la vaga snodatura
del dialogo musicale svolgentesi con una stupenda varietà di espressioni che incarnano le idee e
lumeggiano le parole man mano che si alternano e si seguono, in pari tempo sente che in tutta la
scena è mantenuta assoluta e salda unità e gli elementi ond’è costituita vi sono disposti e fissati
come le numerose figure di un ampio e armonioso bassorilievo marmoreo.
Ciò dipende dal fatto che lo Zandonai, colto il significato e il sapore dell’episodio, lo sviluppa
naturalmente come in un tempo di classica composizione ciclica, che forma sicura base e bella
cornice al brano di vita che vi si dispone in ammirabile ordine, movendosi però con magnifica
spigliatezza: l’agile penna del musicista segna rapidamente sulla trama così ben disposta i nitidi
tratti in cui si individuano i pensieri e le figure, risolvendo plasticamente e coloristicamente il
difficile problema della perfetta coincidenza di elementi diversi ed anche tra loro antitetici, in un sol
blocco senza crepe o scheggiature. basti ricordare, fra altri esempi non rari, il terzettino delle donne
nel primo atto de La via della finestra, eloquente saggio di siffatta forma musicale.
Come già ho accennato, lo Zandonai ha subìto anche i difetti del libretto: le ripetizioni di identici
concetti e fatti, anche se con diverse espressioni e vocabili, importano fatali uguaglianze di colori e
sensazioni musicali; gli episodi-riempitura, se non animati da qualche intimo significato, si
risolvono in lungaggini inutili, con innegabile danno della economia dello spartito. Per tali ragioni
tutta la parte del tenore assume unità di colore, con insistente tendenza al grigio-malinconico, tale
da generare un senso di monotonia; le smancerie non sincere di lui con le forosette sono, anche
musicalmente, fredde e non spontanee: d’altra parte il trescone e la scena della caccia, di un
contenuto schiettamente musicale, sono pagine tutte freschezza e animazione prodigiosa, anche se il
3.2.2/27
tema della fanfaretta di caccia, nella sua brillante vivezza, non possa dirsi esente da banalità: e gli
agresti stornelli contadineschi sono tra i più puri e delicati gioielli dell’opera.
A tutto sovrasta la sincerità giovanilmente ardente del musicista, che sa interessarci anche con
linee melodiche e spunti ritmici non sempre di largo respiro o di originale aspetto: la sua ingegnosa
e saporosa armonizzazione (che nella cruda uniformità della sonorità pianistica può sembrare
insistentemente ricercata) nella espressione orchestrale, così stupendamente flessibile, ricca e varia,
si rivela di superba spontaneità, sto per dire di assoluta necessità. Se Riccardo Zandonai porrà
animosamente le forbici nel suo nuovo lavoro, eliminandone le superfetazioni sceniche da cui
derivano le divagazioni musicali non necessarie, egli ci offrirà un tipo di commedia lirica che,
rannodandosi idealmente ad una delle tendenze più sinceramente italiche dell’arte musicale che
raggiunse in altri tempi i più lieti e meritati trionfi, se ne stacca nettamente nei modi e nei mezzi di
attuazione: sana gaiezza nostrana, rifiorente da un cuor giovane in una visione e in una forma
d’espressione di non meno sana modernità.
La Via della finestra, eseguita la prima volta il 27 luglio 19175 al teatro Rossini di Pesaro per
iniziativa degli Amici della Musica, presieduti dal cav. Maccagno, ebbe accoglienze trionfalmente
festose. All’esito bene contribuì una esecuzione mirabile per virtù di artisti scelti con la massima
cura e che parevan creati apposta per assumere le rispettive parti; erano Juanita Caracciolo
“Gabriella”, Elvira Casazza “Marchesa madre”, Maria Avezza “Giovanna”, Ferdinando Ciniselli
“Renato”, Ernesto Baldini [sic] “Marchese zio”, Luigi Cilla “Stornellatore”; concertò e diresse
l’opera Edoardo Vitale; istruì i cori Vittore Veneziani.
402
Domenico Alaleona, “La Via della finestra” di Riccardo Zandonai, [testata non identificata]
Assistei il 27 luglio in Pesaro alla “prima” della Via della finestra di Riccardo Zandonai. Non
enuncio questa data semplicemente pel gusto di riempire due righe: ma perché l’elemento di luogo
in essa contenuto ha il suo valore in relazione alla manifestazione d’arte.
Oggi si è perduto il senso di quello che è il pubblico e l’ambiente in una rappresentazione
teatrale. È invalsa l’idea che la “rappresentazione teatrale” abbia i suoi confini netti e crudi e
assoluti in fondo con la carta della scena, di qua e di là con le quinte e coi parapetti, dinanzi con
quel velo d’aria che corrisponde (quando è chiuso) al... sipario. Il pubblico e il rimanente del teatro
vien considerato come qualcosa di affatto estraneo, e che non abbia nessuna relazione se non di
vicinanza materiale e di coordinazione ottica e di diffidente curiosità col parallelepipedo aereo
limitato dai piani cui sopra ho accennato; qualcosa di simile (mi si perdoni il bizzarro paragone che
mi salta in mente) come il pubblico che sta visitando un giardino zoologico non ha niente a che fare
con... le belve rinchiuse dentro le gabbie.
Non occorre che m’indugi a dimostrare quanto tal modo di vedere (che oggi è così radicato da
sembrare naturalissimo) sia falso, e di quale profonda odierna decadenza del teatro sia indizio. E
non occorre ricordi quale senso di questa inscindibile unità spirituale fra spettacolo, pubblico e
ambiente (la disposizione materiale stessa del loro teatro sta a dimostrarlo) avevano i greci, pei
quali la rappresentazione era come un rito; e che le sacre rappresentazioni erano eseguite dinanzi
alle chiese; e che le pastorali ebbero la loro prima sede in mezzo ai campi, fra le divinità silvestri e
boschereccie...
Intendiamoci bene. Nessuno più di me, accanto a questo ideale altissimo e purissimo di arte, ha
senso pratico e coscienza delle crude necessità presenti. Oggi la facilità e vertiginosa rapidità delle
comunicazioni e degli scambi, la artificiosità della vita cittadina, e un certo modo di vedere fra
commerciale e voluttuario e giocattolesco intorno all’arte hanno creato un tale stato di cose per cui
sarebbe assurdo pretendere costantemente la realizzazione di certi ideali. Ed oggi può accader
benissimo di veder eseguire una sacra rappresentazione in una casa da the, o una pastorale nel più
5
[sic]: ma 1919.
3.2.2/28
folto dei grattacieli di New York o su un transatlantico in mezzo al Pacifico; o di trovare autori
italiani che (senza alcuna ripugnanza) scrivano, di maniera e su dati accattati nei libri, opere
giapponesi, e un pubblico italiano che (senza alcuna ripugnanza) le ascolti. Ma non sarebbe male
almeno nella prima rappresentazione, che costituisce la vera “creazione” di un’opera, tener presenti
gli elementi di cui sto parlando. E non è male anche, in mezzo a tanta materialità, a tanta
superficialità ed esteriorità odierna, volgere di tanto in tanto gli occhi a certe vette ideali se non
altro per tenere esercitati gli occhi a certe distanze.
Che cosa c’entra tutto questo con La via della finestra di Zandonai?
Ecco. Sarebbe sciocco chi intendesse lontanamente che quanto io sto dicendo abbia influito a
determinare il successo, che nessun pubblico o ambiente riesce a creare quando l’opera non ha le
qualità intrinseche necessarie. Ma dopo che io avrò spiegato al lettore quali sono le intime qualità
per cui il nuovo lavoro di Zandonai vive come opera d’arte, egli si convincerà che qui si è verificato
proprio il caso in cui la “prima” di un’opera avvenga spiritualmente e poeticamente nel “suo
ambiente”.
La via della finestra è un poema campestre, in cui s’odono risonare, per quelle trasparenti e
serene lontananze che chi non le conosce non sa, i canti marchigiani in cui s’intrecciano danze
rustiche, in cui vibra l’atmosfera mite e luminosa delle campagne in mezzo alle quali Zandonai
dimora e lavora, in cui squillano appelli e gridi gioiosi di quelle feste villerecce e di quelle caccie
che nella nostra poesia e nella nostra musica e nel nostro teatro dei tempi aurei hanno tanta parte.
Ora io debbo confessare che ha contribuito a darmi il godimento totale nell’ascoltare a Pesaro la
nuova opera di Zandonai il trovarmi proprio in mezzo a quei campi la cui atmosfera egli ha fatto
vibrare nel suo lavoro, in mezzo a quell’«odor di fieno» ch’egli canta, in mezzo a quelle visioni di
verde, di fiori, di stoppie che della sua commedia formano lo sfondo.
E, dico la verità, nella chiusa dell’opera, quando, caduta la sera, la visione di verde si fa cupa e
par di sentire i brividi di freddo della notte che si avvicina e Gabriella e Renato sul balcone al mite
chiarore di luna tessono il loro idillio e s’ode a distanza la voce del “Falciatore” che canta l’elogio
della notte e della primavera:
Notte di primavera,
che respiri sommessa
sulla nuova dolcezza...
io ebbi l’illusione che il teatro fosse senza fondo e che il palcoscenico si prolungasse realmente per
le campagne pesaresi; e mi parve di sentire realmente il bisbigliar di foglie e lo zirlio dei grilli; e di
vedere lo scorrere dei ruscelli; e di provare il senso di freddo della bruma notturna... Non è questa
la visione, amico Zandonai, cui hai voluto dar vita? E quale prova più sicura che ci sei riuscito?
(Giorni fa passeggiando pel Corso con un mio amico spirituale ricordavamo i mesi dell’estate
trascorsi in mezzo alle campagne marchigiane: e rievocavamo quelle lontananze serene e
trasparenti, quelle distese immense dagli Appennini al mare colorate di verde e di turchino dai mille
toni e dalle soavissime sfumature che devono aver suggerito a Leopardi L’infinito; ricordavamo di
esserci talvolta quasi immedesimati con quel mondo di alberi e di erbe e di aver provato quasi la
sensazione di ascoltare i moti vegetativi di quelle creature verdi cui ci sembrava non mancassero,
per essere umane, che le facoltà di muoversi e di parlare; di esserci fermati, specialmente sul cader
della sera e alla sommità del nostro paese, a raccogliere con l’orecchio e con l’animo le voci infinite
di animali, di foglie, di uomini, di campane che salivano a noi, vicine, lontane e lontanissime, voci
che non può assolutamente immaginare chi non le conosce; di avere un giorno osservato insieme
per una strada, in una delle connessure della selciatura, un nido di formiche: erano agitatissime, in
rivoluzione, in subbuglio; chi sa che diavoleria era successa in quel mondi piccolissimo e
immenso... E confrontavamo tutto questo con i muri dei palazzi che avevamo dattorno, che ci
impedivano di vedere quasi totalmente il cielo; col lastricato su cui camminavamo, più arido dei
terreni su cui gli antichi spargevano il sale per condannarli alla assoluta sterilità: non sono mica
pazze le formiche a mettervi il piede!... Oh, anche la città ha la sua poesia, la sua nuova poesia,
completamente diversa!... Chi è nato e cresciuto nella campagna è capace di sentirla anche, la
3.2.2/29
poesia della città. Non viceversa, credo, chi è nato e cresciuto nella grande città è capace di sentire
e penetrare pienamente la poesia della campagna!)
Ed ora io dovrei fare la critica della nuova opera di Zandonai. Per lo sciopero tipografico, giungo
un po’ tardi e dopo che tanti ne hanno parlato. Comunque, incomincio.
La via della finestra è scritta benissimo per le voci. È bene armonizzata. È per una piccola
orchestra. È ben istrumentata. Vi sono dei buoni impasti. Vi è largo uso, secondo l’abitudine di
Zandonai, di successioni di tritono, che è quanto dire, per analogia colla pittura, di accoppiamenti
complementari di colori. Vi sono adoperati molti accordi trifonici. Ed esafonici. E poniamo anche il
caso che vi fossero adoperati strumenti che dessero suoni fuor delle consuete intonazioni...
Tutto questo dal punto di vista della valutazione dell’opera d’arte non ha nessuna importanza.
Poiché non c’è alcun nesso necessario fra tutte queste egregie cose e le qualità intime, effettive per
cui un lavoro musicale (e nelle altre arti il fatto è identico) cessa di essere bruta materia e diventa
opera d’arte, realtà vivente. Un lavoro può essere bene armonizzato, bene strumentato, eccetera,
eccetera, ed essere zero meno zero come opera d’arte. Non che debba essere per forza zero meno
zero; può essere anche un capolavoro. Ma tanto se vale zero meno zero come se è un capolavoro
ciò non è perché esso presenti i dati di fatto sopra elencati. E allora a quale scopo parlarne quando
si tratta appunto di valutare un lavoro come “realtà vivente”, come “opera d’arte”?
Si dirà: per curiosità, a titolo di informazione. Ma anche sotto questo aspetto la cosa è inutile, e
anzi irriverente verso l’autore. Poiché Riccardo Zandonai, o Pietro Mascagni, o Giacomo Puccini
sono tali maestri ed hanno tale esperienza, dopo avere scritto cinque, dieci e quindici opere, che si
intende tacitamente ammesso che essi sappiano bene armonizzare, strumentare, eccetera, e valersi
con padronanza completa di tutti i mezzi di espressione di cui oggi l’arte è diventata ricca. Ciò si
dovrebbe intendere ammesso, se l’arte si insegnasse sul serio, anche per qualsiasi giovane che esca
di Conservatorio.
E così accade che gli artisti si irritano a sentirsi dire certe cose. Come un artista si irriterebbe a
sentirsi dire “artista calvo”, “artista alto di statura”, “artista dal naso aquilino”, “artista dotto”,
“artista amante dei maccheroni”, “artista galantuomo” e via dicendo: non perché queste qualità non
possano esistere obiettivamente in lui, ma perché esse non hanno niente che fare con lui come
artista. Oh, se requisiti simili (io ho addotto esempi grotteschi ma, se non alla lettera, nel senso
qualifiche simili se ne adoperano tutti i giorni) contribuissero sia pure in dose infinitesimale a
creare l’artista, di artisti sarebbe pieno il mondo! E cosa volete? L’artista sentendosi trattato (o in
buona o in mala fede) in tal modo ha la sensazione di essere preso in giro, e si irrita. E il pubblico
che legge, non avendo la forza e l’acutezza di sgrovigliare da sé certe matasse, si lascia lentamente
avvelenare; e i pregiudizi sempre più si radicano, e il confusionismo sempre più cresce...
L’unica domanda da doversi porre per la valutazione dell’opera d’arte è questa: qualunque siano
i mezzi di cui Riccardo Zandonai si è servito (e si deve ammettere che egli li possegga, senza
eccezione, tutti, fino alle vernici, ai pigmenti, agli olii essicatori più recentemente messi in
commercio) è egli riuscito dalle sue movenze e dalla sua materia sonora a trarre un palpito di vita
tale che sotto il suo fulgore i mezzi all’occhio dello spettatore totalmente scompaiano? E come? E
dove? E sotto quale aspetto?
A questa domanda a me sembra si debba rispondere affermativamente (badate bene che una tale
risposta affermativa riguarda il problema artistico, non il problema pratico della futura permanenza
più o meno lunga dell’opera in repertorio, cui tanti altri elementi, estranei all’arte, concorrono).
E mi pare che Zandonai sia riuscito a fermare ne’ suoi gesti sonori il goethiano “attimo
fuggente” sotto due aspetti.
Prima di determinare quali sono questi due aspetti, mi son necessarie alcune altre brevi parole.
La via della finestra è una “commedia giocosa”. È strano che tutti coloro che non l’hanno
ascoltata e me ne chiedono notizie mi rivolgano questa domanda: «Fa ridere?»: come se nella
risposta affermativa o negativa a questa domanda stesse la consacrazione del successo o
dell’insuccesso.
3.2.2/30
A questo riguardo, molte cose piacevoli – e forse anche interessanti – avrei da dire, se lo spazio
mel consentisse. Accennerò fuggevolmente a qualcuna. Intanto, se un’“opera comica” fa ridere non
è per la musica ma per il soggetto: per le vicende e i gesti e il parlare dei personaggi. La musica – a
meno che non sia musica onomatopeica o imitativa, cioè di marca assolutamente inferiore e all’arte
estranea – non fa mai ridere: fa buon sangue, esalta lo spirito, produce un godimento, una gioia, un
tumulto nell’anima quale forse nessun’altra arte e nessun altro mezzo riesce a provocare, sveglia in
cuore una letizia che può persino paragonarsi alla letizia paradisiaca dei beati danteschi: ma non fa
ridere nel senso di solletico, di convulso, di contrazione dei muscoli facciali. Potrei trarre
argomento da questo fatto per dimostrare la superiorità della musica come arte e come aspetto della
attività spirituale umana.
E da ciò la mia mente è portata a ripensare ad un discorso che udii da Gabriele D’Annunzio una
sera dell’estate scorsa. Il poeta parlava – e ne parlava per intensificare in noi ascoltatori la febbre e
la tortura dell’arte, in quanto continuo superamento, in quanto lotta bruciante per la conquista di
una meta altissima e quasi irraggiungibile – del carattere eminentemente interiore e spirituale
dell’arte. E il discorso cadde sul “riso”. Il poeta diceva che non c’è niente di più volgare, di più
superficiale, di più ripugnante del riso fenomeno muscolare esteriore e meccanico. Uno sgorbio
qualunque caduto su un disco o su un ovale può creare l’apparenza di una faccia che ride: una
cicatrice qualunque, una contrazione morbosa può trasformare un viso in modo da farlo
eternamente ridere...
E in questo senso materiale, marcatamente visibile, si considera normalmente la parola “riso”.
Non a provocare o a fissare un tal riso mira l’arte; e tanto meno la musica che è la più interiore e la
più spirituale delle arti...
Tronco il discorso. L’intreccio della Via della finestra, tolto da uno scherzo comico di Scribe,
abilmente sviluppato e sceneggiato e dialogato da Giuseppe Adami, e con altrettanta abilità e
padronanza ritmato e intonato da Zandonai, è piacevole; si ascolta volentieri come una
conversazione garbata, come un seguito di incidenti più o meno pettegoli cui capiti di assistere. Ma
non è nella favola, nell’intreccio letteralmente preso che sta il valore di opera d’arte della Via della
finestra, come altresì (potrei dimostrarlo) di qualsiasi altro melodramma. L’intreccio entro certi
limiti potrebbe essere quello o un altro, senza che la creazione musicale venisse a perdere nulla
della sua essenza.
La quale risiede nell’atmosfera di poesia che il musicista è riuscito a creare coi suoni attorno alla
vicenda da lui presa a canevaccio. Nella Via della finestra sotto due aspetti – dicevo – vibra quel
palpito di vita che fa dimenticare e strumenti e accordi e carte dipinte e battibecchi di attori; e per
cui l’ascoltatore può affermare con certezza di trovarsi in conspetto di un’opera d’arte.
Primo: in quanto Zandonai ha dato vita a un quadro di poesia campestre, in cui gli elementi da
me evocati nella prima parte di questo scritto trovano una espressione intensa e delicata. Nel primo
atto, le tre volte in cui s’odono a distanza fuor del balcone (e ogni volta con fervore più alto e più
vivo) i canti dei contadini:
Odor di fieno:
il tuo sorriso
è come il sole...
e nell’ultimo atto, quando scende la sera e tutto si avvia alla pace e al riposo, e il “Falciatore” e il
coro cantano una specie di inno alla «Notte di primavera», la poesia dei campi vibra intensamente e
squisitamente nell’opera di Zandonai: vibra nelle voci, vibra nello sfondo dell’orchestra con
eloquente concento.
La figura del “Falciatore”, che lontana, immobile, nell’ombra della notte intona il suo canto, fa
pensare ad una divinità campestre che s’erga d’improvviso misteriosa e solenne nella solitudine
boschiva; ad un mondo di amadriadi, di fauni, di ninfe; fa pensare (o grande spirito di Arrigo Boito
accogli il mio riverente saluto) all’antica Arcadia, all’età cantata da Virgilio e da Esiodo in cui la
vita scorreva sempre felice e il miele sgorgava dai tronchi.
3.2.2/31
Secondo: in quanto Zandonai ha composto nella Via della finestra un piccolo ma squisito poema
di tenerezza “familiare” e, diciamo pure, “coniugale”. La figura di Gabriella, la moglie buona e
innamorata che una bizza momentanea distacca dal marito e anela di ritornare al suo nido, e vi
ritorna traversando coraggiosa, vincendo la sua timida femminilità, siepi di spine, è resa da
Zandonai con toccante delicatezza. Nell’ultim’atto, quando Gabriella è salita sul balcone e non
trova più la scala per discendere e picchia invano nell’imposta chiusa:
E la notte è profonda
profondo è il mio dolore!
Ho tanto freddo!
Perché non mi riscaldi?
Perché non apri, amore?
la commozione afferra gli spettatori. Quel palpito umano per cui le persone che si voglion bene, nel
momento del pericolo, e direi quasi della preghiera, si aggrappano fra loro, e per cui all’appressarsi
della notte ciascuno è richiamato con bisogno intenso alla propria casa e al proprio nido è stato
colto da Zandonai nella chiusa della sua opera. E credo che niente debba essere a lui più grato della
constatazione che io gli faccio che il sentimento di tenerezza e di affettuosità, che egli ha
certamente voluto far vibrare nell’opera sua, palpita e vive: egli che ha dedicato la sua nuova opera
alla memoria della nonna, dalla quale gli fu suggerito questo argomento forse in una di quelle
lunghe sere intorno al Natale in cui si sta seduti presso al camino e si raccontano fiabe, e i cuori si
sentono più che mai stretti da quel soave e quasi religioso affetto familiare che l’anima buona di
Zandonai sente profondamente ed ha saputo delicatamente ed eloquentemente esprimere.
La via della finestra ebbe a Pesaro una buonissima interpretazione da parte del maestro Edoardo
Vitale che la concertò e diresse con animo squisito di artista, delle signore Caracciolo, Casazza e
Avezza, del tenore Ciniselli e del baritono Baldini. Il successo fu molto vivo. Successivamente
l’opera è stata riprodotta, con esito altrettanto lieto, a Lugo; e lo sarà a Verona,a Firenze e nella
prossima stagione invernale al Costanzi, dove lo stesso maestro Vitale la dirigerà ed avrà ad
interpreti quasi tutti gli stessi artisti che la crearono a Pesaro. Lo spartito è edito dalla Casa Ricordi.
3.2.2/32
Giulietta e Romeo
403
Giorgio Barini, Giulietta e Romeo - Tragedia lirica di Riccardo Zandonai, «Nuova antologia»
LVII/1199, 1.3.1922 - pp. 87-92
Non so bene se l’idea sia stata suggerita da Riccardo Zandonai ad Arturo Rossato, o se vi abbia
questi pensato, o altri l’abbia consigliato: ad ogni modo, avere attinto gli elementi di un libretto
sulla tragedia d’amore di Giulietta e Romeo direttamente dalla novella di Luigi da Porto rielaborata
poi dal Bandello, facendo astrazione dalla mirabile opera di Guglielmo Shakespeare, era idea
buona: se non altro dava modo di evitare i raffronti immediati con i molti spartiti inspirati dalla
trama scenica shakespeariana; e in questi la geniale ricchezza dell’originale è fatalmente alterata e
distrutta nel necessario schematismo del melodramma, per cui devesi rinunziare a molti personaggi
ed episodi caratteristici, cosicché appare monco e insufficiente il disegno drammatico e lo
svolgimento scenico del libretto per chiunque abbia presente il testo dello Shakespeare. Ma se il
libretto del Rossato merita questa lode, ciò non significa che possa dirsi un buon lavoro: tutt’altro; e
questo non soltanto perché la stupenda creazione del grande poeta inglese ha valore definitivo e non
possiamo quindi facilmente sentirci soddisfatti da una differente stesura, ma anche perché manca di
intima efficacia e non presenta organismo saldo e sano. Scomparsi i personaggi principali e
secondari della tragedia, essendo assommati nel solo Tebaldo tutti i Capuleti (sono restati i nomi,
non le vive persone di Gregorio e di Sansone), e in un solo Montecchio l’intero parentado di
Romeo; eliminate figure notevoli come frate Lorenzo, la ineffabile nutrice, Benvolio, il vivace
Mercutio, i genitori di Giulietta, il padre di Romeo; troviamo invece nuovi personaggi come
Isabella fante di Giulietta, un Cantatore, un banditore, un Bernabò padrone di scuderia: tipi incolori
che male sostituiscono gli scomparsi, animati dal genio possente dello Shakespeare.
Anche l’amorosa passione dei due giovani, così ricca di ardente e sana sensualità, assume un
carattere ibrido, tra inamidato e convenzionale, di un sentimentalismo borghese, quasi da
oleografia. Pare che il librettista abbia ceduto a quel superficiale simbolismo di maniera che
considera emblema di castità le colombe, mentre quelle graziose bestiole hanno tendenze ben
differenti. E tutto quell’animato mondo, riboccante di vitalità, di altissima poesia, di audacie per cui
si è scandalizzato qualche pudibondo critico tedesco o scandinavo, incapace di sentire e apprezzare
la sincerità scevra da ipocrisie che l’antichità classica ha tramandato allo spirito italico, si è
dileguato per cedere il posto ad un villanissimo, bestiale individuo che nemmeno ha la scusa di
esser geloso (infatti Tebaldo si compiace di annunziare alla cugina che essa dovrà sposare un conte
di Lodrone); e ad uno sciame di fanciulle incolori che giocano al torchio, giuoco insipido e
scimunito quanto mai; e tutti parlano un linguaggio che vuol essere arcaico ed è soltanto artificioso.
Il primo atto si svolge in una piazzetta in Verona; vi sono due osterie: in una si adunano i
Capuleti, nell’altra i Montecchi. Tebaldo incita i primi a stare in guardia e si allontana con un
gruppo di maschere che si recano al palazzo dei Capuleti, in cui si danza; i Montecchi cantano in
coro una canzone alquanto sguaiata ed escono dall’osteria con una donna, che va proprio a passare
sotto il naso dei Capuleti, tanto per dar pretesto ad una rissa fra i due gruppi. Mentre la zuffa è
impegnata e tumultuosa, un uomo mascherato interviene e ferma tutti, dominando semplicemente
quel putiferio con la voce; ma ecco Tebaldo, sempre inferocito, a rinfocolare le ire, calmate questa
volta dall’annunzio che giunge la scolta: e tutti fuggono a gambe levate. Resta solo Romeo (è il
mascherato); Giulietta si affaccia al balcone: scena d’amore: scalata di Romeo alla finestra, per
discendere presto (è vicina l’alba) dopo interruzione per il passaggio delle maschere essendo finita
la festa: raggio di luna e coretto interno; Romeo allontanandosi manda un bacio a Giulietta,
investita da un raggio del sole nascente.
Il secondo atto è nel cortile del palazzo dei Capuleti: Giulietta e le fanti giuocano al torchio e
pare si divertano un mondo: beate loro! Ma ecco Tebaldo, il quale, con la solita intonazione d’uomo
gratuitamente maleducato, dice a Giulietta (dopo allontanate le fanti) una massa di male parole,
annunziandole il maritaggio combinato dal padre di lei per il giorno seguente: Giulietta protesta e
svela aver giurato fede di sposa a Romeo. Una fiera zuffa fra Capuleti e Montecchi, che si svolge
3.2.2/33
dietro le quinte, obbliga ad allontanarsi Tebaldo, che ritiene potere abbattere Romeo. Ma questi è
nelle stanze di Giulietta: essa lo fa venire in cortile (imprudente! perché non andar lei in casa?) per
dirgli che è disposta a fuggire con lui: ma torna d’improvviso con la spada in pugno Tebaldo, che
ha sorpreso Isabella mentre faceva la guardia (non molto bene, a quel che pare) agli sposi amanti:
solite insolenze villane, finché Romeo perde la pazienza, snuda la spada: i due si battono e Tebaldo
cade. Invasione di Capuleti, che portano via il cadavere, imprecando contro l’uccisore, che è lì ma
nessuno lo vede. Partiti tutti, Isabella suggerisce a Giulietta il narcotico che la farà creder morta e le
permetterà di fuggire con Romeo.
La prima parte del terzo atto è a Mantova, mentre l’avvicinarsi di un temporale fa allontanare la
folla raccolta per una Sagra: giunge un cantore, il quale canta un lamento, allora appreso dai suoi
colleghi di Verona, in morte di Giulietta. Romeo, che è in attesa del ritorno di un famiglio con
novelle da Verona, getta un grido terribile, afferra il cantore e vuole da lui più complete notizie; e
gli fa ripetere il canto di morte. Ecco anche il famiglio a rinarrare la fine della fanciulla: Romeo
chiede il suo cavallo, balza in sella e cavalca in furia verso Verona, mentre la bufera imperversa. Si
riapre il velario, quando il temporale si placa: appare il chiostro del convento ove è la cappella dei
Capuleti: in essa, distesa sopra un’arca, Giulietta, che par morta. Romeo esprime tutto il suo amore,
tutto il suo strazio: chiama a gran voce l’adorata sposa e ingoia il veleno che deve unirlo a lei nella
morte: ed ecco il risveglio della fanciulla, la quale si slancia verso il suo amore, fremente, gioiosa.
Ma il veleno compie l’opera sua, lentamente sì ma irrimediabilmente: suonano campane, si levano
canti religiosi dal chiostro, canti d’amore dalla via, mentre Romeo seguita a sentire gli effetti del
veleno; Giulietta esprime la sua disperazione, presa da un delirio pio, e Romeo continua a soffrire e
contorcersi; ancora si riodono le voci dal chiostro e dalla strada, finché Romeo riesce a morire;
Giulietta lo imita, colta da misterioso malore: e cala la tela.
***
Se il libretto di Giulietta e Romeo non è gran cosa, ha però in sé ben chiari i due fondamentali
elementi drammatici e sentimentali il cui contrasto ha attirato sopra tutto l’attenzione dei molti
musicisti che hanno voluto trattare questo soggetto, scorgendovi viva fonte di espressività intima ed
esterna, di lirismo e di teatralità: l’odio accanito delle due famiglie rivali – l’amore ardente dei due
giovani che alle due famiglie appartengono. Non è mio còmpito indagare quale sarebbe stato il
mezzo migliore per determinare musicalmente tale contrasto: né penso sarebbe stato consigliabile
per un musicista italiano porsi nelle strettoie di un sistema che potrebbe apparire atto a riprodurre
materialmente, plasticamente la lotta affannosa delle due opposte tendenze: il sistema strettamente
tematico wagneriano; piuttosto poteva pensarsi ai ricorsi melodici di tipo italiano quali usò con
tanta efficacia Giuseppe Verdi. Però Riccardo Zandonai non ha delineato con tutta la desiderabile
forza significativa il contrasto profondo che anima la passionale vicenda degli amanti di Verona:
sembra che il fecondo maestro, sicuro di sé per la sua meravigliosa padronanza di ogni mezzo di
espressione sonora, per la facilità prodigiosa della sua penna, abbia affrontato quasi d’improvviso il
lavoro di elaborazione musicale, seguendo e commentando il libretto dal principio alla fine, sotto
l’immediato impulso delle singole posizioni, delle successive manifestazioni di pensiero, di
sentimento, di azione: sembra non abbia accolto in sé, prima di porsi al lavoro, ed evocato
sinteticamente le energie vitali, fondamentali del dramma, immaginando, creando nuclei centrali
cui far capo e da cui irradiare ogni attività sentimentale e scenica.
Si può obiettare che le violente espressioni di Tebaldo sono sottolineate da un rapido tratto
ritmico (una terzina discendente per semitoni), che riappare in altri momenti, quasi debba
rappresentare il substrato dell’odio tra Capuleti e Montecchi: ma non ha davvero la consistenza e la
forza significativa necessaria per assumere siffatto carattere; e ancor meno ha sensibile valore
qualche disegno ritmico che appare e riappare nelle scene d’amore; né può assurgere alla efficacia
di un simbolo: e di simbolo di così grande passione. Seguendo lo svolgimento dello spartito, si può
meglio scorgere la mancanza di essenziali punti d’appoggio sui quali imperniare l’opera d’arte
perché raggiunga organicità perfetta; di temi eloquenti e fecondi da cui possano scaturire fremiti di
vita.
Le prime scene del primo atto non mancano di animazione: tuttavia non può dirsi che la musica
che giunge dal palazzo mentre fervono le danze abbia festosità o brio; né che abbiano giocondità i
3.2.2/34
vocalizzi delle maschere che traversano la piazza. Indovinata è invece la canzone intonata
nell’osteria dei Montecchi, canzone caratteristica nella voluta sua volgarità; animata è la scena della
baruffa; ben sentito il contrasto fra Romeo invocante pace e Tebaldo rabbioso; dopo il passaggio,
piuttosto funebre, della scolta, si svolge largamente il dialogo amoroso tra Giulietta e Romeo: la
musica procede per episodi delicati, elegantemente svolti, molto melodici: non vi sono gli slanci
materiati di amoroso lirismo, non gli scatti passionalmente trascinanti che di momento in momento
si attendono e sperano, quale l’amore fervido dei due giovani sembra promettere: la scena offre
spunti notevoli, che non giungono però a destare vera commozione nel nostro animo, benché ne sia
innegabile la nobile espressione: in fine buon effetto delle voci lontane che intonano uno stornello,
effetto cui nello spartito si ricorre con qualche insistenza, fino a sembrare una ricercatezza
romanticamente manierata.
Il secondo atto si apre con una scena primaverile, in cui il gaio sciame femminile che circonda
Giulietta svolge il giuoco del torchio, giuoco che sembra diverta molto quelle brave figliuole, ma
non interessa eccessivamente lo spettatore, e che si prolunga alquanto, con un commento musicale
spezzato un po’ affannosamente; sembra che nemmeno il musicista sia profondamente convinto del
vero significato e della portata di questo giuoco; è rimasto freddo e fredda è la sua musica. La
brutalità urtante di Tebaldo, nella sua scena (o scenata) con Giulietta, si esplica con accenti
musicali sonori, fragorosi più che robusti: e il solo episodio in cui un senso di dolcezza si diffonde,
nel ricordare che egli fa del tempo della fanciullezza vissuto con la cugina, si espande in un
sentimentalismo alquanto superficiale, come se si trovassero a disagio certe espressioni gentili in
una bocca usa soltanto a sgarbate violenze. Ed ecco l’eco di una nuova baruffa: una breve scena
sentimentale tra i due amanti; un dialogo a contrasto, che richiama alla mente quello del primo atto,
pure tra Romeo e Tebaldo; il duello; la partenza di Romeo e l’accenno al narcotico che farà apparir
morta Giulietta. L’atto è scenicamente movimentato, più del precedente; e i brevi periodi di stasi
valgono a dar risalto alla agitazione degli altri episodi. Nel complesso però il secondo atto appare
musicalmente più debole del primo sotto l’aspetto dell’invenzione, sebbene i colori orchestrali
siano vivaci e densi.
Nel terzo atto, dopo la scena corale, spezzata da brevi episodi, sorge il lamento del Cantatore per
la morte di Giulietta: canto semplice, spontaneo, commovente: melodia di carattere vagamente
popolare, affettuosa, significativa, che si riode ben volentieri per rinnovare una sensazione gentile
ed eloquente. Ed ecco l’intermezzo sinfonico: Romeo balza sul cavallo e corre a Verona mentre
infuria la bufera: pagina orchestrale robusta e irruente, anche se dia l’impressione del procedere un
po’ pesante di un plotone di cavalleria anziché di due soli cavalieri, tanto è fragorosa e densa. La
mente non può a meno di ricordare la meravigliosa corsa all’abisso nella Dannazione del Berlioz,
che produce così profonda impressione con tanta semplicità di mezzi. La cavalcata dello Zandonai
si inizia con tale intensità sonora da non potere, procedendo, acquistarne di più: e allora sembra
quasi vada perdendo vigore: le voci che chiamano dolorosamente Giulietta sono troppo umane nella
realizzazione musicale e non possiamo considerarle, come vorrebbe il librettista, voci del cuore di
Romeo, del vento, del tuono; non «la tempesta, il cielo e la terra, gridano il nome disperato», ma
una moltitudine che esclama «Giulietta mia» al pari di Romeo, con non lieve strazio della buona
reputazione di quella poveretta: l’anima inferocita di Tebaldo pare abbia immaginato simile offesa.
Al turbinìo della tempestosa cavalcata segue la malinconia accorata del chiostro funereo: il lamento
di Romeo, il risveglio di Giulietta, lo strazio della duplice morte. E qui il musicista ha voluto
carezzosamente plasmare i palpiti dei due cuori amorosi, ha voluto lumeggiare i pensieri delle due
menti straziate, avvolgere in un velo d’oro le due anime che amore terrà unite in eterno: e si è
indugiato nella ricerca di espressioni dolorosamente flessibili, in cui si uniscano in un indissolubile
nodo amore e morte. Ma non ha trovato il grido sublime, degno dell’alta tragedia; non il fremito
profondo che squassa i due esseri travolti da un fato inesorabile: forse troppo ha voluto dicessero il
librettista, e troppo ha fatto dir loro il musicista: stringendo, sintetizzando, le espressioni si
eleverebbero e purificherebbero: e gli accenti di morte dei due innamorati giovani potrebbero
levarsi con purezza e intensità avvincenti se più rapidi e semplici e liberi dalle aggiunzioni esterne
dei cori sacri e profani, ideati al solo scopo di un effetto sentimentale, che però turba la tragica
purezza della morte amorosa.
3.2.2/35
***
Riccardo Zandonai ha, con questo nuovo spartito, confermato la sua magistrale forza fattiva di
musicista nobile, sicuro, poderoso: soltanto confermato perché Giulietta e Romeo non segna un
passo innanzi nella sua vita artistica. Ho assistito al nascere di tutti i suoi spartiti: e, oltre la
soddisfazione di potere apprezzare una così lieta fioritura di opere d’arte, ho potuto affermare ogni
volta che il maestro fecondo e sicuro aveva avuto una limpida visione dell’opera d’arte: ogni suo
spartito, pur dimostrandosi frutto della medesima pianta robusta, aveva un suo significato, un suo
carattere, un suo colore: dal Grillo del focolare si differenzia profondamente Conchita; e da essi
nettamente si allontanano Melenis, Francesca da Rimini, La via della finestra: sono tutti figli dello
stesso padre, sani e ben formati: ma ciascuno di essi ha una fisionomia ben distinta. Ora ciò non si
verifica per Giulietta e Romeo né per struttura né per colore né per indirizzo drammatico né per tipo
melodico: Giulietta è troppo sensibilmente sorella di Francesca e, bisogna riconoscerlo, sorella
minore. In essa si ritrovano tutti i pregi di fattura e di espressione della maggiore sorella, col difetto
fondamentale della ripetizione di una uguale manifestazione estetica: non è davvero un passo
indietro, ma neppure è un passo avanti: e da Riccardo Zandonai questo attendevamo. Ma egli, nella
sua equilibrata e organica potenzialità, saprà trovare facilmente nuove parole con nuovo soggetto;
e, meditandoci sopra, senza aver troppa fretta, ci darà quella nuova concezione d’arte che ben
sappiamo che egli può offrirci.
––––
La prima rappresentazione di Giulietta e Romeo (14 febbraio 1922, Teatro Costanzi - Roma) è
stata allestita e diretta dall’autore, ammirevolmente coadiuvato dal comm. Carlo Clausetti per la
preparazione scenica. Ha avuto [come] esecutori eccellenti Gilda Dalla Rizza, Giulietta ideale per
azione, canto, voce, figura; Michele Fleta, Romeo eccellente, che ha saputo con gli splendidi mezzi
vocali e la giovanile foga dar vita alla figura dell’innamorato giovane, alquanto immiserita dal
librettista; Carmelo Maugeri, Tebaldo rabbiosissimo, dalla voce solida, dall’accento incisivo; il
Nardi, prezioso interprete di un Montecchio e del Cantatore. Il maestro Consoli ha istruito in modo
eccellente la massa corale, il cui còmpito è nel nuovo spartito di grande responsabilità e difficoltà.
Orchestra diligente, sicura, omogenea, vigorosa ed elegante. Allestimento scenico e costumi
alquanto discutibili; ma ben curati. Movimenti di attori e masse ben riusciti, animati ed equilibrati.
Il primo atto ebbe le più calorose accoglienze, come era giusto; il secondo lasciò l’uditorio un po’
freddo e non pienamente convinto; il terzo interessò e fu gustato assai nella prima parte e sopratutto
nell’intermezzo orchestrale; l’ultima parte stancò alquanto per la sua prolissità non avvivata da vero
fuoco di inspirazione: ma non mancarono applausi, che salutarono lietamente l’autore e i suoi
cooperatori.
404
Ottone Schanzer, A proposito del libretto di “Giulietta e Romeo” per la musica di Riccardo
Zandonai, «Rivista nazionale di musica» III/65-66, 17-24.2.1922 - pp. 339-42
Un successo serio ed autentico ha coronato la nuova fatica lirica di Riccardo Zandonai.
Giulietta e Romeo, datasi per la prima volta la sera del 14 corrente al Costanzi, è stata infatti
accolta con incontestabile favore dal meraviglioso pubblico che gremiva il nostro maggiore teatro
di musica; e, salvo qualche dolorosa eccezione, col maggior rispetto della critica musicale italiana e
straniera.
Ciò premesso, può sembrare superfluo intrattenersi posticipatamente sul libretto che Arturo
Rossato ha scritto per la musica del geniale compositore trentino, dato che il poeta e il musicista
sono, in complesso, usciti vittoriosi dalla difficile prova.
Senonché la breve disanima che ci proponiamo di fare non tende punto a negare i meriti
dell’opera poetica di Arturo Rossato, che sono reali e incontestabili; ma a porre in discussione, a
proposito del nuovissimo libretto di Giulietta e Romeo, una generale tendenza della moderna scuola
librettistica che ci sembra errata e perniciosa, così per i poeti che scrivono per il teatro di musica
che per i compositori che ad essi ricorrono per ottenerne la tela su cui tessere le loro creazioni
3.2.2/36
sonore. Alludiamo alla tendenza che mira a ridurre e adattare alla scena lirica compiute opere di
poesia; e, quel ch’è ancor più grave, ad apportare alle opere stesse mutazioni così profonde ed
essenziali da alterarne e snaturarne il carattere, diminuendone grandemente l’efficacia drammatica
ed emotiva. Prevediamo una grave obbiezione:
«Oltre i tre quarti dei libretti di opere celebri sono tolti da tragedie o da leggende famose: Verdi
insegni!»
Un momento, diciamo noi.
Fermiamoci al caso Verdi per non divagare.
Ogni qualvolta il gigante ha posto l’artiglio su soggetti d’indiscutibile virtù drammatica ma di
discutibilissima dignità artistica e formale, come quelli dai quali furono tratti e la Forza del Destino
e il Trovatore e lo stesso Rigoletto o su libretti più o meno originali e alquanto ingenui come quello
dell’Aida, egli ha scritto compiuti ed assoluti capolavori.
Allorquando, invece, egli si è cimentato con un gigante suo pari quale è Guglielmo Shakespeare,
non ha potuto evitare, nonostante la sua illimitata grandezza, che un certo senso di disagio filtrasse
a traverso le partiture dell’Otello e del Falstaff, le due opere tolte da Arrigo Boito a una tragedia e
ad una comedia dell’Inglese.
Dio ci salvi dal mancare di rispetto all’ombra di Giuseppe Verdi e dal disconoscere la bellezza di
quelle due opere sue immortali; ma non è chi, in ascoltare l’Otello e il Falstaff, non avverta una
certa quale costrizione, una lieve aura di freddezza ch’egli non avrà mai notate in alcun’altra opera
di Verdi.
La ragione di siffatto fenomeno è, a nostro parere, ovvia: ogni opera d’arte nasce con la sua
propria legge, che non è lecito sotto alcun pretesto violare; ogni grande opera di poesia è, come tale,
compiuta in ogni sua parte; né la musica è in grado di aggiungervi alcunché di nuovo. Avviene
pertanto che quando un Verdi imprende a musicare un soggetto di Shakespeare egli lo riveste di
melodie divine, sotto ogni riguardo mirabili; ma la musica che sgorga da quella fonte d’ispirazione
ha un vizio d’origine indelebile: essa è superflua!
Il genio di Shakespeare aveva già tutto espresso con la parola: il genio di Verdi non aveva più
nulla da aggiungere; esso non ha potuto che sovrapporre ad un’opera di compiuta bellezza un’altra
compiuta bellezza, il marchio della propria immensità.
Diceva Beethoven che la musica nasce ove cessa la parola; là dove la parola vive e trionfa è
inutile che la musica interloquisca.
Un nostro giovane critico musicale, genialissimo, ch’è anche un grande musicista, suol dire con
la foga paradossale che gli è propria che il “libretto” non esiste; ch’è assurdo ricercarlo in un’opera
musicale, in cui esso si trova disseminato e proiettato in mille pezzi, come un corpo umano
maciullato dall’esplosione di una granata da 420; e che sarebbe del pari assurdo ricercare un dato
corpo in una composizione chimica che ne ha annullato ogni traccia per dar luogo al nascimento di
un nuovo corpo, di una nuova sostanza totalmente diversa dalle parti che hanno concorso a
comporla. Anche l’opera in musica sarebbe, secondo quello scrittore, una nuova sostanza.
Questa teoria, alquanto iconoclasta, può urtare la nostra suscettibilità di librettisti; ma essa
contiene, senza alcun dubbio, molti elementi di verità.
Ciò che il nostro critico intende dire si è questo: che il libretto non ha altro scopo se non quello
di suggerire elementi musicali al compositore, di destare in lui il demone della musica.
Quando il librettista abbia assolto opportunamente questo compito, egli ha compiuto la propria
opera; si elimina e scompare. Subentra allora il musicista, il quale, se è grande, maneggia e
sconvolge a modo suo la materia poetica e drammatica che gli è stata fornita, la investe dell’afflato
incandescente della propria ispirazione, la trasforma, la ricrea. E nasce l’opera.
La verità di questo assunto è provata da tutta la immane opera di Giuseppe Verdi.
Ogniqualvolta egli ha potuto dare libero sfogo al suo poderoso istinto, gonfiando con la sua voce
divina i cenci poetici che gli venivano allestiti dai suoi numerosi quanto modesti librettisti, egli ha
creato capolavori eterni.
Egli riplasmava da capo a fondo, egli rimasticava addirittura i libretti da lui prescelti.
Nulla di più interessante, nulla di più divertente – absit iniuria verbis – che seguire da vicino
quest’opera di... ruminazione poetico-musicale.
3.2.2/37
Nelle trenta o quaranta lettere scritte da Giuseppe Verdi al Ghislanzoni durante la gestazione
dell’Aida, lo schema ed i versi del modesto e paziente poeta si sono andati addirittura
volatilizzando.
Alla fine, tanto sarebbe valso che il Grande Vecchio avesse scritto sulla copertina dell’Aida:
Parole e musica di Giuseppe Verdi!
La prima lettera è intestata: Signore, ed è piena di rimbrotti; poi a mano a mano che cresceva
l’intimità fra musicista e librettista, si passa, a traverso una sequela di Egregio Signore, Egregio
Amico, Caro Amico, ad un affettuoso e familiare Caro Ghislanzoni. Ma del libretto di costui non è
rimasto ormai nulla o quasi nulla!...
Un altro che la pensa così è il nostro grande Puccini. Anch’egli è la disperazione dei proprî
librettisti; anch’egli rifà i libretti da capo a fondo, finché non ottiene quel che egli vuole. A fare il
libretto della Manon Lescaut ci si sono messi in tre, compreso il povero buon Domenico Oliva; e
nessuno dei tre ha voluto mettere il proprio nome sulla copertina... perché nessuno dei tre
riconosceva più l’opera sua!!
Ora, per tornare a noi – ci accorgiamo di aver divagato alquanto –, quando il grande Verdi si è
trovato d’innanzi a Shakespeare è stato invaso da una specie di timore reverenziale, che dal sublime
Poeta si rifletteva sull’illustre riduttore, sul librettista, che non era un Piave o un Ghislanzoni ma
nientemeno che Arrigo Boito.
La produzione di un Boito non si poteva frantumare, sconvolgere, volatilizzare; bisognava
prenderla com’era: buona o cattiva.
Ed era senza dubbio buona. Ma...
Nessun riduttore di Shakespeare è stato più coscienzioso, più arguto, più aristocratico di Arrigo
Boito; ma, per quanto egli abbia fatto, gran parte del fascino ch’era nella parola di Shakespeare è
andato perduto; d’altra parte quel ch’è restato era anche troppo personale, troppo irriducibile,
troppo definitivo per non imbarazzare, per non inceppare, sia pure lievemente, l’irruente genio di
Verdi.
E questi seppe ancora far miracoli perché era Verdi.
Ma, in genere, Shakespeare ha portato ben poca fortuna ai musicisti che si sono ispirati a lui.
L’Amleto di Thomas, la Giulietta e Romeo [sic] di Gounod, l’Enrico VIII° di Saint-Saëns, per
non citare che le più celebri opere musicali tratte da Shakespeare, non rappresentarono che una
serie di dignitosissimi fours.
Noi speriamo, anzi fermamente crediamo, che Riccardo Zandonai sia riuscito a vincere la
jettatura che pesava da un secolo circa sui soggetti musicali d’origine shakespeariana.
A giudicare infatti dal successo dell’altra sera, che non può se non andare crescendo, bisogna
ritenere che l’autore di Conchita abbia saputo vincere con la ricchezza del suo temperamento
musicale le molte difficoltà che presentava il libretto apprestatogli da Arturo Rossato.
Abbiamo premesso che non è punto nostra intenzione criticare l’opera poetica del Rossato, che
rivela anzi una forte e sana tempra di librettista, destinato senza dubbio ad alti destini.
Riccardo Zandonai ha sinceramente dichiarato ch’egli ha inteso tornar con Giulietta e Romeo al
nostro antico e glorioso melodramma; naturalmente con vedute moderne per tuttociò che concerne
la tecnica strumentale; e benché noi riteniamo che non convenga destare i morti – per quanto
gloriosamente vivi! – non abbiamo nulla da obbiettare a questo audace progetto del geniale
compositore, che già ha saputo compiere un tour de force prodigioso col musicare da par suo la
Francesca da Rimini di Gabriele d’Annunzio, tragedia di parole e di storiche ricostruzioni che
pareva non potesse né contenere né ingenerare musica di sorta. E riteniamo anzi che il Rossato
abbia mirabilmente secondato il divisamento del Maestro approntandogli un vero melodramma
all’antica, adorno tuttavia di quella dignità formale che faceva completamente difetto ai libretti
dell’epoca eroica dei nostri grandi operisti.
Vogliamo soltanto accennare ad un pericolo grave che offriva il libretto di Giulietta e Romeo del
Rossato e che Riccardo Zandonai ha saputo evitare con sorprendente abilità.
Il pericolo era quello di essersi troppo allontanati da Shakespeare, probabilmente per paura della
sua tremenda grandezza.
3.2.2/38
Abbiamo testé sostenuto che Shakespeare, e in genere i grandi poeti, vanno lasciati in pace,
poiché le loro opere male si prestano ad essere ridotte a libretti per musica, dato che esse sono già
opere d’arte compiute in sé, alle quali la musica nulla può togliere e nulla aggiungere; e non
vorremmo essere tacciati d’incongruenza se ora sosteniamo che Arturo Rossato non si è attenuto
abbastanza fedelmente a Shakespeare!...
Cerchiamo quindi di chiarire il nostro pensiero.
È grave rifarsi a Shakespeare e ai grandi scrittori completi per trarne soggetti d’opera; ma è assai
più grave – l’abbiamo già detto in principio – ricorrere ad essi e snaturarne il carattere, tanto da
renderne quasi irriconoscibile l’opera.
Shakespeare vive eterno nell’anima degli uomini; e non è lecito convocarli a teatro per
ascoltarne la parola trasformata in musica, per cantar, poi, loro parole ch’egli non ha mai detto.
Il senso di disagio l’altra sera diffuso nel pubblico enorme che con intenta religione ascoltava il
nuovo verbo musicale banditogli da Riccardo Zandonai derivava da ciò, che tutti attendevano di
attimo in attimo veder rivelate per virtù di canti e d’incanti l’anima soavissima di Giulietta, a tutti
cara e nota, unica, insostituibile quanto di lei si narri; e invece assistevano allo strazio amoroso
d’un’altra donna, che si chiamava anch’essa Giulietta de’ Capuleti, ma ch’era un’altra, un’altra
donna. Arturo Rossato ha scritto un bel libretto, nonostante le molte inverosimiglianze dovute in
gran parte a ciò ch’egli è volutamente tornato al melodramma di maniera; ma egli ha scritto un
libretto che ha ben poco, troppo poco da fare col Romeo e Giulietta di Shakespeare.
Tanto valeva, allora, ch’egli fosse tornato alle fonti primitive del mito di Giulietta, alla tragica
novella di Masuccio Salernitano, molto opportunamente evocata da Edoardo Pompei nella sua bella
critica sulla Giulietta di Zandonai.
Mariotto Mignanelli e Giannozza Saracini avrebbero sostituito Giulietta e Romeo e il temibile
spettro di Shakespeare sarebbe scomparso.
Il drammaticissimo contrasto immaginato dall’antico novelliere salernitano si sarebbe
mirabilmente prestato ad uno svolgimento prettamente romantico e passionale.
Arturo Rossato ha creduto di risolvere ogni difficoltà ricorrendo alla fonte di Luigi da Porto,
vicentino; ma non è riuscito che a creare un ibrido che sta tra la versione novellistica più antica
della favola d’amore di Romeo e Giulietta e la immortale elaborazione di Shakespeare. Ma troppo
soffermandosi al duro dramma d’odî e di ire partigiane che all’opera di Shakespeare non serve che
di sfondo, egli ha tolto al poema tutto il suo divino profumo di fiori, d’innocenza e d’amore. Egli ha
disegnato abbastanza fedelmente e vivacemente la figura di Romeo, ma il disegno della soave quasi
infantile figura di Giulietta è completamente mancato.
La sua Giulietta è una donna amante, fiera e gelosa del suo amore, non è lo specchio
dell’innocenza gittata senza difesa in preda al destino bieco e feroce.
Noi crediamo che della figura creata dal Rossato si possa fare più e meglio di quel che non ne
abbia fatto la prima interprete di quel ruolo; ma giustizia vuole si riconosca che Gilda Della Rizza
[sic] non poteva creare la parte della Giulietta di Guglielmo Shakespeare che non esisteva nel
libretto del Rossato e, quindi, neppure nella musica dello Zandonai.
Altro grave errore è stato, a parer nostro, quello di abolire di netto la buona, umana figura di Fra
Lorenzo, sostituendola con quella, insipida, d’una confidente.
Il grande Willy sapeva molto bene quel che si facesse! Giacché si ricorreva a lui, conveniva
ascoltare i suoi paterni consigli.
Nonostante questi gravi difetti d’ideazione e di costruzione, la tragedia di Rossato e di Zandonai
ha trionfato come pièce à soi, che nulla o ben poco ha da vedere col meraviglioso poema d’amore e
di morte di Guglielmo Shakespeare.
Ce ne congratuliamo di cuore con Arturo Rossato, che ha dato prova di possedere un forte e
sicuro intuito teatrale; e, più ancora, con Riccardo Zandonai che, con la travolgente sua ispirazione,
ha felicemente condotto in porto una nave ch’era esposta ai più gravi perigli.
Ma, poiché ci consta che Arturo Rossato prepara altre due riduzioni shakespeariane per musica,
l’una dalla Tempesta, l’altra dalla Bisbetica domata6, ci permettiamo di dargli un sincero quanto
6
La tempesta per Felice Lattuada; La bisbetica domata per Mario Persico.
3.2.2/39
disinteressato consiglio: se è ancora in tempo, cambi rotta e crei di fantasia, poiché questa non gli fa
difetto; e se è già... compromesso con i suoi musicisti e non se la sente più di tornare indietro e di
cambiare strada, mantenga ai due soggetti quel tanto che costituisce la vera essenza, il vero afflato
immortale che farà tremare le vene e i polsi ai suoi amici compositori, ma che è da sperare ispiri
loro qualche melodia commossa e non peritura.
405
[Arturo Rossato], Come A. Rossato polemizza con i critici del suo libretto Giulietta e Romeo,
«Rivista nazionale di musica» III/70-71, 24-31.3.1922 - pp. 363-5
Egregio Signor Direttore,
Il cortese articolo di Ottone Schanzer, pubblicato nel numero 65-66 della Sua pregiata Rivista
(articolo ch’io leggo solamente ora) mi offre, finalmente, la possibilità di dire anch’io quello che
penso sul libretto Giulietta e Romeo di Arturo Rossato.
Il quale Arturo Rossato è un buon figliuolo, ma se lo punzecchiano con una certa insistenza si
scrolla come un polledro maremmano, tirando subito dei calci: modo assolutamente inopportuno in
un poeta che si rispetti, e che non voglia ragionare coi piedi come fanno molti critici. Se permette,
quindi, egregio signor Direttore, parlerò io, in difesa del libretto e di Arturo Rossato; io, che sono
nato, si può dire, insieme al poeta ed al libretto, senza però averci tanto così di paternità, sia
nell’uno come nell’altro.
Ottone Schanzer rimprovera due cose al Rossato: la prima – sostanziale – di aver preso un
soggetto shaekespeariano [sic] e poi – commesso il primo errore – di essersi discostato
dall’“immortale” modello. Sarà. Ma io, che non sono un letterato, confesso con molta semplicità
che l’ammirazione focosa per Giulietta e Romeo di Shaekespeare [sic]7, le grandi onde d’incenso al
poema giovanile del comico inglese, la cantica beata di meraviglia e di adorazione che s’innalza
intorno a lui, mi hanno sempre stupito e mi stupiscono tutta via. Creda a me, signor Direttore, a me
che non essendo un poeta me ne intendo un poco di poesia: sono esagerazioni. Io ed Arturo Rossato
siamo stati, per notti e per giorni, in veglia commossa e decisi a commuoverci a tutti i costi sulle
pagine di Giulietta e Romeo, ma, con tutto il rispetto possibile per Guglielmo Shakespeare,
abbiamo dovuto riconoscere che la poesia “immortale”, la poesia che apre i cieli e fa fiorire le
lacrime non l’abbiamo punto trovata. Sarà forse perché noi leggevamo veramente, senza rifarci ai
ricordi e alle tradizioni. Ma che poesia “immortale”, signori miei! Ma che capolavoro “sublime”!
Giulietta e Romeo di Shakespeare è una bella scocciatura. Siamo sinceri ed onesti, una volta tanto.
Prendiamo a caso. Leggiamo un poco a quattr'occhi. Ecco. Atto secondo. Siamo nel giardino dei
Capuleti, precisamente quando Giulietta è alla finestra col piccolo cuore gonfio di passione. Che
cosa dice questa soave farfalletta, imbalsamata fra due dive inglesi? «Non vi ha che il tuo nome,
nemico. Ora che è un nome? Il fiore che chiamiamo rosa, anche con un altro nome sarebbe sempre
una rosa e con profumi eletti empirebbe le aure. Ah! abbandona dunque quel nome ed abbine in
ricompensa me stessa!» Poesia? Ma questa è accademia garbata che precede le gonfie declamazioni
del seicento mariniano e del settecento più che mai petrarchesco! Sentiamo Romeo che cosa
risponde: «Con le ali d’amore, valicai l’altezza di quei muri. Io non so l’arte del navigante, ma se tu
fossi oltre i remoti mari, e fra orridi scogli, non esiterei un istante a dar le vele ai venti, per
approdare a un lido dove si nascondesse tanto tesoro. Odi! Più gravi pericoli io sopporto qui, ché i
tuoi occhi son più crudeli di tutte le armi che lo sdegno fa impugnare. Deh! Addolciscili e sarò
invulnerabile!...» C’è qui dentro, sul serio, la così detta immortale poesia? Ma allora il buon
Petrarca è un vulcano, ma allora le ballatelle del Cavalcanti, le stanze e gli strambotti del Poliziano,
le rime del settecento son poemi d’amore, e il signor di Voltaire ha certamente preso una cantonata
nel colpirle con tanto gioioso scherno nelle preziose. Poesia d’amore? No, signori miei. L’amore è
verità. Le parole d’amore son gonfie di sangue e di gioia, di purezza semplice e di festosa follia,
somigliano al balbettamento dei bambini e al grido delle aquile, e non saranno mai delle cosine così
7
Il nome dell'autore inglese viene così storpiato lungo tutto l'articolo; qui lo si è corretto d'ufficio.
3.2.2/40
carine, così assennatine, così stupidine, leccate, profumate, pettinate come le bambole delle
signorine sole. Io li prenderei a schiaffi, io, due innamorati che perdessero il loro tempo in
accademie di quel genere. Provate un po’ a far l’amore sul serio!...
Messa da parte, dunque, o ridotta ai suoi termini precisi la favola dell’immortale poesia di
Shakespeare, in Giulietta e Romeo, veniamo al fatto specifico dei personaggi falsati o mutati. Un
critico ed autore di un gioiello di libretto intitolato con il nome di una vera bestia feroce8 accusava
Arturo Rossato d’aver fatto di Tebaldo «un tipo da basso fondo civile; un facchino bestialissimo; un
maleducato che grida parolaccie da trivio senza nessun rispetto». In Shakespeare – gridava
trionfalmente quel critico – non c’è traccia di tanta villania! In Shakespeare un tipo così villano non
esiste!... Vediamo. Apriamo il volume dell’allegro comico di Stafford. Ecco. Atto terzo. Scena fra il
Capuleto padre e Giulietta, legittima figliola. «Padre – supplica Giulietta – ascoltatemi. Vi prego in
ginocchione!». «Scostati – risponde gentilmente il padre – e preparati alle nozze. Se ti rifiuterai ti
trascinerò all’altare, per i capelli, sopra un graticcio. Via di qua, clorotica carogna! Al diavolo,
sgualdrina! Lungi da me, bagascia! Faccia di sego!...» E poiché la madre presente interviene, il
cavalleresco Capuleto la fa tacere con questa frase che, ai tempi nostri, giustificherebbe un divorzio
in piena regola o un paio di corna più che mai regolari: «Taci, stolida vecchia! Va al diavolo,
insensata!»
Il Tebaldo di Arturo Rossato (che ha voluto in quel personaggio rappresentare tutti i Capuleti)
parla più educatamente, siamo giusti! È più umano. Più buono. Si commuove, perfino... Ed allora di
quale falseria lo si accusa?... di avere soppresso un padre sconcio che dà della carogna alla figlia in
presenza della madre?... Di non aver fatto tesoro di tutte [le] lubriche porcherie di una Nutrice che
sembra uscita da una casa da tè? di non aver raccolto le filosofiche e luride dissertazioni sull’amore
di Mercutio? Via, signor Direttore, Arturo Rossato sarebbe stato fedele a Shakespeare ma poi ne
avrebbe arrossito... E sì che non è né un mulo né una donzella... quando fa all’amore.
Ho divagato anch’io e ritorno ad Ottone Schanzer, il quale, in sostanza, sostiene che
Shakespeare non si può musicare. E cita, a sostegno di questo suo paradosso, l’Otello ed il Falstaff
di Verdi. Secondo Schanzer, queste ultime opere del vecchio di Busseto non sono riuscite per colpa
di Shakespeare, mentre – puta caso – con la Forza del Destino, i Masnadieri, l’Attila e i Vespri
Verdi ha creato de’ capolavori. Io, che non me ne intendo, regalerei tutti i Vespri, gli Attila, le
Forze del Destino, i Masnadieri ed anche il Nabucco per il quarto atto dell’Otello e per quattro
battute sole di Falstaff. Io. Ma io devo essere un bell’ignorante. In ogni modo, dissento
perentoriamente dall’affermazione paradossale di Ottone Schanzer. Ogni lavoro drammatico che
abbia in sé elementi di poesia e di emozione si può musicare: basta avere in corpo della musica. La
verità è invece che da trent’anni a questa parte la musica italiana e non italiana si è baloccata con le
sartine, con le cocottine, colle francesine, giapponesine, e con altre creaturine simili alle quali
bastava mettere fra i capelli due battute di piedigrotta, in bocca un valtzerino da carillon e nel cuore
una piccola tisi galoppante cum judicio, per cavare dei tremiti dall’ombellico delle signorine per
bene e trarre delle lacrimette dagli occhi di portinaie in riposo domenicale. Qual maestro, qual
poeta avevano osato, fino a ieri, di scrutare le veraci anime delle vere creature del genio? Chi si era
curvato – anche un solo istante – sull’anima tormentosa e tormentata di Re Lear, sulla bocca dolce e
sospirosa di Miranda, sul sorriso arguto di Puck, o sul volto, disperato e cadaverico, di Machbet
[sic]? Troppa fatica, diamine!... Cattivo gusto!... Roba antiquata!... E per giustificare questa piccola
viltà, questa impotenza pietosa, questo servilismo al successo e alla bottega, si è inventata la
storiella «delle opere complete del genio», dei poemi che non si possono musicare, di iettature che
non esistono e di soggetti che non si fanno!... No, caro Schanzer. Si fanno. Basta saperli fare. Che
Arturo Rossato non abbia saputo fare Giulietta e Romeo non vuol dire niente, ma il poema Giulietta
e Romeo si può fare: tanto è vero che Paolo Mulè ne sta cavando un altro libretto per la musica di
Bruno Barilli. (In bocca... al lupo!) Né bisogna fare un rimprovero al Rossato se ha soppresso dei
personaggi in Giulietta come ne ha soppressi – molto lodevolmente – nella Tempesta e nella
Bisbetica. Ma che ne faceva, un poeta, che ne faceva, un musicista, di quello stupidissimo Frate
Lorenzo, iettatore in tonaca ed in barba, senza un lampo di passione o d’intelligenza? Ma quello
8
Allusione a F. P. Mulè e all'opera Al Lupo!
3.2.2/41
avrebbe accoppato l’opera, come ha accoppato Giulietta e Romeo! Perché se non c’era lui, Giulietta
non avrebbe preso il narcotico e Romeo non si sarebbe avvelenato... E veniamo, infine, a Giulietta.
Ottone Schanzer dice: «La Giulietta di Rossato è una donna amante, fiera e gelosa del suo amore,
ma non è lo specchio dell’innocenza, gettata senza difesa in preda al destino bieco e feroce».
Lasciamo da parte il fior dell’innocenza e la figuretta «soave e puerile». Una figliuola che si sposa
segretamente, che riceve il suo amante – sia pure dopo il relativo sacramento – in camera sua e ci si
corica – sia pure legalmente – al fianco, sarà una brava ragazza, un’ottima moglie, una donna
simpatica, ma nego che sia «una figura soave e puerile» e lo «specchio dell’innocenza», come
vorrebbe Ottone Schanzer. No. Giulietta è semplicemente una fanciulla innamorata. Nel primo atto
di Rossato – come in quello di Shakespeare – ciarla, sorride e sospira, ma negli atti successivi – in
quelli di Shakespeare e di Rossato – diventa precisamente una donna «fiera, amante e gelosa del
suo amore». In Shakespeare ella dice (atto quarto): «Salvatemi: o questo ferro, mediator sanguinoso
fra me e le mie sventure, diverrà ancora l’arbitro supremo». In queste parole c’è tutt’altro che la
figura «soave e puerile» che vorrebbe Schanzer! E più oltre, sempre nello stesso atto, continua:
«Sposar Paride? Ditemi di precipitar da quella torre, incatenarmi sulla cima di quell’alta montagna,
chiudetemi la notte in un cimitero, copritemi colle ossa dei morti, ma non ditemi di vivere lontana
dal mio adorato amante». Specchio dell’innocenza, questo linguaggio? Linguaggio di creatura
soave e puerile? A me – che non me ne intendo – sembra invece il linguaggio e lo specchio d’una
donna amante, fiera e gelosa del suo amore. Deh!... quante cose si imparano... leggendo i testi sacri
conosciuti, come la Divina Commedia, attraverso i giudizi altrui! Ottone Schanzer conclude il suo
articolo dicendo: «Arturo Rossato ha scritto un bel libretto non ostante le molte inverosimiglianze
dovute in gran parte a ciò ch’egli è voluto ritornare al melodramma di maniera». Io non lo so. Ma io
– che non scriverò mai né un verso né un libretto dovessi vivere cent’anni – non esito a dire che
Arturo Rossato ha scritto semplicemente un bel libretto, non ostante le molte critiche dei critici che
se ne intendono. Cito due fatterelli di cronaca soltanto.
Anno 1921. Roma. Teatro Valle. La Compagnia Niccodemi rappresenta Giulietta e Romeo,
tragedia immortale dell’immortale Guglielmo Shakespeare. Fiasco. L’autore non è stato fischiato
perché aveva avuto la prudenza di morire cinquecento anni prima.
Anno 1922. Roma. Teatro Costanzi. L’impresa Mocchi e Carelli dà la prima di Giulietta e
Romeo di Arturo Rossato e di Riccardo Zandonai. Successo.
Io sarò un imbecille. Ma... me ne vanto!
Milano, 22 marzo 1922.
ARTURO ROSSATO
406
Abbiamo pubblicato volentieri questa risposta del Rossato ad alcuni dei competenti giudici del
suo libretto «Giulietta e Romeo» perché per noi coesistono con disponibilità di armi uguali il
diritto alla piena libertà di critica di un’opera ed il diritto nell’autore di essa a difendere la sua
creatura.
Pur troppo, nel caso in discussione, Ottone Schanzer, F. P. Mulè9 ed A. Rossato sono in conflitto
di idee, conflitto che si è accentuato quando dall’enunciazione generica di una tesi sono passati
alla particolare enumerazione casistica. Per noi Otello e Falstaff sono da annoverarsi fra i
capolavori che il genio musicale non soltanto di G. Verdi ma di tutto il mondo e nelle epoche più
lontane abbia creato. E affermando ciò riteniamo di non fare alcuna offesa a quell’altro genio, al
genio di G. Shakespeare, che diecine e diecine di generazioni di poeti, di letterati, di eruditi, di
artisti d’ogni paese hanno collocato su di un piedistallo di gloria dal quale a farlo discendere di un
millimetro non bastano venti righi di prosa polemica e sia pur vivace di un giovane librettista.
Peraltro dobbiamo constatare che lo scritto dello Schanzer, provocando al Rossato la risposta
che questi non scriverà più mai né un verso né un libretto dovesse vivere cent’anni (per conto
9
Sulle posizioni espresse da Francesco Paolo Mulè nel suo articolo su «Il mondo» (16.2.1922), si veda sopra il n. 190.
3.2.2/42
nostro non riteniamo valida questa specie d’ipoteca sul futuro poetico abbastanza remoto) ha
implicitamente assodato che esso non attende alle annunziate due riduzioni shakespeariane, per
musica, della Tempesta e della Bisbetica domata.
Inoltre, a quello che il Rossato ha detto riferendosi alla critica del valoroso collega F. P. Mulè
del giornale «Il Mondo» riteniamo di dover obbiettare che [se] a un padre non è lecito, se non
bello, assumere verso una figlia linguaggio irato, violento, non così ad un cugino qualsiasi, come
nel caso di Tebaldo, verso una cugina. Comunque ci sembra che lo stesso Rossato abbia finito col
dar valore alle osservazioni fatte dal Mulè sulla figura di Tebaldo allorché quegli confessa d’aver
voluto in tale personaggio rappresentare tutti i Capuleti. Tebaldo, così, non è più un uomo ma
un’astrazione, un personaggio drammaticamente arbitrario, ciò che ha appunto affermato il Mulè
nella sua critica.
Ed a proposito di quest’ultimo e del suo libretto Al Lupo! osserviamo che il Rossato si sarebbe
espresso forse con parole diverse se avesse saputo ciò che noi sappiamo, cioè che quel libretto
piacque tanto ad Arrigo Boito, che il grande e compianto artista lo propose per essere musicato a
Casa Ricordi, che il titolo originario di tale libretto era Cacce feudali e che lo stesso Boito suggerì
di sostituirlo con quello attuale di Al Lupo!
Quanto, infine, all’affermazione che F. P. Mulè si accinge a scrivere anch’esso un libretto su
Giulietta e Romeo, di vero c’è questo: che il collega di «Il Mondo» non attende ad alcun libretto e
per la nuova opera del fratello Giuseppe è stato lui ad indicare a Casa Ricordi il nome di Ettore
Romagnoli. Giuseppe Mulè, infatti, sta componendo la musica dell’opera Dafni su libretto di E.
Romagnoli.
(N. d. D.)
407
S. Ruberti, “Giulietta e Romeo” e la critica musicale, «Musica» XVI/4, 28.2.1922 - p. 1, col. 3-4 /
p. 2, col. 1-2
La nuova opera di Riccardo Zandonai ha suscitato – com’era da prevedersi – discussioni critiche
vivaci e appassionate. Indubbiamente il maestro trentino aveva dato finora buona prova della sua
alta capacità creativa e delle sue qualità di forte sinfonista; Conchita, Melenis, Francesca da Rimini,
Primavera in Val di Sole, Patria lontana, ecc. rappresentano una mèsse artistica d’importanza non
lieve, specie per un giovane compositore. Riesce perciò spiegabile il fervore della nostra critica, e si
giustifica pienamente la disamina lunga ed accurata che quasi tutti i giornali italiani hanno fatto di
«Giulietta e Romeo».
Ma quello che non si spiega e non si giustifica è il tono acre ed aggressivo che due critici romani
hanno adoperato nella recensione della nuova opera.
Uno – togato giudice d’arte in un giornale del mattino, autore di melodrammi e musicologo10 –
quasi svegliandosi dal letargo in cui era caduto dall’inizio della stagione d’opera al teatro Costanzi,
dove si adagiava pigramente in una poltrona «che rientra nella giurisdizione territoriale» degli
ottoni, dei timpani e della gran cassa, improvvisamente si è scosso ed ha scagliato tutti i suoi
fulmini terribili contro Zandonai e – caso spiritosissimo! – contro il Governo che «appoggia
autorevolmente il programma di decadenza del nostro teatro lirico».
Ora, se è ammissibile dire male di un lavoro, ché la critica deve avere la più ampia libertà di
indagine speculativa, è doveroso d’altra parte spiegare perché di tale lavoro non si possa dire bene.
La stroncatura, anche quando provenga da una candida serenità spirituale (!) deve avere come
substrato la disamina completa dell’argomento o dell’autore sottoposto al torchio critico,
presuppone uno studio penetrante e minuzioso, un profondo interessamento, sia pure demolitore, ed
esige una esposizione chiara di tutti gli elementi che hanno determinato la sfavorevole impressione.
Invece il ricciuto critico del giornale del mattino non ha nemmeno tentato di chiarire ai suoi
lettori le ragioni per le quali egli riteneva pessima la nuova opera, ed ha giustificata la brevità del
10
Bruno Barilli (cfr. n. 194).
3.2.2/43
resoconto con l’abitudine disperata di scrivere la cronaca in fretta, nel timore di non fare in tempo
per l’impaginazione del giornale.
Francamente, un critico che si rispetti e che intenda rispettare i suoi lettori deve disporre con
maggiore accorgimento il suo lavoro, in modo da poter informare seriamente e compiutamente il
pubblico sulle qualità negative o positive di un nuovo melodramma; e il suo accorgimento deve
rasentare la scrupolosità se si tratta di giudicare l’opera di un autore di valore artistico non comune.
Non è permesso ridursi a scrivere le proprie impressioni in furia e dopo la prima
rappresentazione, quando della «Giulietta e Romeo» si sono fatte tante prove parziali di
palcoscenico, di sala e d’orchestra, quando alla vigilia dello spettacolo si è data la prova generale in
costume (prove tutte alle quali il critico in questione è stato ben notato presente!) e quando si
poteva fare una... escursione su per la partitura o, per lo meno, sulla riduzione accurata per canto e
pianoforte.
E poi, parlare di tromboni che si azzuffano, di trombe che s’inerpicano sugli acuti, di timpani
che si gettano ruzzoloni, è cosa faciletta anzichenò, ed è forse, per un profano sbadato che legge, un
pezzo giornalistico di effetto sorprendente; ma, per chi voglia riflettere soltanto che con tali frasi, di
una proprietà critica discutibile, si determina il valore di un artista che ha dato al teatro lirico una
gemma quale la «Francesca da Rimini», questo modo di recensione fa correre la mente a qualche
segreta causa di dispetto, a qualche imponderabile ragione di risentimento personalissimo
dell’arruffato giornalista. E difatti a simile conclusione si deve necessariamente addivenire quando,
nel proseguire la lettura dello scoppiettante critico, dopo chissà quali altri affettuosi e fraterni
tentativi per risparmiare i propri strali, si è deciso perfino a frugare «con gli sguardi e con la punta
del bastone in ogni angolo di quest’opera nella speranza di scoprire un documento
d’identificazione» sebbene abbia sentito «un lezzo intollerabile venir su dalle rimasticature
infracidite che coprivano a mucchi tutto il fondo del lavoro».
Capite: l’opera di Zandonai emana lezzo e non può essere frugata che con la punta del bastone!...
No, egregio musicista e musicologo; non si può e non si deve parlare così quando si conosce,
non fosse altro, la «Francesca», quando veramente la si conosce per averla sentita molte volte, per
averla studiata sulla partitura, per averla sia pure sonata alla men peggio sul pianoforte e
canticchiata, magari stonando, a mezza voce; non si può, arguto e caustico critico, definire
Zandonai un «uomo senza fantasia, e la più completa impersonalità dell’arte» quando un artista ha
dato tanta prova della sua cultura e della sua potenza creativa. Bisogna accingersi a criticarlo con
grande circospezione, con serenità severa e con una buona scorta di ragioni plausibili; altrimenti si
corre il rischio di far pensare male, molto male, del critico-autore di melodrammi ancora in attesa di
rappresentazione.
L’altro critico di cui abbiamo fatto cenno in principio delle presenti note11, pontifica in un
giornale della sera, e al contrario [ ] si è mostrato sveglio e attento [ ] delle alterne vicende
della stagione teatrale e sinfonica di quest’anno. E, fino a quando si è limitato a fare la cronaca
approssimativa degli spettacoli, con quel tanto di buon senso artistico che può avere ogni discreto
appassionato spigolatore di letteratura musicale, senza eccessivo sentenziare sul valore intrinseco
delle opere, e ripetendo con parole audaci le polemichette del foyer, abbiamo quasi consentito con i
suoi articoli coraggiosi. Ma quando si è voluto lanciare nell’agone con la consueta baldanza
verbosamente apocalittica per stroncare non la esecuzione di un’opera ma l’opera stessa, ed ha
tentato ancora una volta il sistema comodo della critica “a braccia” dando scudisciate e lanciando
anatemi, ci siamo sufficientemente accorti che il campo della critica musicale non è troppo adatto
per le di lui attitudini diagnosiche.
Perché, dire che Zandonai “manca di pathos sentimentale o tragico” e che egli non fa che “della
imitazione contorta dell’estetica mascagnana” è veramente un non senso!
Legga bene, se ne è capace il poliedrico scrittore, la produzione del maestro trentino, o meglio se
la faccia eseguire e con pazienza, con molta pazienza però, l’ascolti, e vedrà che l’ombra e la luce
riescirà finalmente a trovarle, e che potrà provare anche – dopo un discreto periodo di preparazione
musicale – delle emozioni finora a lui sconosciute, e pur tanto, tanto dolci!
11
Non è chiaro a chi si alluda.
3.2.2/44
Poiché – e questo mi permetto dirlo, in linea di massima, a tutti coloro che non avendo una
solida base di competenza tecnica vogliono criticare in fatto di musica – la musica, al pari della
poesia, della pittura, dell’architettura, non è arte popolare. Come il popolo non può perfettamente
capire Dante o D’Annunzio e resta indifferente dinanzi ad un quadro di Raffaello o dinanzi alla
bellezza di Palazzo Farnese, così non ha capito Wagner, Debussy, Strauss e Verdi del Falstaff.
È necessario che la commozione artistica si prepari, gradatamente, come riflesso di studi,
d’indagini, di meditazioni e di audizioni. Solo allora si potrà parlare di vero intendimento d’arte; in
tutti gli altri casi vale meglio rassegnarsi a restare nel dominio della canzonetta, dell’operetta o del
ballo coreografico tipo Marengo [sic]; ché nemmeno il ballo russo – quello autentico – e che si basa
su Stravinsky e Borodine potrà scuotere la sensibilità dolciastra del pubblico grosso e facilone e dei
critici più faciloni ancora.
3.2.2/45
I cavalieri di Ekebù
408
Tancredi Mantovani, [Rassegna musicale], «Nuova antologia» LX/1274, 16.4.1925 - pp. 430-3
[...]
Ultima delle “novità” di questa stagione lirica, sono apparsi tra una viva attesa I Cavalieri di
Ekebù di Riccardo Zandonai, rappresentati successivamente alla “Scala” e al “Costanzi”. Chi non
conosce il romanzo della scrittrice svedese Selma Lagerlöff intitolato La leggenda di Giosta
Berling si sarà chiesto, anche dopo la lettura del libretto o dei sunti di esso, chi siano questi novelli
carneadi, pomposamente designati dal titolo altisonante di un fantastico ordine equestre. Ebbene
sono dodici naufraghi della vita, artisti mancati e aristocratici ridotti al verde, ambiziosi delusi e
gentiluomini avariati che Margherita Samzelius, la Signora del castello di Ekebù, proprietaria delle
ferriere che costituiscono l’unica ricchezza di quella regione, ha raccolti e abituati a lavorare nelle
fucine, nobilitandoli con un imaginario titolo cavalleresco. Tra costoro viene ospitato Giosta
Berling, un prete che sciupa la gioventù e l’intelligenza con l’ubriachezza; e il vizio sta facendo tali
progressi in lui che abbandonato l’ufficio religioso e ridotto all’ultimo grado dell’abbiezione si
sarebbe soppresso col suicidio, se non fosse giunta in tempo a salvarlo la Signora di Ekebù, la
Comandante, come nel libretto viene denominata.
La sera di Natale i cavalieri si riuniscono per far baldoria, e tra loro si è insinuato Sintram, che è
invido della ricchezza di Margherita e della prosperità della regione. E qui comincia il fantastico;
perché in quella terra popolata di spettri e di genî malefici Sintram è il più potente: è il Demonio in
persona.
Costui dipinge a foschi colori la figura morale della Comandante, e finisce col promettere ai
cavalieri la proprietà delle ferriere se per un anno intero abbandonando le fucine non penseranno
che a godere tutto ciò che la vita può offrire. Il patto è concluso e mantenuto; tanto più che
Margherita è costretta a lasciare le ferriere di Ekebù. Ma la rovina comincia a manifestarsi; la folla
affamata insorge, minaccia, così che i cavalieri, comprendendo il loro torto, invocano il ritorno
della Comandante. E questa torna in fatti, ma in fin di vita, ancora in tempo tuttavia per infondere
nei suoi protetti la volontà del lavoro, in cui unicamente risiede ogni forza morale e ogni felicità. I
fuochi delle fucine allora si riaccendono, le incudini risuonano allegramente, il maglio riprende il
suo ritmo possente per non interrompersi più.
Tale nelle sue linee generali e nei caratteri salienti la trama della Leggenda di Giosta, della quale
Arturo Rossato ha compendiato la frammentaria materia episodica nei quattro atti e cinque quadri
di un libretto, attenendosi a quelle forme tradizionali che sono pur sempre seguite nel nostro
melodramma. In questo adattamento del romanzo alla scena il librettista si è trovato indotto a
sfrondare episodî, ad eliminare personaggi o ad alterarne altri, come Anna, la dolce figlia del
satanico Sintram, che, ridotta a compendiare in sé le varie donne amate da Giosta, finisce per non
rassomigliare ad alcuna di quelle e neppure a se stessa; e peggio poi avviene di Giosta Berling, che
nel romanzo è «il più forte e il più debole degli uomini», eroico e triviale, beone volgare e seduttore
raffinato, mentre nel libretto non appare altro che un tenore tal quale come tutti i suoi antenati del
vecchio melodramma.
Non intendiamo tuttavia di escludere che la convenzionale riduzione scenica del Rossato, per
quanto arbitrariamente lontana dall’originale, non offra quadri e situazioni rispondenti al concetto
comune della teatralità e svariati elementi di carattere lirico, fantastico o grottesco; dei quali il
compositore ha saputo valersi con quella provetta e perspicace abilità ch’egli ha raggiunto in grado
eminente. Tuttavia nei brani lirici di questo nuovo spartito lo Zandonai ha accentuato, a scapito
della sua personalità, quella tendenza all’enfasi dell’espressione che già aveva cominciato a
manifestare in Giulietta e Romeo: si direbbe che ora più di prima egli si ricordi d’essere stato
l’allievo di Pietro Mascagni... Dove invece l’arte tutta personale del Maestro non si smentisce né
devia è nelle pagine che coloriscono l’ambiente, nei tocchi eloquenti che delineano i personaggi:
sono luci iridescenti od ombre cupe, sono toni delicati o arditi, profusi con mano maestra in gustosi
quadretti di genere. Noi amiamo la musica di Riccardo Zandonai in questi brani della sua prima e
3.2.2/46
schietta maniera, che pur nella partitura dei Cavalieri di Ekebù hanno felici e non infrequenti
ritorni, come quando i lenti ritmi ed i gravi timbri orchestrali evocano la malinconica visione della
nuda campagna sonnecchiante sotto la neve, ovvero nella caricaturale sfilata dei cavalieri, o ancora
quando la diabolica figura di Sintram serpeggia tra sinistri bagliori. In modo più completo la perizia
raffinata dell’armonista e dello sperimentatore emergono nella tipica scena del teatrino, che è
preceduta ed accompagnata dal grottesco commento di un’orchestrina apparentemente stonata
nell’urto dissonante dei corni e dei violini. In altri episodi l’ispirazione dell’artista si espande con
calore di accento spontaneo ed avvincente; sopra ogni altro brano nel nostalgico canto del Natale, in
cui il violino del rapsode Licrona [sic] intreccia una languida melopea. Qui il compositore ha
trovato uno dei suoi momenti più ispirati e commossi: il sentimento spontaneo e profondo ha una
immediata potenza comunicativa.
Nella rapida e fortunata carriera del fecondo Maestro trentino, che iniziatasi con la non fallace
promessa del Grillo del focolare ascende alla sua più geniale e completa manifestazione nella
Francesca da Rimini, questo settimo spartito costituisce un’affermazione indubbiamente
significativa.
Se si dovesse determinare il valore di un’opera a base di confronti, sia pure con altre dello stesso
maestro, si seguirebbe un gretto criterio di giudizio critico. Quale si sia il posto che nella
produzione di Riccardo Zandonai spetta a questa sua nuova partitura, essa ha in sé pregi
d’ideazione e di tecnica che giustificano perfettamente i brillanti incontrastati successi di Milano e
di Roma, nei quali è lecito prevedere il lieto esordio di una lunga serie.
409
Renato Mariani, In vita meritava molto di più, programma di sala del Teatro dell’opera – gennaio
1954
Il teatro musicale di Riccardo Zandonai, con i suoi risultati assolutamente positivi, con
l’alternarsi di episodi più o meno imbroccati e sia pure con la presenza di frammenti trascurabili, ha
una attraente varietà che permette all’esegeta odierno e di domani nuova valutazione e, in alcuni
casi, rivendicazione di aspetti differenziati e differenziabili, di tratti ed atteggiamenti che riflettono
una gamma espressiva svariata e versatile. Il tentativo di formulare una graduatoria apparirebbe,
adesso, vano ed intempestivo. Si tratta qui, se mai, di inquadrare all’ascoltatore leale e coscienzioso
la possibilità di un miglior apprezzamento dell’opera «I cavalieri di Ekebù» che fu probabilmente –
non lo si riferisce per mero pretesto occasionale – lo spartito prediletto del musicista trentino.
Opera d’impegno
Opera di maturità – creata oltre l’avvio della quarantina –, opera d’impegno anche in rapporto
alla trama scenica prescelta. Si comprende, quindi, che al suo primo apparire nel 1925 il lavoro
zandonaiano sia stato oggetto di qualche riserva facente capo, più che altro, alla sensazione di un
divario tra la portata del soggetto e l’indole del musicista. Divario che la valutazione critica
favorevole vide attenuato, se non eliminato, in una precisa attitudine di Zandonai a dipanare, a
proprio uso e consumo, ossia ad uso e consumo delle proprie forze operistiche, i caratteri dei
molteplici personaggi e il fuoco e l’incisività di situazioni sceniche addirittura prepotenti. Insomma
parve che Zandonai avesse affrontato un argomento tale da sopraffare, se non da disperdere, i tratti
di un temperamento musicale felicemente adeguato in ordine al segno sensuale di «Francesca da
Rimini» od alla giocondità appassionata di altri soggetti semplici, gentili, cordiali.
Aggiungiamo pure altri appunti di valore strettamente musicale. La constatazione critica
autorevole di chi credette erroneamente rintracciare nei «Cavalieri di Ekebù» un aperto atto di fede
mascagnana, quasi che l’affetto che Mascagni ebbe per Zandonai presupponesse, o prima o dopo,
questo omaggio inammissibile. O l’asserzione, meno coraggiosa ma più cauta, di altri che ritenne
parlare, a proposito della nuova opera di Zandonai, di un gusto che da Giordano aveva tratto certa
magniloquenza melodica pur abilmente e raffinatamente saporita con salse piccanti e corrosive.
Spunti critici, questi, ai quali si pone mente non già per accertarli oggi, favorevoli o no che ci
3.2.2/47
possano sembrare, ma per ribadire invece la difficoltà di una collocazione esegetica dell’operato di
Zandonai. Tanto più quando, uscendo del tutto dai limiti del documentabile e dell’ammissibile, si
veda l’operista trentino con la lente d’ingrandimento della passione wagneriana e se ne faccia,
chissà poi perché, un episodio della serie degli epigoni nostrani: quella di Catalani, magari, di
Smareglia e di Montemezzi.
Se proprio ai «Cavalieri di Ekebù» si addossarono, quasi trenta anni or sono, tanti fermenti
critici, ciò sta a dimostrare per lo meno che la sostanza dell’opera (e di altre dello stesso Zandonai
giunteci dopo non si potrebbe dire lo stesso) era impegnativa e che la risultanza definitiva, pur
ammettendone qualche deficienza ed appannamento, mostrava un volto importante, ragguardevole,
consapevole, oltreché – come sempre in Zandonai – dignitosissimo, aperto, perfin troppo onesto.
L’allineamento dei personaggi
Fare un eventuale processo al gusto del compositore o a quello del testo letterario che lo ispirò,
indagare in merito al peso della sceneggiatura che ne provenne ed allo spirito complessivo della
vicenda significa, praticamente, considerare l’allineamento di personaggi dei quali la consistenza
lirica fu per Zandonai, come per alcuni suoi colleghi coetanei, croce e delizia di tutta una
produzione musicale, dati di fatto di una riuscita o no di qualificate o inqualificabili esperienze
melodrammatiche. I personaggi dei «Cavalieri di Ekebù» hanno, tirate le somme, di che interessare
l’ascoltatore. Varietà di indoli e di umori, nella singola fattispecie, entro una già dichiarata varietà
di stimoli nella complessiva produzione operistica di Zandonai.
Potremmo iniziare la rassegna indicando la figura che, a cose fatte, sembra affiorare come la più
sentita e completa: Anna, assiduamente circonfusa da una soave gentilezza di sentimenti e di
anèliti; quasi una Giulietta, meno provata e delusa, infantile e sognante nelle trepidazioni melodiche
alimentate da un tipico fervore espressivo entro un giro di ripercussioni melodiche che non è
esagerato identificare come caratteristiche dell’autore. So anche io che Anna non è la protagonista
dei «Cavalieri di Ekebù» e so anche io che la figura predominante – Giosta – resta spesso e
volentieri sùccube di una cantabilità riferibile a quella della sua innamorata. Lo dimostra il
fraseggio, fin dall’esordio; ne dà atto il materiale cantabile nei densi monologhi che pur contengono
(come nel commosso racconto dell’atto 1°) grate schiarite canore; lo conferma l’azione dialogata
con Anna da cui si prospettano pagine di pregevole fattura e di effettivo rilievo lirico, assai
abilmente calibrate sopra alcuni nuclei melodici che del mondo espressivo di Zandonai detengono
un non so quale odore, una sottile malinconia, una tenerezza maliosa, sfaldata e diluita. Né
mancano rigogli melodici di forte vigore – costantemente entro un ambito contemplativo – che il
musicista articola, sàgoma, giustappone in vista di un effetto musicale che alla fine fornisce la sua
impressione.
Camminiamo a ritroso: da Anna a Giosta arriviamo alla protagonista veridica, la Comandante.
Raffigurazione ardua ed insolita – non soltanto in rapporto alle consuetudini melodrammatiche di
Zandonai –; una ribelle piena di cuore, una ostinata creatura che alle ruvidezze e alle rudezze delle
proprie passioni aggiunge uno schivo senso di carità, di misericordia, di appagamento nel bene e
nella felicità altrui. Difficile era per Zandonai omogeneizzare il personaggio, conservarne il piglio e
la fierezza, le distensioni e gli abbandoni – urgenti e suadenti, anche questi – oltre l’impianto
generale. Zandonai non poteva operare in materia se non in un modo indubbiamente efficace di per
se stesso: reprimendo e indurendo il rendimento melodico, accentuando il valore della
declamazione, portando la verbalità alle conseguenze teatrali della trovata e del gesto. Se qualcosa
si è perduto nel procedimento, se il lievito di alcune situazioni è stato sacrificato in omaggio alle
esigenze psicologiche della vecchia donna, occorre dire che il personaggio scenicamente vive e
resiste adeguatamente.
Altre figure s’affiancano alle principali cui si è fatto cenno. Al passaggio di Liecrona il musicista
affida un momento d’intensa poesia (inizio atto 3°), dando vita ad una scena che, se ha qualche
punto di contatto con analoga situazione patetica pucciniana – atto 1° di «Fanciulla del West» –,
s’atteggia, in quanto a invenzione melodica, con un vocabolario proprio. Del resto nei «Cavalieri di
Ekebù» più d’una volta l’incanto di certe atmosfere ambientali – indubbiamente efficaci nel tratto
allusivo e nelle combinazioni orchestrali – sorge dalla ripercussione affettiva degli stati d’animo del
3.2.2/48
personaggio, quasi che l’autore abbia saputo operare induttivamente ossia giungendo dalla
captazione di un sentimento e di una pena singoli ad una raffigurazione determinata con più largo
respiro.
Leggendo lo spartito
Ecco l’introduzione dell’atto 1° gustosamente agganciata all’arrivo di Giosta: un tocco che
ambienta opportunamente il luogo e il particolare momento sentimentale. Una figurazione ritmica
individuata innesta all’atmosfera strumentale trasognata e trepida l’entrata della Comandante alla
quale Giosta confida la propria angoscia col monologo «Bro: la chiesetta triste» articolata in un
serrato fraseggio che punta al «largamente con anima» sulle parole «...e dalla terra». Di bella
efficacia verbale il racconto della donna, asciutto e contrito, all’avvio «Non mi ha perdonato». Poi
l’inno di Ekebù viene prospettato con diversi ingredienti strumentali fino alla perorante iterazione
«Vecchia terra d’Ekebù» che conclude effettisticamente l’atto.
Anche il 2° atto s’apre con una situazione corale grata al senso armonico di Zandonai, pervasa
da una vivacità ritmica indovinata: riecheggiamenti melodici di folla che s’attutiscono all’episodio
della consacrazione di Giosta durante il quale prende corpo la figura di Cristiano. Il duetto tra Anna
e Giosta si fissa sopra movenze di pronta condiscendenza melodica come alle parole della fanciulla
«Vivevo umile e sola», riprendendo lungo la scena della rappresentazione, al caldo sboccio
cantabile di Giosta «E piangerò piano piano», ed esaurendosi, non senza lusinghe di efficace
teatralità, al commosso e felpato finale.
Il 3° atto è senza dubbio il più ricco musicalmente. L’ambiente della fucina è vigorosamente
espresso in orchestra e nelle affaticate interiezioni solistiche. Il frammento di Liecrona dà luogo ad
un momento di fervorosa compunzione cantabile che si ripercuote nelle fruscianti soavità
strumentali con un eloquio che porta sensibile la cifra musicale di Zandonai. Poi il monologo della
Comandante sulle parole «Andrò... conosco il mio destino» è pagina di forte sagomatura dove la
statura del compositore s’impone in modo assoluto in virtù di quei segreti insondabili che nascono
nativamente e schiettamente dalla felicità di una risorsa, dalla prospettiva ingegnosa e magari
geniale di coincidenze sentimentalmente azzeccate, di impianti patetici approfonditi e sofferti.
L’ultimo atto punta sull’episodio introduttivo il cui svolgimento non ha né stanchezza né
rilassamento; la forza del taglio corale e il vigore della folla, movimentata dinamicamente entro
margini fonici adeguati, sono i càrdini di una trattazione di durevole prontezza d’effetto. Dove
s’erge in contrasto, poi, lo squadrato augurio di Giosta «Giusto Signore» e il successivo fraseggio
«Lasciarmi? Tu?» in adesione al canto di Anna. Ancora un forte monologo della Comandante
«Come mia madre» prima che la morte della vecchia donna chiami a raccolta, in urgenza di effetto
sentimentale, tutte le forze del coro e dell’orchestra e lo spartito abbia la sua rude e luminosa
conclusione.
Una parola da ascoltare
Così «I cavalieri di Ekebù» sussistono a dare atto di fiducia, di probità artistica, di serenità di
lavoro.
Consentiamo alla cara memoria di Riccardo Zandonai di beneficiare troppo tardi – oltre un
tremendo e sfortunato destino terreno che sarebbe viltà e colpa dimenticare, che sarebbe
imperdonabile non avere presente – di adesioni diverse.
Lasciate agli uni la predilezione per il 1° atto di «Francesca», fragrante e trepido, fermentato da
una non so qual presaga malinconia; che altri ammiri il malioso senso di struggimento armonico di
una pagina squisita quale l’episodio «Notte a Siviglia» in «Conchita»; che la più aperta e cantabile
melodia del 3° atto di «Giulietta e Romeo» soggioghi altri ascoltatori; che s’impongano «I cavalieri
di Ekebù» per la robustezza della costruzione sinfonica, per il grezzo e nativo eloquio cantabile; che
qualcuno veda infine – e noi siamo tra questi – nella densa e casta asciuttezza del “prologo” di
«Giuliano» il volto vero e segreto, pudico e riposto, di un musicista che meritava in vita molto di
più.
Anche agli artisti, uomini tra gli uomini, il riconoscimento e la gratitudine vanno conferiti finché
siano quaggiù; parecchie volte lo abbiamo ripetuto; è un nostro chiodo fisso. ma oltre la
3.2.2/49
ineluttabilità di un dato di fatto fatale (quella tremenda morte, il 5 giugno del 1944, in Pesaro
sconvolta dalle rappresaglie dei tedeschi in fuga e dagli incessanti bombardamenti; quella morte
elusa, allora, dalla pietà dei più per l’incalzare e il prorompere di avvenimenti troppo catastrofici e
improrogabili), sia per i superstiti – non per lui, ormai schivo di ciò, oltre le soglie dello
Inconoscibile – più consolante che doveroso trarre dalla parola di Zandonai un piccolo, silenzioso
segno di conforto. Sono le parole, anche sommesse, anche sussurrate, degli artisti che aiutano a
vivere. E la parola di Zandonai, in tal senso, ha di che essere ascoltata con pensosa simpatia.
3.2.2/50
Giuliano
410
Giorgio Barini, “Giuliano” di Riccardo Zandonai al “San Carlo” di Napoli, «Italiani pel mondo»
I/2, febbraio 1928 - pp. 229-32 (con un ritratto fotografico di Zandonai e autografo)
Nel novembre del 1908 mi trovavo a Milano per assistere alla prima rappresentazione di una
nuova opera, rappresentazione che, per impreviste circostanze, fu rimandata di alcuni giorni. Stavo
per tornare a Roma, riservandomi di fare a tempo debito una nuova gita a Milano, quando Giulio
Ricordi mi suggerì di profittare del ritardo per recarmi a Torino, ove si doveva eseguire uno spartito
di un giovane musicista ancora ignorato ma che si presentava fornito di doti non comuni di
temperamento e di tecnica, così da far sorgere le più liete speranze di luminoso avvenire. Seguii il
suggerimento: andai a Torino e assistei al “Chiarella” alla prima apparizione dello spartito Il grillo
del focolare, con cui Zandonai iniziava magnificamente quella serie di lavori per cui doveva porsi
in prima linea nella breve schiera dei maggiori maestri italiani. Il valente musicista trentino non
manca mai di ricordare come io lo abbia seguito in tutta la sua carriera artistica, presenziando le
prime rappresentazioni di tutte le sue opere e scrivendone in guisa da avere svolto un completo
studio critico sull’opera sua.
Pertanto, con vera soddisfazione ho assistito ora alle accoglienze festosissime che il magnifico
pubblico del “San Carlo” di Napoli ha fatto al nuovissimo spartito dello Zandonai, «Giuliano», che
assume grande importanza e significato nello sviluppo della attività artistica del Maestro.
***
In una parete di quell’insigne monumento che è la cattedrale di Trento, al di sotto di una finestra
a rosone raffigurante la ruota della fortuna, al di sopra di una serie di pietre tombali in cui sono
effigiati quei vescovi tedeschi che nel trecento e nel quattrocento ebbero colà infausto predominio
(giustamente scrisse Gino Fogolari che quelle pietre «stavano meglio nascoste nell’ombra discreta
della cripta»), si distende come grande arazzo sulla muraglia un affresco – il solo affresco
trecentesco ben conservato nella chiesa – ove è rappresentata la leggenda di San Giuliano
l’ospitaliero nei suoi principali episodi, dalla nascita, col vaticinio funesto, alla uccisione dei
genitori.
Il ricordo di quella visione – sono indimenticabili impressioni dei primi anni – non può non
avere fortemente influito sul maestro trentino, suggerendogli il soggetto per l’opera della sua piena
maturità artistica: né può farsi a meno di ripensare alle parole con le quali termina il celebre
racconto del Flaubert: «Ecco la storia di San Giuliano l’ospitaliero, presso a poco quale si vede in
una vetrata di chiesa, nel mio paese». Non mi par dubbio che l’affresco della cattedrale di Trento
abbia avuto per Riccardo Zandonai significato identico a quello della cetrata della cattedrale di
Rouen per il Flaubert.
A proposito del Flaubert, è da ricordare che il maestro Zandonai, quando le prime volte parlò del
suo lavoro, dichiarò formalmente che il soggetto del suo «Giuliano» era tratto direttamente dalla
«Leggenda aurea» di Jacopo da Varagine e non dal racconto dallo scrittore francese, così come il
libretto di «Giulietta e Romeo» era stato ricavato dalla novella del Da Porto e non dalla tragedia
dello Shakespeare: ma della creazione shakespeariana non mancarono riflessi inevitabili nella
«Giulietta» e nel «Giuliano» si sono introdotti elementi desunti dal racconto del Flaubert. È bensì
vero che Arturo Rossato ha premesso al suo dramma le pagine della «Leggenda aurea» in cui è
narrata la storia dell’Ospitaliero; ma ne ha eliminato l’accenno al fatto che la moglie accompagnò
Giuliano nell’esilio espiatorio: in questo particolare egli segue il Flaubert, ritraendone ragione per
la scena del passaggio dei pellegrini che nell’epilogo dà occasione all’ultimo incontro dei coniugi:
come pure è derivata dal Flaubert la determinazione di quella sfrenata follia sanguinaria da cui
Giuliano è trascinato alla strage di vittime innocenti nella sua passione fierissima per la caccia, che
trova poi riscontro nella atroce strage dei genitori.
Il libretto
3.2.2/51
Le linee del dramma sono segnate con notevole ingegnosa abilità; una cornice, in cui predomina
l’elemento soprannaturale, limita e chiude il tragico episodio umano: sono due atti frementi di vita,
preceduti da un prologo in cui è lumeggiata la figura di Giuliano, fiero, instancabile saettatore di
innocenti creature, abbattuto dalla tremenda minaccia del parricidio, poi consolato dalla promessa
divina del perdono; seguiti da un epilogo in cui l’Ospitaliero è assunto nella eterna gloria.
Il prologo si svolge in una grande selva, tutta vibrante di voci misteriose: sono le voci delle
piante – radici, rami, fronde, fiori – cui si uniscono quelle degli uccelli per levare un inno in lode
del creatore: la luce aumenta di splendore mentre il canto acquista maggiore intensità ed
espansione. Ad un tratto le voci tacciono, si spengono le luci, mentre irrompe Giuliano, tutto invaso
da strana voluttà mentre con le sicure freccie abbatte ogni sorta di augelli e si accanisce contro una
grande cerva che a lungo si sottrae ai suoi colpi, finché è da lui abbattuta coi piccoli che allatta.
Quando gli occhi di fuoco della cerva si spengono, dal buio della selva si leva una voce terribile:
«Tu che mi uccidi... ucciderai tua madre... e tuo padre». Atterrito dalla spaventosa profezia,
Giuliano sente orrore profondo della brutale distruzione compiuta; invoca la divina pietà e promette
di fuggir lontano dal paterno tetto, di non toccare arco e saetta, di farsi protettore di tutti gli oppressi
pur di sottrarsi alla maledizione.
E allora torna gradatamente la luce divinamente pura, le voci della selva riecheggiano; anche dal
cielo discendono voci angeliche per unirsi al cantico degli spiriti della terra, in un solenne inno di
amore sacro: gioiosa promessa di redenzione al peccatore pentito.
***
Ecco nel primo atto Giuliano all’opera: un Barbaro possente asserraglia da un anno la rocca di
Reginella ed ha abbattuto tutti i cavalieri che ne tentarono la liberazione: Reginella, coi suoi,
attende ansiosa l’esito della lotta intrapresa da Giuliano e spera, e teme possa ancora una volta
tornare a galoppo il cavallo con vuota la sella. L’angoscia dell’attesa è acuita dal giungere di una
fanciulla vittima della brutalità del Barbaro, che le ha ucciso i genitori e, folle, alterna lamenti e
danze, lacrime cocenti e risa stridule: quand’ecco si ode il galoppo lontano di un cavallo,
preannunziato da due messaggieri; sale d’impeto Reginella sulle mura e vede alfine il guerriero
vittorioso che giunge; e al canto trionfale succede l’inno dell’amore: Reginella tende le braccia
all’eroe che l’ha salvata, consacrandogli la vita.
La felicità dei giovani sposi è turbata da qualche arcana potenza nemica: Giuliano, al fianco
della donna adorata, talvolta ha momenti di dolore ripensando ai genitori suoi che non deve
rivedere, ed è turbato dagli ululati di una misteriosa belva che si aggira intorno alla Rocca e sembra
voglia ad arte risvegliare nel cuore di Giuliano quegli istinti sanguinari che egli ha voluto sopire ad
ogni costo, incitandolo a rompere il giuramento di non più toccare arco e saetta. L’amorosa donna
cerca lenire il dolore dello sposo; ripete dolcemente la canzone dell’usignolo che egli le ha appreso
e che soltanto i genitori di lui conoscono. Ma la diabolica belva rinnova gli ululati incitatori e
Reginella, affettuosamente premurosa, gli consegna ella stessa arco, freccie, coltello per
distruggere, con la belva, la tormentosa ossessione: lo bacia e ripetutamente lo esorta ad uscire alla
caccia.
Rimasta sola, ripete quasi macchinalmente la prima strofe della canzone dell’usignolo e, con
sommo stupore, ode due voci che si avvicinano continuando il canto: sono due pellegrini, in cui
essa riconosce subito i genitori del suo Giuliano, i soli cui è nota quella canzone: esultante, accoglie
i due vecchi i quali da gran tempo sono in via cercando il figlio; ha per essi cure filiali, vuol farli
rifocillare, li induce a riposarsi nel letto nuziale, che è in una alcova nascosta da una tenda in fondo
alla stanza, e si allontana.
Giuliano, profondamente turbato e atterrito, e dalla tempesta che si è scatenata quando ha
mancato al suo voto, e da misteriose voci maledicenti, torna fremente, come forsennato: si esalta
ancor più vedendo il desco imbandito al quale due persone sedettero: solleva la tenda dell’alcova e
nel letto nuziale vede un uomo al fianco di una donna, che ritiene sia la sua, infedele: impugna il
coltello, si slancia. Rientrando, scorge Reginella che giunge sorridente per dargli la lieta novella; la
spaventosa profezia si è avverata: Giuliano ha ucciso il padre e la madre!
Nell’epilogo troviamo, in un passo montuoso, presso una grotta, Giuliano divenuto Ospitaliero,
che prega: salmodiando, passa una turba di pellegrini, guidata da un Crocifero, che si reca a Roma
3.2.2/52
Santa: una donna si stacca dalla turba, si avvicina all’Ospitaliero e gli chiede pace: è Reginella, che
giunge a lui dopo dieci anni dal giorno funesto. «Giuliano è morto», egli le risponde; e invocando
su di lei la divina grazia e benedicendola la esorta a raggiungere le sue genti.
Rimasto solo, ode una voce alta che lo chiama a nome: è un Ignoto dall’aspetto sofferente:
Giuliano corre a lui, lo sostiene, lo conforta, lo stringe a sé, lo abbraccia, quantunque l’Ignoto gli
dica che muore chi lo tocca: allora la misteriosa figura si trasforma e, dinanzi alla spoglia esanime
di Giuliano, si svela l’immagine di Gesù benedicente. L’anima dell’Ospitaliero redento è salita al
cielo; e dal cielo e dalla terra prorompe il cantico osannante, l’inno solenne all’Amore Eterno, in un
superbo sfolgorio di luci sovrumane.
La Musica
Arturo Rossato ha offerto al musicista un libretto chiaro, plastico, scenicamente organico, dalla
versificazione armoniosa, dalle frasi incisive, ricco di elementi drammatici, di episodi tragici
impressionanti, così da corrispondere assai felicemente al temperamento del Maestro, il quale vi ha
trovato solida trama per intesservi una partitura vigorosamente espressiva e colorita.
Mentre è ancora chiuso il velario e l’orchestra tace, si odono tenui, armoniosi accordi di voci
lontanissime: è il saluto degli spiriti della selva all’Eterno Amore che regge l’universo; in quelle
note è il nucleo iniziale delle laudi che si leveranno al Signore nel prologo e, co, diversa
espressione ritmica, nell’epilogo. Quando si apre il velario e appare la selva in pieno sole, alle voci
misteriose si uniscono armonie vive, col gorgheggiare degli usignuoli, il ritmo insistente del cucùlo,
il frusciar del vento tra le fronde: colorature sonore di vita, che si riproducono mentre Giuliano
impetuosamente compie la strage; il turbinare della tempesta che scuote la selva, mentre fitta
oscurità la invade tutta, si unisce alle paurose voci maledicenti; finché, pel voto solenne del
peccatore pentito, alle voci della selva che risorgono benedicenti si uniscono le voci del cielo, nella
promessa della redenzione, e tutte si fondono in un complesso riboccante di esultanza, mentre le
angeliche trombe squillano sonoramente e si diffonde luce fulgida.
Il prologo, non ostante la varietà dei sentimenti e il loro contrasto fonico ben caratterizzato, ha
nella salda tessitura, nella sapiente condotta, una ammirevole unità organica: stupenda è la
gradazione della intensità delle sonorità strumentali e vocali, e la spezzatura ritmica nella
declamazione musicale di Giuliano, che segue plasticamente ogni manifestazione del pensiero,
afforza lo scorrere fluente dell’onda melodica in cui si diffonde l’esultanza delle schiere celestiali,
degli spiriti della terra, che raggiunge magnifica eloquenza.
***
Nel primo atto, tra gli appelli delle scolte, le voci dell’Arciere e degli altri militi e la significativa
declamazione di Reginella, si diffonde un senso di ansietà, mentre l’intervento di un breve tema
melodico risolvente in un caratteristico gruppetto, nel quale sembra sia racchiuso il germe
dell’intimo sentimento amoroso sbocciato nel cuore della fanciulla e che serpeggia a traverso la
partitura insinuandosi nella trama musicale con grande naturalezza e spontaneità, conferisce al
discorso musicale un senso di unità assai notevole. Efficace è il contrasto tra la dolcezza del canto
della giovane folle e le sue stridenti risate con l’angosciosa danza. Risorge, afforzata, l’ansietà
dell’attesa, e si accentua con crescente animazione tra gli appelli delle trombe, le frasi spezzate dei
messaggieri; si fa più viva la luce del giorno; irrompe la folla, il galoppo sonante di un cavallo si
ode sempre più vicino; al giungere del guerriero vincitore nella lotta feroce, entusiastiche
acclamazioni prorompono tra gli squilli trionfali delle trombe, e le campane suonano a distesa.
Riccardo Zandonai, con la assoluta sua padronanza di tutti i segreti della tecnica, l’ingegnoso
impiego di ogni forza sonora, la sicura intuizione dei timbri meglio rispondenti ad ogni episodio, ad
ogni sentimento, ad ogni aspetto del dramma e dei singoli personaggi, ha ideato e attuato un quadro
di impressionante potenza coloristica e scenica.
La successiva scena, in cui Reginella, rimasta sola con Giuliano, apre a lui il suo cuore e le
anime dei due giovani si uniscono in un bacio, forma nella sua dolcezza profondo contrasto con
l’impetuoso quadro che la precede: è ricca di episodi veramente sentiti e gustosi, come la melodica
frase di Giuliano: «E un dì se al rintoccar della campana», e quella delle due voci all’unisono: «Son
3.2.2/53
la tua fonte dal fresco cantare», che delicati, felicissimi disegni imitativi lumeggiano con suggestiva
efficacia.
***
La prima parte del secondo atto è improntata a malinconia, nel turbamento di Giuliano,
ossessionato dal ringhiare della misteriosa belva che vuol trarlo a rompere il sacro giuramento: un
breve disegno melodico, che inizia l’atto e si ripete senza posa, conferisce alla scena notevole senso
di tristezza, sottolineando foschi presentimenti: la freschezza armoniosa della elegante canzone
dell’usignuolo illumina e avviva l’episodio iniziale, interrompendo la sensazione tragica
incombente, resa più cupa dalle raffiche del mal tempo, dall’urlo provocatore della belva; e torna a
raddolcire la visione scenica partito Giuliano, bene preludendo alla tenerezza ond’è improntato il
dialogo dei genitori di lui con la gentile creatura che gli è sposa.
Ma presto risorge la tristezza nel tragico presentimento di morte: e con lo scatenarsi delle
maggiori energie sonore l’ultima parte dell’atto assume carattere terrificante, fino alla
esasperazione, destando impressione profonda: Riccardo Zandonai ha condotto la scena con
singolare potenza espressiva.
Ecco, nell’epilogo, dopo la fiera tempesta, una calma religiosa, preannunziata da un breve
preludio in cui riappaiono i temi augurali dell’inizio del prologo; sereno è il canto dei pellegrini
salmodianti; e, se pur soffuso di un velo di malinconia, dolce è il dialogo tra Giuliano e Reginella,
sottolineato da ricordi dei temi che accompagnarono nel secondo atto le espressioni della amorosa
donna. Poi, all’apparire dell’Incognito, il dialogo è sostenuto tutto da armoniosi arpeggi in cui
assume ascendente purezza; finché, rivelatasi la sua divina natura, le calanti falangi intonano canti
osannanti, con un crescendo celestialmente luminoso, apoteosi solenne che, se richiama al pensiero
la sacra promessa del prologo, se ne differenzia nell’intima sostanza, ora che la redenzione ha
sorriso all’anima del peccatore, assurta alla gloria celeste.
***
Nel nuovo spartito, l’arte di Riccardo Zandonai appare nella sua più completa e nobile
affermazione: completa per la equilibrata potenzialità creativa, nobile per la visione ideale che lo
distacca da precedenti espressioni meno pure, meno avvincenti e convincenti; nel «Giuliano» le doti
artistiche del maestro si riscontrano assommate e perfettamente equilibrate: limpidezza e
scorrevolezza melodica, che si snoda e plasma con singolare equilibrata giustezza: stupenda abilità
formale, che si manifesta in una armonizzazione ingegnosa, ardita senza arbitrarie contorsioni; in
una strumentazione stupendamente varia e colorita, che lumeggia il quadro scenico con eccezionale
efficacia plastica e dà rilievo scultoreo ad ogni atteggiamento, ad ogni espressione di vita; in una
quadratura saldamente organica, che conferisce ai singoli episodi ed al complesso di ogni atto e
nell’intero dramma significato, carattere unitario netto e preciso, profondamente significativo.
L’esecuzione - Il successo
La nuova opera del Maestro Zandonai è stata presentata la prima volta al pubblico in una
esecuzione ammirabile, tale da porre in piena luce ogni particolare, in una espressione sintetica
completa ed eloquente: la direzione del Teatro “San Carlo” di Napoli ha allestito lo spettacolo in
modo degno dello spartito e della propria rinnovata attività artistica.
Protagonista è stato il tenore Franco Lo Giudice, magnifico per bellezza di voce, arte di canto,
accento, impetuosa animazione, mistica gravità; Matilde [sic] Laurenti, “Reginella”, ha interpretato
con grande finezza e nobile purezza di sentimento il personaggio, rivelando bellissime doti di
cantante e di attrice; Dante Perrone e Tamara Bertacchi, nelle parti dei genitori; Maria Carbone in
quella della Fanciulla folle; Alfredo Auchner, che ha nobilmente impersonato “l’Ignoto”, e gli altri
tutti, hanno molto bene contribuito alla realizzazione dell’opera d’arte.
Il maestro Zandonai ha espresso la sua piena soddisfazione per l’eccellente esecuzione dello
spartito, rilevando come sia stata felicemente rinnovata la massa orchestrale, divenuta omogenea,
flessibile, pronta, atta a rendere alla perfezione ogni particolare della non facile partitura. Il coro,
istruito dal valente maestro Giuseppe Papi, ha assolto con grande sicurezza e anima la sua parte; gli
scenari caratteristici, gli effetti di luce benissimo regolati, l’andamento scenico ottimamente curato
da Ugo Falena, ben coadiuvato da Antonio Rega e Giuseppe Lualdi, completavano il ben riuscito
3.2.2/54
spettacolo che, sotto la bacchetta animatrice dell’illustre maestro-autore e direttore magnifico, ha
proceduto tra la continua ammirazione dell’uditorio, che ha decretato al «Giuliano» e a Riccardo
Zandonai un vero grande trionfo.
3.2.2/55
La farsa amorosa
411
Vito Raeli, Predilezioni attuali degli operisti italiani - Il binomio Rossato-Zandonai e “La farsa
amorosa”, «Rivista nazionale di musica» XIV/298-299, 1.3.1933 - pp. 1911-3
Fatta eccezione di qualche ricorso a personaggi biblici – Dèbora e Jaéle, La Sulamita -, a
personificazioni diaboliche – Belfagor –, a millenari soggetti orientali – La leggenda di Sakuntala –
, a motivi fiabeschi e caricaturali –Belinda e il mostro, Fata malerba, La campana sommersa, Il
diavolo nel campanile, Il re, Il gobbo del califfo, La donna serpente... – l’estro dei nostri
contemporanei librettisti e operisti si è volto, prevalentemente in questi ultimi lustri, a risuscitare
tipi modi e scene di vita italiana medievale, anzi dirò – con parole di più larga portata – dei grandi
secoli della nostra rinascenza spirituale.
Per dare qui soltanto alcuni esempi, benché non tutti cospicui, noterò che Mascagni, votandosi
alla più ardua, forse, delle sue fatiche, si è cimentato a far risorgere Parisina dei Malatesta,
complice lo stesso D’Annunzio evocatore de La figlia di Jorio musicata da Franchetti, già noto a
sua volta per il Cristoforo Colombo. Ma il compianto Giacomo Orefice reclama a tuttoggi
dall’aldilà la priorità di aver riportato per il primo alla luce delle ribalte gli amori di Ugo e Parisina.
Ed ancora D’Annunzio ispira con La nave l’estro di Italo Montemezzi, che più tardi richiamerà la
maggiore attenzione su di sé con L’amore dei tre re offertogli da Sem Benelli. Riccardo Storti
fraternizza con Antonio Lega nella realizzazione scenica e nella idealizzazione poetica-musicale
dell’intimo dramma – sempre in attesa di essere rivelato – del sommo Leonardo. Renzo Bianchi
ritorna all’agone teatrale in compagnia della patrizia senese La Ghibellina, ridonata dopo cinque
secoli alla vita da Dario Niccodemi, per conseguire la vittoria sfuggitagli in precedenza con
Ghismonda protagonista di altra tragedia del declinare del decimo secolo conclusasi nel castello del
principe Tancredi, al dire di Leopoldo Costa. Giuseppe Mulè chiede il battesimo d’arte al Massimo
di Palermo dopo aver asceso insieme col fratello Francesco Paolo il castello della Baronessa di
Carini echeggiante di canti d’amore sicilianissimi.
Ma il fascino sulla fantasia dei nostri operisti promana più particolarmente da vecchie leggende e
da vecchi caratteristici tipi di Toscana, di Firenze. Onde Renato Brogi riesce ad assidersi fra quelli
con Isabella Orsini (tragedia lirica sceneggiata da Valentino Soldani e verseggiata da Eugenio
Coselchi dall’omonimo romanzo del Guerrazzi); Giovacchino Forzano e Giacomo Puccini
immortalano se stessi reimmortalando il dantesco Gianni Schicchi; ed ancora il Forzano con I
compagnacci della città medicea riesce a trarre fuori dall’ombra e per qualche tempo dall’indigenza
un creatore ed un dialogista intuitivo come il Riccitelli prima che con Madonna Oretta risospinga
lo stesso maestro abruzzese – meglio allenato ma finoggi con minor fortuna – tra i marosi della vita
di palcoscenico e, frattanto, con I Carnasciali lanci in onde non meno burrascose Guido Laccetti.
Un giovane fiorentino di sangue se non di panni – Mario Castelnuovo Tedesco – prende pur esso
contatto con le folle delle platee teatrali risuscitando, non senza il patrocinio del grande spirito
machiavellico, la cinquecentesca Mandragola. Un dotto manipolatore di contrappunti – Giacomo
Setaccioli – si appronta a tentare col pubblico romano un’altra, la decisiva partita mercé il
Mantellaccio confezionatogli da Sem Benelli; ma egli – colpito di morte violenta – non fa in tempo
a giuocare le ultime carte...*
Durante la sola annata testé decorsa – oltre Primo Riccitelli con la citata Madonna Oretta – Gino
Marinuzzi si è ripresentato come autore della musica di una vicenda toscana, apprestatagli in forma
librettistica dal Forzano, dell’epoca delle Bande Nere guidate da Palla de’ Mozzi successore di
Giovanni De Medici; Arrigo Pedrollo con la musica di un argomento novellistico boccaccesco
trasportato da Mario Ghisalberti, col titolo di Primavera fiorentina, in pieno quattrocento mediceo e
carnascialesco; Gian Francesco Malipiero con quella del trittico I misteri di Venezia riflettente
l’origine lo splendore la decadenza e la profanazione di una razza e Adriano Lualdi con le melodie
e i ritmi dalmati della Granceola.
È di questi giorni l’annunzio de La fiamma ravennate del binomio Guastalla-Respighi.
3.2.2/56
Da tale orientamento verso soggetti nativamente italiani non poteva restare a lungo lontano il
mutevole dinamico spirito del roveretano Riccardo Zandonai. Ed eccolo tutto intento alla
reincarnazione musicale prima di Francesca da Rimini, nell’ampia smagliante tragica veste
ricamata dalla fantasia dannunziana sulla mirabile visione poetica dantesca, poi di Giulietta e
Romeo secondo la libera interpretazione e ricostruzione, fra Modena12 e Verona, del duplice
cruento dramma apprestatogli da Arturo Rossato reagente alle inevitabili influenze scespiriane.
Questi medesimo – riprendendo un tema di beffa che fu caro a messer Giovanni Boccaccio e che
nell’Ottocento aveva costituito lo spunto fondamentale del breve quanto umoristico romanzo
spagnuolo El sombrero de tres picos di Pietro Antonio de Alarcón (il quale va ricordato anche per il
primo centenario della nascita) – è riuscito a ridestare nello Zandonai gli istinti di natura non
tragica, istinti in verità già affiorati qua e là in episodi della prima opera – Il Grillo del focolare –,
de I cavalieri di Ekebù e meglio nella commedia lirica de La via della finestra su libretto
dell’Adami.
***
È noto che l’intensa fecondità librettistica di Arturo Rossato oscilla continuamente fra il tragico
e il comico, il serio il burlesco e fin l’operettistico. Pertanto il poema de La farsa amorosa (farsa
perché imbastita sulla trama di un intreccio di carattere lepido fino al punto da comprendere due
somarelli innamorati, Ciccio e Checca, fra i suoi personaggi; amorosa perché quest’intreccio è
d’amore) – quantunque il primo, se la memoria non m’inganna, da lui composto per il maestro
trentino, senza epilogo mortale – è soltanto il più recente, realizzato musicalmente e rappresentato,
di tutta una serie del genere cui appartengono Nina non far la stupida, La bisbetica domata, Don
Giovanni, Le preziose ridicole, Tupù e Tepè, Sirenetta, Bombon, La governatrice nuova, Madonna
Imperia, Il favorito del Re.
La intuitiva e acquisita scaltrezza congiunta all’esperienza ormai lunga dell’autore è valsa a
dosare, talvolta fino alla saturazione di motti e giuochi, di battute e trovate, di colpi ed effetti
piacevoli e piccanti, la stesura di ben cinque quadri e due intermezzi, a velario levato, in
maggioranza villerecci e popolareschi per le cornici, per i toni, per i tipi e per le masse partecipi dei
rispettivi episodi.
Ma, dopo la prima prova al fuoco della ribalta, non si potrebbe con fondatezza e franchezza
affermare che tanta scaltrezza e tanta esperienza siano riuscite sufficienti a costituire con tali quadri
e intermezzi un poema unitario e, considerato in blocco, essenzialmente, caratteristicamente buffo
nel significato tradizionale, fra settecentesco e ottocentesco, di questa espressione.
Molti giurano sulla schietta comicità dell’opera El corregidor y la molinera di Ugo Wolf, del
balletto Il cappello a tre punte di Emanuel De Falla [sic] e della zarzuela Tambien la corregidora
es guapa di un altro maestro iberico, perché tutti e tre tali spartiti – persistendo assoluto il rispetto
filiale alla volontà testamentaria del De Alarcón non consenziente alcuna utilizzazione per il teatro
del suo romanzetto – sono stati composti su trama ricavata da fonte della medesima origine di esso,
cioè di un’antica canzone spagnola. Ed ai loro autori ben poco o nulla v’è da obbiettare sol che si
tenga conto dell’essersi essi tenuti ligi all’ambiente prettamente spagnolo e che fra i vari personaggi
portati sulla scena intercede una certa dimestichezza di rapporti sociali e non già il divario netto fra
un Podestà per giunta cavaliere di Spagna e due umili contadinotti lombardi quali sono Renzo e
Lucia nella commedia o farsa del nostro Rossato.
Questi in un’intervista giornalistica ha confessato che, per superare l’ostacolo frapponenteglisi
alla fedele traduzione in libretto italiano del breve romanzo (o novella) spagnolo, aveva dovuto –
oltre che sperimentare la propria pazienza in diligenti indagini sulle fonti storiche del racconto
popolare per opporle in caso di contestazione giudiziaria – sottoporsi alla fatica di ricostruirlo
liberamente, trasferendone l’azione in terra italiana provata dal dominio spagnolo e apportando
mutamenti, in conseguenza, nei nomi nei connotati nel numero dei personaggi, ecc. Al suo fine
ritenne particolarmente acconcia la Lombardia, ove della burbanza spagnola secentesca il ricordo
non è spento, anzi è come di continuo rinverdito dalla diffusa popolarità del capolavoro
manzoniano. nei quadri ed intermezzi della sua “farsa” non mancano infatti richiami alle
12
[sic]: ma Mantova.
3.2.2/57
caratteristiche foggie brianzole, richiami resi più vivi e sonanti dai nomi di Renzo e Lucia dati a due
giovani contadini, personaggi di primo piano.
Ma dei protagonisti del romanzo del Manzoni il nostro librettista ha ripreso esclusivamente i
nomi, l’età primaverile e l’infima condizione sociale.
Facendo grazia ai lettori di qualsiasi considerazione estetica ed etica sui caratteri di essi –
caratteri ben noti ad ogni persona di media cultura – mi limito qui a rilevare che Renzo e Lucia de
La farsa amorosa sono fiorenti di salute e di bellezza, ma già marito e moglie, sempre innamorati e
un po’ gelosi l’uno dell’altra: lui, furbacchione, agile e risoluto in qualche evenienza (p. e. alla
notificazione dell’atto dell’arresto); lei, intelligente scaltra e abbastanza disinvolta, sebbene qua e là
patetica e piagnucolosa. Il Rossato ha assolto così, rispetto ad essi, almeno in parte il suo compito.
Avrebbe fallito completamente allo scopo d’imbastire il tessuto d’un’opera divertente se avesse
addirittura “copiato” dal Manzoni gli omonimi tipi, volutamente da esso plasmati timidi, remissivi,
impacciati, incapaci d’agire di propria iniziativa.
Ho detto dianzi che il librettista ha assolto soltanto in parte il suo compito ed eccomi a
dimostrarlo con poche parole.
Un giovane contadino, sano forte e bello, se provocato ed offeso nei sentimenti istintivi e nelle
persone più care, decide ed agisce mille volte su mille irriflessibilmente, d’impeto. Renzo della
“farsa” si comporta come un fantoccio senza sangue nelle vene quando, alla vista del vestito
podestarile di Don Ferrante, invece di precipitarsi irato e furente nell’attigua camera da letto,
assume l’atteggiamento – strano in lui – meditativo... di una eventuale vendetta, cioè di render pan
per focaccia, e senza troppa fretta si toglie i suoi e indossa quegl’indumenti e così travestito si avvia
dalla podestessa. E ancora, dov’è la burbanza del “corregidor” in D. Ferrante, allorché costui,
cornificato senza aver fatto becco Renzo, o al certo avendo saputo della beffa orditagli, invece di
volare d’un fiato a palazzo per sventarla, indugia come un babbeo e non sa disvincolarsi dalla gente
villereccia che d’intorno allegramente lo schernisce ed ironicamente commenta gli eventi
scandalosetti? Per altro, la burbanza del podestà, meglio realizzata nel secondo atto, in cucina degli
sposi, cioè prima ch’egli dalla paura inciampi, cozzi con la testa contro la pietra e svenga, non
riesce invece a muovere a alcuna ilarità mentre si scioglie, durante il quadro iniziale, in una
dichiarazione d’amore complimentosa sdolcinata melliflua incomprensibile da sempliciotta quanto
intelligente forosetta. Piuttosto muove al riso l’intervento ripetuto, sempre a tempo giusto, di Ciccio
e di Checca con sonori inconfondibili ragli.
Così pure il libretto rossatiano, nel complesso, ha perduto molto del comico sprizzante dal
racconto del De Alarcón, questi in vero abilissimo nel ritrarre sia il tipo – non di un’umile
contadinella – ma di una agiata oltre che formosa mugnaia in dimestichezza quotidiana, come tra
pari, con il podestà il colonnello i giudici gli avvocati le loro signore e fino il vescovo della vicina
città, sia il tipo del marito di costei – non giovanissimo avvenente ed esuberante, ma attempatello,
brutto come il diavolo, alquanto gobbo, riflessivo, prudente e pur restìo per la propria bruttezza a
vendicarsi del corteggiatore della moglie, eccettuato il caso in cui gli sia consentito di rendergli la
pariglia...
Rossato è riuscito invece a disegnare al vivo i personaggi di secondo piano: Frulla, servo fidato,
e Spingarda, podestà del paesello di Renzo bravaccio e beone all’ordine di Don Ferrante. Anche per
Donna Mercedes, la podestessa, per il vecchio segretario Giacomino e per la balia Orsola ha avuto
tocchi indovinati, sicuri e di buon effetto. Né le masse contadinesche e fanciullesche costituiscono
meri riempitivi di talune scene; al contrario, durante la baraonda e il ballo vendemmiali assumono
parte di primo piano.
*
Della Cena delle beffe, d’ambiente fiorentino e mediceo, dello stesso Sem Benelli e Giordano mi
sono già occupato particolarmente.
412
(continuazione), «Rivista nazionale di musica» XIV/300-301, 1.4.1933 - pp. 1923-4
3.2.2/58
Dalle considerazioni fatte sull’ambiente sull’intreccio e sui personaggi del libretto rossatiano si
può dedurre – ormai affrancati dalla preoccupazione di un giudizio arbitrario, illogico o per lo meno
affrettato – ch’esso libretto non costituisce il modello, vecchio o nuovo, meglio concepito e
realizzato per la musica di un’opera comica del tipo Barbiere di Siviglia o di una commedia del tipo
Falstaff o I quatro rusteghi.
Pure, Riccardo Zandonai ha saputo valorizzare dal poema letterario gli elementi di agreste
popolaresca vivacità, le battute di sfacciatello doppio senso, i motti piccanti, gli atteggiamenti
spagnolescamente donchisciotteschi, e così bene che, in mancanza o in difetto di un sostanziale
gioioso spirito umoristico o filosofeggiante o moralistico, gli è riuscito di creare uno spettacolo
divertente – forse il più divertente apprestato in questi anni assai critici anche per la vita dei teatri
lirici – se non un altro capolavoro di comicità da aggiungersi alla collana di gioielli pergolesiani,
paisielliani, cimarosiani e rossiniani; ciò che d’altronde non sarebbe stato possibile attendersi dal
binomio Rossato-Zandonai di precedenti prevalentemente drammatici.
Non intendo defraudare chicchessia – specie gli autodepositari in diverso grado verbosi del
pensiero cosiddetto filosofico – della “privativa” di stabilire, essi, in conclusione di lunghe
disquisizioni più o meno cerebrali e sterili, la precisa “dose”, “proporzione” di interiorità ed
esteriorità, di raffinatezza e faciloneria, di unitarietà e frammentarietà, di idealità e commercialità,
di ricorsi alla tradizione e di nuovi apporti, con cui il maestro roveretano ha tagliato imbastito
cucito e confezionato la veste musicale a questa amorosa farsa. Mi limito soltanto qui a porre in
risalto ch’egli ha compiuto tale sua fatica creativa (con La Partita [sic], tra le più recenti) fidando
sopratutto nel proprio estro e nella propria esperienza, tesoreggiando alcuni noti e caratteristici
spunti folcloristici nostrani e attingendo colori e sfumature alla propria ricca sgargiante tavolozza, e
non già con mezzi risorse espedienti straordinari o di fresco conio – ad eccezione dell’uso del
grammofono per riprodurre al vero i ragli somareschi – od utilizzando ricette internazionalistiche di
alchimia tematica armonica ritmica strumentale.
Mercé un processo di introspezione e di selezione – processo che gli ha consentito d’infrenare il
temperamento e l’eloquio suoi istintivamente orientati versi il tragico; di dominare la tendenza agli
ampi sviluppi o sfruttamenti, talvolta tormentati e tormentosi, di piccole idee melodiche e fin di
brevi figurazioni ritmiche (tale dominio gli è mancato in parte nella stesura del primo duetto fra il
soprano e il tenore ed in qualche altro episodio di secondo piano); di coartare sino quasi
all’annullamento l’abuso di complicati e grevi tessuti polifonici (infatti così alla “ronda” come al
“brindisi” finale ha evitato la complessità del fugato); di ridurre al minimo possibile le
supersonorità strumentali ed i clamori vocali rovesciati a masse dall’orchestra e dal coro (ad
eccezione del bacchico primo intermezzo in cui pure, in verità, l’insieme creativo, nonostante
l’ondata sincronica piena di tutte le voci strumentali [e] vocali a disposizione del compositore, non
risulta per nulla appesantita, neppure per un attimo, anzi realizza e conserva da cima a fondo la
voluta dinamicità dei movimenti e l’immaginato sfolgorio dei toni) – Riccardo Zandonai ha dato
prova indubbia di saper costruire anche un’opera in sé agile e chiara, considerata sia in blocco sia
nei particolari momenti dell’azione; dilettevole per le folle anche per il discreto uso fatto delle
risorse della coreografia e non spiacente alla generalità... della critica quotidiana.
Gl’impasti di tinte leggere e trasparenti benché non prive di calore emotivo a sostegno di episodi
sentimentali (fra cui lo “stornello”, che si potrebbe definire della gelosia, fra Renzo e Lucia; la
“filastrocca” di sapore popolaresco pure a duetto fra essi, la risposta o preghiera tremante di Lucia
all’assedio del Podestà, l’intima melodica nenia di Donna Mercedes...) vi si alternano agli scoppi di
piena sfolgorante meridiana concordanza corale ed orchestrale (cito per esemplificazione il
dionisiaco e pittoresco baccanale dei vendemmiatori e delle vendemmiatrici preceduto dalla
luminosa scena campestre autunnale al levarsi del velario sul primo quadro e ripreso con
intensificata ebbrezza al calare del quadro terzo).
I giuochi sonori, ben graduati di luci e di ombre, ad integrazione di scene di carattere strano e
misterioso (p. e. quella del complottare del Cavaliere spagnolo col suo fido Frulla, mentre
Spingarda spia ed origlia, e l’altra dell’irrompere di Renzo travestito nell’appartamento della
Podestessa) ovvero di scene d’atmosfera abbastanza erotica (quelle in cui Don Ferrante snocciola la
sua prima dichiarazione d’amore a Lucia e tenta di conquistarla con modi più spicciativi dopo aver
3.2.2/59
fatto arrestare Renzo) vi si avvicendano dei “concertati” ariosi e condotti formalmente secondo il
modello di qualche notissimo concertato verdiano.
Il “terzetto” sospirato da Spingarda, Orsola e Giacomino sul tema ricavato dal suono della
campana dell’Ave Maria – per la sua perfetta aderenza al testo del poema, per freschezza inventiva,
per snellezza di linee e per grazia di movenze – la menzionata filastrocca a due ed il tempo di
“bolero” – sul cui caratteristico ritmo d’impronta spagnola Spingarda13 ricanta la sua ardente
irriducibile febbre d’amore alla bella forosetta – costituiscono la triade dei pezzi lirici più gustosi,
più originalmente concepiti, più armonicamente architettati e conclusi dell’opera ed inoltre più
facili ad imprimersi nella memoria degli uditori e quindi a divenire popolari.
Non mancano, anzi abbondano, le pennellate caricaturali ironiche grottesche. Esse, distribuite
qua e là e dosate con criterio, accentuano di quando in quando la vivezza e la piacevolezza della
partitura e dello spettacolo; i quali si concludono farsescamente al terzo quadro del primo atto
mentre il raglio di Ciccio mozza in gola a Don Ferrante l’enfatica parola, bizzarramente all’atto
secondo con il ritmo marcato della incisiva caratteristica “ronda” e festosamente al terzo con un
“brindisi” impostato su tema popolaresco e svolto anch’esso in forma ben definita di “concertato”.
413
m[atteo] i[ncagliati], La nuova opera comica di Riccardo Zandonai, «Il Messaggero», 16.7.1935 p. 3 (con una foto di Zandonai)
Riccardo Zandonai ha ormai conquistato la diffusa popolarità riservata agli operisti geniali. È il
suo “momento” musicale e artistico; e ben chiaramente lo fece intendere la folla adunata sere
addietro alla Basilica di Massenzio, durante il concerto da lui diretto. Parve quasi che gli si volesse
manifestare e tributare un senso di gratitudine. Perché continua con il maestro trentino la singolare
tradizione onde gli operisti di vasta rinomanza, nel passato lontano e vicino, in ogni epoca, da
Cimarosa a Rossini e da Bellini a Verdi, concorrono a rinnovar giovinezza a quel melodramma il
quale, nato in Italia, è ancora vegeto e prospero, nonostante tutti i piagnistei di una critica arida e
amara, senza che al primato legittimamente e vittoriosamente conquistato nessuno si proponga o
attenti a fargli mutar sede. Zandonai con le sue opere è vigile delle sue facoltà inventive e
fantastiche, lo si attende fiduciosamente e orgogliosamente a nuove prove perché la scena lirica ne
tragga motivo di vita non effimera.
Sensibile alla voce dell’epoca, al suo estro non da oggi sorride lo spirito dell’opera comica. È di
recente natalità la Farsa amorosa, ch’ebbe qui in Roma, al Teatro Reale dell’Opera, il suo primo
chiaro schietto fervido successo, ripetutosi poi su altre ribalte, e alle quali è da augurarsi si
aggiunga quello della Scala dove nella ventura stagione essa sarà posta in scena.
Ma prima della Farsa amorosa Zandonai aveva mostrato questa sua felice tendenza all’opera
comica con La via della finestra.
Ora l’orientamento della sua fantasia non sembra disposto a rinunciarvi. Ne ha dato un esempio
con la ouverture Colombina che Bernardino Molinari tenne a battesimo all’Augusteo e che, sotto la
stessa direzione, alla Basilica di Massenzio in questa stagione ha diffuso i suoi accenti sereni,
ridenti, pettegoli e caricaturali, in una ridda di suoni gai e agili, quasi a rallegrare quel trillo
falstaffiano che è come il segno d’un faro per i compositori teatrali.
La Colombina preannuncia forse una nuova opera comica di Zandonai? Dopo il concerto alla
Basilica di Massenzio tentammo di conoscere dalla viva voce di lui se questa nostra ipotesi fosse
giustificata o pur no. Ma Zandonai ci rispondeva scherzosamente che aveva altro da fare.
Tanto da fare che è ripartito per Trieste di buon mattino, poche ore dopo il concerto da lui diretto
e terminato in un’ovazione significativa e clamorosa provocata dalla Cavalcata di Romeo, divenuta
ormai uno di quei brani sinfonico-corali acquisiti alla popolarità. A Trieste era atteso per prender
parte come giudice a quel grande Concorso di bande, che poi tutte insieme hanno dovuto, sotto la
sua direzione, eseguire la Sinfonia verdiana dei Vespri Siciliani e la Cavalcata in Giulietta e Romeo.
13
[sic]: ma Don Ferrante.
3.2.2/60
Dopo Trieste, Torino, dove concerterà e dirigerà la sua Francesca da Rimini per l’Eiar che alla fine
del mese ne farà due trasmissioni eccezionali. Da Torino, senza concedersi tregua, ritornerà nelle
Marche per organizzare e dirigere, nella prima metà di agosto, tra Sanseverino e Macerata, dei
concerti all’aperto con un’orchestra imponente, oltre centocinquanta strumentisti, dei quali vari
sono stati scritturati dall’Augusteo e altri dall’orchestra di Bologna. Nella seconda metà dello stesso
mese dovrà concertare e dirigere nel teatro “Rossini” di Pesaro la Farsa amorosa per la breve
stagione lirica, ideata per iniziativa e proposta dello stesso Zandonai, e che sarà inaugurata con La
fiamma di Respighi, invitato a dirigerla. Non basta. Nei primi di settembre farà ritorno a Roma per
concertare e dirigere all’Eiar la sua Giulietta e Romeo per la trasmissione in tutta Italia. E poi a
Rovereto per dirigere a quel teatro La farsa amorosa.
Ora, con tanti impegni che probabilmente si ripeteranno sempre più frequenti – perché Riccardo
Zandonai desta un interesse singolare come direttore animatissimo e interprete sicuro – è a
presumere e a deplorare che resti inoperoso in lui il compositore? vero è che dopo una diecina di
opere teatrali e non pochi lavori sinfonici, Zandonai reclama il diritto di fare adesso quanto meglio
gli piaccia – non escluso il... mestiere di cacciatore, appena sarà aperta la caccia, su e giù per i suoi
monti trentini – e anche quello, se gli fosse possibile, di fannullone.
Vana supposizione, per quanto queste sue scorrerie e divagazioni estive giustifichino il profilo di
quell’interrogativo. È noto ed è risaputo che il maestro ha sempre assiduamente lavorato e lavora in
ogni campo perché si possa ritenerlo uno sfaccendato. D’altronde, non soltanto il gran pubblico che
ora penetra anche la sua musica più fine e aristocratica, ma anche gli ambienti aristocratici [e]
intellettuali desiderano nuovi prodotti dalla sua genialità creatrice, pur così feconda, varia e sempre
personale. È bastato l’ultimo suo breve e grazioso lavoro, la ouverture intitolata Colombina ed
elaborata sul motivo del Carnevale di Venezia, per acuire quel generale desiderio. E l’ultima sua
opera, La farsa amorosa, in cui, a parte La via della finestra, l’autore di potenti tragedie musicali –
Francesca, Giulietta e Cavalieri di Ekebù – ha rivelato una vena comica felicissima, non fa forse
pensare che molto ancora il maestro può, deve anzi dare al teatro lirico?
-Al teatro lirico voi non potete rinunciare – gli dicemmo durante la cordiale conversazione avuta
con lui prima che lasciasse Roma per Trieste, tendendogli una specie di insidia nella lusinga di
svelarci il segreto entro cui è custodito il titolo della nuova opera a cui lavora. Toccato su questo
punto, il Maestro si è lasciato andare a un amichevole sfogo sulla difficoltà per tutti gli operisti, lui
non escluso, di far “camminare” le opere nell’attuale situazione dei teatri lirici, una difficoltà che
non invoglia certo alla produzione.
Per lui, al punto attuale della sua carriera operistica, e con la reputazione e la fiducia conquistate
con i precedenti lavori, e anche – ad multos! – con gli anni trascorsi, è grave, sempre più grave la
responsabilità di presentarsi con un’opera nuova, che non può più essere un tentativo sia pure
audace quale è consentito ai giovani. Egli ha l’obbligo ormai d’imbroccarla più o meno un’opera,
se la pensa e la scrive – imbroccarla nel soggetto che non può non avere un certo valore letterario e
buona materia teatrale – imbroccarla nella forma e nel contenuto musicale che non possono
prescindere né dal passato né dal presente, vale a dire né dalle grandi tradizioni nostre
melodrammatiche e né dalla modernità in cui i gusti di tutti, inconsapevolmente, si evolvono. Tutto
questo, senza dubbio, non è facile né invogliante, specialmente per quanto riguarda la scelta del
libretto, rispetto al quale il pubblico teatrale ha esigenze forse anche soverchie.
-Per fortuna – dice Zandonai – mi è andata bene col soggetto comico della Farsa amorosa che
diverte ogni specie di pubblico, grazie soprattutto all’ingegno e all’abilità del mio librettista e caro
amico Arturo Rossato. Ma come trovarlo un altro soggetto altrettanto ricco di situazioni senza
lunga e paziente ricerca? Perché, se volete che mi confessi con voi, io ho preso un gusto matto
all’opera comica; mi son tanto divertito io stesso a comporne una che ho voglia di scriverne
un’altra.
-Quando?
-L’avvenire è sulle ginocchia di Giove. Rossato giura e spergiura che, appena io sarò libero
dagl’impegni direttoriali di questa stagione e mi ridurrò tranquillo a Pesaro, mi procurerà un
soggetto di opera comica non indegno di succedere alla Farsa amorosa. Se son rose fioriranno...:
3.2.2/61
ma fioriranno tardive, per tutte le buone o cattive ragioni, le distrazioni, le perplessità, le
responsabilità che vi ho detto.
Ma è probabile che la nuova opera comica di Riccardo Zandonai balzi viva e fresca e ridente, e
fiorisca prima delle... rose tardive.
414
Gastone Rossi-Doria, [Musica] - Novità teatrali di Zandonai e Malipiero, «Nuova antologia»
LXVIII/1464, 16.3.1933 - pp. 310-2
Tra le poche opere nuove apparse in questa stagione 1932-33 in Italia particolarmente
significative, a diverso titolo, ci sembrano La farsa amorosa di Riccardo Zandonai (Roma, Opera,
22 febbraio) e Il finto Arlecchino di G. Francesco Malipiero (S. Remo, Casino, 5 marzo).
Nella prima di esse noi vediamo la stessa sostanza che già animava le altre opere zandonaiane.
Per esempio, alcune delle osservazioni mosse di recente a Una Partita (Milano, Scala, 19
gennaio) potrebbero muoversi anche a questa Farsa amorosa.
Nella partitura presentata a Milano non si videro, p. es., sortite dal campo trincerato dell’opera
abituale zandonaiana, ma sibbene «melodiosità, nobiltà ideale e tecnica» (Ambrosiano), sensibilità
«...più che di lirismo, permeata di vivacità coloristica, di respiro armonico e di penetrazione
drammatica» (Popolo d’Italia). Altri ne deplorarono – però – «quel senso di anonimo che grava su
tutta l’opera» (Italia letteraria).
Soltanto è necessario osservare: Melodiosità può darsi in una musica melodica, e può anche
essere un penoso surrogato di melodia; come poeticità non è sinonimo (anzi!) di poesia.
Vediamone le sorti presso lo Zandonai, che certo è “melodioso” se mai alcuno lo è stato, e che
nessuno stima però un “melodista”. Nella maggior parte dei casi, il suo eloquio tende al canto, lo
evoca da tutte le parti e da tutti i venti, e al canto non s’eleva quasi mai. Quasi mai vi si oblìa, libero
da ogni contingenza e da ogni dubbio, in quell’estatica fissità di sguardo in cui il lirico vede
alcunché di unicamente suo. Lo Zandonai vede quel che vedono tutti in tutta la giornata, e lo vede a
un dipresso come tutti. Ne vien fuori una musica che se non è “anonima” certo non è neppure una
rivelazione largita dal suo animo alla massa.
Ciò accade dunque anche nell’elemento melodico, che non si libera in canto appunto perché non
v’è una intuizione individuale abbastanza nuova per determinarne la necessità. Dalla Francesca alla
Farsa amorosa la melodiosità cambia di posizione e si quadra in varie “melodie”: Duetto RenzoLucia al primo atto (“Bello, la gelosia mal ti consiglia...”), arie di Lucia al II atto («Passo i miei dì
tranquilla...») e al III («Puoi dunque credere...») ma quasi mai il giro di queste melodie accresce
l’émpito della commozione, ché anzi il più delle volte lo avvilisce e lo sperde. Anche qui, dunque,
ce ne restiamo, per quel ch’è “affetto”, alla solita melodiosità, cioè al solo primo ansito verso il
canto. Notiamo qui, per incidenza, la diversa natura della scrittura “melodiosa” di un Pizzetti, la
quale si fa canto, e talvolta canto “chiuso” magari a dispetto di Maestro Ildebrando, per una sua
insopprimibile liricità: si ricordi, p. es., il sognante canto dello Straniero «Uscire ogni mattina alla
prim’alba...» (II atto).
E questa stessa fondamentale scarsezza di individualità che illanguidisce, appena evocata, la
“rivelazione” melodica e la riconduce nel movimento confuso delle “considerazioni” più o meno
melodiose, cioè alla solita “prosa”, è la stessa ragione di altre deficienze zandonaiane:
l’approssimazione cioè delle figure, dei “personaggi”. Non si vedono persone vive, ma tipi (o
maschere) per l’ennesima volta riportati di peso alla ribalta. Il librettista Rossato è quel che è: tutti
abbiamo noia grande dei suoi ispiratori ed esempi, da Berrini, se è possibile, in giù; e si pensi un
po’ se possiamo tollerare la miseria delle sue “arguzie” e del suo “popolaresco”. Ma in un’opera
nella quale entri la musica, è la musica che riassume in sé, secondo la sua intuizione, secondo la sua
volontà, e scene e persone e battute e il dramma e tutto ciò che avviene. E – l’osservazione è
vecchia e stantìa – i fantocci di F. M. Piave noi non li conosciamo affatto: al loro arrivo in iscena ci
parlano da persone vive più di noi. Andate a dimenticarvi di Violetta! Potete dimenticarvi di Verdi?
Perché è il Verdi che ci parla.
3.2.2/62
Qui nella Farsa amorosa non oseremmo neanche parlare di maschere, se ci ripensassimo bene.
Tutt’al più potremmo dare questo nome, che ha un suo peso non trascurabile (senso della tradizione
autentica, vis comica e in ogni caso teatrale, ecc.), al personaggio del “Podestà” e proprio per virtù
della sua presentazione musicale (vedi il vivente Bolero del II atto) ed allo Spingarda (perché non
Pistola?) che è il solito “capitano” della vecchia commedia italiana. Un’ombra di umanità ci appare
soltanto per un attimo, al principio del III atto, nella pudica, sorridente tristezza di Donna Mercedes
che sola nella sua camera, al lume delle candele, si canta a mezza voce una canzoncina.
Anche questa deficienza di “caratteri”, si diceva, è conseguenza della scarsa individualità del
compositore, il quale non può osare affermazioni decise, proiettare sentimenti suoi in sue diverse e
vigorose personificazioni artistiche.
E tutto il suo linguaggio musicale rispecchia questo “indefinito”, questa “approssimazione”: la
stessa armonia, nella quale l’accordo è disposto sì da viziare l’effetto sia dissonante sia consonante,
e dove il frequente uso della gamma esatonale dà il senso d’un “surrogato d’armonia” più che d’un
“colore” appropriato che – in funzione timbrica di tale scrittura armonistica – anch’essa vizia ogni
colore con impasti neutri e grigi.
Ed ora, raccogliendo le fila dopo questa serie di osservazioni, troviamo posti in luce alcuni punti
essenziali. La musicalità della Farsa amorosa è la stessa che circola nelle precedenti opere di
Zandonai: musicalità vaga e piuttosto grigia, incapace di decise affermazioni volontarie. Rispetto
alla Conchita e alla Francesca, la Farsa amorosa rappresenta dunque, con la sua “quadratura” e la
sua ostentazione di popolaresca giocondità, un passo indietro, un allontanamento dalla vera natura
del musicista. Non per nulla, infatti, il momento veramente “lirico” è stato indicato, proprio da
coloro che preferiscono la Farsa alle opere precedenti, nel vago mormorio “neutro” del terzetto
Orsola-Giacomino-Spingarda, tra gli sbadigli e le campane dell’Ave Maria. Cui noi aggiungiamo la
scena, dianzi citata, di Donna Mercedes che aspetta invano tra le candele, e la ronda che serve quasi
da ultimo ripiego e via d’uscita al Podestà schernito ed ai deplorevoli Frulla e Spingarda. Altre
pagine “riuscite” non mancano: i cori, il concertato del III atto (tecnicamente perfetto), la scena di
Renzo nelle stanze della podesteria. Pagine “riuscite” non in sé ed esteticamente, nel senso ch’esse
entrino nella Musica, ma ai fini pratici dell’economia scenica di questo spettacolo.
Più musicale, invece, il Bolero cui più sopra s’accennava, coi suoi preziosi disegni a mezzo
lume. Quale finale constatazione possiamo fermare? Da tutte queste “negatività” si viene a
delineare un valore positivo: l’attitudine della musicalità zandonaiana all’espressione di stati
d’animo non già violenti o gioiosi ma anzi intimissimi, rassegnati; dolcemente sognanti una lontana
consolazione che, già si sa, è ormai smarrita. Non già cavalcate e battaglie, ohimè, ma Chansons
grises, queste sì che vorremmo da Zandonai. E le belle pagine della Francesca,di Giulietta e
Romeo, del Giuliano son proprio qui: mezze voci, penombra, tocchi di campane, canzoni
dell’usignolo, Ave Maria.
[...]
415
Lele D’Amico, “La farsa amorosa” al Teatro Reale, [testata non identificata - data non
ricostruita]14 (con un disegno di Zandonai)
Siamo forse tutti d’accordo nel riconoscere in questa Farsa amorosa un progresso rispetto alle
altre opere di Zandonai, soprattutto riguardo alla costruzione teatrale, che è qui innegabilmente più
semplice, rapida e chiara.
Una volta stabilito questo, sarà bene aggiungere, a scanso d’equivoci, che tutto ciò si deve
intendere in un senso puramente esteriore. In senso proprio, cioè estetico, quando s’è fuori dell’arte
far differenze sarebbe privo di significato; allo stesso modo che, secondo la morale cristiana, Iddio
ha stabilito di spedire fra i così detti “reprobi” chiunque abbia da scontare una qualunque colpa
14 Il presente articolo è stato trovato nella raccolta della Biblioteca Civica di Rovereto (fasc. SZ 572) sotto forma di ritaglio privo
di indicazioni identificative.
3.2.2/63
grave, senza perdersi in distinzioni di gravità maggiore o minore. Tuttavia, appunto perché s’è fuori
dell’arte, possono tornare ad aver valore, arrivando anzi addirittura a porsi in primo piano,
osservazioni d’ordine pratico; si potrà per esempio preferire un’opera a un’altra solo in quanto, al
confronto, nell’ascoltare quest’opera la stanchezza fisica venga prorogata di qualche quarto d’ora,
sia a causa di una costruzione esteriormente più varia, sia per il fatto di appartenere al “genere”
comico (il quale tiene lontane prolungate effusioni “sentimentali”, che, com’è noto, costituiscono le
pesantezze più estenuanti).
In questo senso noi possiamo dire che la non-arte di questa Farsa è di una qualità sensibilmente
meno invadente e offensiva, e quindi più innocua, più alla mano, quasi diremmo più leale, di quella
pretenziosa e smaccata di tante altre del medesimo autore. Nonostante la faccenda dei ragli d’asino,
e altre trovate analoghe del libretto.
Tanto che, a un certo punto, si finisce perfino col sentire odore di musica. È un breve momento,
nell’ultima scena del prim’atto: un momento in cui, cessato il chiasso e le burle “ridanciane”, i
personaggi sono in uno stato di placida sonnolenza, e il compositore sembra volersi concedere
anche lui un breve riposo dalla sua arida fatica di “fecondo operista”. Sono poche battute, ma
azzeccate; per le quali non si potrebbero certo far parole troppo grosse, ma che insomma sarebbe
disonesto ignorare. Del resto è noto che tutti gli artisti mancati, a furia di lavorare e lavorare a
vuoto, hanno i loro brevi momenti di stanchezza, fatta di piccole irriflesse nostalgie di un mondo
più umano, a loro negato, e scoprono allora anch’essi, senza volerlo, qualche lato autentico.
Dopodiché non abbiamo molto da aggiungere. Lasciamo ai giornali quotidiani, i quali hanno
l’obbligo di far della cronaca, oltre che della critica, il compito di un lungo e minuto esame dello
spartito. Non è d’altronde colpa nostra se l’assenza, sui cartelloni dei grandi teatri italiani, di nomi
moderni significativi ci impedisce di parlare di cose che abbiano a fare coll’arte.
Tutt’al più potremmo dare, in un orecchio e colla più grande umiltà, un consiglio a quei
pochissimi critici dei quotidiani che, pur sapendo molto bene in qual conto si debba tenere certa
musica, usano dissimulare le loro idee, parlando di cose di nessun valore collo stesso tono con cui
si parla di cose serie.
Nel caso specifico, vorremmo far loro notare come l’uso di questo tono sia più pericoloso che
mai. Giacché dei vecchi autori della cosidetta “giovane scuola italiana”, per fare un esempio, anche
i profani loro ammiratori sanno almeno di non poterli considerare come musicisti moderni, e quindi
l’elogio di maniera può anche passare come la scappatoia a una discussione ormai superata. Ma
Zandonai appartiene a quella categoria di artisti che vorrebbero, per dirla in una parola, salvare
capra e cavoli: il suo fondo è, ci vuol poco a capirlo, l’opera verista, che è quanto dire la sistematica
evasione dalla musica per arrivare al “fatto” contenuto in un libretto; ma un mestiere molto più
avanzato di quello rudimentale e dilettantesco in uso nella citata “giovane scuola” gli permette di
condire la sostanza con varii ghiribizzi strumentali, e parecchie puntatine “impressioniste”, che
conferiscono al tutto una veste “moderna”. Una posizione equivoca insomma; che se per un verso
può servire a dar rilievo, col confronto, all’autenticità degli artisti veri (si pensi per esempio al
modo di accostarsi a d’Annunzio di Pizzetti; per quante riserve si possano fare sulla sua Fedra,
basta metterle accanto la vacua illustratività di Francesca per farvi percepire un tono di verità
indiscutibile), per un altro genera confusioni fastidiosissime: quale quella di sentir salutare il
successo della Farsa amorosa come il trionfo, finalmente, d’un’opera “moderna”.
Per questo, ripetiamo, sarebbe bene in casi simili parlare chiaro. Almeno rifiutando,
cortesemente ed esplicitamente, di attribuire le ventotto chiamate alla musica moderna; alla quale,
non si sa mai, potrebbero magari far bene piuttosto i fischi. In fin dei conti, questi temuti fischi
risolvono il difficile problema di mantenere le distanze come nessuna altra cosa.
3.2.2/64