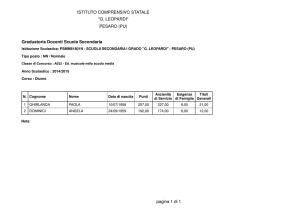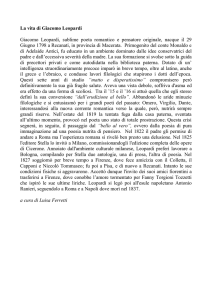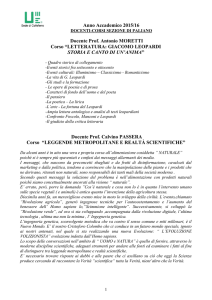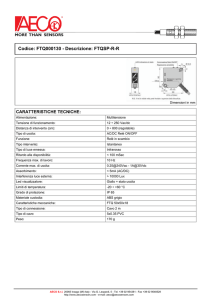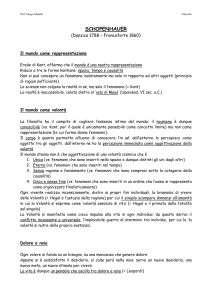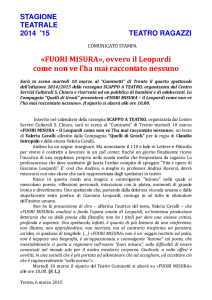Vincenzo Di Marco
Tutto è male
Uno studio su Giacomo Leopardi
Aprile 2012
Noia, dolore, illusione:
“tutto è male”
1. La scoperta della noia
Nello Zibaldone dei pensieri (2415), Giacomo Leopardi afferma che: “La vita è fatta naturalmente per la vita, e
non per la morte. Vale a dire è fatta per l’attività, e per tutto quello che v’ha di più vitale nelle funzioni de’ viventi”. A sentire Francesco De Sanctis, il parlar schietto e diretto del recanatese, la mancanza di un vero impianto
sistematico, la presenza di un pensiero filosofico somigliante più ad un moralismo personalissimo (“un color suo
proprio e personale”) che ad una filosofia asseverativa ed assiomatica, lo confina tra gli scettici e gli stoici, o
tutt’al più lo rendono simile ad un Seneca moderno, spiantato ed inefficace. Più di una ragione ci fa pensare
all’inesattezza di questo giudizio. La virtù speculativa, edificativa e metodica, cercata e non trovata dal De Sanctis nelle
pagine di Leopardi, sappiamo non essere più l’orizzonte entro il quale si muove la riflessione filosofica moderna.
La contraddizione, il paradosso, l’inattuale e l’irregolarità al limite dell’irrazionale ne sono per così dire i corollari
principali. Quasi essa stessa una virtù in controtendenza. Infatti in Zib. 2433 e poi 2434, Leopardi sembra quasi
contraddirsi: “Amando il vivente quasi sopra ogni cosa la vita, non è meraviglia che odi quasi sopra ogni cosa la
noia, la quale è il contrario della vita vitale. Ed in tanto non l’odia sempre sopra ogni cosa, in quanto non ama
neppure la vita sopra ogni cosa: per esempio quando un eccesso di dolor fisico gli fa desiderare anche naturalmente la morte, e preferirla a quel dolore. Vale a dire quando l’amor proprio si trova in maggiore opposizione
colla vita che colla morte. E perciò solo egli preferisce eziandio la morte, se non quanto spera di liberarsi dal dolore, e il desiderio della vita è così mantenuto puramente dalla speranza. Del resto l’odio della noia, è uno di quei
tanti effetti dell’amor della vita (passione elementare ed essenziale del vivente) che ho specificati in parecchi di
questi pensieri. E l’uomo odia la noia per la stessa ragione per cui odia la morte, cioè la non esistenza. E
quest’odio medesimo della noia è padre di altri moltissimi e diversissimi effetti, e sorgente d’altre molte e varie
passioni o modificazioni delle medesime, tutte essenzialmente derivanti da esso odio, delle quali ho pur detto in
più luoghi”1. In più di un passaggio, Leopardi contrappone idee che sembrano spingere il discorso verso una
contraddizione insanabile, ma alla quale dobbiamo fare l’abitudine. Non si tratta ovviamente di una mancata corrispondenza ad un sistema di regole e di idee considerate inamovibili, si tratta di dar corso ad un pensiero sospinto dall’incalzare del bisogno e della suggestione del momento. Producendo però “bellissima armonia di contrari”.
Uno di questi momenti “contraddittori” è il tema della noia, spina dorsale del pensiero maturo leopardiano.
La scoperta della noia in Leopardi non è un elemento accidentale dell’esistenza, ma assomiglia piuttosto ad una
vocazione di fondo presente nell’essere umano, anche se smentita continuamente dai diversi modi con i quali egli
cerca di concepire la sua vera destinazione umana e personale. La noia tende ad essere interpretata come un disagio passeggero, non meritevole di grande attenzione. Infatti le teorie che spiegano il sentimento “complesso” della noia riconducendola alla carenza, o alla sovrabbondanza, degli stimoli sensoriali, non tengono conto del fatto
che essa non è “un momento accidentale dell’esistenza umana”2. Anzi, nel mondo moderno il sentimento della
noia si fa sempre più penetrante negli individui sensibili, aperti alla cultura e all’arte, inclini ad una vita spirituale
più elevata. Se per gli antichi l’immersione nella natura consisteva in un contatto diretto con il proprio oggetto,
da cui traevano alimento per la soddisfazione dei propri bisogni e piaceri fondamentali, ora questo rapporto si fa
più problematico. L’uomo spiritualizzato dei nostri tempi sconta la comparsa della noia con la denuncia
dell’inattingibilità dell’oggetto del pensiero (Dio) e del desiderio (piacere), in quanto tale perdita dell’oggetto metafisico – Dio come non-ente, il ni-ente affermato dalla metafisica e teologia cristiana e, occorre dirlo,
dall’avanzamento del pensiero tecnico-scientifico (un sovra-mondo che schiaccia l’autentico mondo delle cose
naturali) –, è un evento drammatico e irreversibile. L’elevazione del desiderio a Dio consiste nella rinunzia al
1
I riferimenti allo “Zibaldone” di Giacomo Leopardi sono tratti dall’edizione a cura di Emanuele Trevi, Newton Editori,
Roma 2007.
2 Si legga, per una valutazione generale, il bel libro di Lars F.H. Svendsen, Filosofia della noia, uscito in Italia per Ugo Guanda
Editore, Parma 2004, nella trad. di Giovanna Paterniti, che analizza il clima culturale della contemporaneità in rapporto con
il sentimento della noia.
mondo oggettuale e fattuale, comprensibile con i sensi e l’istinto, per far posto ad un “oggetto più alto”, più degno, immateriale e spirituale. Ma l’uomo non ha fatto i conti con la propria finitezza e caducità esistenziale ed intellettuale, con i propri deficit gnoseologici, a volte irriducibili, che lo portano spesso di fronte alla incapacità di
conoscere e “attingere” l’oggetto della sua passione mentale, da lui stesso collocato in un luogo eccessivamente
alto per le sue possibilità.
Roberto Garaventa, nel commentare Zib. 1815, che definisce la noia “…la più sterile delle passioni umane…
figlia della nullità… madre del nulla; giacché non solo è sterile per sé, ma rende tale tutto ciò a cui si mesce o avvicina”, parla di “caducità e vanità abissale di tutte le cose”, in conseguenza di questo avvertimento problematico
presente nel pensiero di Giacomo Leopardi:
“Essa [la noia] è il sentimento dell’«infelicità nativa» dell’essere umano, della problematicità radicale del reale, della caducità e
vanità abissale di tutte le cose, della sostanziale insensatezza dell’esistere; è l’esperienza di un male radicale che segna il cosmo e costituisce il destino degli uomini e di tutte le creature – un male «che è nell’ordine», un male «che è essenziale» – e
che, a differenza dei concreti singoli mali storici, non è redimibile per buona volontà umana; è la percezione dell’illusorietà e
nullità di ogni donazione di senso, del nulla assiologico che sottende e mina l’esistenza. Provare noia è infatti come sentirsi
immersi, avvolti, sperduti nel nulla”3.
Se qui notiamo l’avanzare della vanitas annientatrice di ogni cosa, non per questo il declassamento dei grandi
ideali che fino a questo momento hanno retto il consorzio civile deve essere letto come una resa al nulla. La noia,
pur rendendo tutto illusorio, non è in se stessa cosa vana. La noia è un sentimento dal grande potere conoscitivo,
se vogliamo è la via privilegiata per indagare la privazione di senso dell’esistenza umana, che emerge con
un’evidenza mai conosciuta prima. La noia è ciò che ha maggiore consistenza, anche se la sua presenza rende vano tutto il resto.
Giacomo Leopardi descrive la “patologia” dell’individuo dei nostri tempi sulla base della brillantezza e vivacità
intellettuale di ciascuno. Alla maggiore sensibilità per le cose dell’intelletto presente in molti individui (che amano
riflettere sulle questioni del cuore e della mente, sulle ragioni dell’inquietudine, del tempo e dell’eternità e ad interrogarsi sui motivi della felicità e del dolore umano), corrisponde un più alto grado di sofferenza (“La noia non
è se non di quelli in cui lo spirito è qualche cosa”, Pensieri, 67). La maggioranza degli uomini ama trascorrere la
propria vita in passatempi intonati al diletto e alla dolce svagatezza della mente; il pensiero “annoiato” ha molta
difficoltà ad insinuarsi in tali contesti. Nessuno sfugge, però, come sappiamo, alla noia. Mentre nei più sensibili
essa si presenta con una fenomenologia sovente penosa, dai risvolti terribili, negli altri uomini la noia viene disinnescata grazie all’impiego misurato del tempo, con una immersione “irriflessa” nelle occupazioni e nei doveri della vita sociale. Una “malattia dello spirito”, se è appropriato esprimersi in questi termini, che ritroviamo ampiamente analizzata nella tradizione filosofico-letteraria.
La prima rappresentazione di questa condizione si deve al padre orientale Evagrio Pontico e a Giovanni Cassiano, un teologo del V secolo, autore delle Istituzioni cenobitiche4. Cassiano “...assegna all’accidia un congruo numero di filiazioni che sono nell’ordine: oziosità, sonnolenza, scontrosità (importunitas), inquietudine, vagabondaggine (pervagatio), instabilità della mente e del corpo, verbosità, curiosità. Le trova infine un rimedio che si aggiunge
a quelli della tradizione orientale, la forza, la pazienza, la perseveranza, e che si rivela capace di svolgere un’azione
preventiva: il lavoro manuale. Al monaco accidioso Cassiano contrappone la figura di un monaco che segue alla
lettera i moniti paolini sulla necessità di provvedere con il quotidiano lavoro delle mani al sostentamento proprio
e della comunità cui appartiene. Diviso tra i doveri spirituali e quelli corporali, tra preghiera e lavoro, contemplazione e fatica, il monaco di Cassiano non conoscerà mai momenti di ozio e di inquietudine, non avrà tempo e
modo di prestare attenzione ai rumori che vengono dal mondo, non sentirà il bisogno di occuparsi dei problemi
degli altri, potrà concentrarsi su se stesso e sui modi per raggiungere la perfezione spirituale cui aspira”5. I rimedi
dovevano servire ad annullare il pericolo di questo vizio, che si presentava sotto il segno di una inquietudine incomprensibile, apparentemente inspiegabile. Come poteva nascere – e sarà questo interrogativo l’oggetto della
riflessione di Tommaso d’Aquino secoli più tardi – la disaffezione dell’uomo di chiesa verso la preghiera e la meditazione rivolta a Dio, quando la speranza, il conforto e la gioia del cristiano provengono tutte da lì? Perché
3
In Roberto Garaventa, La noia. Esperienza del male metafisico o patologia dell’età del nichilismo?, Bulzoni Editore, Roma 1997,
pagg. 235-236.
4 Si veda il volume di Giovanni Cassiano, Le istituzioni cenobitiche, riproposto dalle Edizioni Qiqajon, Comunità di Bose, 2007,
per la trad e note a cura di Luigi d’Ayala Valva, in particolare il Cap. X, “Lo spirito dell’acedia”.
5 Nel volume di Carla Casagrande e Silvana Vecchio, I sette vizi capitali. Storia dei peccati nel Medioevo, Einaudi Editore, Torino
2000, pagg. 79-80.
vengono deluse nel momento del massimo contatto con Dio? Può Dio essere fonte di tristezza e di dispiacere,
quando in realtà a Lui si devono ogni bene e ogni perfezione?
La risposta a queste domande non si fece attendere: “Da Cassiano a Benedetto da Norcia, all’epidemica inerzia
che affliggeva i chiostri si contrappone l’etica del lavoro manuale (ora et labora) assunta come espediente ideologico per far fronte a una carente capacità contemplativa”6. Impresa ardua e sostanzialmente fallimentare. Come
sappiamo, l’attingibilità del mondo è data dalla capacità della realtà fisico-corporea di darsi in tutta la sua pregnanza, mentre Dio, o lo spazio silenzioso del cosmo nel quale siamo immersi, è caratterizzato dalla sua assenza mistica e dal suo mistero insondabile. In Leopardi, la noia si connota di aspetti parodistici e iperbolici, di solito attribuiti ad un materialismo che non lascia spazio a riflessioni di carattere spiritualistico. In realtà il recanatese sovente ama perlustrare la dimensione dell’indeterminato e dell’indefinito che emerge dalla riflessione sulla noia e
sentimenti consimili, senza però arrivare a concludere con ciò la necessità del simbolismo metafisico-religioso per
trovare risposte a quesiti altrimenti irrisolvibili.
Leggiamo questa pagina leopardiana dai Pensieri, in cui sembra ravvisarsi una eco pascaliana:
“La noia è in qualche modo il più sublime dei sentimenti umani. Non che io creda che dall’esame di tale sentimento nascano
quelle conseguenze che molti filosofi hanno stimato di raccorne, ma nondimento il non potere essere soddisfatto da alcuna
cosa terrena, né, per dir così, dalla terra intera; considerare l’ampiezza inestimabile dello spazio, il numero e la mole meravigliosa dei mondi, e trovare che tutto è poco e piccino alla capacità dell’animo proprio; immaginarsi il numero dei mondi infinito, e l’universo infinito, e sentire che l’animo e il desiderio nostro sarebbe ancora più grande che sì fatto universo, e sempre accusare le cose d’insufficienza e di nullità, e patire mancamento e voto, e però noia, pare a me il maggior segno di grandezza e di nobiltà, che si vegga della natura umana. Perciò la noia è poco nota agli uomini di nessun momento, e pochissimo
o nulla agli altri animali”7.
“La noia è prima di tutto qualcosa in cui viviamo e non qualcosa su cui riflettiamo sistematicamanente”, così
esordisce Lars Fr.H. Svendsen nell’Introduzione al suo saggio sulla “noia”8. Il Tasso rinchiuso a Sant’Anna è rivisitato dal Leopardi in questa chiave interpretativa: i piaceri sono meno “reali” del desiderio; la verità consiste nel
“solido vuoto” dell’esistenza; mentre la “noia” è la vera protagonista della vita umana (si confronti l’operetta morale “Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare”). La noia, ad una prima sommaria descrizione, è ciò in
cui siamo immersi e non ciò verso cui indirizziamo i nostri atti consapevoli. Essa comporta in molti casi un blocco delle normali funzioni del desiderare, del volere, del motivare, del giudicare, che nei classici greci era chiamata
“akedia”, nei latini “tedium”, nel medioevo “acedia” e nel rinascimento “melanconia”.
Seguiamo da vicino il pensiero leopardiano dello Zibaldone:
“[3622] Sempre che l’uomo non prova piacere alcuno, ei prova noia, se non quando o prova dolore, o vogliamo dir dispiacere qualunque, o e’ non s’accorge di vivere. Or dunque non accadendo mai propriamente che l’uomo provi piacere vero, segue che mai per niuno intervallo di tempo ei non senta di vivere, che ciò non sia o con dispiacere o con noia. Ed essendo la
noia, pena e dispiacere, segue che l’uomo, quanto ei sente la vita, tanto ei senta dispiacere e pena. Massime quando l’uomo
non ha distrazioni, o troppo deboli per divertirlo potentemente dal desiderio continuo del piacere; cioè insomma quando
egli è in quello stato che noi chiamiamo particolarmente di noia” […] “L’idea e natura della quale esclude essenzialmente sì
quella del piacere che quella del dispiacere, e suppone l’assenza dell’uno e dell’altro; anzi si può dire la importa; giacchè questa doppia assenza è sempre cagione di noia, e posta quella, v’è sempre questa. [3714] Chi dice assenza di piacere e di dispiacere, dice noia, non che assolutamente queste due cose sieno tutt’una, ma rispetto alla natura del vivente, in cui l’una senza
l’altra (mentre ch’ei sente di vivere) non può assolutamente stare. La noia corre sempre e immediatamente a riempiere tutti i
vuoti che lasciano negli animi de’ viventi il piacere e il dispiacere; il vuoto, cioè lo stato d’indifferenza e senza passione, non
si dà in esso animo, come non si dava in natura secondo gli antichi. La noia è come l’aria quaggiù, la quale riempie tutti
gl’intervalli degli altri oggetti, e corre subito a stare là donde questi si partono, se altri oggetti non gli rimpiazzano. O voglia6 Il bel libro di Carlo Maggini e Riccardo Dalle Luche, Il paradiso e la noia. Riflessioni metapsicologiche sulla noia morbosa, Bollati
Boringhieri, Torino 1991, pag. 18, è in realtà il lavoro di due psichiatri che hanno indagato il sentimento della noia prendendo le distanze dagli studi psicopatologici e scientifici, evidenziandone i limiti teorici e metodologici. Infatti, “l’intuizione letteraria e scientifica, attualizzando con il ricorso alla metafora il mito delle origini, percepisce forse con esattezza il senso di
questo malessere «tanto maligno quanto più anodino» (Jankélévitch, 1963), che il pensiero scientifico sull’affettività, così
come oggi si propone a noi, non esita a considerare «morboso», allorché tenta di soffocarlo”. E più avanti: “Tutti gli autori
che si sono dedicati allo studio psico(pato)logico della noia stupiscono del singolare misconoscimento di questo sentimento
originario e irriducibile che, allorquando individuato come morboso, è stato scientificamente ri(con)dotto nell’ambito degli
epifenomeni dell’affaticamento (Le Savoureux, 1914) o delle categorie diagnostiche storicamente dominanti quali la «neurastenia», la «psicastenia» o, tout court, nel circolo della «melanconia» o della «depressione», pag. 19.
7 In Giacomo Leopardi, Pensieri, BIT 1995, a cura di Marilena Salvarezza. Si tratta del “pensiero” LXVIII.
8 Lars Fr. H. Svenden, op. cit., pag. 5.
mo dire che il vuoto stesso dell’animo umano, e l’indifferenza, e la mancanza d’ogni passione, è noia, la quale è pur passione.
Or che vuol dire che il vivente, sempre che non gode né soffre, non può fare che non s’annoi?”9.
“La noia corre sempre e immediatamente a riempiere tutti i vuoti che lasciano negli animi de’ viventi il piacere
e il dispiacere”, così Leopardi. La noia è lo spavento del “vuoto” che attacca l’uomo quando il piacere e il dispiacere non lo riguardano più. Sorge quando l’animo umano è prigioniero dell’indifferenza, della mancanza di passione, del decadimento del desiderio. Ma è anche vero che l’uomo consiste nel desiderare in modo puro, nonostante sia in grado di soddisfare solo piaceri temporanei, limitati nel tempo e nello spazio. In questa asimmetria
tra piacere e desiderio si insinua il tarlo della noia. Lo noia, in ogni caso, non appartiene all’ordine dei fenomeni
naturali, trattandosi di un male figlio del “vuoto” e del “nulla”, un male pneumatologico, che penetra in ogni dove, soprattutto nella psiche dell’uomo moderno, che, occorre ricordarlo, mal sopporta le pause di una vita regolamentata dall’etica del lavoro e dell’efficientismo.
La noia parla dell’”assenza”, della “mancanza” di vera passione, di vero desiderio e di autentico piacere. In
questi casi la noia sopraggiunge a “riempiere” il vuoto lasciato dal piacere e dal dispiacere, così come farebbe
qualsiasi elemento in natura (acqua, aria, ecc..) che trova il modo di espandersi e penetrare dappertutto. Questa
regola generale è considerata dal Leopardi qualcosa di ineluttabile, di inesorabile, come il peggiore dei mali. Se
neanche le distrazioni sono in grado di alleviare questa condizione, va preso atto “che la vita è per se stessa un
male” (Zib. 4043), e che l’infelicità è maggiore in coloro che dimostrano una “acutezza”, un sentimento forte di
questo male, non solo per il ridursi delle occasioni di divertimento:
“La noia è manifestamente un male, e l’annoiarsi una infelicità. Or che cosa è la noia? Niun male né dolore in particolare,
(anzi l’idea e la natura della noia esclude la presenza di qualsivoglia particolar male o dolore), ma la semplice vita pienamente
sentita, provata, conosciuta, pienamente presente all’individuo, ed occupantelo. Dunque la vita è semplicemente un male: e il
non vivere, o il viver meno, sì per estensione che per intensione è semplicemente un bene, o un minor male, ovvero preferibile per se ed assolutamente alla vita (8 Marzo 1824)” [Zib. 4043].
La vita consiste nel male, semplicemente. È la scoperta di un male ineluttabile che non coincide con un dolore
particolare. La sua natura è paragonabile a quella di un individuo inerte, impassibile, divorato dall’assuefazione
del vivere, per il quale le vicende del mondo non suscitano reazioni emotive ricche di significato, e verso le quali
non vale la pena impegnarsi e sacrificarsi con tutto se stessi. La noia è il vuoto lasciato nell’animo dal desiderio
inappagato, dal desiderio infinito dell’essere divenuto malauguratamente un ni-ente, dalla scoperta della finitezza
di cui è fatta l’esistenza umana, fallace e transeunte. Il nulla che avvolge tutto è tale da vanificare anche il dolore
in cui è immerso l’uomo (“Tutto è nulla al mondo, anche la mia disperazione, della quale ogni uomo savio, ma
più tranquillo, ed io stesso certamente in un’ora più quieta conoscerò, la vanità e l’irragionevolezza e
l’immaginario. Misero me, è vano, è un nulla anche questo mio dolore, che in un certo tempo passerà e
s’annullerà, lasciandomi in un vôto universale, e in un’indolenza terribile che mi farà incapace anche di dolermi”,
Zib. 73). L’infelicità procurata dalla noia dell’esistenza è proprio questa “indolenza” o incapacità di sentire alcunché. Fino a ridurre l’uomo all’impassibilità assoluta. Fino allo spavento di essere avvolti dal “solido nulla” che riduce la vita umana all’insignificanza (“Io era spaventato nel trovarmi in mezzo al nulla, un nulla io medesimo. Io
mi sentiva come soffocare considerando e sentendo che tutto è nulla, solido nulla”, Zib. 85), che ci fa riflettere su
questa verità paradossale: la nostra esistenza è un sussistere, cioè un consistere nel nulla.
Nella canzone Ad Angelo Mai, Leopardi risalta in tutta la sua limpidezza la contrapposizione tra il mondo “eroico” dei grandi italiani immortalati dai versi, Dante Colombo Ariosto Tasso Alfieri, e la mediocrità dei tempi moderni, molte volte denunciata a causa della razionalizzazione e spiritualizzazione del sapere operato dalla scienza,
che ha ridotto l’uomo alla crudeltà del vero e alla nudità delle cose, dissolvendo l’armonioso mondo del passato
in cui vivevano gli uomini di una volta. “A questo secol morto, al quale incombe/ Tanta nebbia di tedio?”, corrisponde la descrizione di un presente totalmente inconsapevole e malvagio, che vede ricomparire i libri di Cicerone della “Repubblica”; “…a noi presso la culla/ Immoto siede, e su la tomba, il nulla”, sottolinea con parole forti
la conclusione della strofa dedicata all’Alighieri; di Colombo scopritore di nuove terre, alfiere dell’epoca che ha
visto porre le fondamenta di un nuovo mondo, ricco di prospettive inizialmente fortunate e felici: “Ecco tutto è
simile, e discoprendo,/ Solo il nulla s’accresce”; e infine tutta l’apostrofe al Tasso sintetizzata in questi versi:
“Ombra reale e salda/ Ti parve il nulla, e il mondo/ Inabitata piaggia”.
Il commento di Emanuele Severino a riguardo è particolarmente efficace, soprattutto nel rilievo dato
all’equivalenza tra noia e nullità della vita:
9
Giacomo Leopardi, Zibaldone, op. cit., 3622 e sgg., 3713 e sgg.
“La noia è lo stesso sentimento e conoscenza della nullità delle cose, considerato in rapporto all’incapacità delle cose, proprio perché nulle, di soddisfare il desiderio infinito dell’esistenza e di distrarre l’uomo da esso. Nell’esistenza, il divenire infinito delle cose (il loro infinito annientarsi) è inseguito, per essere arrestato, dal divenire infinito del desiderio illusorio. Volere
l’infinito e l’eterno significa voler abrogare l’annientamento. L’infinito divenire del desiderio è tanto più illusorio quanto più
il desiderato è preda, nel processo del suo annientamento infinito, della caducità e del nulla. L’esistenza è l’intreccio del divenire infinito del desiderio e del divenire infinito di ciò che viene desiderato, dell’annientamento della speranza e
dell’annientamento di ciò in cui la speranza era stata riposta”10.
La noia rende sterile tutta la vita, “figlia della nullità” (Zib. 1815), essa non può che partorire sforzi umani vanificati già in partenza da un risultato fallimentare. Passione decisamente contraria al corso naturale delle cose, la
noia impedisce di tradurre gli sforzi compiuti dall’uomo in ogni campo, sociale o culturale che siano, verso un
esito positivo, anche quando egli si illude di averlo trovato. E allora si può dire che la natura ha provveduto a lenire ogni male e ferita dell’esistenza, fuorché la noia (Zib. 2220). Di fronte a questa creatura contro-natura non si
può far nulla, non si riescono ad escogitare soluzioni efficaci. Da qui lo sgomento dell’uomo, costretto a dover
ripensare la sua condizione di “animale” che di fronte ai propri simili denuncia il possesso di un malessere “innaturale” quale la noia. Neanche la natura, così provvidente in altri casi, sospettava l’esistenza di qualcosa a lei contraria. Sospetto che può far pensare alla destinazione dell’uomo ad un altro modo di vivere e di soffrire, che Leopardi chiaramente rifiuta in molti punti della sua riflessione. I dolori e le disperazioni derivanti da qualche sventura presente nella vita non sono paragonabili, dice Leopardi in Zib. 140, “all’affogamento dalla certezza e dal sentimento vivo della nullità di tutte le cose, e della impossibilità di esser felice a questo mondo, e dalla immensità
del vuoto che si sente nell’anima”.
Secondo l’opinione di Umberto Galimberti11, noi siamo “figli moderni dell’accidia”, in particolare le nuove generazioni. Molti giovani mostrano una spiccata propensione a chiudersi in se stessi e, spesso, una pericolosa inconsapevolezza nell’agire. L’assenza di interessi qualificanti e l’immobilità interiore completano il quadro di questa complessa fenomenologia umana e sociale. “Dunque l’uomo è impotente sul mondo e ancora più lo è il filosofo, non perché non è ascoltato dagli “sciocchi che sono la stragrande maggioranza”, ma perché, se la sua verità
fosse ascoltata, la vita sarebbe impossibile. Vita e verità non possono coesistere. Questo è l’annuncio di Schopenhauer,
che così toglie la maschera alla filosofia dell’Occidente per aprire l’epoca della disillusione. Noi abitiamo quest’epoca,
un’epoca postuma perché viene dopo l’illusione, che Platone ha inaugurato, di dominare il mondo con la ragione, e
quindi di aver ragione del mondo. Anche il trionfo della scienza e della tecnica, che sono le punte avanzate della
razionalità, non riescono a rivivificare l’illusione platonica, e il filosofo, che questo trionfo constata, si imbatte
nell’Eclisse della ragione, quasi a riprendere e a ribadire il disincanto di Schopenhauer, la fragilità della maschera”12.
Dunque la noia, o accidia, è figlia di una fase storica carica di illusione, sfociata in cocente disillusione, segno distintivo di un’epoca postuma nella quale in qualche modo tutto è già accaduto e tutto ciò che l’uomo aveva da
proporre è stato ridotto a pura negatività. Dal punto di vista sociologico possiamo constatare l’incremento che
nella nostra epoca hanno avuto i tentativi di “combattere la noia”, o di “ammazzare il tempo”, come lo svago, i
divertimenti di massa, il lavoro, la guerra, la pornografia e la grafomania, occupazioni in forte aumento. Leopardi
ne è del tutto consapevole. Nel “Dialogo della moda e della morte”, nonostante le due protagoniste siano entrambe impegnate “a disfare e a rimutare di continuo le cose di quaggiù”, si afferma che “tutte e due siamo nate
dalla caducità”. Egli dirà che l’uomo, nel disattivare la noia con attività narcotizzanti ed eccitanti (come lo sport,
la moda, e oggi le droghe o la televisione), e nel trovare rifugio in quella idolatria sociale che Pascal ha chiamato
divertissement (da de-vertere, fuggire dagli affanni della quotidianità, volgere lo sguardo altrove, che Heidegger ha identificato nella banalità del “si dice” quotidiano), dimostra il timore del vuoto d’anima che può causargli
l’interrogazione sulla propria condizione esistenziale. Lì dove viene a mancare la domanda che Svendsen giudica
cruciale, “perché faccio quel che faccio?”, il terrore della noia è in agguato. Quindi l’uomo che evita queste domande è un uomo che non vuole sapere nulla di sé.
Zygmunt Bauman, nell’introdurre il suo saggio sulla “modernità liquida”13, esordisce con un pensiero di Paul
Valéry molto appropriato: “Non riusciamo più a sopportare nulla che duri. Non sappiamo più come mettere a
frutto la noia”. L’epoca moderna ha eletto la “leggerezza”, la “fluidità”, la “liquidità” a idoli culturali del tempo,
10
Vedi Emanuele Severino, Il nulla e la poesia. Alla fine dell’età della tecnica: Leopardi, BUR Rizzoli, Milano 2005, pag. 115.
Queste considerazioni sono desunte dal volume di Umberto Galimberti, Gli equivoci dell’anima, Feltrinelli, Milano 2001.
Sempre di Galimberti si veda il recente saggio dedicato al rapporto tra “Il nichilismo e i giovani”, dal titolo L’ospite inquietante,
Feltrinelli, Milano 2007.
12 Idem, nel § “L’epoca della disillusione”, pagg. 280-281.
13 In Zygmunt Bauman, Modernità liquida, Editori Laterza, Roma-Bari 2002, trad. di Sergio Minucci, pag. V.
11
contribuendo a “de-realizzare” intere mentalità sociali. Nel nostro mondo non hanno rilevanza come in passato
concetti e strutture equiparabili alla sostanza, alle cose reali, alla solidità, ma è come se la “profanazione” dei simboli
culturali messa in atto dalla razionalità strumentale e dalla globalizzazione economica rappresentasse l’ultimo stadio della dissoluzione dell’idea di mondo che faticosamente la nostra civiltà millenaria aveva contribuito a costruire. In campo economico-politico è largamente diffuso un linguaggio a prima vista neutrale (espressioni apparentemente anodine come “liberalizzazione”, “flessibilità”, “deregolazione”, sono la regola), ma esso comporta, come sappiamo, l’abbattimento degli ultimi “sistemi” sociali e mentali del passato. Il sociologo Ulrich Beck ha
chiamato “società del rischio” l’epoca del deterioramento e dello sfaldamento delle principali istituzioni che avevano retto le società umane fino a questo momento, quali la famiglia e le classi sociali tradizionali.
Da qui potrebbe derivarne “la fine della vita dell’individuo” così come l’abbiamo conosciuta fino a questo
momento. Le nozioni di “tempo” e “spazio”, di “lavoro” e “società”, di “benessere” e “felicità” potrebbero subire un forte stravolgimento se davvero dovessero avverarsi le previsioni dei teorici della “fine della storia”, della
“post-modernità” o della “seconda modernità”. Come afferma Bauman, alla lunga potrebbe verificarsi una distopia sociale nella quale ai ricchi spetterebbe il compito della “transitorietà”, della leggerezza e della libertà dagli
obblighi sociali restrittivi, mentre ai poveri la “durata” e la staticità sociale carica di fatica non remunerata e di noia mortale. Un passaggio di Arthur Schopenhauer sembra particolarmente illuminante ed in sintonia con quel
sentimento leopardiano del moderno che Bauman ha colto perfettamente.
“Se la vita, nel desiderio della quale consiste la nostra essenza ed esistenza, avesse un valore positivo e un contenuto reale in
se stessa, non potrebbe esservi noia: bensì la pura esistenza in se stessa dovrebbe appagarci e soddisfarci. Ma noi gioiamo
della nostra esistenza solo in questi due modi: o nel desiderio, nel quale la lontananza e gli ostacoli ci fanno apparire la meta
come un appagamento – e questa illusione scompare dopo che si è raggiunta la meta –, oppure in un’occupazione puramente intellettuale, nella quale però, propriamente, usciamo dalla vita onde considerarla dall’esterno come gli spettatori nei palchi. Perfino il godimento dei sensi consiste in un continuo desiderio, e cessa non appena è raggiunto il suo scopo. Ogni volta che non ci troviamo in uno di quei casi, ma siamo respinti nella nuda esistenza, ci convinciamo della vacuità e nullità di
essa – e questo è la noia”14
“Di solito si crede che la noia sia un momento accidentale dell’esistenza umana, ma tale opinione si basa su
presupposti assai discutibili circa la natura umana”, insiste Svendsen, per affermare che la noia, così come altri
momenti “deiettivi” dell’esistenza, riguarda un aspetto essenziale, rivelatore, imprescindibile, per comprendere la
nostra epoca e il nostro essere. La psicologia psichiatrica non ha ancora chiarito del tutto quale ne sia l’origine e
quali possano essere le modalità di risposta alle ricorrenti domande dell’uomo su un problema così sfuggente
com’è quello della noia: Che cosa ci tormenta? Che cosa ci accade quando siamo in preda alla noia? Perché accade e come si sconfigge?, potrebbero essere domande leopardiane. D’altra parte la stessa ricerca psicologica corrente trova molte difficoltà a parlare di qualcosa che assomiglia, secondo Kierkegaard, ad un sentimento “vuoto”, piuttosto che ad un
“pieno”. La valenza ontologica ed esistenziale della noia è evidente in ogni suo aspetto. Leopardi ne fa un leit
motiv di tutta la sua produzione poetica e saggistica.
Inafferrabile, per molti aspetti indescrivibile, la noia è uno strato della nostra psiche cui manca una sua qualità
dirimente. Si addice all’uomo senza qualità della nostra epoca, nel senso che è proprio di chi non riesce a trovare il
bandolo della matassa della propria esistenza. Non perché siamo in presenza di domande cruciali che non trovano risposta, ma perché constatiamo un azzeramento del domandare e misuriamo continuamente l’annichilimento
della vita vissuta e di “altre” possibilità di esistenza.
Un convincimento diffuso ritiene di poter ricondurre la noia alla carenza di stimoli sensoriali, ma essa purtroppo insorge anche in soggetti e in contesti nei quali questi stimoli sono presenti in gran numero. La noia si compone di sensazioni, emozioni e pensieri che non si lasciano facilmente analizzare. Essa è impenetrabile al senso, o
per lo meno non si schiude ad un senso possibile dell’esistenza, essendone privo. Nella migliore tradizione psicologica e psichiatrica, emerge questo aspetto decisivo. La noia trascende tutti i tentativi di spiegarla in senso deterministico, compresa la psicanalisi, la “psicologia del profondo”:
“Nella loro essenza, le moderne teorie psicoanalitiche della noia finiscono per riproporre, pur in una sofisticata dimensione
metapsicologica intrasoggettiva, le concezioni romantiche della noia come scacco e immagine negativa del desiderio: la noia
è ancora il destino di chi non sa arrendersi alla propria finitudine, rinunciare ad un sogno di onnipotenza, è la malattia delle
esistenze dilaniate dall’incorporazione avida e coatta volta a colmare una beanza ineliminabile. «La noia – scrive Leopardi
nello Zibaldone – è il desiderio della felicità lasciato per così dir, puro». In questo senso la noia trascende ed evade dalla sua dimen-
14
Arthur Schopenhauer, Parerga e papalipomena, a cura di Mario Carpitella, titolo originale,Parerga und Paralipomena: kleine philosophische Schriften, Adelphi, Milano 1998, pag. 377.
sione psicopatologica riproponendosi di nuovo come «sintomo» puro e fondamentale del «male di vivere», del fallimento
intenzionale del desiderio infinito”15.
Risultando improbabile l’equiparazione ad un normale disagio, la noia ha suscitato poca attenzione tra gli studiosi di problemi psichiatrici e di psicopatologie. Pur essendo molto diffusa tra la popolazione, si tratta di uno
stato emotivo difficile da definire, multiforme, sfuggente. Si sbaglierebbe a definirlo semplicemente un sintomo o
un disturbo della psiche, poiché è qualcosa di più e qualcosa d’altro. Non si tratta di una malattia vera e propria,
di depressione o di sofferenza psichica. Non esistono cure per la noia e non bastano espedienti come le “distrazioni” per avviare un processo di “guarigione” del soggetto annoiato. Anche se può sembrare paradossale o inquietante, la noia non si cura, non sono state ancora inventate tecniche appropriate di guarigione, dal momento
che riguarda una condizione di fondo della persona e solo lateralmente interessa la scienza medica. Essa è definibile come una tonalità emotiva che riesce a porsi in sintonia con il nucleo dinamico di maggior rilevanza
dell’essere.
Se la noia è l’impossibilità di orientarsi nel tempo e nello spazio, e quindi nell’esistenza abitudinaria, con la conseguente perdita di valori vitali e ideali, potremmo dire che il soggetto annoiato ha “perso la bussola”, “la rotta”,
o, meglio ancora, con Agostino e Jaspers, ha fatto “naufragio”. C’è chi esalta, al contrario, la virtù dell’erranza sociale e del nomadismo culturale. Se la rotta è obbligatoria, il naufragio individuale apparirebbe come una colpa o,
secondo il forte ammonimento di Kierkegaard (La malattia mortale), un peccato, un male. Ma è proprio così? Sia
Hamann, il mago del Nord, che si definiva “amante della noia”, che Cioran, sostenitore divertito della noia come
“condizione superiore” della conoscenza, testimoniano che la noia è senza peccato e piena di risorse per l’uomo.
Non siamo “condannati” alla noia, ma “salvati” dalla noia.
“Grado zero della sofferenza”, in apparenza a-sintomatica, senza effetti negativi immediati che possano esser
descritti comunemente, la noia in Leopardi è tutto questo. Lo strano tipo di animale che è l’uomo emerge nel
momento cruciale della disamina dell’agire di fronte alla pressione dell’ambiente e delle circostanze. Mentre
l’animale scorda immediatamente la sofferenza, passando di continuo da un flusso all’altro di stati di veglia/stordimento, di fastidio/liberazione, l’uomo porta con sé la memoria degli affanni presenti e passati come un
fardello perenne, per tutta la vita. Carico di tutta l’esistenza passata, l’uomo “tematizza” il dolore, la noia, le afflizioni, attraverso un processo di introspezione continua, paragonabile ad una “ermeneutica perenne”, che interroga la qualità e la condizione del proprio esistere. Infatti, l’essere umano è definito “l’animale che si annoia” e
proprio questa sua disposizione interiore lo rende dis-simile – come dice Heidegger – dalla “povertà di mondo”
dell’animale.
Nella celebre interpretazione fornita da Schopenhauer, la noia deriva da una insopprimibile condizione di disgusto nei confronti degli eccessi vitali che impediscono all’uomo (“fenomeno della sua volontà”) di intraprendere la via della libertà. La libertà dal volere (ciclo vitale) si acquista con la capacità di saper operare una rinuncia al
piacevole e all’utile per superiori ragioni della psiche (ab-negazione): “La volontà come cosa in sé può allora manifestare la sua libertà, mettendo il fenomeno in contraddizione con se stesso. Questo fatto, che si dice abnegazione, può spingersi fino alla vera e propria soppressione dell’essenza in sé del nostro proprio essere; è l’unico e vero
modo con cui la libertà della volontà come cosa in sé può insinuarsi nel campo del fenomeno”16. La noia-libertà è
nell’essere-in-sospeso, nel vivere “inattivo”, nell’essere inerti come le cose inanimate, da cui può scaturire una
perdita di inter-esse (cioè lo “stare tra le cose” dell’esistenza) e di stabilità della psiche non più mossa da valori
positivi.
La psicologia della noia sottolinea peraltro queste difficoltà17: la “non disponibilità” del soggetto ad instaurare
un rapporto di “interesse” con il mondo circostante; la “meccanicità” nel rapporto io-mondo; il sentimento di
“insufficienza” rispetto alla realtà, che genera reazioni spiacevoli e turbamenti; l’”inadeguatezza” rispetto ai compiti sociali da assolvere. Al contrario dell’indifferenza, che si riduce alla passività della coscienza, la noia mostra una
relativa vigilanza della coscienza, non tradotta, però, in un rapporto riuscito con il proprio oggetto, divenendo
piuttosto un “rapporto mancato”, una interazione io-mondo non funzionante. È come se si verificasse una pausa
della coscienza, una messa fra parentesi del mondo; come se il soggetto annoiato mostrasse inavvertitamente un
15
In Carlo Maggini, Riccardo Dalle Luche, cit., pag. 89.
In Arthur Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, a cura di Giuseppe Riconda, Mursia, Milano 1991, pag. 343.
Più avanti Schopenhauer dirà: “...anche l’attività del nostro spirito non è che uno sforzo costante per cacciare la noia”, compito supremo del tentativo di “disattivazione” del volere nell’esistenza umana. Riferimenti essenziali si trovano ovviamente
sul tema della “nausea” di Sartre, che qui non prendiamo in esame.
17 Si consiglia di consultare la voce “Noia” del dizionario Psicologia, a cura di Umberto Galimberti, Garzanti, Milano 2005,
secondo l’accezione filosofica, psichiatrica e psicoanalitica della questione presa in esame.
16
distacco o un rifiuto dell’oggetto-mondo con il quale si relaziona abitualmente. La noia può causare un blocco
della cinetica coscienziale, un corto circuito.
La riflessione di Schopenhauer allude però all’idea che la noia, come assenza di una precisa attività del volere,
può diventare altresì una condizione di privilegio, nel senso di qualcosa di “privato”, inerente al singolo individuo,
indicatore di una sua personale “salvezza”. Il tendere-a-qualcosa di positivo per Schopenhauer è perciò privo di
scopo, dal momento che pure l’individuo geniale, ultimo esempio in ordine di tempo nella scala dell’essere che va
dagli insetti ai vertebrati, è destinato alla sofferenza, come ricorda l’Ecclesiaste in più di un punto18.
Per uscire dalla legge opprimente del “desiderio” e delle “soddisfazioni”, cui segue il tedio che si rinnova ciclicamente, Schopenhauer rivolge l’invito all’uomo affinché trovi qualche attività in grado di annullare la tensione
vitale che lo anima. La noia è quella condizione di sospensione psicologica, un “aspirare senza oggetto”, che ricorda molto da vicino il godimento puro dell’arte e che in Leopardi è costantemente enunciato in prosa e in poesia.
Soprattutto con Martin Heidegger (Che cos’è la metafisica?, 1929), la noia è interpretata come totalità dell’esistere e
momento “rivelativo” dell’esistenza:
“Anche quando, e proprio quando, noi siamo particolarmente occupati dalle cose e da noi stessi, ci soprassale questo “tutto”
per esempio nella noia autentica. Essa è ancora lontana quando ad annoiarci è solo questo libro o quello spettacolo,
quell’occupazione o quell’ozio, ma affiora quando “uno si annoia”. La noia profonda, che va e viene nella profondità
dell’esserci come una nebbia silenziosa, accomuna tutte le cose, tutti gli esseri, e con loro noi stessi in una strana indifferenza. Questa noia rivela l’ente nella sua totalità”.
Secondo il commento di Giorgio Agamben a questo brano di Heidegger: “Il Dasein è semplicemente un animale che ha imparato a annoiarsi, si è destato dal proprio stordimento e al proprio stordimento. Questo destarsi del
vivente al proprio essere stordito, questo aprirsi, angoscioso e deciso, a un non-aperto, è l’umano”19.
La noia profonda si presenta quindi con le caratteristiche della involontarietà, dell’assenza di emotività, della rappresentazione istantanea della totalità degli oggetti presenti nel mondo. Heidegger fa risalire questi caratteri al Dasein, all’”esser-ci”, alla condizione originaria che precede ogni nostro rappresentare e comprendere intellettivo
della realtà. Nell’ambito della psichiatria fenomenologica, Ludwig Binswanger, partendo dalla “Daseinsanalyse”
(“antropo-analisi”) heideggeriana, fissa con l’espressione “a-priori esistenziale” gli elementi che caratterizzano la
condizione umana di immersione nel mondo, che non possono essere ridotti a semplice psicologia descrittiva. Le
ragioni dell’agire umano sono in primo luogo “intrapsichiche”, nell’”essere gettato” nel mondo (Geworfenheit), nel
“nudo orrore”, nel “nulla fenomenologico” di husserliana memoria:
“L’oggetto dell’angoscia o del raccapriccio (di cui parla Schopenhauer), o del nudo orrore (come noi lo chiamiamo), non è
“qualcosa”, cioè un oggetto materiale o un nemico, ma la spettralità o l’inconsistenza della presenza come tale, quando ha
perduto il mondo. Per questo motivo non parliamo più di una tonalità emotiva o di un affetto (come nel caso della paura),
ma di una perdita del mondo e del Sé”20.
Sigmund Freud, nel suo breve saggio su “Lutto e melancolia” (1917), vedrà nella melanconia nient’altro che un
deperimento esistenziale, una diminuzione del Sé, senza scorgervi i caratteri propri della esistenza umana che si
possono leggere nell’osservazione della condizione di disagio vissuta da tanti individui: “Nel melanconico si manifesta qualcosa che nel lutto manca: una straodinaria diminuzione dell’autoconsiderazione, un impoverimento
dell’Io su vasta scala. Nel lutto è il mondo che è diventato povero e vuoto; nella melancolia è l’Io stesso. Il paziente ritiene il suo Io indegno, incapace, e moralmente spregevole; si rimprovera, si denigra e si aspetta di essere
malvisto e punito”. (Più avanti Freud paragonerà la melancolia ad una imprecisata “malattia della coscienza”).
Essendo l’unico ente in grado di porre a se stesso la questione dell’essere, il Dasein heideggeriano può considerarsi da sempre capacità di auto-comprensione e di auto-rappresentazione. La noia è precisamente uno di questi
stati d’animo “rivelativi” fondamentali, ché precede ogni ricognizione sociologica, psicologica e scientifica sulla
condizione umana. La noia è una situazione emotiva fondamentale capace di svelare la modalità di “essere”, o di
18
Si legga il commento al Qohelet e le sette malattie dell’esistenza di Gianfranco Ravasi, Edizioni Qiqajon, Comunità di Bose,
2005.
19 In Giorgio Agamben, L’aperto. L’uomo e l’animale, Bollati Boringhieri, Torino 2002, nel capitolo “Noia profonda”, pag. 73.
20 Ludwig Binswanger, Essere nel mondo, con una introduzione critica di Jacob Needleman, Casa Editrice Astrolabio, Roma
1973, trad. di Giorgio Banti, pag. 342.
“trovarsi”, dell’uomo nel mondo. Lo sbigottimento, l’angoscia, la rassegnazione, l’inoperosità, lo svuotamento
interiore ne sono per così dire i possibili correlati. Filosofare sulla noia per Leopardi può allora avere un senso
come modalità pregnante di risalire ai moventi fondamentali del nostro stare al mondo, nel percepirlo o “emozionarlo” originariamente, nello smarrimento come nella meraviglia, nella negazione come nello stupore21.
Attraverso la noia abbiamo la possibilità di recuperare quella totalità della condizione umana che precede la discorsività razionale, la compiutezza dei linguaggi sociali e l’“amministrazione” dei sentimenti presente nella società odierna. Una società portata a valutare certe emozioni come anomalie o deformità psicologiche, a sostituire
l’autenticità del “sentire” filosofico con surrogati mediologici e a reprimere il vissuto esistenziale attraverso
l’imposizione di valori standardizzati e inautentici, difficilmente potrà comprendersi fino in fondo.
Il paradosso più evidente è rappresentato dalla nostra società che, se da un lato non riesce a capire il valore dei
sentimenti autentici (in particolare delle persone malate), dall’altro diventa essa stessa inautentica, assumendo in
molte circostanze la fisionomia di una realtà schizofrenica, patologica, volgare e “povera di mondo”. Una società
anestetizzata non può contribuire a far emergere tali esperienze emotive dall’oblio in cui sono state cacciate. Dichiara lo psichiatra Eugenio Borgna: “La tristezza, l’inibizione, la sofferenza, l’angoscia e lo scacco della speranza
sono elementi che, afferrati isolatamente, non sempre assumono una radicale connotazione clinica (diagnostica).
Sono sintomi (sono segni) che si osservano non solo nella malinconia come fonte di vita psicotica (endogena) ma
anche nella malinconia come stato d’animo (come Stimmung) che è al di là di ogni categoria psicopatologica”22.
La Stimmung particolare della noia è l’“apertura” a ciò che si chiude al senso, e precisamente riguarda l’ente uomo “che si rifiuta” di accedere al suo essere. La sospensione del rapporto fiduciario e autentico con l’ambiente
storico-sociale, indipendentemente da situazioni di normalità o di patologia soggettiva, è il punto nevralgico da
cui dovrà ripartire la riflessione filosofica e scientifica, illuminando quella zona “intermedia”, posta tra soggetto e
oggetto, dove si collocano i significati esistenziali che andiamo cercando.
2. L’infelicità nativa del dolore e del nulla
L’«infelicità nativa» dell’essere umano presente nella prosa e nella poesia leopardiana confina con il sentimento
religioso dell’infinito e dell’eterno, ma questo non vuol dire che Leopardi – come intenderebbe la facile vulgata
che vuole annoverarlo tra i credenti mancati o un metafisico in nuce – aderisca ad una prospettiva tendente ad indirizzare l’esistenza umana verso un valore metafisico più ampio, capace di annetterlo al suo interno. Al contrario, il dramma leopardiano del nichilismo vitale e umano, dell’esistenza priva di senso, può essere compreso solo
se investigato “in solitudine”, una “piena solitudine”, se è concessa questa espressione ossimorica. Proprio per
questo motivo certe accentuazioni nichilistiche, certo periodare e pensare “impertinente”, possono risultare deflagranti come un ordigno in attesa di esplodere. In Leopardi il dramma metafisico dell’uomo è l’accoglimento di
Dio in quanto “assente” nel mondo-cosmo che abbiamo di fronte, che si può comprendere solo “in lontananza”,
per evitare di aggiungere alla illusione della “vita terrena” anche quella della “vita ultraterrena”.
In uno studioso come Alberto Caracciolo, l’esistenza umana che patisce sulla propria pelle “l’esperienza del
nulla” sfocia decisamente in un dramma metafisico che può essere spiegato, al contrario, solo ricorrendo al senso
religioso della vita. Il “vuoto” dell’esistenza verrebbe colmato dal “pieno” dell’esistenza metafisica di Dio, in un
crescendo esistenziale ed ontologico che trova nella circolarità Dio-uomo-Dio la sua ragion d’essere23. Pronunciando la frase, “solo quando sia vittoria sulla «malattia mortale», la vita è veramente vita”, Caracciolo sfrutta il
“nichilismo metodico” presente in Leopardi per esaltare quel fondo religioso, quell’ansia filosofica e metafisica
che la critica letteraria maggiore, dei De Sanctis Croce De Robertis Gentile Russo, non ha saputo cogliere fino in
fondo. A suo parere in Leopardi possiamo rintracciare una Grund-frage, una Ur-frage, una domanda complessiva di
senso, una implicazione etica del filosofare e del poetare che molti non hanno notato adeguatamente. La poesia
“dice” in modo finito una “verità” sull’infinito che gli sta davanti. Come l’attimo posto di fronte all’eterno,
l’istante fuggevole si fa esperienza dell’eterno infinito. Incontrato come πάθη, emozione profonda, passione caotica, notte luttuosa, male radicale, l’uomo si affida ad una sensibilità fortissima posta di fronte “alla nullità delle
cose”. L’esperienza profonda del nulla, l’annichilimento come momento teorico essenziale del pensiero leopardiano, la Nichtserfahrung (esperire l’annichilimento, il nulla), dicono che il nostro poeta non è più quell’autore “evasivo” e incerto sul piano filosofico-teoretico tramandatoci dalla tradizione. Il nihil leopardiano, collocato non
indifferentemente da Caracciolo accanto a quello heideggeriano (sulla base delle parole-guida morte-Dio-tempo, Tod21
Uno studioso che recentemente ha trovato degli interessanti accostamenti fenomenologici ed esistenzialistici tra Leopardi
e Heidegger è Gino Zaccaria, Pensare il nulla. Leopardi, Heidegger, Ibis, Como-Pavia 2008, di cui si dirà più avanti.
22 In Eugenio Borgna, Malinconia, Feltrinelli, Milano 2001, pag. 21.
23 I riferimenti testuali di Alberto Caracciolo appartengono alla raccolta di saggi Leopardi e il nichilismo, Bompiani 1994, ma
anche a Pensiero contemporaneo e nichilismo, Napoli 1976.
Gott-Zeit), è il contrasto-confronto tra il “niente oggettivo”, con il quale interpretiamo un nichilismo dalle forti
parentele atee e materialistiche, e il “nulla religioso”, che ha ovviamente una valenza diversa.
“Il Nulla che sta sull’orizzonte dell’angoscia non è il niente che si può prospettare al termine della mia vita […] il Nulla
dell’angoscia è lo spazio in cui si genera ciò che costituisce la vita dell’uomo in quanto uomo”24.
Solo dalla “contingenza” del mondo25 emerge la domanda filosofica cui può seguire un riscatto, una invocazione religiosa, una comunicazione autentica (Jaspers), anche perché lo stesso Leopardi ammonisce che “gli uomini
sono miseri per necessità, e risoluti di credersi miseri per accidente”. Il male presente nel mondo, che insidia
l’uomo fin nella radice profonda del proprio essere, è un male radicale, strutturale, trattandosi di un indiscutibile
malum mundi, e non di mala contingenti destinati a passare. Ora, questa “negatività originaria che inficia le strutture ultime del reale e che nessuna buona volontà d’uomo è in grado di redimere” (Caracciolo, cit., pag. 22), paragonabile ad una sorta di “peccato originale” di memoria biblica che pesa sul mondo, non è in grado di ricevere
un senso pieno e profondo né nel nostro mondo, né dall’extramondo della metafisica, in quanto questo significato complessivo della vita non si rivela all’uomo. Nella Storia del genere umano, composta nel 1824 e collocata strategicamente come Premessa delle “Operette morali”, troviamo la favola di Giove che cerca di alleviare le sofferenze e la noia umana con la creazione di un mondo vario e interessante. Dopo il diluvio universale, la nuova umanità di Decaulione e Pirra riceverà altri conforti dalla divinità ma senza costrutto; la vanità e l’avidità sostituiscono
l’antico terrore dell’oscurità e della morte, ed ecco subito ripresentarsi le “meravigliose larve” delle illusioni, la
fervida immaginazione che conduce gli uomini alla perdizione, la vanagloriosa sapienza che si illude di conoscere
la verità.
Il dramma dell’uomo non dipende dall’esistenza dei mali presenti sulla terra, ma deriva dalla impossibilità di riferire l’esistenza macchiata dal male ad una ragione-spiegazione che ne possa stemperare la durezza e la crudeltà.
Come il Danton di Büchner, “presto il nulla sarà il mio rifugio!”, o il Payne della “roccia dell’ateismo”26, in Leopardi il nichilismo emergente dai suoi scritti ci consente di toccare da vicino il cuore delle cose stesse, “aus der
Sache selbst”. Silvia, la Nerina delle Ricordanze (“I giorni tuoi/ Furo, mio dolce amor. Passasti. Ad altri/ Il passar
per la terra oggi è sortito,/ E l’abitar questi odorati colli”), il “garzoncello scherzoso”, la “donzelletta”, il “pastore
errante”, presto scoprono l’arido vero partorito dalla ragione e l’insensatezza della vita. Questi personaggi
dell’anima, proiezione dell’io e di noi stessi, li ritroviamo accomunati da questo intimo convincimento
dell’insensatezza del vivere, anche in quelli non disposti ad ammetterlo, o per ignoranza, per superficialità, o infine per supponenza.
L’arido vero, figlio della ragione, è per Caracciolo un aspetto direttamente collocabile a livello ontologico, essenziale, evidente come il sole e devastante per limpida chiarezza: “Il pensiero di un peccato di origine ontologico, che inficia la struttura stessa non solo dell’esistere dell’uomo, ma del vivere di quanto vive nell’immensità dei mondi, fu
da lui pensato – proprio filosoficamente pensato – con una lucidità e una coscienza eccezionali di ciò” (Caracciolo, cit., p. 30). Se da qui ricaviamo l’idea della in-essenzialità dell’essere umano, diretta conseguenza del suo “nulla
sostanziale”, vani sembrano i tentativi della cultura moderna di trovare dei sostituti alla disperazione calma e
fredda dei nostri tempi. “Chimeriche” appaiono le nuove scienze, enfatiche e presuntuose nel presentarsi come
“risolutive” delle problematiche sociali e soprattutto “inutili” quando pretendono di parlare alle “masse”, quasi
supponendo che esse esistano realmente. I successi “mondani” che alcune di queste scienze pretendono di aver
raggiunto sono trattati da Leopardi con la serenità dell’ironia e la passione negativa dell’insoddisfatto.
Nel Cantico del gallo silvestre, scritto da Leopardi nel novembre del 1824, viene svolto il tema della infelicità della
vita come diretta conseguenza di un ordine naturale sorretto dal nulla. Il gigantesco gallo che “sta in sulla terra
coi piedi, e tocca colla cresta e col becco il cielo”, dotato di ragione, parlante come un pappagallo ammaestrato,
recita tutte le mattine agli uomini increduli il suo “cantico”, il suo “inno religioso”, per ricordare la soavità del
sonno, le sofferenze quotidiane della vita, e l’ineluttabilità della morte. Al termine della giovinezza, quando i sogni di beltà scadranno nello scetticismo più cupo, non resta che la cruda consapevolezza della morte, del nulla
eterno, e la “profondissima quiete”, derivante da un universo indifferente alla sorte dell’uomo.
24
Idem, pag. 21.
Qui andrebbe consultato il lavoro proposto da Gaspare Polizzi, in Leopardi e le ragioni della verità, Carocci, Roma 2003, che,
con l’indagine degli scritti scientifici giovanili e dello Zibaldone, arriva alla formulazione di una “filosofia delle circostanze”,
tutta derivante dall’esame dell’esistenza come contingenza e, appunto, circostanza.
26 Questi due riferimenti sono desunti dal testo teatrale di Georg Büchner, La morte di Danton, nella trad. di Giorgio Dolfini,
Mondadori, Milano 1971.
25
“Pare che l’essere delle cose abbia per suo proprio ed unico obbietto il morire. Non potendo morire quel che non era, perciò
dal nulla scaturirono le cose che sono. Certo l’ultima causa dell’essere non è la felicità; perocché niuna cosa è felice” […]
“Tempo verrà, che esso universo, e la natura medesima, sarà spenta. E nel mondo che di grandissimi regni ed imperi umani,
e loro meravigliosi moti, che furono famosissimi in altre età, non resta oggi segno né fama alcuna; parimente del mondo intero, e delle infinite vicende e calamità delle cose create, non rimarrà pure un vestigio; ma un silenzio muto, e una quiete altissima, empieranno lo spazio immenso. Così questo arcano mirabile e spaventoso dell’esistenza universale, innanzi di essere
dichiarato né inteso, si dileguerà e perderassi”27.
Il “silenzio muto”, “una quiete altissima”, governano “lo spazio immenso” dell’universo, per dare vita ad un
“arcano mirabile e spaventoso”, in cui si dileguano le cose, i sogni e le speranze umane. Ritroveremo questi accenti nella celeberrima lirica L’infinito, scritta ben cinque anni prima (“Ma sedendo e mirando, interminati/ Spazi
di là da quella, e sovrumani/ Silenzi, e profondissima quiete”, vv. 4-6), e nel Canto notturno di un pastore errante
dell’Asia, in cui il rapporto tra infelicità umana e dolore cosmico è giocato tutto sul finto dialogo tra un pastore
asiatico, la luna posta nel cielo e la greggia ignara accanto a sé. L’esistenza umana, illusa di poter sopravvivere ai
colpi del caso, della fortuna e al dramma di esistere con la convinzione della superiorità intellettuale rispetto a tutto il resto dei viventi, è di gran lunga svantaggiata, e dovrà presto riconoscere i vantaggi dell’ignoranza e della inconsapevolezza. Leopardi reclama il diritto all’oblio, il bisogno di una felicità non intaccata dalla coscienza di essere nel mondo, che fa dell’uomo un essere destinato a morire dal primo giorno della nascita. Annota Mario Andrea Rigoni che “solo nelle forme di esistenza prive o povere di vita (secondo una nota distinzione dello Zibaldone
tra esistenza come pura esteriorità e vita come interiorità senziente), solo nel mondo inorganico o animale sembra
immaginabile quella felicità negata all’uomo che ha scoperto, con la conoscenza e con la storia, l’inutilità e la noia
del tutto (e si ricordi che i versi sulla greggia hanno direttamente ispirato l’inizio della seconda delle Considerazioni
inattuali di Nietzsche, centrato proprio sul motivo della felicità come «oblio», come «capacità di sentire, mentre
essa dura, in modo non storico»)28.
Il “Canto notturno” corrisponde ad una angoscia metafisica del dolore universale, appena stemperata dal clima
familiare e onirico con cui viene presentato il dialogo uomo-luna-greggia. Il Leopardi materialista e illuminista
cede il passo alla contemplazione muta dell’evento cosmico: dolore intriso di silenzi, quiete, astratta trasfigurazione degli affanni umani. Il lento meditare del poeta-filosofo conquista pian piano la scena precedentemente occupata dall’analista coriaceo della società e del tempo storico. La dialettica che qui si pone è quella tra il nichilismo oggettivo di tutta la tradizione precedente (da ricercare nel Settecento sensista e illuminista su cui Leopardi
si è formato) e il “nulla religioso” (Caracciolo), ancora alla ricerca di una sua fisionomia da precisare. Secondo
l’osservazione di Giovanni Getto:
“In tutto il componimento si alterna la prospettiva del tempo fragile del pastore, della vita destinata alla morte dell’uomo, di
questo nostro affrettarci verso il nulla, e della vita immortale dell’universo, dell’«infinito andar del tempo», dell’eterno circolo
dell’esistenza sulla terra e nel cielo. Il grande interrogativo sul mistero della vita, mosso dalla considerazione della vicenda e
del destino della luna confrontati a quello del poeta, si approfondisce attraverso la rappresentazione tutta negativa del «Vecchierel bianco» che nell’infermità e nel disagio, sotto un peso durissimo, s’affretta per una terra inospitale, tra l’avversità degli
elementi, fra cadute e ferite, con una fatica immensa, per arrivare alla fine e precipitare nella voragine della morte nell’abisso
dell’oblio, nel nulla della cessazione della memoria e del tempo […] E il poeta si preoccupa subito di insistere sull’infelicità
che è alle sorgenti stesse del vivere, nella nascita e nei primi anni”29.
Nei versi di Leopardi riecheggiano probabilmente echi dell’episodio di Re Mida che chiede a Sileno la verità
sulla cosa più desiderabile nella vita, ottenendo una risposta imprevista e poi divenuta proverbiale: “Per prima
cosa non essere nato, non essere niente, e dopo morire al più presto”30.
L’uomo è segnato nel mondo dalla delusione degli eventi esterni (naturali e storici) e personali. Noi siamo heideggerianamente “gettati nel mondo”, il mondo non dà nulla, anzi è un nulla. Il mondo è un luogo di detenzione,
per giunta crudele e pieno di affanno. Come creature innocenti, vaghiamo nel mondo alla ricerca di una soluzio27
Operette morali, cit., pag. 242 e 244.
In Poesie e prose di Giacomo Leopardi, a cura di Mario Andrea Rigoni, Mondadori, Milano 1987, pag. 968. Si ricordi che
Leopardi, oltre ad aver anticipato considerazioni nietzschiane divenute famose e solo oggi messe in evidenza dalla critica,
conduce un suo discorso parallelo alla filosofia di Schopenhauer, che, occorre dirlo, trova nel recanatese una sorta di cantore
lirico di verità destinate a rimanere inespresse nella chiusa oscurità della prosa filosofica.
29 Giovanni Getto, in Introduzione a Giacomo Leopardi, Opere, Milano, Mursia 1966.
30 Si veda al riguardo l’interessante studio di Umberto Curi, Meglio non essere nati. La condizione umana tra Eschilo e Nietzsche, Bollati Boringhieri, Torino 2008, che parte dal detto di Sileno per approdare a Nietzsche, e al suo “sì” alla vita, attraverso la filosofia greca, la letteratura veterotestamentaria, Giobbe, Qohèlet e Geremia in particolare, fino a Kierkegaard e Simone Weil.
28
ne ai nostri mali, presto delusa. L’uomo soffre tutto il male presente in natura vivendolo come necessità ed estraneità. La “necessità” è la categoria portante del mondo. L’”estraneità” ne è per così dire un correlato di pari rilevanza. In questa condizione inospitale, la natura è una sovrana che ignora tutti i nostri patimenti; l’uomo non può far
altro che avvertire la “distanza” che lo separa dall’ispirazione verso il desiderio puro dell’infinito. L’estraneità
dell’uomo alla natura è paragonabile al “disinganno” dell’età moderna segnata dallo sviluppo scientificotecnologico, dove la nuova società avanzante sostituisce tumultuosamente la natura nell’immaginario dell’uomo
ma come quella è incapace di “dilettarlo” e lenirgli le sofferenze31.
Lo stesso Leopardi aveva dichiarato che la vera filosofia si riconosce dalla capacità di saper rappresentare “il
mondo contraddittorio della vita”. Questo vuol dire negare la possibilità di ridurre la vita stessa ad un sistema astratto di riferimento che pretenda di spiegare ogni cosa. La vita considerata come “scolorar del sembiante”,
“male”, “funesto dì fatale”, scorre come materia fluida e contingente, linfa vitale caratterizzata dalla contraddizione e dal differimento. A parere di Sergio Givone, “questo non significa che per Leopardi la contraddizione è
cosa del pensiero, ma non della realtà. Al contrario, significa che contraddizione è l’esistenza, contraddizione è la
verità, poiché la verità non è se non l’esistenza stessa della contraddizione. Infatti la verità secondo Leopardi non
è altro che la nullità dell’essere. Sapere, questo, perfettamente contraddittorio. Sapere per cui «la vita ripugna alla
vita, l’esistenza all’esistenza»”32. Givone giustamente fa riferimento alle più recenti indagini sul pensiero ontologico del Leopardi, che si discostano dal riferimento alla linea Luporini-Timpanaro e a quella ancora più remota dei
De Sanctis e Croce, che denunciavano il carattere scarsamente speculativo del pensiero del recanatese. In Leopardi il suo specifico nichilismo metafisico spazza via ogni ipotesi interpretativa di questo genere. La multiformità del suo pensiero, la contraddittorietà delle investigazioni, l’imprevedibilità delle conclusioni, fanno del pensiero
leopardiano un “pensiero aperto”, mai concluso, dovuto in primo luogo al volto magmatico del mondo in cui ci
troviamo a vivere e alla impossibilità di concepire un “ordine retto” dello stesso. Vivere e pensare sono nettamente e definitivamente in contrasto, un contrasto nient’affatto psicologico ma reale, essenziale, metafisico.
Se è pur vero che Leopardi, secondo l’opinione di Emanuele Severino, rappresenta il culmine del nichilismo
della tradizione occidentale, in parte determinato dall’influenza esercitata dal Cristianesimo sulla cultura e che ritiene il mondo un “nulla” creato da Dio e destinato a rientrarvi, a meno che non l’impedisca uno specifico decreto divino teso ad eternizzarlo, l’originalità del nostro pensatore consiste nell’aver messo a nudo questo stesso nichilismo, portandolo verso conseguenze impensabili, assimilando l’essere al nulla, e nientificando le ragioni stesse
con cui solitamente spieghiamo scientificamente le cose e l’esistenza. Per Leopardi non esiste alcun elemento
“immutabile” cui far riferimento. La realtà è mistero, “cosa arcana”, enigma, discorso aperto, sofferenza allo stato puro33.
“Tutto è nulla al mondo” (Zib. 72), l’essere finito fonda se stesso sul proprio annullamento e quindi coincide
col nulla. In questo senso l’eternità dell’Essere e l’eternità e infinità del Nulla si equivalgono. A differenza del
pensiero metafisico della tradizione, che pone l’Essere e il Nulla come antitetici, in Leopardi li ritroviamo come
elementi indistinti. Leopardi è un vero spartiacque nella cultura poetica e filosofica contemporanea. In lui la coscienza dell’azzeramento nichilistico dell’essere, inteso come eternizzazione del finito e del mondo creato, diventa piena e consapevole. L’angoscia leopardiana derivante da questa estrema consapevolezza dello svanire
dell’essere nel nulla accogliente, è da collocare nel contrasto insanabile tra l’eterno e il mortale. In Zib. 644 egli
descrive questo tema con parole laceranti e intimamente personali: “Non c’è forse persona tanto indifferente per
te, la quale salutandoti nel partire per qualunque luogo, o lasciarti in qualsivoglia maniera, e dicendoti, non ci rivedremo mai più, per poco d’anima che tu abbia, non ti commuova, non ti produca una sensazione più o meno trista.
L’orrore e il timore che l’uomo ha, per una parte, del nulla, per l’altra, dell’eterno, si manifesta da per tutto, e quel
31
Occorre ricordare che tutta la critica leopardiana di ispirazione marxista parte dal presupposto “infondato” che dietro il
peregrinare cosmico-metafisico del poeta recanatese si nasconda una esigenza di umanizzazione del mondo e della società.
Dal Leopardi “progressivo” di Luperini al Leopardi “verde” di Timpanaro, in particolare degli scritti militanti 1966-2000, Il
verde e il rosso, a cura di Luigi Cortesi, Odradek, Roma 2001, la prospettiva marxista ed ecologista di questi autori tende a vedere in Leopardi un antesignano del pensatore di Treviri, che sarebbe animato dalla esigenza di rendere “accogliente e familiare il mondo in cui viviamo”. La finalità del presente lavoro, al contrario, mira a dimostrare una tesi in contro tendenza. Il
mondo leopardiano è un inesorabile passaggio dal sensismo delle origini allo gnosticismo pessimista degli anni della maturità.
Questa convinzione nasce dalla consapevolezza che cento anni e passa di critica estetica e filosofica hanno o equivocato il
poeta recanatese o interpretato in una chiave sbagliata, secondo categorie superate e schemi ideologici antiquati, vedi il positivismo e l’idealismo degli inizi e lo storicismo marxista successivo al secondo dopoguerra.
32 Contenuto in Leopardi e la filosofia, a cura di Gaspare Polizzi, Polistampa 2004.
33 Luigi Baldacci ha chiamato questa “eresia teoretica” di Leopardi Il male nell’ordine, Edizione Rizzoli 1997, concependo il
proposito “mostruoso” del recanatese come un antipensiero che vuole a tutti costi rappresentare la realtà così com’è, contro
tutti quei tentativi di “addomesticamento” del pensiero tendenti a dare una visione rassicurante, edulcorata e purtroppo mistificata, della realtà, che provengono dagli ambienti conformisti e reazionari della società.
mai più non si può udire senza un certo senso”34. Coscienza della lacerazione operata da quel mai più che molti
uomini non vorrebbero pronunciare e nemmeno ascoltare, angoscia delirante che prova sgomento dell’eterno posto di fronte a noi in posizione di muta e inquietante figura, Leopardi consegna alla contemporaneità un paesaggio umano del tutto irriconoscibile. La reazione al nulla dell’esistenza può comportare il vano orgoglio scadente
nella bêtise umana, la chiusura di fronte alla crudezza della realtà che si crede di poter superare rifugiandosi nello
spiritualismo a buon mercato dalla religione, o la vaghezza delle illusioni.
Leggiamo in Schopenhauer questa chiara rappresentazione della nullità dell’esistenza:
“Ciò che è stato non è più; e non è allo stesso modo di ciò che non è mai stato. Ma tutto ciò che è, nell’attimo successivo è già
stato. Perciò il presente più insignificante ha, rispetto al passato più significativo, il vantaggio della realtà; sicché il presente
sta al passato come qualcosa al nulla.
D’un tratto si esiste, con nostra meraviglia, dopo non essere stati per innumerevoli millenni, e dopo breve tempo si deve
non essere per un periodo altrettanto lungo. – Ciò non è affatto giusto, dice il cuore: e perfino un rozzo intelletto da questo
tipo di considerazioni riceverà un barlume dell’idealità del tempo. Ma questa, insieme all’idealità dello spazio, è la chiave di
ogni vera metafisica, perché, proprio mediante tale idealità, si fa posto a un ordine di cose del tutto diverso da quello della
natura. Per questa ragione Kant è così grande.
A ogni evento della nostra vita l’«è» appartiene solo per un attimo, poi gli apparterrà per sempre il «fu». Ogni sera, siamo più
poveri di un giorno. Nel vedere scorrere questo nostro breve periodo di tempo potremmo diventar pazzi, se nel più profondo recesso della nostra essenza non vi fosse la segreta coscienza che ci appartiene la sorgente inesauribile dell’eternità, per
poter rinnovare con essa continuamente il tempo della vita”35.
3. Il gioco voluttuoso dell’illusione
Luogo dell’inverosimile, realtà mutante e febbrile, l’esistenza umana (il “vivente” per eccellenza) per Leopardi
non è finalizzata ad alcuna ricerca razionale, tanto meno alla ricerca salvifica personale, che è al di là delle nostre
forze e in fin dei conti illusoria. Luogo contraddittorio per definizione, sede di molteplici paradossi, l’esistenza
umana oscilla tra l’impulso naturale alla felicità e al piacere (come sembrerebbe indicare il primo passo citato
all’inizio del capitolo) e la comparsa della noia come proiezione di quel nulla che troneggia sullo sfondo della realtà, visto e considerato che il dolore fa desiderare a volte la morte piuttosto che la vita (seconda citazione).
Il Leopardi figlio dell’Illuminismo e dello scientismo settecentesco mina al suo interno l’essenza stessa di questa
filosofia. Nonostante il linguaggio e l’argomentare possano far riferimento ad altre scuole di pensiero, Leopardi
rivede profondamente il ruolo della ragione nello sviluppo dell’uomo e della civiltà moderna. Il progresso della
ragione è la causa specifica dell’infelicità umana e addirittura viene rivalutata la Religione come “puntello” di un
“crollante edifizio” (Zib. 1982, 23 ottobre 1821), così come in molti spunti poetici, ad esempio Alla primavera o
delle favole antiche (1822), “Forse alle stanche e nel dolor sepolte/ Umane menti riede/ La bella età, cui la sciagura e
l’atra/ Face del ver consunse/ Innanzi tempo?”, è affermato chiaramente il contrasto nettissimo tra la dolce età
degli antichi e la miserevole condizione dei moderni, dove la prima età felice dell’umanità non sarà riconquistata
né ora né mai36.
34
Qui noterei una straordinaria affinità tra questo passaggio e alcuni versi di Rainer Maria Rilke, tratti dalle Elegie duinesi,
BUR Rizzoli, Milano 2001, Elegia IX, pag. 91: “Di noi, i più fugaci. Ogni cosa/ una volta, solo una volta. Una volta e mai
più. E noi pure/ una volta. Un’altra mai più. Ma questo/ essere stati una volta, anche solo una volta,/ essere stati terreni, sembra irrevocabile”. Mi permetto di rinviare ad un mio saggio, Sulla sofferenza. Un breve profilo fenomenologico-esistenziale, con postfazione di Giovanni Ferretti, Editrice La Cassandra, Pineto (TE) 2006, capitolo “Ek-statica del dolore”, in cui il commento a
Rilke è all’insegna del dolore “irrevocabile” e definitivo, come necessaria conseguenza della caducità e finitudine
dell’esistenza.
35 Arthur Schopenhauer, Parerga e paralipomeni, cit. Cap. XI, “Aggiunte alla dottrina della nullità dell’esistenza”, 143, pagg.
371-372. L’autore prosegue, nel § 144, dicendo che: “La nostra esistenza non ha alcuna base e fondamento su cui riposare se
non il fugace presente […] In un mondo del genere, nel quale non è possibile una qualsiasi stabilità, una condizione duratura, ma tutto si trova in un vortice e in un mutamento incessanti, tutto incalza, vola, si tiene in piedi sulla corda camminando
e movendosi continuamente – non è possibile nemmeno immaginarsi la felicità”, pagg. 372-373. In una nota cancellata
Schopenhauer aggiunge che “noi non siamo altro che species transitivae, fuggevoli figure, ombre senza un attimo di ferma e
permanente esistenza in tutta la nostra vita, in quanto essa è una catena di mutamenti: in continuo movimento, senza posa,
ci precipitiamo verso la nostra fine. Il nostro opposto, rettamente riconosciuto, sono le idee di Platone, le forme fisse e immutabili degli esseri: ciò che sempre è e mai diviene; mentre noi rappresentiamo ciò che sempre diviene e mai è” (pag. 373).
36 Poesie e prose, cit., a cura di Mario Andrea Rigoni, si dice in nota, pag. 933, che a differenza di Wordsworth, Shelley, Keats,
Platen e dei romantici tedeschi, Schegel, Schiller e Hölderlin, Leopardi non crede “…alla possibilità di ricostruire la beata
armonia primitiva su un altro piano (che non sarà, ovviamente, quello della spontaneità e della naturalezza irriflessa, ma
quello dello spirito consapevole e del divenire «dialettico»)”. Nel commento alla poesia Rigoni afferma:”Torna la stagione
Nonostante prevalga la insistita, e tragica, constatazione della nullità della vita odierna, che rischia di condurre
l’uomo alla paralisi del sentire, poiché soggiogato dai falsi bisogni e dalle illusioni del mondo, nel pensiero di Leopardi la contraddittorietà dell’«umano sistema»37 non può essere curato con il riferimento ai valori della libertà
gloria virtù (De Sanctis), ma ad un livello superiore rispetto ai vecchi valori umani, per aspirare al di là dell’uomo,
ad una destinazione “diversa da questa miserabilissima esistenza” (come nello Schopenhauer dei Parerga). Leopardi indica in ogni luogo del suo pensiero la radice metafisica e non psicologica di quel desiderio naturale al godimento della vita presente in ogni essere umano. Piuttosto che “servire la vita” in modo deterministico e necessario, noi dobbiamo “servirci della vita” per indirizzarla in un’altra direzione. Non l’egoismo dei piaceri, non la
golosità materiale della vita, neanche la mitologia della falsa gioventù, ma, come in Zibaldone (2529), la consapevolezza della condizione di nullità della vita umana non è la premessa dell’irresolutezza, al contrario è stimolo ad una
diversa modulazione della stessa esistenza, più consapevole ed autentica:
“Finché si fa conto de’ piaceri, e de’ propri vantaggi, e finché l’uso, il frutto, il risultato della propria vita si stima per qualche
cosa, e se n’è gelosi, non si prova mai piacere alcuno. Bisogna disprezzare i piaceri, contar per nulla, per cosa di niun momento, e indegna di qualunque riguardo e custodia, i propri vantaggi, quelli della gioventù, e se stesso; considerar la propria
gioventù ec. come già perduta, o disperata, o inutile, come un capitale da cui non si può più tirare alcun frutto notabile, come già condannata o alla sofferenza o alla nullità; e metter tutte queste cose a rischio per bagattelle, e con poca considerazione, e senza mai lasciarsi cogliere dall’irresoluzione neanche nei negozi più importanti, nemmeno in quelli che decidono di
tutta la vita, o di gran parte di essa. In questo solo modo si può goder qualche cosa. Bisogna vivere εική, témere, au hasard, alla
ventura” (30 giugno 1822).
L’amarezza della vita porta alla considerazione estrema che tutto è destinato al male, alla perdita della felicità e
delle illusioni. Se il progresso della ragione e del vero scientifico è all’origine dell’infelicità umana, non è da scartare l’ipotesi che “…questa interpretazione storica convive fin da adesso con lo straziante sospetto che il dolore sia
la condizione naturale, metafisica, e quindi astorica, del vivente”38. Una vera esperienza del mondo nasce dal dolore e dalle delusioni provate nel corso dell’esistenza. L’illusione, come dice Franco Cassano39, è un rimanere rinchiusi nel ludus, nel gioco, nell’il-ludersi, per poi passare nell’età adulta, attraverso l’alba di un nuovo giorno rischiaratore e infelice, nella delusione, nel de-ludersi, nell’allontanamento più o meno volontario dal mondo infantile. Il
nucleo sostanziale di questa illusione che è in primo luogo giovanile, consiste nello scoprire sulla propria pelle la
legge inesorabile del mondo, irrazionale e puntuale, necessaria e al tempo stesso arbitraria, barbarica. “Ad ogni
gioventù appartiene la convinzione e l’illusione di potersi sottrarre alle regole valse per le generazioni che l’hanno
preceduta, perché ogni giovane pensa di costituire un’eccezione che cade fuori delle regole comuni”. Da qui
l’insegnamento leopardiano di apprendere rapidamente questo duro sacrificio, e il segreto di questo “pesante apprendimento” consiste nello “scoprire dolorosamente che non esistono eccezioni”.
primaverile, ma non torna né quella primavera della vita individuale che è la giovinezza né quella primavera del mondo che
fu l’antichità, quando l’universo era un’intatta e sacra unità, palpitante di una vita insieme materiale ed arcana: i fiumi erano
abitati da ninfe, le selve scosse da misteriose danze «d’immortal piede» e il pastorello che nell’ora segreta del meriggio conduceva sulla riva il gregge assetato poteva udire le musiche dei fauni e avvertire stupito, nel tremolio delle acque, la presenza
di Diana al bagno. Tutto allora – i fiori, le erbe, i boschi, gli animali, i venti, le nuvole, gli astri – era in animato, personale
accordo con l’uomo. Ma, dopo che la terra fiaccola del vero ha insediato nel mondo il dominio dello spirito, della scienza,
della metafisica, […] quella «santa natura» si è dileguata per sempre e la Terra, disertata dagli dèi, appare vuota e cieca, insensata e straniera”.
37 Si veda il testo di Adriano Lanza, Leopardi e la trasmutazione dell’uomo, Solfanelli, Chieti 1992, pref. di Carlo Ernesto Meriano, scritto nel 1953 ma ancora carico di ricche suggestioni interpretative neognostiche e neoplatoniche sul Recanatese.
38 In D. Consoli, Cultura, coscienza letteraria e poesia in Giacomo Leopardi, Le Monnier, Firenze 1967, pag. 12. Nello stesso volume l’Autore ha modo di sottolineare l’importanza dell’illusione nel sistema di riferimento complessivo del pensiero leopardiano, commisurandolo al desiderio di espansione vitale dell’uomo e non alla mancanza di risolutezza come comunemente viene interpretato: “Illusione è uno dei vocaboli tematici del secolo, e tuttavia possiede mutevolissimi significati. Può esprimere
bisogno d’infinito e di totalità, evasione dalla realtà nella favola, aspirazione alla libertà, concepimento di una esistenza spaziante oltre i suoi aspetti schematizzabili, richiamo alla creatività dell’uomo, alla sua natura sentimentale, alla sua tensione
religiosa, alla sua sensibilità intatta e intangibile dalla razionalità”, ivi, pagg. 11-12. Non dimenticherei in questo momento il
breve saggio di Franco Fortini, “Il passaggio della gioia”, (1967), in Verifica dei poteri, Il Saggiatore, Mondadori Editore 1969,
in cui l’Autore giudica positivamente l’apporto di pensiero dei “Canti” al resto dell’opera di Leopardi come ciò “che agli
uomini sia dato consumare nella «forma» una pienezza vitale o (se si preferisce) godere una esperienza «totalizzante», in altri
tempi o società configurata come religiosa o mistica e in Leopardi estetica invece e poetica”, pag. 253.
39 Di cui segnaliamo Oltre il nulla. Studio su Giacomo Leopardi, Editori Laterza, Roma-Bari 2003.
Bibliografia essenziale
AA.VV., Omaggio a Leopardi, Francisci, Abano Terme 1987.
AA.VV., Leopardi e il pensiero moderno, a cura di Carlo Ferrucci, Feltrinelli, Milano 1989.
AA.VV., Leopardi e noi. La vertigine cosmica, a cura di A. Frattini, G. Galeazzi, S. Sconocchia, Studium, Roma 1990.
ANONIMO FRANCOFORTESE, Libretto della vita perfetta, a cura di Marco Vannini, Tascabili Economici
Newton, Roma 1994.
BALDACCI Luigi, Il male nell’ordine. Scritti leopardiani, Rizzoli, Milano 1997.
BARSOTTI Divo, La religione di Giacomo Leopardi, Morcelliana, Brescia 1975.
BIRAL Bruno, La posizione storica di Giacomo Leopardi, Einaudi, Torino 1974.
BO Carlo, L’eredità di Leopardi e altri saggi, Vallecchi, Firenze 1964.
BOSCO Umberto, Titanismo e pietà in Giacomo Leopardi, Le Monnier, Firenze 1957.
BOVELLES de Charles, Il piccolo libro del nulla, Il Melangolo, Genova 1994.
BRIOSCHI Franco, La poesia senza nome. Saggio su Leopardi, Il Saggiatore, Milano 1980.
CARACCIOLO Alberto, Nulla religioso e imperativo dell’eterno, Genova 2003.
CARACCIOLO Alberto, Leopardi e il nichilismo, Bompiani, Milano 1994.
CARBONARA NADDEI M., Momenti del pensiero greco nella problematica leopardiana, Milella, Lecce 1977.
CASOLI Giovanni, Dio in Leopardi. Ateismo o nostalgia del divino?, Città Nuova, Roma 1985.
CASSANO Franco, Oltre il nulla. Studio su Giacomo Leopardi, Laterza, Roma-Bari 2003.
CASSIANO Giovanni, Le istituzioni cenobitiche, Edizioni Qiqajon, Cominità di Bose, 2007.
CONSOLI D., Cultura, coscienza letteraria e poesia in Giacomo Leopardi, Le Monnier, Firenze 1967.
DE ROBERTIS Giuseppe, Saggio sul Leopardi, da Opere, Vol. I, Rizzoli, Milano 1937.
DE SANCTIS Francesco, Leopardi, Einaudi, Torino 1960.
ERMETE TRISMEGISTO, Corpus hermeticum, a cura di Valeria Schiavone, BUR Rizzoli, Milano 2002.
FABRO Cornelio, Introduzione all’ateismo moderno, Studium, Roma 1964.
FARNETTI M., Leggere lo “Zibaldone”, Edizioni Essegi, Ravenna 1991.
FERRARIS A., L’ultimo Leopardi, Einaudi, Torino 1987.
FILORAMO Giovanni, L’attesa della fine. Storia della Gnosi, Laterza, Roma-Bari 1983.
FOLIN Alberto, Da Leopardi all’eresia. Saggi sulla poesia e sul potere, Dick Peerson, Napoli 1987.
FRATTINI A., Studi leopardiani, Nistri, Pisa 1956.
GALIMBERTI Cesare, Linguaggio del vero in Leopardi, Firenze 1959.
GARAVENTA Roberto, Angoscia, Alfredo Guida Editore, Napoli 2006.
GARAVENTA Roberto, La noia. Esperienza del male metafisico o patologia dell’età del nichilismo?, Bulzoni, Roma 1997.
GILSON Etienne, L’ateismo difficile, Vita e Pensiero, Milano 1983.
GIOANOLA Elio, Leopardi. La malinconia, Jaca Book, Genova 1995.
GIROLAMI Patrizia, L’antiteodicea. Dio, dei, religione nello «Zibaldone» di Giacomo Leopardi, Leo Olschki Editore, Firenze 1995.
GIVONE Sergio, Storia del nulla, Laterza, Roma-Bari 2003.
GREGORIO DI NISSA, L’uomo, Città Nuova, Roma 1982.
JONAS Hans, Gnosticismo, esistenzialismo e nichilismo, SEI, Torino 1991.
LANZA Adriano, Leopardi e la trasmutazione dell’uomo, Solfanelli, Chieti 1992.
LUBAC de Henri, Il dramma dell’umanesimo ateo, Morcelliana, Brescia 1979.
MAGGINI Carlo, DELLE LUCHE Riccardo, Il paradiso e la noia. Riflessioni metapsicologiche sulla noia morbosa, Bollati
Boringhieri, Torino 1991.
MARIANI Carlo, Alfabeto leopardiano, Moretti & Vitali Editori, Bergamo 1991.
MARITAIN Jacques, Il significato dell’ateismo contemporaneo, Morcelliana, Brescia 1967.
MASCI Filippo, L’infinito e il Nulla, Napoli 1920.
MEISTER ECKHART, Sermoni tedeschi, a cura di Marco Vannini, Adelphi, Milano 2001.
MORRA Gianfranco, Dio senza Dio, Pàtron, Bologna 1970.
NEGRI Antimo, Interminati spazi ed eterno ritorno, Le Lettere, Firenze 1994.
NICCOLI E., SALVARANI B., In difesa di Giobbe e Salomon, Leopardi e la Bibbia, Diabasis, 1998.
NIETZSCHE F., Intorno a Leopardi, Genova 1992.
PELOSI P., Leopardi fisico e metafisico, Palladio, Salerno 1984.
PELOSI P., I fiumi del tempo, i luoghi dell’anima. Tempo e spazio nei Canti leopardiani, Federico & Ardia, Napoli 1996.
PLOTINO, Enneadi, a cura di Giovanni Reale, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 2002.
PODDIGHE M. Grazia, Sull’abisso del nulla. Il pensiero di Giacomo Leopardi e la filosofia del ‘900, Bulzoni, Roma 1998.
POLIZZI Gaspare, Leopardi e le ragioni della verità, Carocci, Roma 2003.
POLIZZI Gaspare, a cura di, Leopardi e la filosofia, Polistampa.
PRETE Antonio, Il pensiero poetante. Saggio sul Leopardi, Feltrinelli, Milano 1980.
PUECH Henri-Charles, Sulle tracce della gnosi, Adelphi, Milano 1985.
RAVASI Gianfranco, Qohelet, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 1988.
RICORDI Franco, Lo spettacolo del nulla. Shakespeare, Leopardi e il nichilismo occidentale, Bulzoni, Roma 1998.
RIGONI Mario Abdrea, Il pensiero di Leopardi, Milano 1997.
RIGONI Mario Andrea, Saggi sul pensiero leopardiano, Liguori, Napoli 1985.
ROMANO Francesco, Il neoplatonismo, Carocci, Roma 1998.
ROTA Paolo, Leopardi e la Bibbia. Sulla soglia d’«alti Eldoradi», Società Editrice Il Mulino, Bologna 1998.
SCARAMUCCI I., La dimensione pasca liana da Leopardi a Montale, IPL, Milano 1972.
SCHOPENHAUER Arthur, Il mondo come volontà e rappresentazione, a cura di Giuseppe Riconda, Mursia, Milano
1991.
SEVERINO Emanuele, Cosa arcana e stupenda, Milano 1997.
SEVERINO Emanuele, Il nulla e la poesia. Alla fine dell’età della tecnica: Leopardi, BUR Rizzoli, Milano 2004.
SOLMI Sergio, Studi leopardiani, Milano 1987.
SVENDEN Lars Fr. H., Filosofia della noia, Guanda, Parma 2004.
TILGHER Adriano, La filosofia di Leopardi, Roma 1940.
TIMPANARO Sebastiano, Classicismo e illuminismo nell’Ottocento, Nistri Lischi, Pisa 1969.
TIMPANARO Sebastiano, Il verde e il rosso. Scritti militanti, 1966-2000, Odradek, Roma 2001.
VITIELLO Vincenzo, Dire Dio in segreto, Città Nuova, Roma 2005.
ZACCARIA Gino, Pensare il nulla. Leopardi, Heidegger, IBIS, 2008.
Opere di Giacomo Leopardi
A cura di M.A. Rigoni, La strage delle illusioni. Pensieri sulla politica e sulla civiltà, Adelphi, Milano 1992.
Giacomo Leopardi, Il manuale di Epitteto, Salerno Editrice, Roma 1990.
Giacomo Leopardi, Operette morali, Garzanti, Milano 1984.
Giacomo Leopardi, Pensieri, Biblioteca Ideale Tascabile, Milano 1995.
Giacomo Leopardi, Poesie e prose, a cura di Rolando Damiani e Mario Andrea Rigoni, Mondadori, Milano 1987.
Giacomo Leopardi, Tutto è nulla, BUR Rizzoli, Milano 1997.
Giacomo Leopardi, Zibaldone, Newton Compton Editori, Roma 2007.