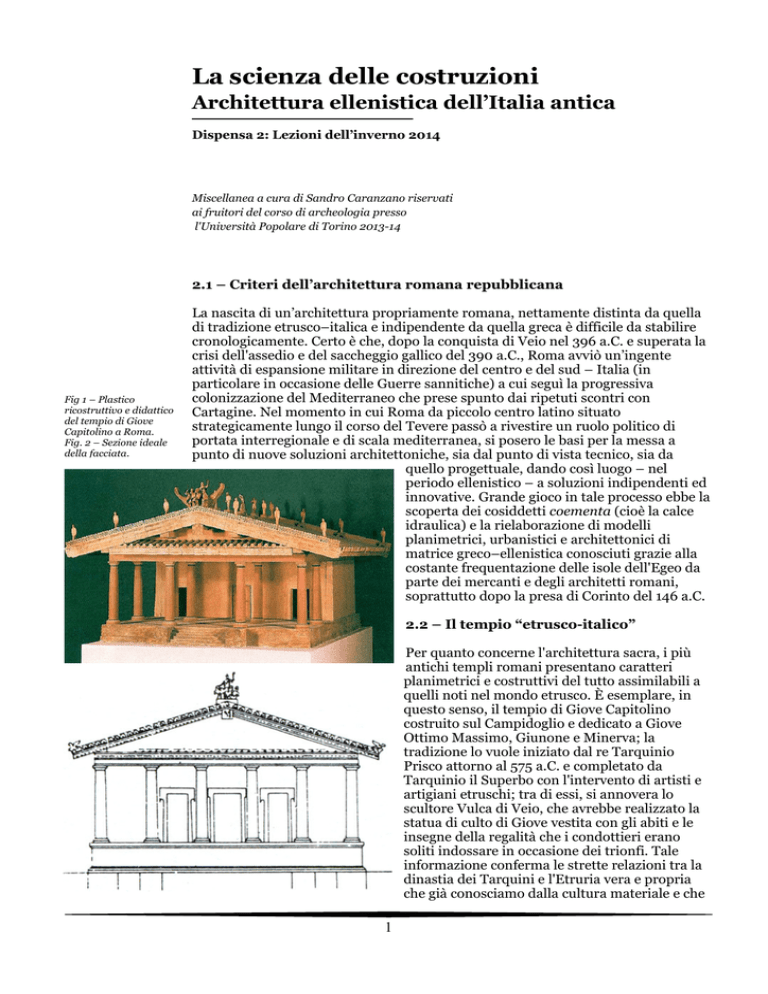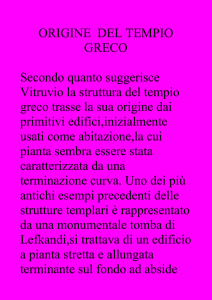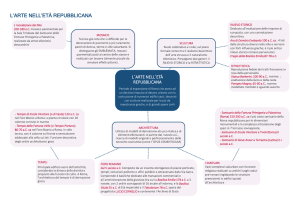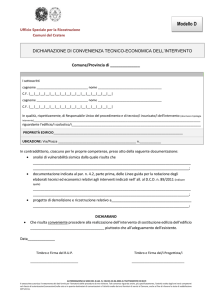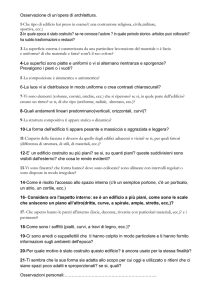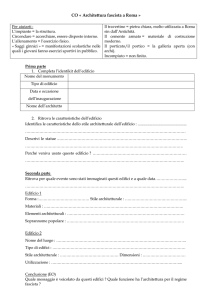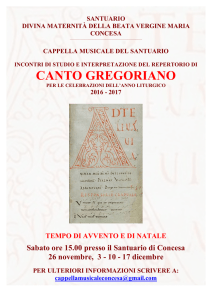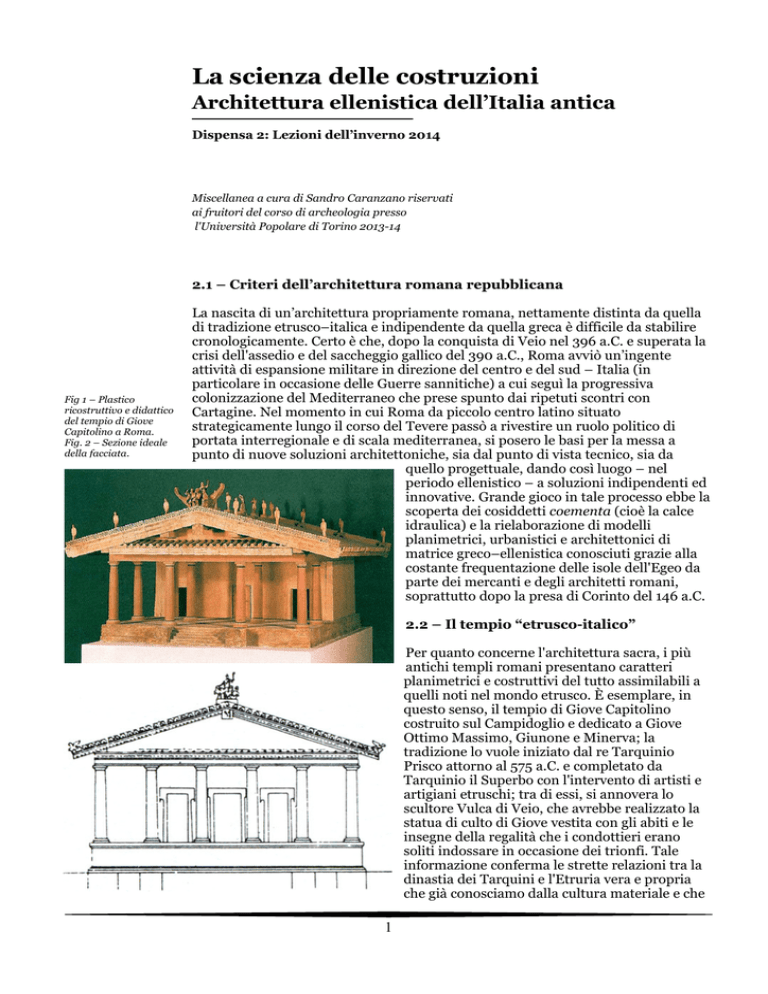
La scienza delle costruzioni
Architettura ellenistica dell’Italia antica
Dispensa 2: Lezioni dell’inverno 2014
Miscellanea a cura di Sandro Caranzano riservati
ai fruitori del corso di archeologia presso
l'Università Popolare di Torino 2013-14
2.1 – Criteri dell’architettura romana repubblicana
Fig 1 – Plastico
ricostruttivo e didattico
del tempio di Giove
Capitolino a Roma.
Fig. 2 – Sezione ideale
della facciata.
La nascita di un’architettura propriamente romana, nettamente distinta da quella
di tradizione etrusco–italica e indipendente da quella greca è difficile da stabilire
cronologicamente. Certo è che, dopo la conquista di Veio nel 396 a.C. e superata la
crisi dell'assedio e del saccheggio gallico del 390 a.C., Roma avviò un’ingente
attività di espansione militare in direzione del centro e del sud – Italia (in
particolare in occasione delle Guerre sannitiche) a cui seguì la progressiva
colonizzazione del Mediterraneo che prese spunto dai ripetuti scontri con
Cartagine. Nel momento in cui Roma da piccolo centro latino situato
strategicamente lungo il corso del Tevere passò a rivestire un ruolo politico di
portata interregionale e di scala mediterranea, si posero le basi per la messa a
punto di nuove soluzioni architettoniche, sia dal punto di vista tecnico, sia da
quello progettuale, dando così luogo – nel
periodo ellenistico – a soluzioni indipendenti ed
innovative. Grande gioco in tale processo ebbe la
scoperta dei cosiddetti coementa (cioè la calce
idraulica) e la rielaborazione di modelli
planimetrici, urbanistici e architettonici di
matrice greco–ellenistica conosciuti grazie alla
costante frequentazione delle isole dell'Egeo da
parte dei mercanti e degli architetti romani,
soprattutto dopo la presa di Corinto del 146 a.C.
2.2 – Il tempio “etrusco-italico”
Per quanto concerne l'architettura sacra, i più
antichi templi romani presentano caratteri
planimetrici e costruttivi del tutto assimilabili a
quelli noti nel mondo etrusco. È esemplare, in
questo senso, il tempio di Giove Capitolino
costruito sul Campidoglio e dedicato a Giove
Ottimo Massimo, Giunone e Minerva; la
tradizione lo vuole iniziato dal re Tarquinio
Prisco attorno al 575 a.C. e completato da
Tarquinio il Superbo con l'intervento di artisti e
artigiani etruschi; tra di essi, si annovera lo
scultore Vulca di Veio, che avrebbe realizzato la
statua di culto di Giove vestita con gli abiti e le
insegne della regalità che i condottieri erano
soliti indossare in occasione dei trionfi. Tale
informazione conferma le strette relazioni tra la
dinastia dei Tarquini e l'Etruria vera e propria
che già conosciamo dalla cultura materiale e che
1
Fig 3 –La planimetria
canonica del tempio
etrusco-italico.
Fig 4 –Gli enigmatici
"mercati di Ferentino",
struttura coperta di età
repubblicana le cui
volte, e parte dei muri,
sono costruiti in
coementa.
è confermata dalla storiografia antica; la stessa planimetria
dell’edificio risente strettamente, d’altronde, delle formulazioni
architettoniche messe a punto oltretevere.
Dotato di un podio di fondazione, l'edificio misurava 53 x 62 m, era
orientato verso sud–est e preceduto da una gradinata posta tra due
avancorpi. La distribuzione delle colonne nella cella era quella in
seguito diventata canonica: esastilo sulla fronte, proprio come i
templi etruschi presentava un porticato in facciata molto profondo
costituito da tre file di colonne disposte ai vertici di diciotto moduli
quadrangolari; la cella tripartita occupava 3 x 3 moduli, attestandosi
così su una profondità pari a metà di quella coperta dal tetto, fatto
che rendeva il colonnato anteriore piuttosto oscuro. L'edificio privo
di colonnato sul lato posteriore (sine postìco) era circondato su tre
lati da colonne, era completato verso l'alto da un tetto a due falde
molto sporgenti, capace di proteggere le murature realizzate in
materiale effimero (legno, mattone crudo, argilla e tufo) dalle
intemperie; non particolarmente sviluppato in altezza a causa delle
problematiche legate alla statica, l'edificio affidava il suo prestigio
estetico alla ricchissima decorazione delle falde del tetto ricoperte da
lastre in terracotta dipinte (gheison e sime), mentre lo spazio interno del timpano
– considerato ancora come un elemento di risulta – non era sfruttato in modo
organico; esso ospitava una piccola falda di tetto longitudinale destinata a
proteggere le colonne del pronao dalla pioggia ed un ampio spazio vacuo, da cui si
enucleavano semplicemente le testate delle travi sulle quali – con ogni probabilità
– erano applicate delle lastre in terracotta decorative o a soggetto mitologico (del
tipo di quelle scoperte nel tempio etrusco di Talamone).
Non è un caso che le fonti antiche riferiscano in primo luogo il nome del coroplasta
incaricato di realizzare le statue acroteriali piuttosto che quello dall'architetto, a
causa della valenza fondamentale ancora attribuita all'apparato decorativo rispetto
alla struttura architettonica: un dato costante e caratteristico del tempio etrusco–
italico, che doveva rendere l’effetto prodotto sull’osservatore da questi edifici simile
a quello offerto da certe pagode orientali, i cui tetti elaboratissimi e sfrangiati si
dissolvono verso l’alto contrastando con la luce atmosferica del cielo.
Come appare chiaro non sembra possibile identificare in tale edificio caratteri
spiccatamente individuali, ed esso sembra piuttosto inserito nella grande koiné
dell’architettura centro–italica del’epoca.
2.3 – L’innovazione dei coementa
Una vera e propria svolta nella tecnologia e nell'architettura romana si enuclea a
cavallo tra il III e il II sec a.C., nel momento in cui cioè Roma viene a contatto con
le grandi civiltà mediterranee – in particolare quella cartaginese e quella greca –
nell'ambito di un processo di espansione militare e coloniale di grande scala.
Nello specifico, sembra che l'utilizzo di polveri carbonatiche impastate con acqua
per realizzare calce fosse già noto presso i cartaginesi almeno a partire dal primo
periodo ellenistico; tuttavia – per quanto ne sappiamo – la calce così ottenuta era
utilizzata come materiale secondario e privo di funzione strutturale, e perlopiù
impiegato nella coibentazione di alcuni ambienti o nella rifinitura di alcuni
particolari architettonici.
Tale invenzione fu dunque conosciuta da Roma dopo le famose vittorie delle isole
Egadi (Prima guerra punica) e soprattutto dopo la clamorosa vittoria di Zama del
202 a.C. (Seconda guerra punica) che le permise di controllare politicamente
Cartagine e gli ampi territori da essa dipendenti. Benché la data di nascita del
calcestruzzo romano non sia nota con precisione, è certo che già a partire da questi
anni prime sperimentazioni vennero effettuate sui colli romani e nella stessa Roma
per la costruzione di edifici pubblici e privati, spesso di grande mole.
2
Economica e facile da reperire, la calce svolse un
ruolo importantissimo nell'ambito dell’architettura
monumentale pubblica e privata di Roma antica:
superate le problematiche tecniche e il notevole
costo connesso all’estrazione e al trasporto dei
blocchi di pietra necessari con il vecchio metodo di
costruzione (opus quadratum, opus poligonale), la
possibilità di realizzare un impasto di pietrame e
calce determinò un abbattimento dei tempi e dei
costi di realizzazione delle opere murarie,
permettendo la costruzione a Roma di grandi
edifici monumentali (quali templi, basiliche e
santuari), e la veloce edificazione di edifici pubblici
di spiccata valenza politica e amministrativa nelle
Fig. 5 – Il portico
esterno del santuario di
Ercole Vincitore a Tivoli
le cui semicolonne sono
realizzate in opus
reticulatum ed erano
anticamente mascherate
con uno stucco decorato
in modo da imitare il
più prezioso marmo.
regioni di recente conquista.
Dal punto di vista tecnico è bene premettere che la calce può essere prodotta
tramite la cottura in forni opportunamente predisposti della pietra calcarea –
composta prevalentemente da carbonato di calcio (CaCo3) – a temperature
relativamente elevate, oscillanti tra gli 800 e i 1000°C. Forni di questo tipo
implicano una conoscenza tecnologica abbastanza basilare ma, in ogni caso, un
maggior impegno rispetto a quanto necessario per la cottura del gesso.
Quest'ultimo era stato utilizzato sino a quel tempo unicamente per il rivestimento
delle pareti (expolitio) o per la realizzazione di finiture superficiali.
La cottura del calcare avviene con lo sviluppo di anidride carbonica (CO2)
trascinata dai gas della combustione, anch'essi prevalentemente costituiti da CO2
secondo la seguente formula:
CaCO3 > CaO+CO2 (^)
Come appare chiaro, la cottura del carbonato di calcio produce un ossido di calcio
(detto anche semplicemente calce) che, trasferito sul cantiere da costruzione, deve
essere unito ad acqua per ottenere idrossido di calcio (calce idrata):
CaO + H20 > Ca(OH)2.
Normalmente, tale reazione chimica avveniva all'interno delle casseforme lignee
erette dai capomastri romani assecondando la forma che il muro avrebbe dovuto
avere al termine dell'essiccazione. Dopo avere disposto in modo ordinato i conci di
pietra spaccati e regolarizzati a martellina a contatto con l'impalcatura (in modo
tale da garantire alla parete del muro una superficie il più possibile piana e
regolare) si procedeva a distribuire calce mista a pietre all'interno delle casseforme
stesse, in successive giornate di lavoro.
La calce idrata ottenuta con l'aggiunta dell'acqua a contatto con l'anidride
carbonica dell'aria produce la seguente reazione:
Ca(OH)2 + Co2 > CaCo3 + H20
La carbonatazione della calce idrata chiudeva il ciclo, permettendo di ottenere –
come in partenza – del carbonato di calcio solido e resistente inframezzato da
pietrame, con un perimetro conformato secondo
il profilo stabilito dai muratori durante la
disposizione delle casseforme di contenimento.
L'indurimento della calce richiede un processo
di asciugamento per l’eliminazione aerea
dell'acqua che si forma secondo la reazione
appena enunciata; per tale ragione i muratori
antichi attendevano la completa essiccazione
della massa muraria prima di procedere alla
gettata delle «giornate» successive.
Come è facile intuire, per la stessa plasmabilità
del muro – non più limitato a forme semplici
dalla ortogonalità dei blocchi squadrati o
poligonali – la nuova tecnica dei coementa
invitò i progettisti a realizzare le pareti con gli
andamenti più vari; inoltre, dal momento che le
assi della cassaforma – del lato esterno e interno
3
del muro – erano indipendenti, fu possibile forse per la prima volta, in modo
radicale, sganciare il perimetro dell'edificio dalla planimetria degli spazi interni (le
stanze), che potevano ora presentare forme del tutto differenti.
È bene comunque aggiungere che la straordinaria applicazione del calcestruzzo nel
mondo romano fu possibile solo grazie alla scoperta di un ulteriore ingrediente che
i capomastri romani erano soliti aggiungere all'impasto di base; si tratta della
pozzolana, una sabbia vulcanica ampiamente diffusa in Campania nella zona
prossima al Vesuvio, nella quale la presenza di Silice (SiO2) ed Allumina (Al2O3)
determina una complessa trasformazione chimica. Tramite di essa, la calce si
trasforma infatti in alluminato di calcio idrato (C – A – H) e, in particolare, in un
idrosilicato di calcio (C – S – H), dando luogo a una malta di straordinaria
resistenza meccanica, per la prima volta capace di indurirsi anche sott'acqua e di
resistere all'azione dilavante della pioggia.
Gli architetti romani sembrano aver intuito sin dall'inizio le potenzialità di questa
tecnica costruttiva, ma si trovarono in difficoltà a causa del ritiro micrometrico
delle malte in fase d’essiccazione. Per sua causa, probabilmente, fratture e crepe
piuttosto problematiche si crearono nella massa muraria; il problema non era
tanto quello di limitare il collasso strutturale degli edifici (tanto più che due grandi
muri monolitici accostati lungo una frattura si trasformano, inevitabilmente,
nell'equivalente statico di due conci di arco adiacenti), ma piuttosto di evitare la
percolazione di acqua piovana all'interno degli ambienti abitabili, che avrebbe
lentamente e inesorabilmente distaccato gli intonaci e danneggiato l'edificio.
Le soluzioni e i tentativi messi in atto per limitare il problema furono molteplici e
articolati; in linea di massima, la soluzione adottata fu quella di limitare il più
possibile la presenza di grumi o concentrazioni di calce nella massa del muro,
sezionandolo con giunti elastici costituiti per esempio da mattoni (un materiale
capace di compensare le trazioni piuttosto forti esercitate della malta in
essiccazione, opus listatum) o distribuendo il pietrame in modo regolare almeno
sulla superficie esterna del muro, così da creare linee di trazione oblique e
scongiurare ammassi di calce (opus reticolatum).
Il carattere progressivo e sperimentale di queste ricerche architettoniche fanno sì
che alcuni edifici monumentali della media e tarda età repubblicana nel territorio
del Lazio alternassero ancora le tradizionali tecniche lapidee in opus quadratum ed
opus poligonale all'opus coementicium.
Lo sfruttamento del calcestruzzo per la costruzione di edifici monumentali indusse
gli architetti romani a teorizzare e a mettere in atto l'innovazione architettonica
costituita dai fornices; il fornix può essere descritto semplicemente come un
modulo di spazio coperto da una volta (a botte o a crociera, a seconda che si
desideri uno spazio di transizione o centralizzante). Il “fornice modello” si può
descrivere come costituito da quattro pilastri in calcestruzzo su cui si appoggia la
volta, costruita nello stesso materiale. I fornici rappresentano delle unità modulari
che possono essere affiancate longitudinalmente a creare dei corridoi (aperti o
chiusi, a seconda della presenza o no di muri di tampognamento) o delle vere e
proprie sale pilastrate, se disposti allineati su più filari.
2.4 – Principi etici e pratici dell’arte del costruire romano
Il famoso trattato di Vitruvio dedicato all'architettura ci fornisce un’interessante
testimonianza del punto di vista di un architetto della prima età imperiale, e ci è
perciò di grande aiuto nella comprensione dell'architettura dei secoli precedenti.
L’architetto romano, nel tentativo di mettere assieme in chiave letteraria una lunga
serie di competenze maturate nel corso dei secoli, e con un fare accademico
estraneo ai caratteri precipui della manualistica tecnica, accoglie metodicamente
una vasta serie di testimonianze letterarie del periodo ellenistico di lingua greca,
interpretandole e riordinandole con gli strumenti a disposizione di un uomo
dell'età di Augusto. Nei diversi passi è possibile osservare come molte delle
terminologie e dei concetti espressi dagli autori più antichi non sono ai suoi tempi
ormai comprensibili in senso compiuto; dobbiamo infatti considerare come gran
parte delle ricerche scientifiche furono elaborate da scienziati del calibro di
4
Fig. 6 –Esemplificazione
del discorso proposto da
Vitruvio nel primo libro
del De Architectura.
Archimede, Ctesibio, Erone alla corte dei principi ellenistici di Alessandria,
Siracusa, Antiochia e Pergamo due o tre secoli prima. I Romani avevano avuto
modo di consultare gran parte di questi studi nella biblioteca di Alessandria e nelle
metropoli del Mediterraneo di recente conquista, ma molti di questi centri erano in
fase di decadenza e gli architetti e i capomastri romani del tempo possono essere
meglio paragonati ad abili ingegneri militari piuttosto che a dei filosofi della
scienza. Gran parte di essi aveva avuto modo di formarsi sul campo, costruendo
fortificazioni, fortini, città e ponti in occasione delle campagne militari o della
colonizzazione delle zone di recente conquista: la prevalenza delle loro conoscenze
sembrano pertanto essere state tramandate oralmente o per mezzo di una
manualistica tecnica anziché che il frutto di studi teorici approfonditi.
Nell'ambito del nostro discorso è piuttosto interessante ricordare la distinzione tra
i “modi di agire” e i “modi di essere” dell’architettura proposti da Vitruvio.
Secondo Vitruvio l'architettura si divide in sei parti: ordinatio, dispositio,
eurythmia, symmetria, decor e distributio.
L'ordinatio consiste nella conoscenza delle misure dei singoli membri
architettonici e delle loro proporzioni rispetto a un modulo o unità di misura; da
essa dipende l'esecuzione armonica di un edificio. Roma fu in grado di
perfezionare l'organizzazione logistica del cantiere nel rispetto di misure standard
e ripetitive, che permisero la veloce messa in opera dell’apparecchio murario
permettendo l’uso di materiali edili di diversa origine e manifattura in perfetta
compatibilità. È questo il caso del mattone sesquipedale (lungo un piede e mezzo),
divisibile nei suoi sottomultipli a seconda delle esigenze costruttive.
Le dispositio regola la corretta messa in opera di ogni elemento ed è divisa a sua
volta in tre parti: icnografia, ortografia e scenografia. Questo dettaglio è
particolarmente importante perché ci conferma come gli architetti di età
repubblicana e primo imperiale sfruttassero parimenti il disegno in pianta, in
alzato e in prospettiva per fornire alla committenza e alle maestranze un'idea
dell'edificio, tanto in fase di progettazione che di esecuzione. Già per quanto
concerne l'età greca siamo a conoscenza di disegni bidimensionali realizzati
5
direttamente sul cantiere (su una parete, su uno scalino
…) per permettere alle maestranze – che facevano uso di
calibri fissi – di riportare sul blocco in marmo le stesse
misure e proporzioni.
Vitruvio ricorda che per l'icnografia è necessario saper
usare il compasso e la riga, che l'ortografia si occupa
della facciata e presuppone la conoscenza delle
proporzioni, e che la scenografia consiste nello schizzo o
disegno in scorcio. Tutte e tre le cose derivano da
cogitatio e inventio. La prima, fondata sullo studio e la
disciplina nell'operare, ha per meta le «sensazioni
piacevoli»; la seconda, consiste nell'abilità nell'affrontare
e risolvere problemi nuovi o insoluti.
Terzo elemento è la cosiddetta distributio, consistente
nell'uso sapiente di materiali e superfici, come pure nell’oculata parsimonia di
spesa nel costruire.
Non dobbiamo infatti dimenticare come l'architetto non solo fosse responsabile del
progetto teorico, ma anche dell'organizzazione dei ponteggi e della costruzione
delle macchine di sollevamento; tale poliedricità rappresenta un fatto eccezionale
nella storia dell'architettura e ci dimostra la stretta relazione esistente tre le
problematiche tecnologiche e la conduzione dei lavori.
In una seconda parte Vitruvio ricorda anche i tre modi di essere dell'architettura.
Questa deve garantire la eurythmia, ovvero la cura della figura e le dimensioni e
proporzioni dei singoli elementi.
Simile ma non identica è quindi la simmetria – ovvero la conmisurazione e il
collegamento armonico dei singoli membri dell'edificio, consistente nella
corrispondenza proporzionale fra una parte e il tutto di un'opera, misurata a
moduli o frazioni di modulo. Questa parola necessità di un maggiore chiarimento
dal momento che assume nella lingua latina un significato per certi versi differente
da quello utilizzato oggi. La simmetria corrisponde – in architettura come in
geometria – nella proporzione armonica delle singole misure che compongono
l'edificio. Un rapporto simmetrico è per esempio quello rappresentato dalla sezione
aurea laddove, solo per una determinata misura si verifica un rapporto tra i
segmenti del tipo A:B=B: (A+B)
Gli architetti antichi erano dunque convinti che, esattamente come in natura,
l'armonia estetica di un edificio fosse determinata dalla rispondenza delle misure
delle sue singole parti, realizzata utilizzando dei numeri presenti in natura e
calcolabili preventivamente.
Vitruvio, nello spiegare il significato dell’eurythmia della symmetria stabilisce un
paragone fra il corpo umano ideale e un edificio.
L'eurytmia o armonia di un corpo umano dipende
dall'aspetto e dalla disposizione delle sue parti
anatomiche. Nei templi, la simmetria – o
corrispondenza proporzionale – si ricava dal modulo o
unità di misura (o massimo comun divisore), che è il
diametro delle colonne oppure il triglifo. La natura –
che l'architetto deve imitare – ha composto il corpo
dell'uomo ideale in modo tale che, se misurato dal
mento alla sommità della fronte e alla radice dei
capelli, il viso corrisponde a un decimo dell'altezza del
corpo.
La stessa proporzione si presenta nella mano aperta se
misurata dalla sua articolazione fino alla punta del dito
medio. L'altezza del viso si divide poi in tre parti uguali:
dal mento alla base delle narici, dal naso fino al punto
d'incontro con le sopracciglia e da queste alla radice dei
capelli; il piede è la sesta parte dell'altezza del corpo e
così via. «Rispettando tali proporzioni i pittori e gli
scultori dell'antichità ottennero grandi elogi. Alla stessa
maniera, le misure delle parti di un tempio dovranno
6
Fig. 9 – Schema
ricostruttivo di una gru
di sollevamento grecodel tipo polyspaston con
indicazione delle diverse
parti citate nel testo in
lingua originale.
avere una stretta corrispondenza e concordanza con il tutto».
Vitruvio aggiunge che il corpo umano ha un centro che corrisponde all'ombelico: se
infatti «si collocasse supino un uomo colle mani e i piedi aperti e si mettesse il
centro del compasso nell'ombelico, descrivendosi una circonferenza si
toccherebbero tangenzialmente le dita delle mani e dei piedi. Ma non basta: oltre lo
schema del circolo, nel corpo si troverà anche la figura del quadrato. Infatti, se si
misura dal piano di posa dei piedi al vertice del capo, poi si trasporterà questa
misura alle mani distese, si troverà una lunghezza uguale all'altezza, come accade
nel quadrato tirato a squadra». Questo brano, in cui Vitruvio riconduce l'uomo
ideale (microcosmo) alle figure geometriche della circonferenza e del quadrato –
simbolo dell'universo e della terra (macrocosmo) – ha affascinato schiere di
architetti che a partire dal Rinascimento si sono cimentati nella traduzione grafica
di tale insegnamento. Fra questi, va ricordato il famoso disegno di Leonardo da
Vinci conservato presso le Gallerie dell'Accademia di Venezia, quello di Fra'
Giocondo pubblicato nel suo trattato a Venezia nel 1511 e quello di Andrea Palladio,
pubblicato nel commento a Vitruvio di Daniele Barbaro del 1567.
Per Vitruvio, segue quindi il decor, e cioé il bell'aspetto di un'opera composta da
elementi e forme le cui misure e proporzioni sono determinate con gusto, sapienza,
consonanza e uniformità.
Il decor può essere raggiunto usando la statio (ovvero la collocazione adeguata
dell'edificio rispettò la sua funzione), la consuetudo (ovvero il rispetto della
tradizione e coerenza interna dell'opera) e la natura (cioè l'obbedienza della logica
topografica del suolo all'opera che si vuole realizzare): una serie di precetti molto
utili che sarebbe opportuno non dimenticare troppo facilmente soprattutto giorno
d'oggi.
2.5 - Le macchine di sollevamento
L'introduzione del calcestruzzo nell'ambito
dell'architettura romana non eliminò mai del
tutto la necessità tagliare, trasportare e rifinire
blocchi lapidei anche di grandi dimensioni;
basti pensare ai colonnati marmorei dei
diversi fora o alle facciate dei grandi templi e
santuari suburbani. Per tale ragione la civiltà
romana continuò a sfruttare le scoperte
tecnologiche messe a punto nell'età ellenistica
per il sollevamento dei blocchi da costruzione,
perfezionandole.
L'elemento più semplice a tale scopo è
certamente costituito dalla carrucola, una
ruota pivottante su un'asse, capace di
trasferire il suo moto circolare a quello
rettilineo di una fune; non a caso,
nell'antichità nacque la leggenda secondo la
quale essa sarebbe stata inventata da Archita
di Taranto, un seguace della scuola pitagorica
interessato a problemi di ordine geometrico e
matematico.
In realtà, non esiste una vera e propria data di
nascita della carrucola e sembra possibile che
già in periodi molto antichi fosse già
conosciuta. Piuttosto discusso è il rilievo della
tomba di Ipuy a Saqqara, datato attorno al 2500 a.C., in cui sembra rappresentata
una nave a vela con due pennoni manovrati con dritte governate a poppa; piuttosto
convincente è anche il dipinto di una nave affrescato sull'isola di Santorini datato
al 1400 a.C.; in esso è possibile riconoscere due pennoni affiancati a un albero
maestro al cui vertice sembra di poter distinguere ben dieci carrucole, otto delle
quali impiegate per la manovra dei pennoni.
7
Fatto sta, che il salto di qualità si
ebbe con ogni probabilità nel periodo
ellenistico con la messa a punto di
macchine
dotate
di
carrucole
multiple, inizialmente progettate non
tanto in funzione dei cantieri edili,
quanto per facilitare il carico e lo
scarico delle navi presso i porti
commerciali. Per tale motivo le
prime gru dovevano armonizzare
l'esigenza di sollevare con la minor
fatica possibile carichi piuttosto
ingenti, con quella di poterli spostare lateralmente.
Vitruvio sembra cosciente dell'importanza del principio della leva (vectis) nel
funzionamento delle macchine da trazione. Recita infatti: «ora la lunghezza di
quella parte della leva che va dal fulcro fino a sotto il peso, sarà inversamente
proporzionale all'altra parte che va dal fulcro all'altro estremo su cui deve far
pressione. Premendo su questa impugnatura, anche con le forze di poche mani, si
costringe la leva a compiere un movimento circolare capace di spostare un peso
anche rilevantissimo. E dopo avere presentato l'esempio della stadera, del timone e
delle vele, ricorda come anche i remi delle navi, quando vengono spostati in avanti
o indietro con le mani, spingono innanzi con maggiore impeto la nave se si
immerge nei flutti soltanto la pala che è situata all'estremo. Sia dunque nelle
stanghe che nei gioghi, quando l'attacco delle corregge non è centrale ma spostato
da una parte, esso rende necessariamente un lato più breve e l'altro più lungo.
Se si facesse dunque compiere alla stanga o al giogo un movimento circolare
intorno al centro, il lato più lungo descriverebbe la circonferenza più ampia e
quello più corto la circonferenza minore. Come dunque queste macchine
funzionano combinando insieme i loro moti rettilinei e circolari in rapporto a un
centro, così anche i carri, le ruote, gli scorpioni, le baliste, i torchi e tutte le altre
macchine producono i loro effetti con analoghi movimenti rettilinei e circolari
corrispondenti a un determinato centro».
La macchina per il sollevamento architettonico per antonomasia fu il cosiddetto
polyspaston, una sorta di elaborazione dei cosiddetti
“picchi di carico” in uso nelle navi moderne. In
sostanza il polyspaston assolveva la funzione di una
gru girevole sfruttando dei paranchi a tre pulegge
distribuite tra tre carrucole fisse e due mobili. Le tre
carrucole fisse costituivano la tròclea summa, mentre
quelle pendenti la tròclea infima.
Si trattava di macchine da sollevamento di eccezionale
solidità e rapidità, in cui i valori di potenza e di velocità
erano strettamente connessi al numero di bozzelli
mobili di cui era formato ogni paranco. La manovra di
questi picchi di carico era di notevole difficoltà perché
l'abbassamento o il sollevamento dell'albero
comportava una variazione dei rapporti tra resistenza e
potenza. La macchina poteva anche operare in senso
girevole con l'uso di un'unica trave inclinata ad altezza
regolabile. In due parole, il sistema di carrucole veniva
fissato al vertice di una trave obliqua fissata al suolo su
uno snodo pivottante che le permetteva di muoversi
lateralmente. Il peso veniva sollevato tramite un
sistema di tre fumi (tres ductarii funes) che si
avvolgevano inizialmente nelle ruote (orbiculi) della
carrucola inferiore per poi salire e avvolgersi su quelle
della carrucola superiore. Condotte infine verso il
basso giravano attorno all’artemo per essere tirate da
un argano a mano (ergata) o da vere e proprie ruote in
legno di grandi dimensioni al cui interno camminavano
8
degli addetti così da imprimere un movimento al meccanismo (peritechion o rotae
calcatoriae).
Si è calcolato una gru di questo tipo, dotata di cinque carrucole, tre corde una
grande ruota a gradini mossa da uomini che vi camminavano all'interno, potesse
sollevare 6 tonnellate con l'apporto di soli due uomini senza troppa fatica.
2.6 – L’acropoli e le mura di Ferentino
Fig. 12 – La Porta
Sanguinaria di
Ferentino caratterizzata
da un arco tutto sesto in
conti di tufo impostato
su imponenti opere
ciclopiche di età
repubblicana.
Fig. 13 – Tipologie di
costruzione a secco
come proposte in un
tipico manuale di
architettura antica.
Le mura ciclopiche di Ferentino rientrano in una casistica ben rappresentata nel
territorio a sud di Roma (ad esempio ad Alatri e Gabi) e presentano caratteristiche
di monumentalità insospettate. Sviluppato per oltre 2 km, il circuito murario,
presenta un basamento in opera poligonale fatto di grandi blocchi di calcare su cui
si sovraimpone una tessitura muraria isodoma a blocchi quadrati di minore
pezzatura di arenaria. Particolarmente suggestiva è la porta denominata
popolarmente Sanguinaria, il cui arco a tutto sesto si apre nel punto di giunzione
tra le due tecniche murarie e che permette l'accesso all'area abitata tramite la
strada che conduceva all'acropoli. La datazione della cinta non è nota con sicurezza
e si è dibattuto sulla possibilità che le due tecniche murarie corrispondano a due
diverse fasi costruttive; tuttavia, sembra più probabile che l'opera sia unitaria e che
la scelta della tecnica poligonale sia stata influenzata dalla difficile malleabilità del
calcare il quale, in fase di taglio, tende a sbracciarsi secondo linee oblique
imprevedibili. I grandi blocchi poligonali costituiscono, pertanto, la sostruzione
megalitica principale della cinta difensiva, poi completata verso l'alto da blocchi
squadrati più piccoli, tagliati nella malleabile arenaria, la cui funzione era di
allontanare gli spalti dei difensori dal piano di campagna, facilitando la difesa della
città che sarà avvenuta facendo anche uso di baliste.
Caratteristiche costruttive per molti versi simili
presenta la cosiddetta acropoli, una struttura
monumentale di pianta quadrangolare dalle
dimensioni colossali (base 140 x 95 m) che
attualmente sostiene la basilica di San Giovanni
e Paolo andata a sostituire, nel medioevo, il
tempio pagano.
Di particolare interesse è l'allargamento della
terrazza superiore – oggi sormontato dal palazzo
vescovile – in cui si osserva l'accostamento della
tecnica lapidea con il più moderno calcestruzzo.
Anche il rivestimento esterno presenta una
duplicità di tecniche: la parte inferiore, ancora
una volta, è infatti realizzata in opera poligonale
e quella superiore in opera quadrata lasciata
volutamente grezza a costituire una sorta di
"bugnato rustico". Lo spazio superiore
dell'avancorpo è occupato da un portico interno
(criptoportico) realizzato nella massa di
calcestruzzo e prende luce da una fila di finestre
coperte da archetti dotati di doppia strombatura.
Di particolare interesse è l'iscrizione latina
disposta sotto le finestre della facciata principale,
ripetuta con una leggera variante sulla porta che
dava accesso al criptoportico; una terza
iscrizione è stata anche scoperta all'interno del
criptoportico. Le iscrizioni commemorative ci
forniscono alcune indicazioni sui termini
utilizzati dagli architetti romani per definire le
varie parti costituenti il complesso.
Nell'iscrezione esterna si citano infatti le
fundamenta e i muros, presso la porta di accesso
esterna solo più le fundamenta, mentre nella
9
porta interna del criptoportico – giustamente – si accenna alle fundamenta e ai
fornices. Appare così chiaro come per gli architetti antichi il potente muro di
sostruzione in opera poligonale fosse sentito con una valenza autonoma per lo
sforzo tecnico necessario alla sua costruzione (i fundamenta); con uno spirito un
po' generalizzante, invece, il termine muros è impiegato per indicare gli edifici
situati al vertice della spianata (con ogni probabilità il tempio e i suoi portici), oggi
scomparsi. Questi ultimi, non visibili dall’entrata laterale, furono ignorati nella
seconda iscrizione. Nella terza, leggibile del criptoportico interno, a fianco delle
fundamenta si pone attenzione ai fornices (ovvero alle campate del portico
percorribile) ma non più ai muros che, trovandosi alla sommità della spianata, non
potevano essere visti da questa posizione.
Ci si è chiesti a lungo quale potesse essere la funzione di questi ambienti
sotterranei; certo è che essi non erano raggiungibili direttamente dalla terrazza del
tempio ed era necessario un lungo percorso attraverso le vie cittadine per
raggiungerne l'ingresso, tra l'altro poco monumentale.
L'esempio di Ferentino, più di ogni altro, ci permette di chiarire una caratteristica
del tutto precipua dell'architettura romana tardo repubblicana,ovvero la
distinzione tra i muri di sostruzione e l'edificio deve proprio. Le disponibilità dei
coementa – e dunque di un materiale da costruzione resistente ed economico –
permise gli architetti romani di allargare la sommità delle alture di cui i dintorni di
Roma sono ricchi con una serie di arcate cieche che venivano a definire la
cosiddetta substructio, sulla quale veniva poi appoggiato l'edificium vero e proprio.
Anche nel caso di Ferentino le fondamenta e i muri non rappresentano nient'altro
che una sopraelevazione artificiale, e gli ambienti di risulta del criptoportico non
devono necessariamente essere collegati funzionalmente all'edificio superiore (il
tempio). La datazione del complesso non è certa sembra porsi nel corso del II sec
a.C.; anche qui, la prudenza degli architetti – ancora in parte insicuri sulla capacità
di resistenza del calcestruzzo – li spinse a realizzare il muro portante esterno
(fondamentale per gli aspetti statici) in pietra, limitando l'uso del calcestruzzo alla
massa interna, ottenendo comunque, anche in questo caso, un notevole risparmio
economico in fase di costruzione.
2.7 – Il santuario della Fortuna Primigenia di Palestrina
Fig. 14 – Veduta aerea
delle terrazze di cui si
compone il santuario
della Fortuna
primigenia di
Palestrina.
Il santuario della Fortuna primigenia di Palestrina costituisce il vero e proprio
capolavoro dell'architettura romana repubblicana. L'edificio fu costruito a cavallo
tra II e I sec a.C. su un’imponente collina sormontante l'antica città di Preneste in
funzione dell'antichissimo culto della Fortuna, assimilato dagli antichi romani alla
Tyche greca e, in un momento successivo, alla divinità egizia Iside. Il santuario fu
oggetto di una continua frequentazione nel corso dei secoli, ricevendo donativi e
offerte dai pellegrini al punto che quando Carneade, nel 156 a.C. venne a Roma,
affermò di non avere mai visto «una fortunata più fortunata che a Preneste». I resti
dell'edificio monumentale rimasero nascosti dalle costruzioni medievali e barocche
almeno sino alla fine della Seconda guerra mondiale quando, a seguito di un
ingente bombardamento, l'abbattimento dei muri moderni permise di portare alla
luce la struttura nella sua forma originaria,
evidenziando le grandi rampe di accesso, le
terrazze cultuali, le scalinate e il tempio vero e
proprio. L'edificio esprime meglio di ogni altro
la sensibilità architettonica dell'architettura
ellenistica che ci è nota attraverso rare
testimonianze della Grecia propria. Per contro, il
gusto scenografico, la presenza di linee di fuga e
di percorsi monumentali hanno indotto alcuni a
ipotizzare che l'architetto che progettò il
complesso non fosse romano ma di origine
greca; comunque siano andate le cose, la
costruzione del santuario fu possibile grazie alle
ingenti rendite derivate dai commerci con
l'oriente greco ottenute dei mercatores e degli
10
Fig. 15 – Ricostruzione
al computer dell'aspetto
originario del santuario
della Fortuna
primigenia di
Palestrina.
Fig.16 – Ricostruzione
assonometrica del
santuario come
proposta dopo le
ricerche degli anni 60.
imprenditori romani e fu completato sfruttando
la tecnica costruttiva dei coementa che sappiamo
essere propriamente romana.
I pellegrini che accedevano al complesso
“vivevano”, pertanto, una vera e propria
esperienza processionale costituita da una serie
di tappe che si palesavano, passo passo, l'una
dopo l'altra, in una serie di scenografie nascoste
reciprocamente da quinte o bruschi passaggi di
direzione, nel rispetto di una progettualità di
grande scala che risponde profondamente alla
sensibilità ellenistica. Ai lati del duplice accesso
al santuario si trovano i resti di due portici le cui
architravi – disposte progressivamente con
andamento obliquo – dimostrano la conoscenza da parte dell'architetto delle
correzioni ottiche con cui ottenere una dilatazione spaziale della prospettiva.
Partendo dalla base, due rampe diagonali si appoggiano a un imponente muro di
sostruzione realizzato ancora una volta in opera poligonale, alle cui spalle sono
disposti dei muraglioni in calcestruzzo; i pellegrini erano accompagnati nella loro
salita da due porticati obliqui che convergevano al centro, dove si trovava una
prima grande balconata affacciata sulla vallata.
Da qui si diparte una scala perpendicolare che conduce a una prima terrazza su cui
si aprono due emicicli; uno di questi avvolge una struttura a tholos posta sopra un
pozzo, a lato della quale sono stati trovati i resti di una statua di culto, mentre i
fedeli potevano prendere posto su un bancone che correva all'interno degli emicicli
stessi. La frequentazione da parte dei fedeli della terrazza è garantita dal
ritrovamento di una grande quantità d’iscrizioni dedicatorie poste da
commercianti, artigiani, liberti o schiavi, che forse un tempo erano applicate al
parapetto della terrazza e che sono dotati di una serie di fori superiori per
l'inserzione di bronzetti votivi. È possibile che la tholos fosse utilizzata per
l'estrazione delle sortes, ovvero dei fogli di corteccia iscritti che si diceva fossero
stati scoperti anticamente da un uomo del posto a seguito di un sogno premonitore
e che erano utilizzati dei sacerdoti per esprimere vaticini e oracoli.
Ritornando alla scala principale era possibile salire di un piano per raggiungerla la
terrazza superiore, segnata da una serie di fornici
in cui si alternano nicchioni e pareti lisce, tutti
inquadrati da semicolonne con capitello ionico
diagonale. Lo spazio che separa la parete frontale
dalla base rocciosa della collina è costipata di
fornici in calcestruzzo che permettevano di
consolidare la piattaforma su cui sorgeva il
santuario tramite una serie di ambienti ciechi
inutilizzati.
La terrazza più alta si caratterizza per la presenza
di una scala frontale che conduce a una sorta di
teatro destinato a ospitare i fedeli durante le sacre
rappresentazioni in onore della Fortuna. La
sostruzione è qui occupata nuovamente da un
criptoportico che crea una sorta di percorso a L,
forse utilizzato dai fedeli durante le processioni. È
interessante notare come due grandi nicchie
furono allestite in forma di fontana; la presenza
dell'acqua era infatti quanto mai importante, sia
per la purificazione dei fedeli che si accingevano
alle celebrazioni, sia per il suo valore simbolico
nell'ambito del culto della Fortuna e di Iside.
L'edificio è concluso in alto da un colonnato
semicircolare che nasconde alle spalle un
ulteriore tholos nella quale doveva essere posta
principale statua di culto.
11
Il santuario della Fortuna rimase in vita sino
all'età imperiale ma ormai degradato per
prestigio e importanza; sembra che il colpo di
grazia alla “fortuna” sia stato dovuto in buona
parte agli espropri e alle epurazioni condotte da
Silla dopo la guerra contro Mario; il municipio di
Palestrina, in effetti, si schierò dalla parte del
perdente ricevendone gravi espropriazioni e
subendo l'insediamento sul postodi una colonia
di veterani di guerra (Praeneste diventò, di fatto,
una colonia sillana); le riforme economiche di
carattere conservatore portate avanti nel periodo
successivo non poterono che indebolire i
commercianti e i coltivatori di olio e di vino che
ne avevano finanziato la costruzione. L'edificio
rimane comunque a testimonianza di una fase di
particolare dinamismo e vivacità dell'economia e
della cultura romana repubblicana.
2.8 – Tempio di Giove Anxur a Terracina
Fig. 17 – Ricostruzione
assonometria del
santuario di Giove
Anxur a Terracina come
proposta nel
dopoguerra.
Fig. 18 – Veduta dal
basso (ingrandimento
con teleobiettivo) della
terrazza del santuario
posto al vertice di Monte
Sant'Angelo.
Rientra nello stesso ambiente architettonico e
culturale – benché caratterizzato da una
maggiore staticità dei percorsi interni – il
santuario romano repubblicano di Monte
Sant'Angelo presso Terracina, dedicato alla
divinità indigena di Anxur che i Romani
assimilarono a Giove. L'edificio è nuovamente
impostato su un'ampia terrazza artificiale
realizzata in calcestruzzo al vertice della
montagna affacciata sul Circeo; le arcate di
scarico che sostenevano la piattaforma superiore
sono – ed erano – ampiamente visibili dal basso
(ove sorgeva la città vera e propria) ma ancor meglio dal tratto di mare antistante,
frequentemente solcato da navi e bastimenti.
Il santuario di Terracina ripropone ancora una volta la distinzione tra sostruzione e
edificio che abbiamo visto come caratteristico della media età repubblicana a Roma
e nel Lazio. In questo caso i fornici di sostruzione erano resi agibili tramite una
scala, e i fedeli avevano la possibilità di percorrere un criptoportico interno fino a
raggiungere una sorta di antro aperto su un grande vano sotterraneo presso il
quale si è supposto fosse attivo un oracolo.La terrazza superiore ospitava un
tempio esastilo, periptero sine postìco il cui orientamento deviava decisamente da
quello della terrazza per esporre il frontone a oriente. Sono ancora ben visibili –
alle spalle dell'edificio – i resti del portico destinato ai pellegrini dove, con ogni
probabilità, venivano transitoriamente esposte le offerte e i doni dei fedeli. Di
maggior interesse è la piccola struttura in calcestruzzo addossata a una roccia
naturale immediatamente a destra della facciata del tempio, ove è ancora possibile
riconoscere – alla sommità – un foro naturale comunicante con l'antro inferiore. Si
dovrebbe trattare di un secondo punto destinato all'ascolto dell'oracolo da parte
dei sacerdoti, che raggiungevano la balaustra tramite una scala oggi scomparsa. In
un piccolo edificio quadrangolare posto al vertice della roccia è stato anche
identificato un piccolo podio in cui si riconosce l'auguraculum, ovvero il luogo
delegato all’esplorazione spazio celeste da parte dei sacerdoti durante le cerimonie
augurali. Il Tempio di Giove Anxur a Terracina si data a cavallo tra II e I sec a.C. e,
come molti monumenti dell'epoca, colpisce per la sua imponenza e per la sua
capacità di imporsi sul paesaggio circostante tramite la terrazza artificiale,
realizzata sfruttando appieno le potenzialità dei coementa. Rispetto al santuario di
Palestrina, il santuario di Giove manifesta, tuttavia, una certa limitatezza dinamica
dei percorsi interni e offre una visione più bloccata che preclude alle realizzazioni
della fine dell'età repubblicana e soprattutto dell'età imperiale. Benché non siano
12
disponibili dati stratigrafici precisi, la datazione del tempio di Giove Anxur si basa
sulla presenza di un castrum romano collegato a un circuito difensivo di torri e
muraglioni che scende a valle sino a bloccare la via Appia e che fu realizzato nel
periodo delle guerre tra Mario e Silla; esso viene pertanto a costituire un termine
ante data quem che sopporta le datazioni già avanzate.
2.9 - Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli
Fig. 19 – Restituzione
grafica dell'aspetto del
santuario di Ercole
vincitore a Tivoli di età
repubblicana.
Fig. 20 – Immagine del
criptoportico realizzato
in corrispondenza del
primo piano fuori terra
dell'edificio.
Caratteristiche architettoniche non molto differenti presenta anche il santuario di
Ercole vincitore a Tivoli, uno dei maggiori complessi sacri dell'architettura romana
di età repubblicana. Costruito nel corso del II sec a.C. esso sorgeva su un tratto
dell'antica via Tiburtina e, con la sua ampia sostruzione quadrangolare in
calcestruzzo si estendeva su un'area di 188 x 40 m, coprendo complessivamente
oltre 3000 metri quadri. La scenografia del complesso era garantita nuovamente
da una terrazza artificiale sostituita da fornici sulla quale era appoggiata la cavea di
un teatro destinato alle sacre rappresentazioni, al cui vertice si ergeva il tempio
esastilo, periptero sine postìco. La piazza superiore era circondata da un portico di
due piani, di cui quello inferiore seminterrato a formare il tipico criptoportico di
ordine dorico, e quello superiore con colonnato a vista di ordine ionico. L'impiego
disinvolto del calcestruzzo permise di realizzare tanto i muri quanto le semicolonne
in pietra e calce, mascherando la modestia del materiale costruttivo con una tipica
stuccatura dipinta che imitava i colori del marmo. Il gigantismo del complesso
permise il passaggio nei fornici di base di una strada consolare tramite un ampio
passaggio voltato; le sue dimensioni colossali ne hanno permesso la partizione e
frammentazione nel corso del Medioevo per svariati usi e funzioni tra cui, è degna
di nota, la trasformazione in cartiera di alcuni
dei fornici del cortile nel corso del Novecento.
Anche il santuario di Ercole vincitore aveva
probabilmente una funzione oracolare;
sembrano da riferirsi a quest'ultima un pozzo
circolare scoperto durante gli scavi archeologici
nel quale venivano forniti gli oracoli osservando
il movimento e la posizione degli oggetti gettati
dall'alto nell'acqua. La fondazione di
quest'importante santuario dedicato al culto di
Ercole sembra giustificarsi in conseguenza del
passaggio sul luogo di un antichissimo tratturo
utilizzato stagionalmente dei pastori; l'antico
culto indigeno sarebbe dunque stato nobilitato
nel periodo tardo repubblicano dando il via alla
costruzione dell'ennesimo santuario
monumentale grazie alla benevolenza e
all’evergetismo delle classi sociali emergenti
native del luogo.
2.10 – La Porticus Aemilia
Se la datazione al 176 a.C. fosse confermata, la
Porticus Aemilia rappresenterebbe uno dei più
antichi edifici conosciuti in Roma antica
edificato facendo uso della nuova tecnica
costruttiva dei coementa.
L'edificio fu così denominato per ricordare i
censori Marco Emilio Lepido e Lucio Emilio
Paolo che nel 193 a.C. costruirono ai piedi del
Aventino, a circa 90 metri dal corso del Tevere,
un magazzino destinato a stoccare le derrate
alimentari giunte a Roma per via fluviale;
distrutto da un incendio, l'edificio fu ricostruito nel 174 a.C. dai censori Quinto
13
Fig. 21 – Ricostruzione
tridimensionale dei
fornici della Porticus
Aemilia.
Fig. 22 – Ricostruzione
grafica del Tabularium
appoggiato al colle del
Campidoglio, antico
fondale del foro
Romano.
Fulvio Flacco e Aulo Postumio Albino. Resti
dell'edificio sono stati identificati già a partire
dall'Ottocento tra via Beniamino Franklin e via
Marmorata, e altri resti sono tuttora visibili in
via Branca, in via Rubattino e in Via Florio.
L'edificio fu concepito nella forma di una serie
di fornici allineati e disposti a file parallele
sostenuti da pilastri, adagiati sul versante della
collina sfruttando dei salti di quota regolari che
permettevano, tra l'altro, di ricavare prese di
luce per i lucernari e l’areazione in
corrispondenza dello scalino del tetto.
Complessivamente l'edificio raggiungeva una
lunghezza di 487 metri e una larghezza di 60
metri, ed era partito in fornici da 294 pilastri
che creavano 50 navate ognuna delle quali
composta di sette campate. La superficie
coperta con tale sistema raggiungeva l'impressionante dimensione di 25.000 m2.
Recentemente si è proposto di identificarvi piuttosto l’edificio destinato ad ospitare
navi da guerra della flotta romana di età repubblicana – i cosiddetti Navalia – ma
dal punto di vista dell'architettura poco cambia. In questa realizzazione è infatti
possibile osservare lo sfruttamento sistematico della nuova tecnica del calcestruzzo
per realizzare un ampio spazio coperto, riducendo al massimo i tempi di
costruzione e i relativi costi. Gli architetti per conferire maggiore solidità
all'edificio realizzarono i conci degli archi con i tradizionali blocchi di tufo.
2.11 - Il Tabularium
Un’ulteriore evoluzione della tecnica costruttiva romana di età repubblicana è ben
rappresentata dal Tabularium, l'edificio destinato a ospitare l'archivio di stato
costruito nel 78 a.C. dal console Lutazio Catulo in prossimità dell'antico foro
romano, con la funzione di mascherare la sella che univa il colle dell’Arx con quella
del Capitolium. Data la sua funzione, l'edificio si presentava come una scenografia
fortemente verticalizzata, costituita da un muro di sostruzione (alla base ) in opera
quadrata fatto con blocchi di peperino – che con la sua monotona neutralità
forniva un ottimo fondale alla sfilata degli edifici del foro – , un primo piano
caratterizzato da archi inquadrati da semicolonne con capitelli dorici, e un secondo
piano costituito da un porticato corinzio. Quest'ultimo oggi non è più visibile
perché Michelangelo vi impostò il palazzo senatorio che oggi ospita il comune di
Roma. L'intera facciata fu realizzata completamente in tufo peperino (dunque con
una tecnica “di tradizione”) ma alle spalle della facciata, le vie di passaggio, i corpi
scalari e i corridoi sono interamente realizzati in calcestruzzo.
La spiccata frontalità dell'edificio, la sovrapposizione canonica di fornici inquadrati
da semicolonne e da colonne di ordine
rispettivamente dorico e corinzio, manifestano
una freddezza e un accademismo che sembrano
contrapporsi alla dinamicità e al gusto
scenografico delle architetture di Palestrina e di
Terracina, e sembrano invece anticipare un gusto
che troverà sbocco nell'architettura di età
cesariana e augustea. Tutto l'edificio è concepito
come una massa compatta e il calcestruzzo vi è
impiegato entro il perimetro dell'edificio è
contenuto da muraglioni lapidei che fungono da
sostegno e contrafforte. È noto il nome
dell'architetto che portò a compimento l'opera
grazie all'iscrizione dedicatoria: si tratta di un
certo Lucius Cornelius, forse un personaggio di
origine greca naturalizzato a Roma.
14
2.12 - Il Macellum
Nel medesimo periodo in cui si assiste ad una emancipazione della tecnologia
costruttiva degli edifici di Roma e del Lazio, si manifesta la comparsa di nuove
tipologie edilizie di funzione pubblica che sarebbero diventate patrimonio
consolidato della cultura romana. È questo il caso del macellum, il mercato coperto
all'ingrosso del pesce e degli ortaggi costituito da una serie di vani affacciati su un
cortile porticato, al centro del quale si trovava regolarmente una fontana per il
lavaggio delle merci. Un primo esemplare sembra essere stato realizzato a Roma
nel periodo della Prima guerra punica (264 – 241 a.C.), rimanendo un esempio
isolato per oltre cinquant'anni, fino cioè al 179 a.C., quando le fonti storiografiche
ricordano la costruzione di un secondo esemplare. A partire dalla metà del II sec.
a.C., in corrispondenza cioè di una fase di particolare dinamismo della società e
dell'architettura romana, tale tipologia si diffuse anche nelle città minori, come
testimoniato dagli esempi di Morgantina, Pompei e Ostia, diventando comune
anche nelle provincie. Sembra possibile che motore di questa nuova tipologia
architettonica siano stati ancora una volta i contatti
con il mondo cartaginese, ove edifici di questo tipo
sembrano essere stati presenti da tempo. Al mondo
punico rimanda anche la radice etimologica della
parola macellum che è stata riallacciata all'etimo
ma’kal, traducibile in «il luogo in cui si mangia».
Naturalmente, Roma disponeva di molteplici mercati
all'ingrosso riservati alle diverse tipologie
merceologiche, ma questi non presentavano una
specifica formula architettonica e vennero definiti con
la più generica espressione di fora: esisteva pertanto
un foro boario destinato alla vendita all'ingrosso della
carne, un foro olitorio destinato agli ortaggi, una
forum cuppidinis destinato ai dolci e alle prelibatezze
e un forum piscatorium per il pesce e così via, così
che il macellum rappresentò sempre una specifica
singolarità tipologica.
Fig. 23 – Il macellum di
Pozzuoli, espressione
matura di età imperiale
di queste tipologia
elaborata in età
repubblicana.
2.13 - La Basilica civile
Un altro edificio che sembra strettamente collegato ai contatti avuti da Roma con le
regioni di recente conquista è la basilica, un edificio civile riservato alle attività
giudiziarie realizzato in prossimità del foro. L'etimologia del nome sembra da
connettersi alla greca aulè basilichè, l'aula ipostila (cioè circondata da colonne)
utilizzata nel mondo greco – ellenistico per i ricevimenti all'interno del palazzo
reale. Tale tipologia sembra a sua volta essere stata mediata dalla cultura persiana,
“scoperta” in occasione della conquista di Susa e di Persepoli al tempo di
Alessandro (il cosiddetto apadana).
L'aula divisa in tre navate era coperta centralmente da un tetto capriate, e in quelle
laterali da semicapriate; essa ben si adattava a ospitare un ingente numero di
persone protette dalle intemperie per le normali attività giudiziarie e forensi.
È noto che tale soluzione architettonica fu poi ereditata dai cristiani, dando luogo
alla chiesa basilicale (nella quale però l'accesso non avveniva più dal lato lungo
bensì dal lato corto, per sfruttare l’abside come fondale per la liturgia religiosa).
Per quanto concerne il foro romano, una prima basilica fu costruita tra il 210 e i 191
a.C. in prossimità del clivus argentarious; pavimentata con lastre di tufo di Grotta
Oscura, essa era divisa in quattro navate da tre file di colonne, e aveva una facciata
preceduta da un portico. Nel 179 a.C. una nuova basilica fu costruita da Marco
Fulvio Nobiliore e Marco Emilio Lepido in qualità di censori; l'ultimo di essi, tra
l'altro, era stato precedentemente incaricato dal Senato di Roma della tutela del re
di Egitto Tolomeo V Epifane, e nel 201 – 200 a.C. aveva avuto l'occasione di
visitare Alessandria e di osservare direttamente le grandi sale impostile nelle quali
i monarchi ellenistici davano pubblica manifestazione del loro potere e ad esse,
probabilmente, si volle ispirare.
15
La nuova basilica denominata Aemilia fu ampliata con architravi in legno e
pavimenti in travertino. Ricostruita in diverse occasioni, mantenne nel corso del
tempo una pianta sostanzialmente immutata, su una superficie di 70 x 29 m.
Nelle immediate vicinanze, quasi di fronte, sorgeva invece la basilica Sempronia.
Edificata nel 170 a.C. per volere del censore Tiberio Sempronio Gracco (padre dei
ben più famosi tribuni della plebe) ed impostata sullo spazio occupato
precedentemente dalla villa di Scipione l'Africano e da alcuni magazzini, nello
spazio compreso tra il tempio di Saturno e quello dei Dioscuri. Distrutta da un
incendio nel I sec a.C. fu quindi rimpiazzata dalla cosiddetta basilica Giulia,
edificata nel 55 a.C. per volere dell’edile Lucio Emilio Paolo, fratello del triumviro
Marco Emilio Lepido.
Fig. 24 – Ricostruzione
assonometrica del
teatro di Pompeo, primo
edificio di spettacolo in
muratura costruito a
Roma.
2.14 – Il primo teatro in muratura
Alla metà del I sec a.C. si assiste all'introduzione anche in Roma della tipologia
edilizia del teatro in muratura, ampiamente sperimentata nell'ambiente culturale
greco a partire dal V sec a.C. (prima nella forma
di un edificio con gradinata rettilinea, poi con
cavea semicircolare) e sino ad allora osteggiato
dalla classe senatoria come espressione di uno
stile di vita contrario al cosiddetto mos
maoiorum (il comportamento etico degli avi).
Il primo teatro di Roma fu pertanto costruito da
Pompeo a celebrazione dei trionfi militari nel 61
a.C. e inaugurato con grandi spettacoli sei anni
più tardi, nel 55 a.C. La sua costruzione avvenne
grazie all'astuzia di Pompeo che riuscì ad eludere
il divieto vigente in Roma di costruire teatri in
pietra con il pretesto che la costruzione in atto
era soltanto la scalinata per accedere al Tempio
di Venere Vincitrice situato sulla sommità della
cavea ed al centro della facciata curva, mentre in
realtà erano le gradinate del futuro teatro; questo aneddoto, riportato da tardi
scrittori cristiani, ha un suo significato se consideriamo la conformazione tipica dei
grandi santuari dell'età repubblicana (tipo Tivoli, Ferentino e Palestrina) in cui il
tempio era sempre associato un teatro in muratura destinato alle celebrazioni
sacre.
Le dimensioni del teatro di Pompeo sono veramente eccezionali per l'epoca, se si
considera che la cavea aveva un diametro di circa 150 metri e la lunghezza della
scena era di circa 90 metri, con una capacità di almeno 20.000 posti. La facciata
semicircolare della cavea era impostata su una serie di arcate poggiate su pilastri
di pietra gabina e travertino ornati da semicolonne. L'interno era costituito da una
doppia serie di muri radiali collegati tra loro da strutture curvilinee che formavano
dei cunei coperti da volta a botte, che sostenevano le gradinate. La scena, decorata
da quattordici statue rappresentanti le quattordici nazioni conquistate da Pompeo
(due delle quali sono oggi conservate al Museo di Napoli ed al Louvre), era
articolata nella parte anteriore da tre esedre colonnate, delle quali la centrale era
rettangolare mentre le due laterali semicircolari. Dietro la scena si estendeva un
quadriportico di 180 x 135 metri, un vero e proprio parco pubblico ornato di statue,
con boschetti di platani bordati da fontanelle e terminante con una grande esedra
rettangolare, utilizzata come Curia per le riunioni del Senato e ornata con una
grande statua di Pompeo (rinvenuta nella vicina via dei Leutari ed oggi conservata
all'interno di palazzo Spada): si trattava della famosa Curia Pompeia dove il 15
marzo del 44 a.C. venne ucciso Gaio Giulio Cesare, poi fatta murare da Augusto in
qualità di locus sceleratus.
Sandro Caranzano
16